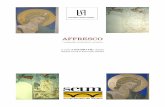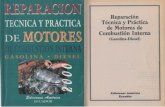L’architettura dei cantieri Tosi tra arte e tecnica
Transcript of L’architettura dei cantieri Tosi tra arte e tecnica
In copertina Dirigenze e Maestranze dei Cantieri Tosi. 25 febbraio 1932.
Direzione e coordinamento editoriale Salvatore Mellea Grafica e impaginazione Pasquale Bondanese
Edito da Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli onlus
Mostra a cura di Salvatore Mellea
Catalogo della mostra a cura di Salvatore Mellea e Antonio Monte
Progetto allestimento e grafica Pasquale Bondanese e Luigi Esposito
Audiovisivi Giuseppe Borrillo, Massimo Cerbera, Roberta Criscio e Domenico Marziliano
Comitato scientifico Antonio Conte, Angela Colonna (Università della Basilicata; Facoltà di Architettura) Renato Covino (AIPAI - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) Pietro Dione, Antonella Carella (Ordine degli Architetti di Taranto) Salvatore Mellea (Fondazione Michelagnoli) Antonio Monte (CNR/IBAM - Istituto Beni Ambientali e Monumentali) Ornella Sapio (Archivio di Stato di Taranto) Marco Scano (Arsenale MM di Taranto)
I Cantieri Tosie la Cantieristica navale
tra storia e patrimonio industriale
a cura diSalvatore Mellea e antonio Monte
Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli onlus
Patrocinio Regione Puglia Provincia di Taranto Comune di Taranto
Sponsor- Assonautica
- Banca Popolare di Puglia e Basilicata
- ENI - Raffineria di Taranto
- INTERFIDI Taranto
- Lions Club Taranto Host
- Orizzonte Sistemi Navali
- Raccomar Taranto
- Regione Puglia
- Rotary Club Taranto
- SIMAV SpA
- Franco Tosi Meccanica Spa
Foto Archivio Arsenale Militare Marittimo di Taranto Archivio di Stato di Taranto Archivio Fondazione Michelagnoli Archivio Maestri del Lavoro di Legnano Archivio Maestri del Lavoro di Taranto Archivio Tosi Meccanica S.p.A. Collezione privata Ettore Guercia
Questa pubblicazione è stata realizzata in occasione della mostra “I cantieri Tosi e la cantieristica Navale. Tra storia e patrimonio industriale”, tenuta al castello Aragonese di Taranto dal 6 dicembre 2012.
Indice Presentazione Fabrizio Martello - Fondazione Michelagnoli
Cronologia degli eventi Mellea Salvatore - Fondazione Michelagnoli
LE TAPPE DELLA CRESCITA Arsenali e cantieri navali dello Ionio e del basso Adriatico Renato Covino e Antonio Monte - AIPAI e CNR-IBAM
Franco Tosi e la sua industria a Legnano. Alessandro Schiavi - Università Cattolica di Milano
Il Cantiere navale “Franco Tosi” di Taranto. Alessandro Schiavi - Università Cattolica di Milano
I Cantieri Tosi nella “Voce del Popolo” di Taranto Aldo Perrone - Associazione Gruppo Taranto
LA PRODUZIONE E I LUOGHI DELL’ATTIVITa’ L’evoluzione del sommergibilismo italiano e i Cantieri Tosi Ermenegildo Ugazzi - Dipartimento MMI Jonio e Canale d’Otranto
Taranto, i Cantieri “Tosi” e la costruzione dei sommergibili Ermenegildo Ugazzi - Dipartimento MMI Jonio e Canale d’Otranto
Gli Stabilimenti Navali ex Tosi. Riparazione e chirurgia navale Luciano Crocicchio, Antonio Greco, Vito Imperiale, Giuseppe Lazzaro - Gruppo ex Capi Reparto “Stabilimenti Navali di Taranto”
L’architettura dei Cantieri Tosi tra arte e tecnica Angela Colonna, Antonio Conte, Francesco Maggiore, Antonio Monte - Università della Basilicata
I Cantieri e la città. Un polo per lo sviluppo urbanistico di Taranto Antonella Carella, Pietro Dione, Vincenzo La Gioia e Luigi Oliva - Ordine degli Architetti di Taranto
I Cantieri Tosi nelle fonti dell’Archivio di Stato di Taranto Nascono i Cantieri Maria Alfonzetti - Archivio di Stato Taranto
“In nome di Dio...taglia!”. Il cerimoniale dei vari tra storia e cronaca Cosma Chirico - Archivio di Stato Taranto
Vita di fabbrica Ornella Sapio - Archivio di Stato Taranto
L’ETa’ DELL’ORGOGLIO E QUELLA DEL DECLINO Le commesse estere dei Cantieri Tosi Salvatore Mellea - Fondazione Michelagnoli
I Cantieri dal 1935 alla vigilia della guerra. Un polo di grande capacità e professionalità nella storia della cantieristica italiana Vittorio De Marco - Università del Salento
Il declino dei Cantieri Navali ex Tosi Roberto Nistri - Storico
I Cantieri navali e l’Arsenale Militare. Relazioni e sinergie Marco Scano - Arsenale Militare Taranto
appendice
1. Il lungo necrologio a Franco Tosi 2. Il cordoglio per Gianfranco Tosi 3. Le turbine Tosi consegnate alla M.M. 4. I Sommergibili realizzati nei Cantieri Tosi
colophon
I CantIerI tosIe la cantieristica navale tra storia e patrimonio industriale
Alla fine del 1914 la “Franco Tosi” avvia la costruzione del cantiere navale a Ta-ranto, in località “Leggiadrezze” sulla
riva settentrionale del mar Piccolo, utilizzan-do le agevolazioni finanziarie previste dalla legge n°383 del 1906 per favorire lo sviluppo agricolo e industriale delle province meridio-nali.Il cantiere navale dell’impresa Tosi e i due arsenali di Taranto e di Brindisi rappresenta-no insieme uno dei punti di forza del pro-getto di rinnovamento della Marina Militare Italiana, avviato nell’ultimo quarto del secolo
XIX sotto l’impulso dell’Ammiraglio Paco-ret di Saint Bon e dell’ingegnere Benedetto Brin Ministro della Marina. Il programma di ammodernamento della flotta militare viene pensato a seguito della sconfitta di Lissa, del 20 luglio 1866, e con il rilancio assunto dal-la politica della neonata Italia d’inserimento nel quadro delle grandi Potenze. Sull’onda della cosiddetta “sindrome di Lissa” si apre un dibattito che dà l’avvio a nuove politiche militari industriali che maturarono, a partire dal 1876, con l’ascesa al governo della sinistra storica, e che ha come esito la realizzazione di nuovi stabilimenti cantieristici di concezione moderna. La Marina diventa l’epicentro di questa politica, e dà vita a due grandi stabi-limenti contemporanei, di concezione assolu-tamente nuova, che marciano parallelamente e in maniera, per molti aspetti, sinergica: da una parte l’Arsenale di Taranto e dall’altra l’Acciaieria di Terni1; il primo, un impianto militare gestito sotto il controllo della Mari-na, l’altro un impianto che nasce per volere e con sovvenzioni dello Stato, anche se affida-to all’iniziativa di un gruppo privato. Grazie alla scelte degli anni Ottanta, all’iniziativa pubblica, alla integrazione tra fabbricazione
L’architettura dei cantieri Tosi tra arte e tecnica
angela Colonna, antonio Conte, FranCeSCo Maggiore, antonio Monte
Ex “Cantieri Navali Franco Tosi”. Vista d’insieme delle offici-ne. Taranto, 2007.
Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli onlus
La produzione ed i Luoghi deLL’attività
dell’acciaio e costruzioni navali, prendeva avvio quello che è stato definito “l’itinerario protezionistico siderurgico dell’industria ita-liana”2. La localizzazione a Taranto dei cantie-ri navali delle “Officine Franco Tosi” sulla co-sta settentrionale del seno di ponente del Mar Piccolo, ha una motivazione commerciale strategica che dipende in larga misura dall’in-teresse di condividere lo stesso “mare” con l’Arsenale del capoluogo jonico assicurandosi con esso un vantaggioso rapporto. Il Cantiere Tosi, infatti, fronteggia l’Arsenale della Ma-rina Militare collocato sulla sponda opposta del Mar Piccolo. Il complesso nasce per svol-gere tutte le attività di cantieristica navale con particolare applicazione nella realizzazione di sommergibili. Il Cantiere, che si estende su un’area di circa 12 ettari, è costituito origi-nariamente da sei corpi di fabbrica principa-li: le Officine navali; le Officine meccaniche; le Officine congegnatori; la Sala Tracciati; la Fonderia in bronzo e ghisa; il Reparto Car-
penteria in legno. A questi si aggiungono se-dici gru a braccio girevole, piccoli fabbricati sorti come appendici per assolvere funzioni minori e un bacino artificiale. Costruito alle soglie della prima guerra mondiale, il cantiere viene rinnovato nei suoi impianti nel periodo che precede la seconda guerra mondiale. In questa fase vengono ultimate la nuova offici-na meccanica navale, la caserma per equipag-gi, la palazzina per ufficiali e le vie di corsa delle nuove gru degli scali, e viene prolungata la darsena. L’impianto è riconducibile ad una forma pressoché rettangolare dove la dispo-sizione dei fabbricati secondo assi paralleli è dettata dalla linea di costa lungo cui si atte-stano tutti i prospetti principali. Per esigen-ze tecniche di lavorazione e di adeguamento funzionale l’impianto ha subito negli anni, fino alla sua prima chiusura nel 1960 e par-ziale dismissione nel 1980, varie trasforma-zioni. All’interno del perimetro si posiziona centralmente la Sala tracciati: un grande ca-
Ex “Cantieri Navali Franco Tosi”. Vista del bacino artificiale con due delle origi-narie 16 gru, ormai in stato di abbando-no. Taranto, 2007.
I CantIerI tosIe la cantieristica navale tra storia e patrimonio industriale
pannone sobrio e austero, risolto nella cru-da rappresentazione di materiali e funzioni, segnato da reiterazioni formali e da motivi elementari. Si tratta di un edificio lineare e simmetrico caratterizzato da strutture por-tanti in conci di pietra locale del tipo “tufo” lasciati faccia a vista. Le facciate in muratura portante, sempre in “tufo”, sono definite da un partito architettonico scandito da lesene e diviso in due livelli da una fascia marcapia-no, con ampie finestre vetrate, su entrambe i piani, ritagliate in sommità a corda di arco. Il prospetto dei lati minori è tripartito da due lesene che delimitano uno spazio centrale più alto a chiusura superiore orizzontale, dietro la quale si nasconde la sommità del tetto a spio-venti, e le due campate laterali, chiuse da due lesene e da un tetto a salienti. L’impostazione simmetrica delle facciate minori e gerarchiz-zata dalla diversa dimensione delle finestre vetrate, così come la sequenza modulare delle campate nelle facciate del lato lungo del ca-pannone, mostrano una declinazione sobria ed essenziale di un linguaggio che utilizza an-cora, anche se ridotti all’essenziale, i vocaboli e la tessitura del linguaggio classico, veicola-
to dall’esperienza dell’eclettismo ottocente-sco ma contaminato dalle sperimentazioni moderne di oltralpe. All’interno lo stesso capannone mostra la tecnologia del metallo utilizzata per il tetto del tipo “a capriate”, con un lucernario mediano lungo quasi tutto il tetto. Alla massività dei muri perimetrali fa da contrappunto la leggerezza della copertura in metallo, laterizi e vetro. Anche all’interno della sala è riproposto il partito architettonico delle facciate esterne, con l’ordine delle lesene e le grandi finestre vetrate. Nella sala tracciati il sistema delle grandi finestre vetrate, com-binato con il lucernario a nastro al colmo del tetto a intelaiatura metallica, produce una il-luminazione naturale diffusa e sottolinea uno spazio del lavoro pensato con i criteri dell’ef-ficienza e della salubrità, come richiamava il nascente dibattito architettonico internazio-nale di quegli anni intorno agli standard nei luoghi di lavoro così come nei servizi pubblici e nella casa d’abitazione. Un linguaggio serrato di ritmi uniformi, di strutture metalliche e di telai a traliccio, definisce i plessi laterali, impostati su schemi
Ex “Cantieri Na-vali Franco Tosi”. Vista d’insieme della “Sala a trac-ciare”. Taranto, 2007.
Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli onlus
La produzione ed i Luoghi deLL’attività
modulari; questi sono riconducibili agli im-pianti basilicali formati da navate contigue.Due caratteri qualificano complessivamente queste opere: l’articolazione robusta delle superfici perimetrali e l’impiego di grandi aperture vetrate che ne infrangono la conti-nuità. Le ampie vetrate annullano la separaz-ione tra spazio esterno e interno, e tendono a smaterializzare le superfici murarie. In questa contrapposizione tra pieni e vuoti è possibile rinvenire in filigrana le tracce protorazionali-ste dell’architettura moderna, rintracciando alcuni riferimenti al quadro culturale europeo dove negli stessi anni l’architettura industriale rappresenta uno dei filoni di sperimentazi-one principali del Modernismo. In partico-lare per gli insediamenti industriali che si svilupparono in Germania nei primi anni del Novecento. Peter Behrens (1868-1940) con le sue cinque fabbriche costruite per la A.E.G. (Allgemeine Elektrizitats Gesell-schaft), in special modo con la Turbinnenfab-rik di Berlino nel 1908, cambia il concetto di funzionalità dell’architettura industriale; così nel 1911 il suo allievo diretto Walter Gropius (1883-1969) con le Officine Fagus a Alfeld
an der Leine rivoluziona ulteriormente la concezione di costruzione industriale ponen-do attenzione al lavoro e quindi agli operai attraverso l’utilizzo di ampi superfici vetrate; Hans Poelzig (1869-1936), nel tentativo di eliminare gli stili storicizzati per attribuire un valore simbolico all’edificio industriale, si fa artefice di opere imponenti e geometrizzate come accade nel complesso Chemische Fab-rik a Luban (1911). In Italia proprio nel 1916, mentre s’inaugura il Cantiere Tosi, vengono avviati a Torino i lavori di costruzione dello stabilimento Fiat-Lingotto progettato da Giacomo Mattè-Truc-co (1869-1934), opera rivoluzionaria per la soluzione dell’autodromo sul tetto.Questi sono alcuni degli esempi più impor-tanti di architetture concepite nei primi due decenni del Novecento con la volontà di trarre dal tema funzionale un valore compositivo e formale; esempi che seppur indirettamente hanno influenzato il linguaggio e i caratteri dell’architettura industriale europea.Il Cantiere Tosi per certi versi risponde a questi caratteri anche se vanno riconosciuti i limiti di un’architettura industriale che
Ex “Cantieri Na-vali Franco Tosi”. Interno della sala a tracciare. Taranto, 2007.
I CantIerI tosIe la cantieristica navale tra storia e patrimonio industriale
aderisce con sobrietà e semplicità alle esigenze di concretezza funzionale e di necessità tec-nologica. Opere i cui caratteri sono affidati agli aspetti funzionali e costruttivi, contrad-distinti dalla semplificazione e annullamento di qualsiasi episodio decorativo.Nel panorama del bacino del Mar Piccolo gli edifici dei Cantieri Tosi e quelli di fine Ottocento dell’Arsenale Militare, fronteg-giandosi dalle due coste opposte dello stesso specchio d’acqua, sembrano tuttavia ricon-oscersi per alcuni rimandi formali nelle fac-ciate: ad esempio la forma della cornice che inscrive una sorta di bifora che si ripete lungo il prospetto sul bacino Ferrati della Centrale elettrica sembra ripreso nelle finestre del ca-pannone per i tracciati dei cantieri Tosi. Pur se leggermente più decorate le facciate degli edifici dell’Arsenale, in entrambe i casi le ar-chitetture traducono le forme sobrie e fun-zionali delle opere industriali nel linguaggio della città borghese alle soglie della moder-
nità. Con la facciata definita da un principio di simmetria, o di ripetizione modulare del partito architettonico, dove nell’Arsenale la simmetria è sottolineata in alcuni prospetti da elementi di decoro formale lungo l’asse mediano -come nella facciata sul Bacino Brin della Stazione di pompaggio in cui campeggia una trifora inscritta in un arco con due oculi, quasi in un neorinascimento di vaga memo-ria veneziana- entrambi i luoghi del lavoro sul bacino tarantino incarnano, attraverso la sobrietà, l’immagine moderna del luogo del lavoro dove la razionalità funzionale è congi-unta al decoro, attributo del moderno homo faber.Per comprendere il carattere prevalentemente tecnico di queste architetture è opportuno fare delle considerazioni sul rapporto tra arte e tecnica: esporre e costruire un progetto significa proporre una conoscenza valuta-tiva dell’architettura e a sua volta qualunque
Taranto. Arsenale Militare Marittimo. Facciata sul Bacino Brin della Stazione di pompaggio in cui campeggia una tri-fora inscritta in un arco con due oculi.
Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli onlus
La produzione ed i Luoghi deLL’attività
atteggiamento valutativo non è separabile dall’analisi della realtà.Questi grandi capannoni, questi luoghi col-lettivi del lavoro dismessi o abbandonati pon-gono il problema del loro rapporto con la conoscenza dell’architettura in senso propria-mente scientifico e tecnico. La storia di una parte consistente della produzione manualis-tica ha registrato in periodi determinati come una sorta di impulso e di avanzamento ris-petto al resto del mondo produttivo. Questi manufatti sono modelli costruttivi delle cul-ture e delle teorie di quegli anni in cui anche il lavoro aveva la possibilità di misurarsi in modo costante con lo svolgersi delle forme, dei tipi, del linguaggio propri dei grandi manuali dell’Ottocento come il “Trattato di costruzioni civili” di Gustav Adolf Breymann a Stoccarda o il “Nuovo corso completo di pubbliche costruzioni” di Giuseppe M. Sgan-zin a Venezia.
I materiali utilizzati per queste architetture sono quelli che la tecnica e l’arte del costru-ire raccontano e descrivono nei manuali di uso civile del tempo. Le questioni tecniche e costruttive sono parte dell’idea stessa di pro-gresso con cui queste architetture entrano in sintonia, accettandone il rigore tecnico e la ra-gione scientifica. La vicenda dell’architettura industriale moderna è profondamente seg-nata dalla parallela vicenda tecnologica. La conoscenza organizzata e proiettata nello spazio dell’architettura del lavoro contiene gli avanzamenti della cultura e del sapere, delle professioni e dei mestieri che vanno con-solidandosi proprio nelle scuole tecniche e d’ingegneria.Non c’è tecnica, definita nelle forme del costruito, che contemporaneamente non af-fronti anche le questioni di rappresentatività sociale o collettiva come il sobrio e proporzi-onato fronte principale della fabbrica dei “tracciatori” dei cantieri Tosi.
Ex “Cantieri Na-vali Franco Tosi”. Officina navale dei cantieri, particolare delle coperture in ferro della Ditta Savigliano di Torino. Taranto, 2007.
I CantIerI tosIe la cantieristica navale tra storia e patrimonio industriale
La “sala tracciati”, non è una originale opera di architettura ma una sapiente costruzione sintesi del progresso civile tra arte e tecnica. Il manufatto è una sorta di testo costruito, nel senso della grande divulgazione manualistica, ed è un modello di intreccio strettissimo tra bisogni economici, forma e soluzioni tec-niche. La dimensione della razionalità scien-tifica va individuata come matrice teorica di una risposta pratica del costruire, una misura sottesa ad una esemplificazione reale di un esempio specifico. Certo, questa complessa composizione di luoghi della produzione e
del lavoro è una storia condizionata, definita anche da condizioni sociali di sfruttamento degli uomini, ma sicuramente è anche un patrimonio della conoscenza, delle tradizioni costruttive, che possono oggi rappresentare una interessante memoria, identità di una conoscenza tecnico-scientifica diffusa che nel moltiplicarsi è un tassello della storia del Sud. I modi e le forme della produzione artigianale dopo la prima guerra nel settore dell’edilizia affrontano il problema della normalizzazione dei prodotti, e l’uso del ferro nelle grandi cop-erture è stata una risposta in continua evoluz-ione e sperimentazione. Queste architetture sono un mosaico di questi avanzamenti.
Ex “Cantieri Na-vali Franco Tosi”. Officina navale dei cantieri, particolare del tetto del tipo “a capriate”, con un lucernario media-no. Taranto, 2007.
Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli onlus
Colophon
Maria alFonzetti
La Dott.ssa Maria Alfonzetti è Funzionario dell’Archivio di Stato di Taranto.
antonella Carella
L’Arch. Antonella Carella è Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto e Assessore Centro Storico e Decoro Urbano del Comune di Taranto.
CoSMa ChiriCo
La Dott.ssa Cosma Chirico è Funzionario dell’Archivio di Stato di Taranto.
angela Colonna
L’Arch. Angela Colonna è ricercatrice in Storia dell’Architettura presso l’Università degli Studi della Basilicata.
antonio Conte
Il Prof. Arch. Antonio Conte è docente ordinario di Disegno presso l’Università degli Studi della Basilicata.
giUSePPe Corona
Il P.I. Giuseppe Corona già dipendente degli Stabilimenti Navali di Taranto, è stato Capo Reparto Congegnatori di bordo.
renato Covino
Il Prof. Renato Covino è docente ordinario di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Perugia e Presidente Nazionale Aipai.
lUCiano CroCiCChio
Il P.I. Luciano Crocicchio già dipendente degli Stabilimenti Navali di Taranto, è stato Capo Reparto Impianti Provvisori di bordo.
vittorio de MarCo
Il Prof. Vittorio De Marco è Professore Ordinario di Storia contemporanea presso l’Università del Salento.
Pietro dione
L’Arch. Pietro Dione è Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto.
gli Autori
I CantIerI tosIe la cantieristica navale tra storia e patrimonio industriale
vito iMPerialeIl P.I. Vito Imperiale già dipendente degli Stabilimenti Navali di Taranto, è stato Capo Officina Meccanica.
vinCenzo la gioia
L’Arch. Vincenzo La Gioia è Responsabile della Commisione Cultura della Fondazione Archi.TA.
giUSePPe lazzaroIl Dott. Giuseppe Lazzaro già dipendente degli Stabilimenti Navali di Taranto, è stato Capo Reparto Saldatori, Ribaditori, Ossigenisti.
FranCeSCo Maggiore
L’Arch. Francesco Maggiore è dottorando in Architecture and Urba Phenomenology presso l’Università degli Studi della Basilicata.
Fabrizio Martello
L’Ing. fabrizio Martello, Presidente della Società CISDEG SpA, è il Presidente della Fondazio-ne Michelagnoli.
Salvatore Mellea
L’Ing. Salvatore Mellea è il Direttore Generale della Fondazione Michelagnoli.
antonio Monte
L’Arch. Antonio Monte è ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di Lecce.
roberto niStriIl Prof. Roberto Nistri, docente di Storia e Filosofia presso i Licei, è Storico e Saggista.
lUigi oliva
L’Arch. Luigi Oliva è professore di Archeologia Urbana presso l’Università degli Studi di Sas-sari.
aldo Perrone
Il Prof. Aldo Perrone, Preside, Saggista, è presidente della Associazione culturale “Gruppo Taranto”.
ornella SaPioLa Dott.ssa Ornella Sapio è Direttore dell’Archivio di Stato di Taranto.
MarCo SCano
Il Contrammiraglio Marco Scano è il Direttore dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto.
aleSSandro SChiavi
Il Prof. Alessandro Schiavi è Professore associato di Geografia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano.
erMenegildo Ugazzi
L’Ammiraglio di Squadra Ermenegildo Ugazzi è Comandante in Capo del Dipartimento MM del Canale d’Otranto e dello Jonio.
I CantIerI tosIe la cantieristica navale tra storia e patrimonio industriale
Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli OnlusTaranto, Via Nitti, 7
Tel/fax 0994535431 - tel 0994526095
e-mail: [email protected]: www.fondazionemichelagnoli.it
Finito di stampare nel mese di novembre 2012da
ISBN 978-88-98196-07-4