F.R. Stasolla, La rete dei contatti e degli scambi: caratteri generali. Periodo tardoantico e...
Transcript of F.R. Stasolla, La rete dei contatti e degli scambi: caratteri generali. Periodo tardoantico e...
©PROPRIETÀ ARTISTICA E LETTERARIA RISERVATA
Copyright by
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.p.A.
2002
FotolitoMARCHESI GRAFICHE EDITORIALI S.p.A.
Via Bomarzo, 32 - 00191 Roma
StampaGRAFICHE ABRAMO
Traversa Cassiodoro, 19 - 88100 Catanzaro
Printed in Italy
Per quanto riguarda i diritti di riproduzione, l’Istituto si dichiara pienamente disponibile a regolare
eventuali spettanze per quelle immagini di cui non sia stato possibile reperire la fonte
Italian Wines in Roman Egypt, in Opus, 2 (1983), pp. 81-98; M. CorsiSciallano - B. Liou, Les épaves de Tarraconaise à chargement d’amphoresDressel 2-4, Paris 1985; C.R. Whittaker, Trade and Aristocracy in the RomanEmpire, in Opus, 4 (1985), pp. 49-75; J. Remesal Rodríguez, La annonamilitaris y la exportación de aceite bético a Germania, Madrid 1986; A.Tchernia, Le vin de l’Italie romaine. Essai d’histoire économique d’après lesamphores, Rome 1986; J.C. Edmondson, Two Industries in Roman Lusitania.Mining and Garum Production, Oxford 1987; D.J. Mattingly, Oil for Export?A Comparison of Lybian, Spanish and Tunisian Olive Oil Production in theRoman Empire, in JRA, 1 (1988), pp. 33-56; M. Ponsich, Aceite de oliva ysalazones de pescado: factores geo-económicos de Bética y Tingitana, Madrid1988; Anfore e storia economica: dieci anni di ricerche. Atti del colloquio(Siena, 22-24 maggio 1986), Roma 1989; P. Arthur, Aspects of ByzantineEconomy: An Evaluation of Amphora Evidence from Italy, in V. Déroche, -J.-M. Spieser (edd.), Recherches sur la céramique byzantine, Athènes - Paris1989, pp. 79-93; C. Panella, Merci e scambi nel Mediterraneo in età tar-doantica, in Storia di Roma, III, 2, Torino 1993, pp. 613-97; D. Manacorda,Produzione agricola, produzione ceramica e proprietà della terra nella Calabria
romana tra Repubblica e Impero, in Epigrafia della produzione e della distri-buzione. Actes de la VIIe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du mon-de romain (Rome, 5-6 juin 1992), Rome 1994, pp. 3-59; C. Panella - A.Tchernia, Produits agricoles transportés en amphores. L’huile et sourtout levin, in L’Italie d’Auguste à Dioclétien. Actes du Colloque (Rome, 22-25 mars1992), Rome 1994, pp. 145-65; V. Revilla Calvo, Producción cerámica, vi-ticultura y propriedad rural en Hispania Tarraconensis (siglos I a.C. - III d.C.),Barcelona 1995; P. Reynolds, Trade in the Western Mediterranean, AD 400-700: the Ceramic Evidence, Oxford 1995; C. Panella, Rifornimenti urbanie cultura materiale tra Aureliano e Alarico, in W.V. Harris (ed.), TheTransformations of Urbs Roma in Late Antiquity, Portsmouth - Rhode Island1999, pp. 183-215; T. Peña, The Urban Economy during Early Dominate.Pottery Evidence from the Palatine Hill, Oxford 1999; C. Carreras Monfort,Economía de la Britannia romana: la importación de alimentos, Barcelona2000; R. Étienne - F. Mayet, Le vin hispanique. Trois clés de l’économie del’Hispanie romaine, I, Paris 2000.
Clementina Panella
LE VIE, I LUOGHI, I MEZZI
638
PERIODO TARDOANTICO E MEDIEVALE E MONDO BIZANTINO
LE RETE DEI CONTATTI E DEGLI SCAMBI: CARATTERI GENERALI
Nel tracciare le dinamiche viarie e commerciali del periodo tar-doantico e medievale, le fonti archeologiche vanno, forse piùche in altri casi, lette in stretta connessione con altri tipi di fon-ti. Un tracciato stradale, infatti, può nascere per scopi com-merciali, essere sfruttato per ragioni militari, tornare in augeperché via di pellegrinaggio, restare in vita come collegamen-to dei centri che nel frattempo sono sorti lungo il percorso, convariazioni di scelte e di percorrenze diverse per ogni suo tratto,tutto questo in una dinamica di casualità e programmazioneche la sola ricerca archeologica – come ogni altra indagine uni-voca – non consente di recuperare. Ciò non toglie che i risul-
tati di tali indagini siano in alcuni casi dirimenti nel rivalutarearee considerate commercialmente depresse o nel porre l’ac-cento su rotte e tracciati stradali non altrimenti ipotizzabili.Questo genere di dati acquista particolare valore proprio per ilperiodo tardoantico e altomedievale. A lungo infatti la man-canza di ritrovamenti delle caratteristiche anfore romane ha in-dotto a ritenere che con la tarda età imperiale le condizioni disicurezza del Mediterraneo, la conquista vandala dell’Africa, leincursioni delle popolazioni germaniche – anche a fronte didocumentazione letteraria che lamentava la devastazione ap-portata dai “Barbari” – e le generali condizioni di instabilitàpolitica avessero ridotto drasticamente le relazioni commercialiall’interno del bacino mediterraneo, fino alla cesura delle rela-zioni determinata dalla diffusione araba. I limiti cronologici diquesto fenomeno sono stati collocati in modo variabile tra laTarda Antichità e i primi secoli del Medioevo, a seconda dellemotivazioni addotte per giustificarlo: dalle migrazioni germa-
759
Principali strade
di pellegrinaggio
in Italia:
1) Santiago de
Compostela;
2) Aosta; 3) Nizza;
4) Genova; 5) Vipiteno;
6) Klagenfurt;
7) Czestochowa;
8) Venezia; 9) Roma;
10) Napoli; 11) Bari;
12) Otranto.
cammino di Santiago
via Francigena
via Romea
Madonna Nera
Santo Sepolcro
12
4
56
8
7
9
10
11
12
3
niche, alle epidemie, alle variazioni climatiche, alla diffusionedell’Islam. In realtà, le indagini archeologiche nei livelli post-classici di molti siti ed il rinvenimento di una serie di relittihanno confermato il mantenimento di un’efficiente rete com-merciale transmarina e quindi l’esistenza di rotte ed itineraritra il Mediterraneo occidentale e quello orientale, sia pure conmodalità differenti. Negli ultimi decenni, la mole dei ritrova-menti di manufatti, soprattutto ceramici, ha consentito di ana-lizzare sotto altra visuale i fenomeni migratori ed i nuovi assettiche, sia pur destabilizzanti rispetto al precedente ordine socia-le ed economico, hanno comunque prodotto nuove esigenze enuove economie, quindi nuove vie di comunicazione.
Pure la numismatica contribuisce a delineare il quadro del-le vie commerciali, anche se per l’età tardoimperiale i dati ar-cheologici appaiono apparentemente falsati dalla tesaurizza-zione del circolante aureo ad opera delle popolazioni germa-niche che lo ricevevano in tributo da parte dell’impero di Co-stantinopoli, così che in molti di questi casi la presenza di mo-nete non è sintomo di scambi commerciali e la loro cronolo-gia differisce in alcuni casi anche notevolmente da quella delcontesto archeologico di appartenenza.
Uno dei rischi dell’analisi esclusiva delle fonti archeologi-che consiste nella tendenza a ridurre le ragioni degli incontrie quindi della definizione di tracciati viari ad esclusive moti-vazioni economiche che, se pur necessarie e in taluni casi do-minanti, non costituiscono però l’unico motivo dell’incon-trarsi. Altri vettori della comunicazione non hanno lasciatotracce materiali di analoga portata, ma anche nei periodi me-no sicuri gli uomini stabilivano collegamenti per desiderio diavventura, conquiste di nuove terre, spinte missionarie e mil-le altre ragioni, così che la storia dei contatti tra i popoli nonpuò ridursi alla loro storia economica. L’alto clero e i mona-ci, soprattutto, percorrevano distanze anche molto lunghe pervisitare comunità isolate o impiantarne di nuove, i penitenti edi pellegrini intraprendevano lunghi viaggi allo scopo di visi-tare i sepolcri dei martiri o le vestigia di Cristo e dei suoi apo-stoli, dove talvolta lasciavano traccia del loro passaggio neigraffiti rinvenuti presso le sepolture venerate. Tali viaggi era-no intrapresi al seguito di carovane o su navi mercantili, op-pure autonomamente o con altri pellegrini, in un fenomenodalle dimensioni sempre più imponenti e che trovò nelle cro-ciate uno degli aspetti più appariscenti. I pellegrinaggi, cheinizialmente hanno seguito vie già tracciate, progressivamen-te ne hanno definito di nuove oppure hanno valorizzato per-correnze minori, che però conducevano ad un luogo santo.
Conosciamo le direttrici viarie di tale fenomeno grazie al-la comparazione tra fonti letterarie e fonti archeologiche, con-frontando cioè i diari e gli itinerari tracciati dai pellegrini conle risultanze dei rinvenimenti di santuari venerati. Per la ve-rità, gli itineraria, una sorta di mappe stradali descrittive (ad-notata) o rappresentative (picta) che rappresentavano le prin-cipali località di un percorso con le distanze intercorrenti, era-no molto in uso tra coloro che per ragioni diverse erano costrettia percorrere lunghe distanze. Tra i più noti si annovera sicu-ramente la Tabula Peutingeriana, un itinerarium pictum mol-to ampio, presumibilmente in uso ai funzionari del cursus pu-blicus. A partire dall’età tardoantica, però, gli itinerari più no-ti sono quelli legati alle pratiche devozionali, che costituisconola testimonianza della permanenza in uso di determinati trac-ciati stradali e contemporaneamente la rilevanza assunta dal-la viabilità di collegamento tra i santuari più importanti. Adesempio, l’Itinerarium Burdigalense sive Hierosolymitanum, del-la prima metà del IV secolo, nella differenziazione dei percorsidi andata e di ritorno attesta le due possibilità di collegamen-to tra Bordeaux e la Terra Santa: seguendo le vie consolari fi-no a Costantinopoli e poi proseguendo via terra, per mare dop-piando il tratto tra la costa dalmata e la Puglia e poi raggiun-
gendo Roma tramite l’Appia e quindi proseguendo per le vieFlaminia ed Emilia. Il più noto Itinerarium Egeriae, della se-conda metà dello stesso secolo, attesta le percorrenze terrestrimedio-orientali. L’instabilità determinata dall’estendersi del-le incursioni persiane è attestata da altre fonti analoghe del VIsecolo, che mostrano una spiccata preferenza per i viaggi permare, sia tra Costantinopoli e le coste fenicie (Itinerarium Ano-nimi Piacentini) sia nei più avventurosi percorsi fino all’India(Topographia Christiana di Cosma Indicopleuste).
Comunque, ancora all’inizio del X secolo i pellegrini oc-cidentali potevano andare in Terra Santa via mare, attraver-so Alessandria o un altro porto siriano, oppure a Costantino-poli e poi via terra. Per quanto riguarda l’Europa occidentale,dall’VIII secolo è attestato l’utilizzo della via Romea o Fran-cigena (Itinerarium Sancti Willibaldi), un asse stradale di fon-damentale importanza per tutto il Medioevo, di collegamen-to tra le regioni del Mare del Nord e Roma, da dove si potevapoi proseguire per il santuario di S. Michele al Gargano e quin-di imbarcarsi per la Terra Santa. Una serie di tracciati viari var-cava infine i Pirenei per raggiungere Santiago de Compostela.L’analisi di queste fonti eccezionali va integrata dalle notiziesulle strutture di accoglienza per i pellegrini che costellavanoi percorsi viari più frequentati, attestate sia a livello docu-mentario che sul piano archeologico. La loro dislocazione to-pografica ha inoltre consentito di cogliere il variare dei per-corsi, che tendevano a farsi pedemontani a motivo della scar-sa sicurezza di alcuni periodi o di disgregazione del tessutostradale più antico (scarsa manutenzione, avanzamento dellearee paludose, ecc.).
Le vie terrestri di commercio vennero inoltre facilitate pro-prio dai vettori apparentemente meno probabili: i movimentidelle popolazioni germaniche, se da un lato rendevano insicu-re alcune aree, per altri versi paradossalmente facilitarono alcu-ne comunicazioni, così che le loro migrazioni finirono in qual-che caso per costituire i vettori di alcune merci: è questo il ca-so ad esempio dell’ambra, che nella prima metà del VI secoloera di nuovo presente sui mercati italiani, evento per il qualeTeodorico riconosceva il merito degli Esti (Cassiod., Var., 5,2).Infatti gli Unni nel V secolo e i Longobardi nella seconda me-tà del VI giunsero in Italia proprio lungo la via dell’ambra,
PERIODO TARDOANTICO E MEDIEVALE E MONDO BIZANTINO
639
760
Principali strade
di pellegrinaggio
verso Santiago
de Compostela:
1) Saint-Omer;
2) Bruxelles; 3) Amiens;
4) Laon; 5) Reims;
6) Parigi; 7) Tours;
8) Troyes; 9) Langres;
10) Vézelay;
11) Clermont-Ferrand;
12) Cluny; 13) Lione;
14) Einsiedeln;
15) Le Puy; 16) Fréjus;
17) Saint-Gilles-du-
Gard; 18) Saint-
Guilhem-le-Désert;
19) Tolosa; 20) Puente
de la Reina; 21) Burgos;
22) Santiago de
Compostela.
22
2120
4
68
9
10
7
3
2
4
1
5
13
12
14
16
15
11
17
1819
O C E A N O
A T L A N T I C O
che percorreva le città pannoniche unendo il Mar Baltico al-l’Adriatico e giungendo quindi ad Aquileia.
Appare ormai accertato come in età tardoantica non sia ces-sato il commercio transmarino, ma che questo sia proseguitocon modalità differenti. In assenza di un consistente numerodi relitti di età postclassica, il tracciante archeologico di que-sta analisi è costituito ovviamente dai ritrovamenti anforici,per i quali sono ormai abbastanza noti gli aspetti formali e pro-duttivi anche per tale epoca. Le produzioni anforiche tar-doantiche, almeno fino al VII secolo, segnalano come il com-mercio di beni prodotti in Oriente avesse un andamento pre-ferenziale lungo l’asse sud-nord, con perno a Costantinopolie con importanti punti di transito, primo fra tutti Cipro. LaGrecia meridionale e Creta, pur mantenendo con le regionisiro-palestinesi e con l’Egitto rapporti autonomi, fungevanoda intermediari nei commerci tra Mediterraneo orientale edoccidentale. Sotto Anastasio (491-518), al comes commercio-rum per Orientem et Aegyptum succedettero due preposti alcommercio, rispettivamente in Mesopotamia e nel porto diClysma sul Mar Rosso.
Ciò che appare modificato afferisce piuttosto alle dinami-che del commercio, che sembrano prevedere il ricorso intensoad una navigazione di cabotaggio e alla commistione di mer-ci eterogenee. Proprio la morfologia delle anfore di produzio-ne orientale sembra far riferimento ad una pluralità di mezzidi trasporto, visto che le loro modeste dimensioni e la loro for-ma particolare ben si adattano all’alternanza tra piccole im-barcazioni e percorsi terrestri a dorso di animali, senza gli altipuntali per lo stivaggio nelle grandi navi di età romana. Co-munque, l’analisi delle imbarcazioni di questo periodo si av-vale del ritrovamento di alcuni relitti (tra i più noti quelli diMarzamemi in Sicilia, del VI sec., e di Yassi Ada in Turchia,del VII sec.) e sembra prevedere il ricorso a navi di più mode-sto tonnellaggio rispetto ai carichi di età imperiale.
Successivamente al VII secolo, la netta diminuzione del-l’uso delle anfore da trasporto sembra sancire in Occidente uncalo dei commerci, anticipando uno scenario che in Orientesi manifesterà circa un secolo dopo, ma la certezza del diffon-
dersi di contenitori alternativi alle anfore – le botti lignee inprimo luogo – rende difficile formulare precise ipotesi quan-titative in merito alle direttrici commerciali. L’arrivo degliArabi spezzò comunque l’asse mediterraneo Cartagine-Costan-tinopoli, che aveva retto fino al VII secolo. Dal 636, infatti,nel giro di un secolo l’Islam aveva conquistato il Vicino Oriente,le aree del Mediterraneo meridionale, parte della Penisola Ibe-rica ed alcune grandi isole del Mediterraneo. Le rotte tra l’AfricaSettentrionale e la Sicilia da una parte e le coste meridionalidall’altra sono confermate nel VI secolo dai ritrovamenti direlitti (Cefalù in Sicilia e Anse Saint-Gervais a Fos-sur-Mer,presso Marsiglia) e dai rinvenimenti di manufatti ceramici nel-le stratigrafie dei centri importatori. In realtà ritrovamenti dimateriale africano sono presenti anche nelle stratigrafie diRoma (Schola Preconum, prima metà del VII sec.), ma le fon-ti attestano che tali merci vi pervennero non direttamente, macon la mediazione dei porti siciliani e sardi.
La navigazione fluviale nel corso dell’Alto Medioevo ebbenotevole importanza, tanto da essere gravata da una serie diimposte – non sempre di agevole comprensione per la storio-grafia successiva – in quanto di proprietà sovrana. Proprio dal-la documentazione in merito a privilegi ed elargizioni fiscalisiamo a conoscenza della rete delle acque interne, che interes-sava sia i grandi corsi d’acqua che quelli di più modesta por-tata, con l’eventuale cambio di imbarcazione e la presenza diveri e propri porti o di semplici approdi. I principali corsi d’ac-qua utilizzati nell’Europa mediterranea erano l’Ebro, il Da-nubio, il Rodano e il Po, oltre ai grandi fiumi francesi (Loira,Senna, Mosa, Mosella, Reno). La documentazione archeolo-gica è piuttosto scarsa, anche in considerazione dell’uso, nel-la realizzazione di attracchi fluviali, di strutture minimali, dimateriali deperibili, soprattutto il legno che, come nel casodelle navi non più in uso, poteva essere riutilizzato.
Il quadro degli intensi traffici mediterranei non deve di-stogliere l’attenzione dall’Europa centrale e settentrionale, areenelle quali proprio con l’età altomedievale si svilupparono cen-tri e relazioni commerciali, oltre a dinamismi migratori chefurono propulsori anche di traversate transoceaniche. L’in-tenso traffico costiero del Mar Baltico e del Mare del Norddeterminò, a cominciare dal VII secolo, la nascita di wike, em-pori commerciali costieri o lungo i canali navigabili, utilizza-ti come stazioni di sosta e luoghi di scambi, in genere svilup-patisi attorno ad una via rettilinea o alle banchine di scali, consemplici e funzionali costruzioni in materiali per lo più de-peribili, che costituiscono indicatori archeologici della navi-gazione minore e costiera. La mancata aderenza alle realtà eco-nomiche e sociali delle terre in cui sorsero ne determinò la de-cadenza in concomitanza con il mutare delle rotte: sono questii casi di Quentovich in Francia, in vita tra il 670 circa e l’864;di Haithabu/Hedeby che, posto alla base dello Jütland, co-stituiva un nodo viario tra la Germania settentrionale e la Da-nimarca. Altri centri riuscirono invece a sviluppare fenomenidi vita urbana, come nel caso di Haarlem, in Olanda, sorta diperiodo carolingio lungo la rotta delle dune che percorrevail delta del Reno. In altri casi, mercanti e viaggiatori occupa-rono alcune zone di città già esistenti (Colonia, Magonza,ecc.). Il fenomeno del mercato propulsore di vita urbana oprotourbana è un fenomeno che si riscontra anche nell’Euro-pa orientale, come nei casi di Stare Mesto e Mikulcice, en-trambi nel IX secolo. La stessa Praga, posta lungo la via com-merciale Ratisbona-Cracovia-Kiev, nel X secolo era un centrocommerciale sviluppato.
Il dinamismo delle popolazioni scandinave comportò la co-lonizzazione di altre terre. Così, a coloni norvegesi, che ave-vano già percorso le isole settentrionali della Scozia, sembra-no doversi i primi insediamenti stabili in Islanda, nel corsodel IX secolo, come evidenziato dalle pratiche funerarie e dai
LE VIE, I LUOGHI, I MEZZI
640
761
Particolare della
Tabula Peutingeriana.
Vienna,
Österreichische
Nationalbibliothek.
PERIODO TARDOANTICO E MEDIEVALE E MONDO BIZANTINO
641
manufatti recati dalle prime generazioni. Alla fine del X seco-lo (nel 985) anche la Groenlandia venne raggiunta nell’am-pliamento delle rotte settentrionali, più precisamente da po-polazioni norrene provenienti dall’Islanda che vi fondaronodue colonie, Vesterbygd e Österbygd. Tali popolazioni sonoattestate fino al XV secolo soprattutto grazie ai risultati delleindagini archeologiche, che hanno consentito di ricostruirnele modalità di stanziamento e la consistenza demografica. Essesi spinsero, a partire dalla fine del X secolo, fino alle coste nord-americane, tanto che le tracce del loro passaggio sono state rin-venute ad Anse-au-Meadows (Canada), che presumibilmentedoveva costituire un punto di passaggio per spedizioni che siestendevano più a sud. Certamente le spedizioni transconti-nentali verso Occidente erano impresa non facile, ma non spo-radica, visto che gli scavi groenlandesi hanno evidenziato lapresenza di manufatti e capi di abbigliamento prodotti in Eu-ropa nel periodo che va dal X al XV secolo, senza significati-ve soluzioni di continuità.
A partire dall’XI secolo, l’Occidente si espande nel Medi-terraneo, dopo i secoli precedenti di “chiusura”, fino all’Asiainterna. Una nuova spinta propulsiva si deve alle attività del-le città costiere, alcune delle quali si consorziarono con accordidi non belligeranza e patti commerciali, il più noto dei qualiè quello dell’Hansa (detto Lega Anseatica), che riunì i centridel Mare del Nord, mentre altre riuscirono ad assurgere a for-me di governo autonomo e di autentico predominio del ma-re, come nel caso italiano delle cosiddette Repubbliche Ma-rinare. La loro attività cominciò nell’Alto Medioevo, facilita-ta dalla situazione di instabilità politica che nelle relazioni traimpero bizantino e l’avanzante mondo musulmano necessita-va di intermediari per le attività commerciali. In questo pe-riodo, infatti, a causa dei rischi e dell’alto costo, in Occidenteappare limitata l’importazione di alcune merci di lusso (spe-zie orientali, piante aromatiche, tessuti preziosi, tinture, gem-me, avorio). Fino alla metà del X secolo i commerci a lungadistanza in Occidente sono fondamentalmente in mano a mer-canti stranieri: Siriani, Greci dell’Italia meridionale bizantina,Arabi maghrebini ed Ebrei che, protetti dai sovrani, si muo-vevano soprattutto via terra, recando le merci direttamente aiclienti o ai mercati. Gli Ebrei erano facilitati dalla rete dei rap-porti intercomunitari, dalla lingua comune e dal buon livellodi alfabetizzazione; data la marginalità religiosa, inoltre, fun-gevano da intermediari tra cristiani e musulmani. Ruolo ana-logo, grazie ai legami di sudditanza formale all’imperatore diCostantinopoli e al libero scambio nelle aree islamizzate, svol-gono a partire dall’VIII secolo i mercanti amalfitani e vene-ziani, tanto che questi ultimi nell’828 riuscirono addiritturaa trafugare le spoglie di s. Marco ad Alessandria d’Egitto. Perquanto riguarda le imbarcazioni, i Veneziani svilupparono lamarina da guerra, con la diffusione della galera e della naverotonda, e una certa attenzione al trasporto di viaggiatori che,anche se raramente autonomo rispetto all’aspetto commercialedei viaggi per mare, è attestato da cronache del XV secolo re-datte da pellegrini che si recavano in Terra Santa (ad es., i dia-ri di Santo Brassa e di Gabriele Capodilista).
Per quanto riguarda il pieno Medioevo, le fonti diventanomolteplici e di varia natura, così che il dato archeologico mi-ra, piuttosto che a fornire elementi di novità quanto alle di-rettrici dei commerci e delle comunicazioni, ad integrare le co-noscenze offerte dalla documentazione scritta, soprattutto inmerito ai luoghi dello scambio. Ad esempio, tra XIII e XV se-colo i manuali di mercatura consentono di ricostruire le dina-miche economiche all’interno del Mediterraneo, con esten-sioni fino all’Inghilterra, alla Penisola Scandinava, al Mar Nero,al Catai. Nel XV secolo la maggior parte del traffico che per-correva le quattro rotte occidentali (tirrenica, adriatica, cata-lana ed oceanica) era svolto dai mercanti biscaglini, a scapito
dell’attività siciliana, che dal periodo normanno aveva ripreso,dopo la parentesi araba, a gravitare verso Occidente, penaliz-zata dalla carenza di legname per l’industria navale, tanto chea partire dal XII secolo si assiste nelle acque siciliane al domi-nio delle navi genovesi, che detenevano anche la gestione del-le più importanti tonnare. Proprio Genova, infatti, a partiredal secolo successivo costituì il fulcro dei rapporti tra l’Europainterna da un lato e l’Oriente bizantino ed islamico, l’Occidenteiberico e nordafricano dall’altro, fino alle Fiandre e all’Inghil-terra, detenendo anche la gestione dei centri produttivi di al-lume a Focea e di mastice a Chio, riuscendo a sconfiggere iPisani che cercavano di inserirsi lungo le rotte del Mar Nero,bruciandone le navi nel 1277 lungo le coste della Crimea, fon-dando centri fin sul Don (ad es., Porto Pisano). Così che nonstupisce l’attribuzione della Carta Pisana, carta nautica dellafine del XIII secolo, nella quale il Mediterraneo è tracciato conintenso realismo. La potenza genovese cede a partire dalla finedel XIII secolo, e soprattutto nel corso del seguente, per mol-teplici cause, non ultime il declassamento del suo porto, ina-datto alle navi di grande tonnellaggio, e la perdita delle posta-zioni sarde ad opera della Corona d’Aragona, che cominciò ilsuo dominio non solo nel Mediterraneo occidentale, ma an-che nel Levante, nell’Egeo e nel Mar Nero. Per quanto riguar-da le tecniche e le modalità di navigazione, un punto nodale ècostituito dall’arco cronologico che va dalla metà del XIII al-la metà del XIV secolo, quando il diffondersi dell’uso della bus-sola e dei nuovi tipi di imbarcazioni comportò una vera e pro-pria rivoluzione nautica. Prese l’avvio un fenomeno di “omo-geneizzazione” di tecniche che trova riscontro anche a livellolessicale nella creazione di una vera e propria “lingua franca”marinara, le cui espressioni sono evidenti nel Compasso de na-vigare, carta nautica del Mediterraneo di origine presumibil-mente pisana, redatta alla metà del XIII secolo.
I risultati della ricerca archeologica e dell’analisi struttura-le delle emergenze sono in questo periodo sostanzialmente uti-li alla ricostruzione dei punti di mercato creati lungo le costepiù frequentate, che in alcuni casi diventarono vere e propriecolonie franche. Un esempio ben noto è costituito da San Gio-vanni d’Acri, dove le fonti documentarie ed archeologiche han-no concorso alla ricostruzione del quartiere veneziano, che eb-be origine da concessioni dell’inizio del XII secolo, che già de-finivano l’intenzione di impiantare una struttura stabile, conedifici civili e religiosi, fino alla risistemazione difensiva delquartiere alla metà del secolo e agli ultimi lavori, pochi anniprima della conquista mamelucca del centro, nel 1291. Appa-re evidente come accanto alle strutture funzionali alle attività
762
Frammento di stoffa
di seta (X sec. d.C.)
prodotto nel Khorasan,
Iran, cd. “sudario
di St.-Josse”.
Parigi, Louvre.
41. – Il mondo dell’archeologia – Vol. II
portuali e agli impianti religiosi fossero previste varie unitàcommerciali ed abitative, queste ultime sia per la popolazio-ne residente che per l’alloggio temporaneo dei mercanti ve-nuti dalla madrepatria.
Le aree destinate agli scambi sono ben definite anche al-l’interno dei centri urbani: nel Medioevo infatti il luogo de-putato allo scambio per eccellenza era il mercato, la cui per-manenza determinò in alcune città romane il prosieguo d’u-so dell’area forense. Nelle aree che non hanno risentito dellatradizione urbanistica romana, la posizione del mercato rimasecomunque centrale e ben visibile, al centro del più importan-te crocevia, sovente protetto da una croce, soprattutto nel ca-so in cui le rendite mercantili erano di pertinenza vescovile.Questo fenomeno diede vita allo sviluppo urbanistico di nu-merose città, con impianti quadrangolari o triangolari (ad es.,s’Hertogenbosch, in Olanda, della fine del XII sec.). La cen-tralità della piazza del mercato diventa determinante ancheper le nuove fondazioni bassomedievali, quali le bastides e le“città nuove”.
Bibl.: La navigazione mediterranea nell’Alto Medioevo. XXV Settimana CISAM 1977, Spoleto 1978; S. Arenson, Shipping and Maritime Trade.Medieval Period. Selected Bibliography, Haifa 1978; E. Ashtor (ed.), Studiesin the Levantine Trade in the Middle Ages, London 1978; Id., Gli Ebrei nelcommercio mediterraneo nell’Alto Medioevo (sec. X-XI), in Gli Ebrei nell’AltoMedioevo. XXVII Settimana CISAM 1979, Spoleto 1980; Id., Storia econo-mica e sociale del Vicino Oriente nel Medioevo, Torino 1982 (trad. it.); L. DeSalvo, Rifornimenti alimentari e trasporti marini nelle Variae di Cassiodoro,in S. Lenza (ed.), Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, Soneria Mannelli 1986,pp. 409-19; L’Italia e i Paesi Mediterranei. Vie di comunicazione e scambicommerciali e culturali al tempo delle Repubbliche Marinare. Atti del ConvegnoInternazionale di Studi (Pisa, 6-7 giugno 1987), Pisa 1988; I Vichinghi(Catalogo della mostra), Malmö - Firenze 1989; La Venetia nell’area pada-
no-danubiana. Le vie di comunicazione. Atti del Convegno Internazionale(Venezia, 6-10 aprile 1988), Padova 1990; C. Keller, Vikings in the WestAtlantic: a Model of Norse Greenlandic Medieval Society, in ActaArch, 61(1990), pp. 126-41; R. Stopani, Le vie di pellegrinaggio del Medioevo. Gliitinerari per Roma, Gerusalemme, Compostella, Firenze 1991; P. Barozzi,Esploratori, mercanti e religiosi in Oriente nel Medioevo, in Optima Hereditas.Sapienza giuridica romana e conoscenza dell’ecumene, Milano 1992, pp. 321-77; M. Tangheroni, L’Italia e la navigazione mediterranea dopo la fine del-l’impero d’Occidente, ibid., pp. 381-434; Les Vikings, les Scandinaves etl’Europe 800-1200, Paris 1992; J.-P. Callu, I commerci oltre i confinidell’Impero, in Storia di Roma, 3, I, Torino 1993, pp. 487-524; C. Panella,Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico, ibid., 3, II, pp. 613-97; D.Jacoby, Nuovi e mutevoli orizzonti: verso ed oltre l’Oriente mediterraneo, inStoria d’Europa, III. Secoli V-XV, Torino 1994, pp. 1143-192; Peregrinatio.Pilgerreise und Pilgerziel. Akten des XII. Internationalen Kongresses fürChristliche Archäologie (Bonn, 22.-28. September 1991), Città del Vaticano -Münster 1995; S. Origone (ed.), Le vie del Mediterraneo. Idee, uomini, og-getti (secoli XI-XVI), Genova 1995; D. Jacoby (ed.), Trade, Commodities andShipping in the Medieval Mediterranean, London 1997; F.R. Stasolla, A pro-posito delle strutture assistenziali ecclesiastiche: gli xenodochi, in ArchStorRom,121 (1998), pp. 5-45.
Francesca Romana Stasolla
LE VIE E I LUOGHI DEGLI SCAMBI E DEI CONTATTI NEL MONDO TARDOANTICOOCCIDENTALE
Già a partire dall’età augustea, in seguito all’intensificarsi deirapporti con le province transalpine, la via Postumia sembraessersi rivelata inadeguata a contenere il traffico di buona par-te dell’Italia del Nord, mentre la costruzione di nuove infra-strutture territoriali spostò il baricentro degli interessi econo-mici verso nodi stradali come Mediolanum, Brixia, Verona,Aquileia, determinando per Placentia e Ariminum il passag-gio ad un ruolo secondario. Verso la metà del I sec. d.C., inrelazione al perfezionamento della rete stradale settentriona-le, venne verosimilmente aperta una via pedemontana che,collegandosi alla preesistente via Postumia, unì Milano adAquileia. Questa nuova arteria, di cui non è noto il nome an-tico, venne denominata Gallica a partire dalla tradizione ot-tocentesca. Nel III-IV secolo le strutture stradali create in etàrepubblicana erano ancora efficienti per le comunicazionidall’Italia centrale verso i territori transpadani: i grandi assistradali consolari Flaminia-Emilia, in particolare, agevolandoi collegamenti con il Nord, permisero a Mediolanum di emer-gere come centro di importanza strategica, in grado di colle-gare sia la viabilità transalpina sia i traffici fluvio-lacuali. Anchele fonti epigrafiche e i cippi miliari confermano l’efficienza ela funzionalità della viabilità settentrionale, a cui l’autoritàimperiale dedicò una costante manutenzione, particolarmen-te intensa nel periodo di Gallieno (260-268). Nel Tardo Imperoi miliari attestano un gran numero di opere di restauro a trat-ti viari e alle relative infrastrutture, nonché la costruzione ditronchi stradali stagionali alternativi, paralleli a vie in deperi-mento; venne inoltre sviluppata una rete secondaria per rag-giungere i centri minori. In tale attività risulta imponente l’o-pera di Costantino (306-337), mentre nei periodi successivil’enfasi propagandistica delle iscrizioni sui miliari, riutilizza-ti per successivi imperatori, è sintomo della generale crisi eco-nomica; gli assi strategici che conducono a Mediolanum e aiprincipali centri cisalpini vengono comunque mantenuti sem-pre in efficienza.
Sin dall’antichità, i naturali punti di partenza per valicarele Alpi erano stati Aosta verso il Piccolo e il Gran S. Bernardo;Como e Chiavenna verso lo Spluga, il Settimo e lo Julier;Emona verso la Carnia. Quando Milano divenne capitale, creb-be l’importanza dei valichi delle Alpi centrali, unitamente aquello delle due vie, ad esse trasversali, che si dipartivano dailaghi lombardi: il Verbano e il Lario. Le due maggiori località
LE VIE, I LUOGHI, I MEZZI
642
763
Frammento
del cd. “sudario
di s. Austremonio”,
di manifattura bizantina
(X-XI sec.).
Lione, Musée Historique
des Tissus.














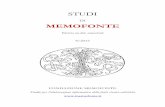









![PRELOŽNIK A., GUŠTIN M.: Cinturoni da parata: esempi di contatti tra l’area veneta e la Dolenjska nell’età del ferro. - Archeologia Veneta 35, 2012 [2013], s./p. 118-127.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63161c373ed465f0570be358/preloznik-a-gustin-m-cinturoni-da-parata-esempi-di-contatti-tra-larea.jpg)


