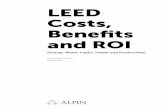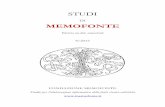Il sale come fattore trainante della produzione e degli scambi nelle zone interne nella preistoria...
Transcript of Il sale come fattore trainante della produzione e degli scambi nelle zone interne nella preistoria...
Le peuplement de l’arc alpin. paris, éd. du ctHS, 2008, p. 289-298.
riaSSuntoSono presi in esame i seguenti aspetti, relativi alla produzione e al consumo del sale, con particolare attenzione alle zone interne e montane della penisola italiana: 1) le esigenze economiche alla base della domanda di sale; 2) i luoghi e i metodi di produzione; 3) i mezzi e le vie di trasporto; 4) gli effetti sinergici dei tre aspetti precedenti. è verosimile che, con il neolitico, per la necessità di conservare notevoli quantità di derrate alimentari, sia nata l’esigenza di trovare nuove forme di conservazione per prodotti specifici (ad es. i derivati del latte). e’ oggi possibile desumere l’importanza della produzione e circolazione del sale anche in assenza di reperti specifici: infatti in alcuni siti neolitici vicini a sorgenti salmastre è attestata una percentuale di ossidiana e di selce importate più alta rispetto ai siti della stessa regione. Vengono quindi discusse alcune ipotesi relative al briquetage in italia. infine si cerca di avvalorare l’ipotesi, secondo cui la transumanza degli ovini, oltre alla propria specificità economica, doveva comportare un indotto in cui il sale può avere svolto un ruolo importante anche come mezzo di scambio.
réSumé Le sel comme élément moteur de la production et des échanges dans les zones intérieures pendant la préhistoire italienneLes aspects suivants seront pris en considération, concernant la production et la consommation du sel dans l’italie préhistorique, avec une attention particulière aux zones intérieures et de montagne : 1) les exigences économiques à l’origine de la demande du sel ; 2) les lieux de production ; 3) les moyens et les voies de transport ; 4) les effets synergiques des trois aspects précédents. il est probable qu’au néolithique, en raison de la nécessité de conserver de très importantes quantités de denrées, de nouvelles formes de conservation ont vu le jour (en particulier pour les dérivés du lait). aujourd’hui il est possible de déduire l’importance de la production et de la circulation du sel même en l’absence de pièces spécifiques, car dans certains sites néolithiques voisins de sources salées, on enregistre un pourcentage d’obsidienne et de silex importés plus élevé que sur les sites de la même région. enfin, le phénomène de la transhumance devait comporter, outre sa propre spécificité économique, une série d’activités collatérales dans lesquelles le sel peut avoir joué un rôle important.
AbstrActsalt as an element propelling production and exchanges in the prehistoric Italian hinterlandthis paper considers the following issues concerning salt production and its use in prehistoric Italy, particularly regarding the inland and the uplands: 1) the economic needs which give rise to salt demand; 2) the production areas and methods; 3) the means and ways of transport; 4) the synergic effects of the three former aspects. the most plausible hypothesis suggests that salt spread first and foremost as a food preservative in the new Neolithic economy, which needed to preserve an important food stock, particularly dairy products, for a long time. today it is possible to infer the importance of salt production and circulation even in the absence of specific objects, because some Neolithic sites near salt springs have yielded a percentage of obsidian and imported flint higher than in other sites of the same region. some supposed evidence of brickwork is also discussed. Finally the author defends the hypothesis according to which the transhumance of sheep in central-southern Italy constituted a complex integrated system, in which shepherds could procure salt during their stay on the coast and use it primarily to produce cheese, but probably also as exchange currency.
iL SaLe come Fattore trainante deLLa produZione e deGLi ScamBi neLLe Zone interne neLLa preiStoria itaLiana
tomaso di fRaia
università di pisa, dipartimento di Scienze archeologiche
290
Le peuplement de l’arc alpin
perché il sale?
recenti studi condotti sulla dieta di cacciatori-raccogli-tori attuali, caratterizzata da un rapporto animali/vege-tali di 35% a 65%, hanno cercato di ricostruire la proba-bile dieta degli uomini del paleolitico Superiore (eaton, 1992). per il sodio è stato osservato che la sua scarsa quantità nell’alimentazione paleolitica, stimata intorno ai 700 mg al giorno, è “perfettamente compatibile con una vita normale, … e molto idonea a prevenire l’iper-tensione arteriosa” (delluc et al., 1997, p. 191); per una popolazione di cacciatori è sufficiente una discreta quantità di carne rossa, con eventuale integrazione di vegetali contenenti sodio. dobbiamo allora chiederci perché sia stato introdotto il cloruro di sodio nell’ali-mentazione umana. poiché la documentazione arche-ologica indica che la produzione del sale assunse una certa importanza durante il neolitico (Weller, 1998), si è ipotizzato che il suo uso alimentare sia cominciato con l’avvento dell’agricoltura, per la necessità di rein-tegrare i sali persi, soprattutto dai vegetali, durante la bollitura. tale ipotesi però è inconsistente, giacché da una parte la bollitura non era sconosciuta alle popola-zioni di cacciatori-raccoglitori, dall’altra cereali e legu-mi possono essere cotti con metodi diversi. tuttavia è vero che il fabbisogno di sale aumenta col diminuire dell’apporto carneo, tendenza prevalente nelle popo-lazioni neolitiche. inoltre anche gli animali necessitano del sale e pertanto nell’allevamento stanziale, in cui gli erbivori non possono scegliersi le risorse vegetali più adatte per integrare la propria alimentazione, potreb-be insorgere la necessità di somministrare agli erbivori una certa quantità di cloruro di sodio. ma soprattutto è verosimile che, nell’ottica neolitica dell’accantona-mento e conservazione di notevoli quantità di derrate alimentari, si sia affermata l’esigenza di trovare nuove forme di conservazione per prodotti specifici, soprat-tutto di origine animale. in questa prospettiva spicca la lavorazione del latte; infatti, per alcuni dei suoi derivati è indispensabile l’aggiunta di sale, poiché la salatura costituisce un momento fondamentale della caseifica-zione. ciò è tanto più importante perché il latte, in quanto tale, non solo non poteva essere conservato a lungo, ma originariamente non poteva nemmeno essere digerito dagli adulti e quindi non poteva esse-re consumato tutto subito; tale situazione si modificò soltanto quando alcune mutazioni genetiche determi-narono la persistenza della lattasi in individui adulti. Secondo Leena peltonen, dell’università di Helsinki, la
popolazione in cui per la prima volta (tra il 4600 e il 2800 a.c.) si sarebbero prodotte tali mutazioni avreb-be abitato il territorio tra gli urali e il Volga e da qui il gene interessato si sarebbe diffuso in europa1. tuttavia su tale ipotesi, che deve essere ancora vagliata dalla comunità scientifica e non ha supporti archeologici, gravano pesanti interrogativi: si può essere certi che le mutazioni genetiche in questione siano avvenute una sola volta in una sola popolazione? Si può escludere che i geni interessati siano stati introdotti in europa in epoche successive? come si concilia tale teoria con la ricostruzione (Sykes, 2001) secondo cui non più del 20% del patrimonio genetico degli europei è poste-riore al paleolitico e quindi soltanto una percentuale ancora più bassa può essere attribuita ad epoche tardo o post-neolitiche? infatti, poiché oggi la maggioranza degli europei adulti produce la lattasi e d’altra parte non possiamo attribuire a un ipotetico apporto geneti-co di popolazioni provenienti dalle steppe un’incidenza superiore a poche unità percentuali, si pone il proble-ma di come la presenza della lattasi sarebbe passata da un’infima minoranza a oltre la metà della popolazione adulta.
durante il neolitico il sale può essere stato usato per la conservazione della carne di animali, specialmente di taglia medio-grande (ad esempio maiali adulti), per i quali non fosse possibile o economico un consumo immediato, e di pesci, che in certi climi è difficile con-servare diversamente. inoltre il sale può rendere com-mestibili alcuni prodotti vegetali, spontanei o coltivati, come le olive, destinate a diventare un companatico fondamentale nei paesi mediterranei. Vanno poi con-siderati i possibili usi non alimentari: dalla concia delle pelli, alla tintura delle stoffe, alla metallurgia. tutta-via è probabile che per alcuni di questi usi non fosse necessaria una particolare raffinazione e fosse quindi utilizzabile il sale ottenuto dalla semplice evaporazio-ne dell’acqua marina. ulteriori motivazioni, legate ad esempio al gusto o a particolari valenze simboliche e rituali o ancora a particolari rapporti socio-culturali – come ritiene ad esempio Weller (Weller, 2002a) –, possono aver accresciuto l’importanza del sale, ma tali motivazioni devono essere state secondarie o comun-que derivate, sia in senso cronologico che socio-eco-nomico. anche il fatto che la documentazione arche-ologica europea sia enormemente più ampia e ricca per l’età del ferro e per le fasi protourbane, quando diventa essenziale lo stoccaggio di notevoli riserve ali-mentari per un numero elevato di abitanti, rafforza la
291
t. di Fraia — il sale come fattore trainante della produzione e degli scambi nelle zone interne nella preistoria italiana
tesi secondo cui l’aspetto economico-funzionale è sta-to quello più rilevante.
La circolazione del sale
e’ probabile che il sale fin dal neolitico fosse anche destinato agli scambi, magari insieme ad altre materie prime; ad esempio il salgemma siciliano, puro e immediatamente commestibile, potrebbe aver seguito alcune rotte dell’ossidiana; cioè il sale potrebbe essere stato trasportato insieme all’ossidiana, come prodotto pregiato, dai giacimenti della Sicilia all’italia peninsulare, incrementando il valore e l’importanza degli scambi. per il salgemma ci aspettiamo di trovare raramente indicatori archeologici nei luoghi di produzione, in tutti quei casi in cui verosimilmente c’è stato uno sfruttamento ininterrotto delle cave nel corso dei millenni; tuttavia, anche in questa direzione comincia ad aprirsi qualche spiraglio, come dimostrano le ricerche presso la Montagna del sale, a cardona, in Spagna (Weller, 2002b). pertanto sarebbe importante indagare meglio le aree vicine ai giacimenti di salgemma della Sicilia, per verificare se è ancora possibile trovare tracce di presenze preistoriche. recentemente è stata fatta un’illuminante osservazione (Weller, 1999; Vaquer, 2006) sulla possibilità di desumere l’importanza della produzione e circolazione del sale anche in assenza di reperti specifici; ad esempio nei siti neolitici di pescale (modena) e di menglon (Francia meridionale), ambedue vicini a sorgenti salmastre, è attestata una percentuale di ossidiana sarda e di selce pregiata più alta rispetto ai siti coevi dei rispettivi territori. un discorso analogo si può fare per altri siti vicini, tra cui ad esempio Fiorano, del neolitico antico, e Spilamberto, dell’età del rame (Weller, 1999). L’unica spiegazione possibile è che tali siti costituissero due nodi gerarchicamente importanti nella rete di scambi, in quanto tappe obbligate per l’approvvigionamento del sale. osservazioni simili sono state fatte riguardo alla circolazione di manufatti particolari, come le asce levigate: « On peut encore citer la très bonne corrélation observable en Allemagne entre les sources salées et la répartition des dépôts de longues haches alpines en roche verte, qui suggère que le sel a pu jouer un rôle essentiel dans l’acquisition de ces objets de richesse et d’apparat » (Weller, 2002a, p. 171).
a proposito della circolazione di materie prime e manufatti, va considerato il fenomeno della transumanza, che, oltre alla propria specificità economica, comporta un indotto, o meglio un’economia di rete sistemica, in cui il sale può avere svolto un ruolo importante. i pastori cioè,
durante il loro soggiorno invernale nei pascoli presso il mare, avrebbero potuto approvvigionarsi di sale marino, che poi in parte avrebbero utilizzato per la caseificazione, in parte potrebbero avere sfruttato come mezzo di scambio. L’etnografia documenta anche l’utilizzazione delle stesse pecore come bestie da soma durante la transumanza: un esemplare della varietà Jumly poteva trasportare fino a 13 kg di sale dal tibet al nepal nei mesi di luglio-agosto (ryder, 1983) e in qualche caso resti ossei di ovini preistorici mostrano tracce di deformazioni provocate dal trasporto di carichi pesanti. alcuni autori (Lane, morris, 2001) hanno avanzato l’ipotesi del “modello opportunistico”, cioè una produzione di sale effettuata da pastori durante i soggiorni presso le coste marine, anche perché presso i luoghi di produzione non sono state individuate tracce di insediamenti stabili. tuttavia tale ipotesi cozza contro troppe difficoltà. anzitutto la produzione del sale era comunque impegnativa, anche in ambienti mediterranei; infatti se l’evaporazione non era sufficiente o il sale risultante non era abbastanza puro per l’alimentazione o se comunque si volevano ottenere pani facilmente trasportabili, bisognava produrre molti vasi e bruciare grandi quantità di legna (v. avanti). inoltre il soggiorno costiero dei pastori coincide con il periodo autunno-inverno; quindi si richiederebbe una precedente fase di evaporazione, che qualcuno dovrebbe comunque controllare più o meno continuativamente. d’altronde l’assenza di abitati nelle immediate vicinanze delle saline può dipendere, oltre che dalle caratteristiche geomorfologiche, anche dalle condizioni insalubri delle zone con acque stagnanti (si pensi alla malaria).
tuttavia, su un piano generale, si ha l’impressione che l’attività pastorale durante la preistoria in italia, come forse anche in altre aree, sia stata finora sottostimata, con riferimento sia alla sua estensione geografica, sia alla sua importanza economica, sia infine alla cronologia, poichè l’avvio e lo sviluppo probabilmente furono più precoci di quanto si pensasse. ad esempio, recenti studi sul territorio del levante ligure nel terzo millennio a.c. hanno ipotizzato che l’attività pastorale potesse essere collegata all’estrazione mineraria sia di diaspro che di minerali cupriferi, nel periodo di permanenza dei pastori a quote medio-alte (maggi, 2004, pp. 40-41); in uno scenario del genere la produzione e il trasporto del sale potrebbero avere svolto un ruolo di implementazione di processi economici già molto importanti. e’ stato anche ipotizzato (pearce, de Guio, 1999; pearce, in corso di stampa), a mio parere in modo abbastanza convincente, che durante i periodi di soggiorno estivo in certe aree montuose del
292
Le peuplement de l’arc alpin
nordest dell’italia, i pastori avrebbero fornito, attraverso il formaggio, una buona parte dell’apporto alimentare per i minatori impegnati nell’estrazione dei minerali del rame e degli specialisti addetti alle prime fasi di lavorazione del metallo.
La funzione del sale quale conservante alimentare sem-bra confermata dall’unico ritrovamento relativo all’età del bronzo nel mediterraneo: a creta, nella grotta tis Uranias to Frudi (“ciglio di urania”) presso Zakros, (Kopaka, cha-niotakis, 2003), nel 1962 fu recuperato circa mezzo chilo di sale, insieme con vasi, strumenti e resti organici (cereali, legumi e corna di capra); la ceramica ha permesso di da-tare al medio minoico i livelli non disturbati. Studi recenti hanno dimostrato che si tratta di sale marino, posto in di-versi vasi, alternato a strati di sostanza scura carbonizzata, forse fette di carne o vegetali o foglie di vite per pietanze particolari (dolmades?). e’ stato proposto di interpretare un segno della scrittura Lineare B come un contenitore di sale (corrispondente a una precisa quantità); in alcune tavolette di cnosso (tributi pagati al palazzo?) esso è asso-ciato ad altri tre prodotti (capre, maschi e femmine, e cor-na di capra) ed è l’unico prodotto computato in unità di peso. Le bilance, diffuse anche in italia almeno dal Bronzo medio (specialmente nelle terramare emiliane), dovevano pesare il metallo, ma molto probabilmente anche il sale e altre sostanze pregiate, come filati o tessuti. La pesatura della lana grezza, registrata nelle tavolette micenee, era effettuata nel sistema economico palaziale per calcolare la materia prima assegnata ai laboratori artigianali per la produzione di filati e tessuti e potrebbe semmai suggerire un’interpretazione per le bilance e i lingottini di bronzo (probabili pesi) trovate in sepolture dell’europa centrale datate al xiii sec. a. c. in molte di queste erano sepol-ti maschi di alto livello sociale, forniti di spada e talvolta di vasellame bronzeo e di elementi di carro (pare, 1999). anche in questo caso, oltre e forse più che ad un’utiliz-zazione delle bilance per transazioni con gruppi esterni, si potrebbe pensare a forme di controllo nella gestione di attività produttive interne di particolare rilevanza: l’élite guerriera potrebbe aver assegnato determinate quantità di lana o lino a gruppi di artigiani e poi controllato il corri-spettivo peso dei tessuti. per il sale si potrebbe ipotizzare un’analoga utilizzazione delle bilance, ovviamente sol-tanto nella fase di assegnazione di determinate quantità di sale per il confezionamento di particolari prodotti (per esempio formaggi o carni da salare). in questo quadro sembra molto probabile l’utilizzazione del sale (pesato) quale mezzo di scambio, almeno in certi ambienti e a certi livelli. da sottolineare che la produzione del sale in italia
è attestata all’incirca dallo stesso periodo in cui appaiono le bilance, il che non significa che l’uso del sale non fosse diffuso prima, ma potrebbe indicare che in quel periodo si verificò un boom della domanda e una maggiore circola-zione, facilitata appunto dall’utilizzo delle bilance.
La documentazione italiana
Gli unici due siti che abbiano restituito convincenti indizi di attività di produzione del sale nella protostoria italiana sono isola di coltano (presso pisa) e quello denomina-to p13 a sud di nettuno (roma). isola di coltano è una duna di origine pleistocenica, 9 Km a sud di pisa e a 7 km dalla costa attuale. Lo scavo, condotto dal 1993 al 1997 (pasquinucci, menchelli, 1997; di Fraia, Secoli, 2002; di Fraia, 2006), nel settore i registrò 70 uS, con la ricorren-te alternanza fra sedimenti ricchi di materiale ceramico, ceneri e carboni e strati limosi di origine non antropica, per una profondità di circa 1,5 metri. i depositi di origi-ne naturale si sono formati a causa di ripetute ingressioni lagunari seguite da fasi di prosciugamento; il fenomeno è confermato dal ritrovamento di numerosi molluschi bivalvi (soprattutto cerastoderma edule) trovati ancora chiusi, quindi morti in loco a causa della progressiva eva-porazione delle acque. il primo fenomeno di inondazione si può individuare nella parte più profonda dello scavo e probabilmente è da collegare all’uS 60, costituita da un canale (non sappiamo se artificiale o naturale) da cui potevano confluire e defluire le acque. La formazione di piscine-saline naturali può aver suggerito un loro diretto sfruttamento (magari con perfezionamenti) o la creazione di bacini del tutto artificiali; la stratigrafia attesta infat-ti altrettanto cicliche frequentazioni umane. a fronte di oltre 10000 frammenti ceramici, non sono state trovate strutture riferibili ad abitazioni, né reperti tipici degli in-sediamenti stabili, ma molti focolari e alcuni frammenti di probabili alari molto massicci, a sezione subquadran-golare (di Fraia, 2006, fig; 1, n°12). e’ preponderante (oltre il 70%) la ceramica grossolana, molto frammenta-ria, di colore bruno, rossastro o arancione. i contenitori più comuni sono troncoconici o subovoidi, di dimensioni medio-grandi ( di Fraia, 2006, fig; 1, n°6,8,10,11), con fondi piuttosto massicci, adatti quindi a sostenere tempe-rature relativamente alte per tempi prolungati. e’ quindi lecito inferire un’attività che prevedesse la preparazione di una salamoia, tramite evaporazione dell’acqua marina in saline, e la successiva raffinazione e/o riduzione del sale in pani, tramite ebollizione in contenitori ceramici; per favo-rire l’estrazione dei pani dai contenitori erano ovviamente
293
t. di Fraia — il sale come fattore trainante della produzione e degli scambi nelle zone interne nella preistoria italiana
più ergonomiche le forme aperte. i siti in cui sono state riconosciute attività di briquetage (Weller, 1998; daire, 2003) sono accomunati da una serie di costanti: utiliz-zazione di argilla locale, forme aperte dei bollitoi-stampi (conici, troncoconici, troncopiramidali, a calotta), colore arancione-rossiccio della ceramica, assai frammentaria e rinvenuta spesso in grandi concentrazioni, imponenti resti di focolari. Le sezioni sottili di alcuni campioni ceramici di isola di coltano hanno rivelato provenienze litologiche locali; se si considera anche la scarsa cura nelle rifiniture e l’alto grado di frammentazione, si può ipotizzare che i vasi fossero prodotti localmente anche perché soggetti a frequenti rotture, intenzionali o meno.
La composizione tipologica della ceramica, e di conseguenza la specializzazione del sito, non sembra mutare dal Bronzo medio al Bronzo Finale, mostran-do una netta prevalenza di tipi banali sostanzialmente costanti (contenitori medio grandi privi di decorazione, eccetto qualche cordone), accompagnati, nelle singole facies (appenninica, subappenninica, protovillanovia-na), da pochissimi elementi specificamente caratteriz-zati. rispetto ai siti di produzione del sale meglio noti, i contenitori ceramici di isola di coltano non sono così nettamente standardizzati e molti hanno il diametro dell’orlo o del collo inferiore rispetto a quello del ven-tre; quest’ultima caratteristica sembrerebbe ostacolare l’estrazione di eventuali pani, tuttavia si può ipotizzare che tali vasi servissero a produrre pani di volume mol-to inferiore alla loro capacità, e quindi più facilmente estraibili, con il vantaggio pratico che non sarebbe sta-to necessario rabboccare i recipienti durante l’evapo-razione dell’acqua. in altre parole è probabile che tali contenitori servissero semplicemente per la purificazio-ne e separazione del cloruro di sodio, che successiva-mente, informe o ridotto in pani di diversa grandezza, avrebbe potuto essere quantificato e scambiato grazie all’uso di bilance. infatti si può anche ipotizzare che dai contenitori venisse asportata la crosta di cloruro di sodio che si formava continuamente durante l’ebolli-zione, separandosi dai sali sgraditi (carbonato di calcio, carbonato di magnesio, solfato di magnesio ecc.) che restavano nella salamoia. in tal modo le bilance avreb-bero da una parte contribuito a semplificare la catena operativa, eliminando le fasi di produzione di stampi e quindi di pani di sale standardizzati, dall’altra avrebbe-ro garantito un più preciso controllo delle quantità di prodotto scambiate. tra l’altro nella documentazione della ceramica del Bronzo medio e recente nelle valli dell’arno e del Serchio vi sono indizi di rapporti con
l’ambiente terramaricolo, in cui, come ho accennato sopra, le bilance dovevano essere piuttosto diffuse.
per eventuali altre attività, l’ipotesi più ovvia concerne la salatura del pesce, un problema tuttavia ancora da esplorare. in una prospettiva più ampia, la scoperta del monumentale tumulo etrusco di Via di Gello, a pisa, cenotafio dedicato a un “principe” del mare (il cui simbolo è un tridente: Bruni, 1998), suggerisce come il rapporto col mare fosse vitale per le popolazioni che all’inizio dell’età storica abitarono il territorio presso la foce dell’arno; e questo certamente presuppone precedenti esperienze e un probabile radicamento già verso la fine della protostoria.
Sulla costa laziale, tra nettuno e torre astura, in un sito scavato nel 2001 e nel 2002 (attema et al., 2003), sono stati recuperati circa 45000 frammenti ceramici, di cui oltre il 97% di età protostorica. La maggioranza appartiene a contenitori grandi o medi, di forma troncoconica e cilindro-ovoidale, mentre scarso è il vasellame da mensa; i tipi più diagnostici sono attribuiti al tardo Bronzo e al primo Ferro. alcuni frammenti di olle o dolii conservano sulla superficie interna tracce di “salt colours” (cioè colori prodotti dal contatto con acqua salata a temperature relativamente alte), che vanno dal bianco, al rosa, al grigio, al lavanda. molti pezzi di tufo, spesso bruciati e con superfici piatte forse lavorate, sono stati interpretati come possibili supporti per i contenitori durante l’ebollizione della salamoia. per le forme dei contenitori e per possibili attività diverse dalla produzione del sale, valgono le stesse osservazioni fatte per isola di coltano.
un recente riesame del materiale proveniente dagli scavi del castelliere di elleri (fra trieste e l’istria nord-occi-dentale), ha evidenziato la presenza di contenitori cerami-ci troncoconici e, più raramente, conici; addirittura nello strato 20, datato al Bronzo medio-recente, essi costitu-iscono “pressocché l’unico tipo di recipiente attestato” (cassola Guida, montagnari Kokely, 2006, p. 330). Le autrici di tale studio hanno dunque ipotizzato un’ampia attività di produzione ignigena del sale ricavato dall’acqua marina, considerando anche “caratteristiche geomorfolo-giche della costa, dati etnostorici, presenza relativamente alta di materiali esotici” e hanno indicato un possibile col-legamento con la pastorizia transumante.
infine, un caso particolare è quello di Vasche napole-tane (Foggia), un sito che nei livelli del Bronzo medio ha rivelato una serie di piattaforme circolari di battuto deli-mitate da strette e profonde canalette e con molte buche da pali (fig. 1); all’esterno vi sono focolari, avanzi di pasto e vasellame (tunzi Sisto, 1999). questi cerchi sono stati interpretati come aree coperte da una tettoia e destinate
294
Le peuplement de l’arc alpin
all’accumulo di grandi coni di sale, per favorirne la cristal-lizzazione completa e la separazione per deflusso dei sali di magnesio. il ritrovamento di “una singolare concentra-zione di fuseruole (o pesi per la pesca)” è un possibile indizio di quell’attività di pesca più volte ipotizzata per siti consimili.
il caso della piana di Foggia : sale e transumanza
recentemente alcuni studiosi francesi (cassen et al., 2004, pp. 26-27) hanno formulato un’ipotesi interpretativa di alcune strutture che caratterizzano una serie di insediamenti neolitici nel tavoliere di puglia. in particolare, a proposito del sito di masseria passo di corvo gli autori rilevano le seguenti caratteristiche, che dimostrerebbero l’existence de procédés artisanaux de fabrication du sel marin dans cette région d’Italie.
• Une distribution non aléatoire des enceintes, au contact de terrains appartenant à des systèmes lagunaires au cours du Néolithique ; • une volonté d’imperméabiliser des excavations pour la circulation, le stockage, le prélèvement de l’eau, bien au-delà, selon nous, de simples procédés de drainage pour assainir des unités d’habitations, mais en accord de principe avec l’idée d’une « décantation » des liquides émise par notre collègue pour certaines structures en creux, quadrangulaires ;• des fossés en C qui sont systématiquement orientés en fonction de la pente du terrain, c’est-à-dire ouverts en direction du sommet afin de conserver cette eau ou de la faire circuler sous l’effet de la gravité ;• Une typologie céramique de laquelle il ressort des fûts de récipients à la morphologie trop singulière pour ne pas rappeler des productions spécialisées, et en particulier celle du chauffage de la saumure par ce procédé bien connu qui met en œuvre [...] des contenants troncoconiques suspendus au-dessus du foyer [...] (cf. les moules à sel Vinca/c de la région de tuzla en bosnie-Herzégovine).
inoltre, sempre su masseria passo di corvo, gli autori osservano quanto segue.
• Les fossés de ceinture de ces « habitations » (phase IV a 1 bien datée vers 4500 av. J.-c.) contiennent un curieux mur de « contention », parfaitement jointoyé à l’argile, sur leur côté interne ou externe, pouvant être interrompu par un muret. L’auteur (tinè, 1983 : 46) émet l’hypothèse que ces murs ont eu pour fonction de maintenir les terres alentour, favoriser le drainage de l’eau de pluie, éviter ainsi le remblaiement des fossés ; des fossés qui ne peuvent être des palissades et qui, largement ouverts sur un côté, ne peuvent en aucune manière servir d’enceinte défensive, à la différence du grand fossé périphérique.• Des canaletti superficiali (petits canaux superficiels) sont décrits à la surface du secteur, dont la fonction encore une fois admise serait de drainer les eaux pluviales (tinè, 1983 : 48).• Un de ces canaux se jette dans une vasque quadrangulaire décrite comme devant participer à la décantation de l’eau dans un processus de conservation de l’argile (tinè, 1983 : 49), mais qui nous semble, mieux que cela, une organisation en tous points semblable à celle décrite par A. Jodlowski sur les sources salées
Figura 1. Vasche Napoletane (Foggia): sito del Bronzo Medio con strutture probabilmente collegabili alla produzione del sale (da Tunzi Sisto, 1999)
295
t. di Fraia — il sale come fattore trainante della produzione e degli scambi nelle zone interne nella preistoria italiana
de barycz VII (Pologne) (Jodlowski, 1977), datée d’une étape moyenne du Lengyel (4500-4300 av. J.-c.), ou les tranchées d’adduction/écoulement s’ouvrent aussi sur un angle des vasques, selon un type d’excavation peu profonde qui s’accorde par ailleurs étonnamment bien à la morphologie des fosses quadrangulaires décrite en Normandie « historique » pour déposer sur claire-voie les sablons récoltés et lavés à l’eau douce afin d’en récolter la saumure (buron, 1991: 13).• Un puits de plus de 6 m de profondeur et de 1 à 2 m de diamètre va chercher l’eau dans la nappe phréatique.
tali ipotesi interpretative cozzano tuttavia contro troppi ostacoli. anzitutto i fossati a ”c” quasi sempre inglobano strutture abitative, mentre sappiamo che generalmente le saline sono distinte dalle aree abitative, sia per ragioni funzionali (tanto delle saline, quanto degli abitati), sia per ragioni igienico-sanitarie, come abbiamo visto sopra. in secondo luogo non è vero che tali fossati generalmente siano impermeabili o impermeabilizzati, come sembrano suggerire cassen e colleghi, anzi perlopiù sono scavati in rocce permeabili senza nessun trattamento particolare delle loro superfici, tanto che tiné è arrivato ad ipotizzare per la verità senza nessuna prova archeologica che potessero servire non già per produrre, bensì per conservare il sale. inoltre questi fossati sono documentati in molti siti del tavoliere e in alcuni di essi in numero rilevante, pertanto è impossibile che siano stati tutti utilizzati per produrre sale. Se poi si ipotizza, come fanno cassen e colleghi, che tali fossati possano aver avuto diverse funzioni, tra cui quella di raccolta di acque salate, come si spiega il loro costante e stretto rapporto con strutture abitative? ci aspetteremmo semmai che, a seconda della loro (presunta) differente funzione, si trovino in posizioni diverse e in un diverso rapporto con gli altri elementi insediamentali.
Le strutture (canalette, vasche) di masseria passo di cor-vo che vengono comparate con quelle del sito polacco di Barycz presentano effettivamente delle somiglianze morfologiche notevoli, ma, pur nell’ambito di una comu-ne funzione di raccolta e/o decantazione di liquidi, sono comunque possibili interpretazioni diverse: esse potevano servire ad esempio per raccogliere semplicemente dell’ac-qua o per decantare l’argilla.
oltre a queste obiezioni, c’è poi un punto assoluta-mente cruciale. rispetto al lavaggio delle sabbie salate e al briquetage, nell’italia meridionale esistono metodi più semplici di produzione del sale, che possono sfrutta-
re l’evaporazione naturale dell’acqua marina in ambienti come quelli delle coste pugliesi e in particolare del tavo-liere, dove si ha una frequente formazione naturale di lagune e “piscine” costiere e un clima particolarmente caldo e arido (ancora oggi le più importanti saline marine si trovano in puglia, Sicilia e Sardegna); non è un caso se in nazioni a clima freddo-umido, come ad esempio l’inghil-terra, il sale marino è tuttora molto costoso. per queste ragioni geoclimatiche, il contesto pugliese non è com-parabile con territori a più alte latitudini, come il marais poitevin, ma anche, per limitarci all’italia, il Friuli-Venezia Giulia, dove la produzione del sale richiedeva procedure molto più complesse e dispendiose. anche i più recenti studi paleoambientali, come quelli della pubblicazione su masseria candelaro, poco distante da masseria passo di corvo (cassano, manfredini, 2005), mostrano che l’aridi-tà caratterizzò buona parte del neolitico nel tavoliere fog-giano, escludendo quindi che quelle popolazioni potesse-ro disporre di grandi quantità di acqua dolce necessarie per il “lavaggio” di sabbie salmastre ipotizzato da cassen e colleghi. infine, mentre si ipotizza un diffuso sistema di recupero di acque salate con successiva evaporazione tra-mite riscaldamento per combustione, manca qualunque indizio di briquetage (barre di refrattari, grandi accumuli di cenere e carboni, grandi quantità di contenitori molto frammentati e caratterizzati da particolari impasti, colo-ri e consistenza ecc.). quanto ai frammenti di vasi con fondo conicheggiante trovati a passo di corvo, dobbiamo osservare che si tratta di tre soli esemplari su migliaia di pezzi; avendo una forma molto particolare e rara, devono corrispondere a funzioni particolari o a un determinato gusto estetico. La rarità di tali vasi è però assolutamente incompatibile con una presunta produzione massiccia di sale, ed è certamente insostenibile l’ipotesi che altri even-tuali esemplari simili possano essere andati distrutti; infat-ti i fondi di tali recipienti sono particolarmente robusti e resistenti e dunque in uno scavo ampio ed accurato come quello di masseria passo di corvo se ne sarebbero dovuti trovare parecchi, se veramente nel sito fosse stata effet-tuata un’intensa attività di briquetage. per questo stesso motivo si può addirittura affermare che essi sono sovrasti-mati rispetto ad altri tipi di vasi e costituiscono quindi una categoria estremamente limitata.
il carattere abitativo di masseria passo di corvo non sembra contestabile (tutt’al più si può discuterne l’in-tensità e le forme precise), sia per quanto riguarda la presenza di una serie di strutture, sia per la composi-zione dei reperti, che comprendono un’ampia varietà di contenitori e altri tipi di manufatti ceramici, indu-
296
Le peuplement de l’arc alpin
stria litica, resti osteologici ecc. invece, come abbiamo visto sopra, nei due siti costieri italiani (isola di coltano e nettuno) in cui è stata riconosciuta la produzione del sale, troviamo: a) larga prevalenza di contenitori grossolani (di “impasto”) medio-grandi e raro vasella-me da mensa; b) quasi totale assenza di industria litica e di resti osteologici; c) presenza di barre di ceramica refrattaria (isola di coltano) o di pezzi di tufo bruciati (nettuno), chiari indizi non tanto di un vero briqueta-ge, quanto di forme particolari di sistemazione e utiliz-zazione di focolari.
Le precedenti considerazioni non escludono che la zona del tavoliere abbia avuto fin dall’età dei metalli, o forse anche prima, una rilevante importanza per la produzione del sale in rapporto al fenomeno della transumanza. anzi, ritengo che la transumanza degli ovini dalle valli dell’abruzzo e del molise fino alla piana di Foggia sia stato un fenomeno di grande portata economica e culturale e di lunghissima dura-ta, come sembrano indicare tra l’altro le affinità tra alcune facies pugliesi e la documentazione archeologica abruzzese (industria litica campignana, ceramica con decorazioni tipo Laterza) fin dall’età del rame (di Fraia, 2003, p. 277).
297
t. di Fraia — il sale come fattore trainante della produzione e degli scambi nelle zone interne nella preistoria italiana
Bibliographie
atteMa P., de haaS t., nijBoer B. (2003). the astura project, interim report of the 2001 and 2002 campaigns of the Groningen institute of archaeology along the coast between nettuno and torre astura (Lazio, italy). babesch, 78, pp. 107-140.
Bruni S. (1998). Pisa etrusca: anatomia di una città scomparsa. milano, Longanesi.
Buron G. (1991). de l’origine des marais salants guérandais. bulletin de la société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 126, pp. 9-62.
CaSSano S. M., Manfredini a., dir. (2005). Masseria candelaro. Vita quotidiana e mondo ideologico in un villaggio neolitico sul tavoliere. Foggia, Grenzi editore.
CaSSen S., de laBriffe P. a., Ménantau l. (2004). Sels de mer, sels de terre. indices et preuves de fabrication du sel sur le rivage de l’europe occidentale, du Ve au iii e millénaire. cuadernos de Arqueología, Universidad de Navarra, 12, pp. 9-49.
CaSSola Guida P., MontaGnari KoKely e. (2006). produzione di sale nel golfo di trieste : un’attività probabilmente antica. In : studi in onore di renato Peroni, Firenze, all’insegna del Giglio, pp. 327-332.
daire M.-y. (2003). Le sel des Gaulois. paris, errance.
delluC G., delluC B., roqueS M. (1997). L’apport des nutritionnistes à la compréhension des comportements alimentaires des Homo Sapiens. In: patou mathis m., otte m., dir., L’alimentation des hommes du Paléolithique. Approche pluridisciplinaire, Liège, université de Liège (erauL; 83), pp. 187-234.
di fraia t. (2003). il sito eneolitico di roccascalegna. In: Preistoria e protostoria dell’Abruzzo, XXXVI riunione scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, pp. 267-278.
di fraia t. (2006). produzione, circolazione e consumo del sale nella protostoria italiana: dati archeologici e ipotesi di lavoro. In: Materie prime e scambi nella preistoria italiana, XXXIX riunione scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, L’erma di Bretschneider, pp. 1639-1649.
di fraia t., SeColi l. (2002). il sito dell’età del bronzo di isola di coltano. In: Atti quinto incontro di studi di Preistoria e Protostoria in Etruria, milano, centro Studi di preistoria e archeologia, pp. 79-93.
eaton S. B. (1992). Humans, lipids and evolution. Lipids, 27(10), pp. 814-820.
jodloWSKi a. (1977). die Salzgewinnung auf polnischem Bodem in vorgeschichtlicher Zeit und im frühen mittelalter. Jahreschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, 61, pp. 85-103.
KoPaKa K., ChaniotaKiS n. (2003). Just taste additive? Bronze age salt from Zakros, crete. Oxford Journal of Archaeology, 22(1), pp. 53-66.
lane t., MorriS e. l., dir. (2001). A millennium of saltmaking: Prehistoric and romano-british salt Production in the Fenland. Sleaford, Heritage trust of Lincolnshire : Fenland management project committee, 525 p.
MaGGi r. (2004). L’eredità della preistoria e la costruzione del paesaggio. In: de marinis r. c., Spadea G., dir., I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo, milano, Skira.
298
Le peuplement de l’arc alpin
Pare C. (1999). Weights and weighting in Bronze age central europe. In: eliten in der Bronzezeit, ergebnisse zweier Kolloquien in mainz und athen, mains, Verlag des römisch-Germanischen Zentralmuseums (monographien; 43), pp. 421-514.
PaSquinuCCi M., MenChelli S. (1997). isola di coltano (coltano-pi). In: Zanini a., dir., Dal bronzo al ferro. Il II millennio a.c. nella toscana centro-occidentale, pisa, pacini editore, pp. 49-53.
PearCe M. (in corso di stampa). Hard cheese : dating the beginning of hard cheese production in italian prehistory. In : Hidden landscapes, Siena, 25-27 maggio 2007.
PearCe M., de Guio a. (1999). Between the mountains and the plains: an integrated metals production and circulation system in Later Bronze age north-eastern italy. In: della casa p., dir., Papers of the international colloquium PAEsE ’97 in Zurich, Bonn, dr. rudolf Habelt Gmbh, pp. 289-293.
ryder M. l. (1983). sheep & man. London, duckworth.
SyKeS B. (2001). the seven Daughters of Eve. new york/London, W. W. norton & company.
tiné S. (1983). Passo di corvo e la civiltà neolitica del tavoliere. Genova, SaGep.
tunzi SiSto a. M., Batoli f. (1999). Lo sfruttamento del sale a Vasche napoletane. In: tunzi Sisto a. m., dir., Ipogei della Daunia. Preistoria di un territorio, Foggia, Grenzi editore, pp. 134-136.
vaquer j. (2006). La diffusion de l’obsidienne sarde dans le néolithique de corse, du midi de la France et de catalogne (4500-3500 av. J.-c.). In: Materie prime e scambi nella preistoria italiana, XXXIX riunione scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, L’erma di Bretschneider, pp. 483-498.
Weller o. (1998). L’exploitation du sel: techniques et implications dans le néolithique européen. In: Atti XIII congresso UIsPP, Forlì, aBaco, vol. 3, pp. 281-287.
Weller o. (1999). une place pour le sel dans le néolithique alpin. in: della casa p., dir., Papers of the international colloquium PAEsE ’97 in Zurich, Bonn, dr. rudolf Habelt Gmbh, pp. 295-301.
Weller o. (2002a). aux origines de la production du sel en europe. Vestiges, fonctions et enjeux archéologiques. In: Weller o., dir., Archéologie du sel: techniques et sociétés, ia, aStK3, rahden, pp. 163-175.
Weller o. (2002b). the earliest rock salt exploitation in europe: a salt mountain in the Spanish neolithic. Antiquity, 76, pp. 317-318.