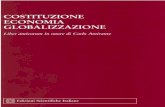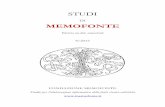S. Daris, Et Alexandriae Ego, in F. Crevatin (cur.), I luoghi della mediazione: Confini, scambi,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of S. Daris, Et Alexandriae Ego, in F. Crevatin (cur.), I luoghi della mediazione: Confini, scambi,...
SERGIO DARIS
&
Et Alexandriae Ego
est ratto da
l LUOGHI DELLA MEDIAZIONEConfini, scambi, saperia cura dl FRANco CREvKXIN
DEPUTAZIONE DI STORIA PAtRiA PER LA VENEZIA GIULIAFonti e Studi per la Storia della Venezia GiuliaSerie seconda: STUDI Vol. XVIII
Trieste 2009
SERGIO DARIS
Et Alexandriae Ego
Uno tra i più prestigiosi studiosi del mondo ellenistico (F.WI Wdbank),in una sede autorevole ( Zbr Camór/ói2? ,4/zf/e f /BffaT, Second edition,Vl1, 1, 1984) ed in una occasione di rilievo metodologico (Saz/rrri#or ZÉeper/oZ, p 10), richiamava gli storici, impegnati a ripensare e ad approfon-dire le testimonianze della tradizione letteraria, alla necessità di far ricorsoad altre categorie documentali. Le iscrizioni, ì papiri, gli ostrica, le mone-te, i resti materiali, le relazioni di scavo, correttamente utilizzati, diventanostrumenti di novità o di revisione delle conoscenze già acquisite.
A veder bene, nel caso della città di Alessandria e nella sterminatabibliografia ad essa relativa, anche di data recente', si dovrebbe concludereche l'appello non abbia avuto adeguata risposta e che l'approfondimen-to auspicato sia avvenuto in misura alquanto inferiore in rapporto allaeffettiva potenzialità delle informazioni almeno per quanto attiene allatradizione papiracea.
IJatteggiamento alquanto tiepido della ricerca in argomento, che, difatto, porta alla sottovalutazione anche di fonti disponibili da vecchiadata, viene giustificato -- come sovente si legge proprio dalla esiguità delmateriale papiraceo utilizzabile in prospettiva alessandrina.
Forse la ragione vera, ancorché incon6essata, potrebbe ritrovarsi altro-ve: affiora la sensazione che, ancor oggi deliberatamente non ci si sappiasottrarre agli eretti dell'onda lunga di una operazione straordinariamenteefficace come quella della propaganda dei Tolemei; una operazione media-tica diremmo noi oggi -- condotta su piani diversi, perfettamente con-vergenti nell'identico fine di conseguire unanime consenso al regime.
In questa prospettiva il contributo più recente si deve a MonAMMEO ABD-EL-GIANI,ALexandrìa andMìtUle fWpt: some mpects ofsocìal and economic contacts u7ìder Romanrz/Ze, in .4mrie/zr .,{&xamZrfa óebzuef/z ZÙZPf .znZ Greece, a cura di William VernonHARRIS e Giovanni RupplNI, Leiden-Boston, Bril1, 2004, pp. 161-178; per labibliografia precedente v. Sergio Dams, .4&is,z/zZrfa Z:fg/rra. w/z mifaP, in "Paideia"45 (1990), PP. 105-120.
51
Sergio Dans
Da un lato, nell'affermazione dell'ideologia monarchica, a livelloculturale-intellettualistico, l'immagine di Alessandria aveva non pocaparte; la sua celebrazione, affidata alla comunicazione letteraria, attraversola parola scritta ne assicurava la notorietà in ogni dove degli ambientidi lingua greca: tant'è che non esiste pagina della letteratura antica (edanche di quella moderna) relativa alla città che non mostri di rinnovarnele suggestioni.
Nel contempo, la studiata promozione della straordinaria realtà urba-nistica di Alessandria risultava essere uno strumento altrettanto efficace:
l'impatto era immediato e forte la sua capacità evocativa. Questa nonsembra venir meno neppure ai nostri giorni; bisogna riconoscere chenon ci lascia indiHerenti il recupero, oggigiorno in pieno progresso, daifondali marini del porto e dell'isola di Faro di obelischi, di colonne, dicapitelli, di sfìngi, di statue, crollate nelle acque sia per effetto di eventinaturali sia per la loro vetustà. Il gigantesco torso, di ben 17 tonnellate,della statua di un Tolemeo Faraone, da solo testimonia la cura progettualeriservata all'impianto urbanistico della città metropoli. Se volessimo esa-sperare questo sospetto al limite del paradosso, potremmo concludere cheneppure il progetto stesso e la costruzione della modernissima BibliotecaAlessandrina siano del tutto immuni dal fascino di un mito.
IJapprofondimento particolare dei testi su papiro non porterà dicerto a sensazionali stravolgimenti del quadro già noto per la città diAlessandria ma, indiscutibilmente, ci concede di allungare lo sguardo aldi là dell'immagine di facciata propria della strategia propagandistica diregime e di riappropriarci almeno di segmenti della vita in essa vissutanella sua concretezza, che le altre conti trascurano, condizionate da queglistereotipi, che hanno trovato fortuna e diffìisione attraverso i canali dellaletteratura.
E ciò, anche senza far parola del Fenomeno generalizzato della immi-grazione, individuale o collettiva, dai paesi esteri, che il miraggio egizianocontinuava ad alimentare con il sogno delle fortune prospettate dallametropoli, mèta di irresistibile attrattiva; di questi movimenti di personenulla ci è noto puntualmente per via documentaria, mentre tutto ci è per-messo ipotizzare, come suggeriscono le esperienze dei nostri giorni.
Il parallelo con le situazioni attuali non potrebbe essere più stringente.La prospettiva di Alessandria -- per dirla con un passo notissimo di Erode(1,26-35) che qui non si può non richiamare dove "tutte, si può dire,le cose che esistono e che si producono al mondo, si trovano in Egitto:ricchezza, sport, potere, cielo sereno, gloria, spettacoli, filosofi, oro, giovi-netti, il tempio degli dei fratelli, il re buono, il Museo, vino, tutti i beniche uno può desiderare, donne quante per Kore sposa dell'Ade -- non
52
Et Alexandriae Ego
si gloria di contenere scelli il cielo e nell'aspetto come le dee ..." (trad.Cataudella) --, che spinge gli abitanti dell'isola di Kos ad abbandonare lapropria patria, in che cosa è diversa dall'immagine dell'Italia televisiva cheseduce tanti a tentare la sorte tra noi?
Come è ben noto, voci dall'interno della città stessa -- cioè quelle piùpreziose per il recupero di almeno qualche momento di reale vita ales-sandrina -- che non siano quelle d'invenzione letteraria, non ne possiamorisentire alcuna; ad esse si sostituiscono, con il peso di testimonianza fon-damentale, le parole di quelle persone, in carne ed ossa, che hanno matu-rato una propria esperienza ad .Alessandria, più o meno fugacemente.
In questo caso però recuperiamo le precise parole e sorprendiamo ipensieri di una folla fatta di gente comune, dall'uomo della strada, dellamassa dei più che, estranei alla storia dei grandi eventi, sono stati trascinatinella metropoli dai casi più diversi della vita ed ai quali i papiri restituisco-no la propria viva personalità.
Alessandria -- come qualsiasi altra metropoli antica o moderna -- oKrìvamolto se non forse tutto alle speranze di chiunque avesse avuto intrapren-denza e personale capacità di iniziativa all'interno di un contesto socio-economico, complesso nei suoi ingranaggi ma ricco di speranze; c'è dacredere però che soltanto una minoranza trascurabile di individui fossein grado di approfittare di condizioni tanto favorevoli; nel contempo, èipotesi da escludere invece che questa categoria di persone di successo fosserappresentata da un numero considerevole di individui inurbatisi e non diorigini metropolitane. A giocare le proprie carte nella grande città eranoi ceti più bassi degli abitanti della provincia, per lo più legati alle attivitàagricole, forse senza nessun disegno preciso ma fermamente intenzionatia sfuggire alla vita faticosa e stentata della campagna: un trasferimentodi una forza lavoro non qualificata che non poteva non essere visto conpreoccupazione dalle autorità, sia per le ricadute di ordine sociale sia perquelle, ancor più pesanti, di natura economica. Di qui i provvedimentimirati al contenimento del fenomeno, riproposti via via nel tempo, sia daparte dei Tolemei sia dagli amministratori romani.
l bisogni ineliminabili per assicurare ad Alessandria il ruolo di capitalericadevano puntualmente sulla collettività dell'intero paese; il singolo cit-tadino, quanto meno godeva dei vantaggi della metropoli, tanto più insop-portabile riteneva questo gravame e lo viveva con giustificato disagio.
Che la dimensione della città comportasse costi non trascurabili perl'economia dell'Egitto e si proponesse come argomento di vigile preoc-cupazione per l'autorità centrale, ci appare documentato da una deliberaprobabilmente dell'anno 50 a.C. (BGU VILI 1730= C.Ord.Pto1. 73). Inquesto tempo di gravi difficoltà, la produzione cerealicola del Medio Egitto
53
Sergio [)aris
era riservata all'esclusivo approvvigionamento alimentare di Alessandria;l'attuazione del prowedimento, che invitava persino alla delazione, eraaffidata alla severità di sanzioni che prevedevano la pena di morte dacomminare ai trasgrcsson.
Nella medesima linea di subordinazione del paese alle esigenze della capi-tale, non poteva suonare molto gradita l'esplicita ammissione della dipen-denza economica di Alessandria dalla produttività agricola del resto del terri-torio; ne fanno espressa parola proprio gli editti di espulsione dei provincialiche prevedevano come unica eccezione possibile quella degli individui rite-nuti utili o addirittura indispensabili per l'economia cittadina.
In questo quadro si colloca pure il fenomeno del reclutamento dellaforza-lavoro, attraverso la prassi della requisizione di persone e di mezzi.Ogniqualvolta il programma urbanistico per lo sviluppo e l'abbellimentodella città lo richiedeva (di KÓapog Tflg hapnpotdTrl$ 1tÓXEo$ già si parlaal tempo di Marco Aurelio, prima del furore edificatorio di Diocleziano,PHarris Il 197, a. 169/176 d.C.), l'onere della sua effettiva realizzazioneera scaricato sulle singole località, chiamate a contribuirvi con uomini ocon tributi sulla base di una quota loro imposta. E difRcile stabilire sinoa che punto la formazione di simili unità lavorative coincidesse con unaopzione spontanea da parte dei lavoratori, perlopiù artigiani specializza-ti, anche perché i termini dei contratti fatti stipulare (e a noi pervenuti)hanno tali aspetti vincolanti che poco hanno a spartire con una decisioneautonoma, libera da effettivi condizionamenti. Lo constatiamo in PSI Tll162, dell'anno 286 d.C., nel quale un costruttore edile, un o'tKoÒÓpog,originario da un villaggio dell'Ossirinchite, si impegna con un giuramen-to, davanti allo stratego, di "recarsi nella splendidissima Alessandria e difermarsi nelle terme colà in costruzione, per svolgervi le medesime attivitàedili per tutto il tempo stabilito e di non allontanarsene prima di esserestato liberato dall'impegno per non subire riprensione alcuna o essereassoggettato alle conseguenze del giuramento." A conclusione dell'atto,l'artigiano si vede costretto a presentare la garanzia di una persona, garan-tita, a sua volta, da altri.
A riprova che si trattava di una procedura ben istituzionalizzata, anco-ra nell'anno 331 d. C., in un territorio tanto decentrato dell'Alto Egittocome l'oasi di Dakhla, avviene di registrare la riscossione di una tassa peril trasporto di statue da spedire ad Alessandria, il q)ópetpov ùvòpctdvTmvùnoa'ceXhoFévmv e'lS' AÀ.8qdvòp81av (PKellis 29), che, qualunque ne sial'esatta interpretazione, la dice lunga sul peso economico esercitato dallacapitale sul resto del paese.
Fatto salvo il caso dell'esercizio di pubbliche funzioni, connesse, inparticolare, con il rifornimento di vettovaglie e dei più disparati prodotti
54
Et Aiexandriae Ego
di largo consumo (dai cereali ai tessuti) o delle delibere autoritative deifìinzionari centrali, ben di rado ci è dato di conoscere le precise ragioni cheinducevano le persone a mettersi in cammino, o meglio in acqua, alla voltadi Alessandria. Ancor più raramente awiene però che l'esperienza direttaed il contatto personale con la città suggeriscano ai viaggiatori che, perquanto assorbiti dalla cura dei loro acari, erano pur sempre i più esposti alleseduzioni della grande città -- un qualche interesse, se non si voglia parlaredi ammirazione o di emozione per lo spettacolo da essa oberto. Sono statid'animo o sentimenti che cercheremmo invano nelle centinaia di lettere
spedite dalla capitale. 1; idealizzazione dei letterati è mille miglia lontana.Comunque sono sempre istanze di carattere pratico e contingente a
mettere sulla via della capitale. Per chi intende affrontarlo, il progettodel viaggio non sembra mai aprirsi a prospettive gradevoli; se ne vedonopiuttosto i rischi ed è per questo che, assai frequentemente, non appenaraggiunta Alessandria, i viaggiatori si affrettano a comunicare il buon esitodella loro awentura per sgombrare le preoccupazioni di chi è rimasto acasa (per tutta questa casistica v. SB XIV 1 1645, sec. Il d.C.). Con tantomaggior sollievo e sollecitudine poi, non indugiano a dar notizia favore-vole degli acari trattati da essi e l'avvenuta conclusione delle commissioniabitualmente loro affidate.
Non di rado si fanno strada problemi pratici, connessi con l'inurba-mento anche se prowisorio: la solitudine assai spesso si €a sentire con unapressione angosciante, soprattutto quando nella folla degli abitanti riescearduo, se non impossibile, ritrovare le persone conosciute sulle quali faraffidamento in quanto le sole in grado di fornire un aiuto prezioso nelritmo convulso della metropoli.
Non è detto poi che la dinamica e ricca Alessandria mettesse sempre adisposizione di ogni categoria di abitanti tutti i beni disponibili; talora èlamentata la carenza anche di generi di prima necessità alla portata delletasche del cittadino medio; tanto meno i quattrini sono sufficienti per chiviene da fuori: non resta perciò che ricorrere alla disponibilità di quantisono rimasti a casa, in provincia, ai quali si fa appello con insistenti richie-ste di sostegno economico.
Il ruolo di Alessandria quale sede dell'autorità centrale, costringeva gliabitanti di ogni sito del paese ad un contatto diretto con i funzionari e
con gli uffici pubblici di ogni ordine e grado; i disagi che ne conseguivanosono facilmente immaginabili; ragion di più per concludere che l'atteggia-mento psicologico delle persone coinvolte, già naturalmente sfavorevolenei confronti della capitale, ne risultasse radicalizzato.
La durata richiesta dalla trattazione di una qualsivoglia pratica pri-VRta negli uffici della capitale ed, ancor più, le convocazioni d'autorità,
55
Sergio Dans
a[[e quali era diffìci]e sottrarsi, conferivano a] soggiorno in Alessandria i]carattere di un vero e proprio soggiorno coatto, sul quale gravava l'ombraindecifrabile delle lungaggini burocratiche. Per l'interessato, i risvolti nonpotevano che essere comunque negativi
A cominciare dall'interruzione stessa delle abituali occupazioni lavo-rative di ciascuno. Una sosta forzata di questa natura compromettevasoprattutto le attività agricole, e la ridotta produttività dei terreni espo-neva a grave rischio la stessa capacità contributiva del singolo indivi-duo. l;argomento non era del tutto trascurabile agli occhi dell'autorità,se -- secondo le parole della Z,effexa di Aristea (cap. 1 10) Tolemeo VIFi[ometore, a]]a metà de] seco]o ]] a.C., decise di intervenire a] proposito.Infatti con l'esplicito divieto ai non residenti di soggiornare in città perpiù di venti giorni e, nel contempo, con l'obbligo ai pubblici funzionaridi concludere le pratiche giudiziarie nell'arco di cinque giorni, il sovrano
oltre che tener d'occhio l'ordine pubblico in una città non facilmentecontrollabile -- mirava a porre un freno al fallimento del centralismoamministrativo ed a €ar apparire il provvedimento come una graziosissi-ma concessione a vantaggio generale. Tutta la documentazione successivalascia credere che la decisione del sovrano non abbia avuto alcun seguito;la sola strada praticabile -- in quanto abitualmente tollerata dalla prassiper i molti che continuavano nel tentativo di owiare alla iattura del viag-gio, rimase il ricorso all'artificio della delega ad un rappresentante.
La formulazione di PMerton 18 (a. 161 d.C.) non potrebbe illuminaremeglio la situazione. "Poiché le parti che sottoscrivono l'accordo non sonoin grado, a] momento presente di navigare alla volta di Alessandria, inquanto ora si awicina il raccolto ed a causa di altri impegni che riguarda-no le rendite, esse nominano come loro rappresentante, con questo atto,il predetto Sarapion, che navigherà alla volta di Alessandria e si presenteràall'illustrissimo Prefetto Volusio Meciano oppure a qualunque altro giudi-ce che egli ritenga idoneo" (righe 18-31).
Non è detto però che giustificazioni di questo tipo, anche se ben circo-stanziate, incontrassero negli uffici accoglimento automatico e tanto menoimmediato, come si ricava da SB IV 7367 (a. 1 36 d.C.), una richiesta fattapervenire all'ufficio alessandrino del ZIÉ /aziz?s. l;estensore del documen-to, convocato dal funzionario nella capitale, chiede che il proprio caso siadiscusso in tempi brevi allo scopo che "possa ritornare indietro ed occu-parmi del raccolto per il pagamento delle tasse statali" (righe 20-28). Eglisoggiorna ad Alessandria già dal 16 aprile ma noi sappiamo che solamenteil giorno 26 maggio, cioè una quarantina di giorni dopo, l'ufficio decidedi prendere in considerazione la sua domanda e ne annota l'avvenutaregistrazione.
56
Et Alexandriae Ego
Che la scarsa speditezza nel disbrigo delle pratiche da parte degli ufficialessandrini apparisse, agli occhi dei cittadini rassegnati, prassi del tuttonormale e che la loro preoccupazione per la lentezza della procedurapiù che legittima, risulta da una decisione di tipo istituzionale presa inPFuad 24 (c.a. 144 d.C.). L'ufRcio dell'4rcó/ZZ,è,direi, in via preliminare,aveva obbligato il promotore della controversia in corso ad una sosta di30 giorni nella capitale, in attesa della controparte; ma, alla scadenza deitermini fissati, ancora una volta, l'assenza dei testi, inutilmente convocati,ne impedisce l'escussione ed al querelante non resta che richiedere unanuova fissazione del dibattito, almeno però in un momento successivo alleoperazioni del raccolto.
Eventi imprevisti contribuiscono talora ad allungare i tempi, già gene-rosamente dilatati dal calendario della burocrazia alessandrina.
Poteva accadere che un ufficio sospendesse le relazioni con il pubbliconell'attesa, sempre dai tempi incerti, del nuovo funzionario responsabile.Un contrattempo inaspettato che non induce a migliori speranze per l'im-mediato futuro. "Voglio che voi sappiate scrive l'interessato nella sualettera -- che da quando ho navigato alla volta di Alessandria, ho trovato,per la maggior parte giornate nelle quali non si conclude alcun affare e,sino ad oggi mi hanno tirato per le lunghe, per quanto riguarda il proces-so. È capitato anche che se ne sia andato 1 2zrró/z&É.zi/?i di prima e siamo inattesa di quello che deve venire. Appena sarà portato qua, spero in dio, infretta me ne verrò via" (PMich. VIllI 493 righe 4-15, sec. Il d.C.).
È assai probabile che, solamente nella prospettiva di azzardare qualcheprevisione circa i tempi necessari all'espletamento dei propri affari, vienedato spazio ad una delle rarissime notizie di cronaca cittadina. Sembra dicapire infatti che per l'autore di una lettera non sia stato motivo di gran-de emozione una cerimonia ufficiale, di per sé di non poco conto, comequella dell'insediamento ad Alessandria del nuovo Prefetto; l'awenimentoappare favorevolmente registrato da chi scrive solo in quanto lo fa benesperare circa una rapida ripresa del fìinzionamento dell'ufficio dal qualeera discusso il proprio caso (PSI Xl1 1241, a. 159 d.C.).
Altre volte il rinvio della trattazione delle questioni ad Alessandria,dipende dagli impegni specifici del Prefetto, regolarmente chiamato alasciare la sede istituzionale di Alessandria, anche per periodi non brevi,per il compito di amministrare la giustizia in altre località del paese.
Ma anche quando egli si trova nella capitale, i contatti diretti con ilmassimo funzionario romano non sono tra i più agevoli. [)i qui le lamen-tele per risposte mai ricevute per iscritto a domande pur correttamentepresentate. E la situazione esperimentata da un certo Kephalìon il qualeinforma il proprio corrispondente Heraklas che il loro caso ancora non era
57
Sergio Dans
stato neppure sottoposto all'attenzione del Precetto; egli scrive: 'Arrivatoad Alessandria ho presentato i documenti al signor Prefetto e fino a questomomento non me li ha sottoscritti" (Roxy. XXXI 2597.3-8, sec. lll/IVd.C.). [)e] pari veniamo a conoscere quanto faticosi fossero stati i tenta-tivi da parte di alcune persone di ottenere un approccio informale conil Precetto; poteva capitare -- e l'esito era da considerarsi fortunato chel'obiettivo fosse raggiunto soltanto dopo una serie di insuccessi, vuoi acausa della festività del giovedì che, nel caso al quale si fa riferimento,cadeva alla data cruciale del 29 dicembre -- o per gli impegni istituzionalied improrogabili del funzionario (POW. XXII 2343= SB XVIII 13932,a. 287 d.C.).
Il protrarsi, per tempi non previsti, dell'indesiderato soggiorno incittà non comportava soltanto il danno immediato e assai pesante dellespese vive; non di rado le conseguenze dell'assenza prolungata dal propriodomicilio facevano registrare guai di ogni genere. Tra questi, non sono davalutare come i peggiori quelli patiti dai beni e dalle proprietà forzatamen-te trascurati durante la lontananza.
Così il proprietario di un fondo, dopo un soggiorno ad Alessandria,si vede costretto a denunciare alle guardie del proprio villaggio il furto ditrenta alberi di tamerisco, venti del valore di tre dramme ciascuno e diecidi due (SB XVI 12823, a. 215 a.C.); identica è la motivazione dell'espo-sto di una persona alla quale, in conseguenza dell'eKrazione di un localedestinato al deposito di cereali, è stata sottratta una certa quantità di grano(lìLouvre 1 3= SB 1 6; BGU 1 321-322, a. 216 d.C.).
In questa casistica non tanto infrequente, si colloca la vicenda, ai nostriocchi paradossale -- sempre che di paradossale sia lecito parlare nei mec-canismi messi in moto dall'apparato della burocrazia statale --, che spingeun agricoltore a chiedere giustizia direttamente al sovrano (Rent. 55, a.222 a.C.). Egli, costretto a presentarsi ad Alessandria per un processo, siera trovato nella impossibilità di lasciare nel suo paese qualcuno a tuteladei propri interessi; ma nei tempi lunghi della causa, la medesima ammi-nistrazione statale, incurante dell'obbligo a lui da essa stessa imposto ditrattenersi ad Alessandria, non aveva avuto esitazioni ad affittare metàdell'appezzamento del suo Fondo ad altri che, a loro volta, si erano affret-tati ad occuparne anche la restante metà.
Da quanto detto sin qui -- cioè da questa somma di esperienze realipoco favorevoli --, apparirebbe del tutto fuori luogo, richiedere alle testi-monianze di questa categoria di viaggiatori forzati ad Alessandria, unadisposizione d'animo svincolata dalle questioni personali e dalle preoccu-pazioni che li assillavano. Significativo appare perciò l'atteggiamento diindiHerenza nei confronti della realtà cittadina, soprattutto nelle persone
58
Et Alexandriae Ego
sgombre da simili comprensibili pressioni psicologiche. Neppure questeregistrano notazione alcuna di ordine emozionale.
L'esperienza di una città "che supera tutte per grandezza e per prosperi-tà" per dirla con le parole della Zea?ra di Aristea (cap. 1 09), z,rr/rx om/z/zzmciz,i/afzzm secondo Ammiano Marcellino (XXII,1 2,7) e la visione del suostraordinario apparato urbano, non sembrano aver mai strappato l'uomodella strada dai propri pensieri: in questi non c'è traccia dell'entusiasmo,proclamato a chiare lettere dagli scrittori, che, in qualche misura, facciabreccia nel disinteresse dei più. IJunica eccezione a t&nta indifferenza,ricorre in una lettera, di epoca tarda (SB XXIV 16164, sec. VI d.C.): èsollecitata da un calamitoso evento naturale che vede i magazzini di unintero quartiere della città, quello di Neapolis, invasi dalle acque; lo scri-vente non si trattiene dall'esclamare "è uno spettacolo nuovo oggi vedereAlessandria
Degna di nota è la diversità di prospettiva secondo la quale le nostreconti inquadrano due tra i più famosi luoghi della città, il ginnasio ed ilSerapeo.
Strabone nella sua visita ad .Nessandria, nell'ultimo ventennio del l sec.
a.C., ha parole di particolare apprezzamento (XVII,l,lO) per la strutturadel ginnasio più importante di .Alessandria, il ginnasio per antonomasia."Per farla breve -- egli scrive -- la città è piena di monumenti dedicatorie di templi; ma il più bello è il ginnasio che ha, al centro, un porticatolungo più di uno stadio, nonchè il tribunale ed i boschetti." IJimponenzadi questo complesso, quale ne sia stata l'esatta disposizione sul terreno, èfuori discussione; suscitava meraviglia la maestosa grandiosità del portico,che, quanto a lunghezza, superava i 180 metri di uno stadio il più estesotra quelli dei ginnasi sinora conosciuti nel mondo classico. Non stupisceperciò che l'edificio abbia costituito un punto di riferimento nell'impiantourbanistico e che abbia offerto lo scenario ad eventi cruciali nella storiadella città, sui quali le fonti letterarie si soffermano con abbondanza diparticolari.
Di tutto questo invece non resta traccia nelle testimonianze papiracee;eppure il luogo era stato da sempre uno dei punti nodali della vita pubbli-ca. Basterebbe ricordare che nel porticato dell'.4a'/zzm À/rzlg7zz/m, ali'internodel complesso ginnasiale, erano esposti, per la dovuta pubblicizzazione e adisposizione generale, gli strumenti legislativi ed i provvedimenti emanatidalle autorità; di qui derivano le copie, ricavate personalmente dagli inte-ressati, della documentazione utile al proprio caso, quelle che ancora oggileggiamo e nelle quali sole ricorre la menzione di questo celebre edificio.
Emblematica al proposito è una lettera, spedita da Alessandria adOssirinco (ROW. VILI 1 155, a. 104 d.C.); l'autore informa il proprio cor-
59
Sergio Dans
rispondente con queste parole: "Voglio che tu sappia che, appena arrivatoad Alessandria, immediatamente mi sono occupato della faccenda che tumi hai domandato ... ti ho spedito la delibera stessa del Prefetto perchètu [i dia da fare per quanto ti riguarda". l termini della comunicazioneed i tempi rapidi nell'assolvimento dell'incarico, non lasciano dubbi sullacircostanza che lo scrivente abbia ricavato copia del provvedimento prefet-tizio affisso alle pareti del ginnasio.
Infatti le pochissime menzioni esplicite della a'tod tot) 'upvaatoue dell'.dazi/m malgpzam, si riconnettono esclusivamente ad operazioni diquesto tipo. Così sappiamo che le risposte date dall'imperatore SettimioSevero ai quesiti a lui sottoposti, erano state affisse appunto nel porti-cato del ginnasio, che decisioni del Prefetto erano disponibili itpòq tòtfÌ'coupé;vQ ltuÀ,óvt 'tob 'uFvaatou, che la iaózlZz .z/ó/.prc@siio/zz/m, con ledichiarazioni di nascita dei cittadini romani, era a disposizione del pub-blico nell'-4rriz/m À7zzlgmz/m. Ma nulla di più. Anzi: tanto era noto il luogoriservato abitualmente alla esposizione pubblica di questi materiali che,perlopiù, se ne dà una indicazione generica bv Ah€1iuvòpetq
Il silenzio della documentazione papiracea relativamente al Serapeo diAlessandria è pressoché totale.
Era questo il tempio più famoso della città, celebrato per la magnifi-cenza delle sue strutture e centro della vita religiosa, simbolo stesso delpaganesimo agli occhi dei Cristiani. Il culto era attivamente esercitato nelsantuario e la visita al luogo santo costituiva un impegno al quale nessunointendeva sottrarsi, per quanto breve fosse il soggiorno in città: anzi loscrupolo religioso li induceva ad attuare, non appena possibile, la visita alsantuario ed ad assolvere l'atto di devozione
La sola notizia di un qualche respiro concernente il Serapeo alessan-drino ci parla proprio in questo senso (lìBrem. 48, a. 1 18 d.C.). Un certoErode, arrivato di fresco ad Alessandria dopo un viaggio tormentato, rife-risce al proprio corrispondente di essere riuscito a portare a termine alcuniaffari; l'urgenza della trattativa non gli ha Catto dimenticare gli obblighireligiosi, come esplicitamente egli dichiara in conclusione di lettera:Prima di tutto, domani farò il mio atto di adorazione per te nel Serapeo,
perchè oggi non vi sono salito, a causa di gravi fastidi e di pericoli" (righe29-32). 1Jaccenno è all'atto del proiÉ7nrma, con il quale lo scrivente affi-dava alla protezione della divinità le persone a lui care. Lespressione, chericorre nella formula stereotipata, 7tpoaKÓvìjpa hole'lv 7tapd TQ KuplQ2apdntòt in moltissime lettere private, costituisce -- secondo la dottrinacorrente prova certa della loro redazione ad Alessandria.
Naturalmente non erano solo i rapporti diretti con gli unici pubblicio i problemi di natura giudiziaria ad imporre alle persone gli spostamenti
60
Et Alexandriae Ego
dalla provincia alla capitale; è naturale supporre che vi avesse buona partel'intero ventaglio degli affari personali. In concreto però, assai raramenteavviene di accertare le motivazioni che sollecitavano i viaggi non di strettocarattere pratico -- turistiche, culturali, di divertimento, significativamenterichiamate anche nell'editto di Caracalla (RGiessen 1 40 Il.24-26); unasola, nella aKollata categoria delle lettere private, Roxy. 1 1 19 (sec. Il/llld.C.), ci rivela apertamente l'entusiasmo di un figlio che esercita pressionisul proprio padre per essere condotto ad Alessandria, luogo vagheggiatoper le sue molteplici attrattive.
(cuando gli spostamenti di una persona dal proprio domicilio inprovincia ad Alessandria comportavano un soggiorno di lunga durata incittà, ]o Stato non intendeva rinunciare a] contro]]o de] flusso migratoriointerno. La stessa dimensione demografica della capitale poneva delicatiproblemi ai quali si intendeva far fronte con una normativa adeguata econ un monitoraggio dell'inurbamento in Alessandria. Le misure mira-vano al duplice scopo di assicurare l'ordine pubblico -- si ricordi ancorala cacciata dalla città della massa potenzialmeiìte pericolosa dci contadiniegizi, prevista sempre dalla decisione di Caracalla (RGiessen 1 40 Il. 1 6-29;cfr. Erodiano, IV19,4) -- e a quello di mantenere inalterata la regolarità delgettito fiscale, eventualmente compromesso dagli spostamenti incontrol-lati delle persone e dall'abbandono dei lavori agricoli.
Precise disposizioni prefettizie 7tepì lòv bn' AÀ,eqav8pelaq òLaTpll3óv-Tmv stabilivano che ogni individuo, soggetto a tassazione, provvisoria-mente presente ne]]a capitale, era sempre tenuto a] pagamento dei tributinel domicilio fiscale del luogo di provenienza (Roxy. XXXVI 2756, a.78/79 d.C.). Questa situazione di un cittadino di Ossirinco che, purtrovandosi momentaneamente ad Alessandria, continuava ad essere iscrit-to nei ruoli dei contribuenti del proprio domicilio abituale, prova che,almeno in questa circostanza, i provvedimenti presi avevano raggiuntolo scopo; per assicurare il controllo efRcace di costoro ci si affidava adisposizioni specifiche che obbligavano quanti non avessero il domicilioin città a giustificare adeguatamente la loro presenza: solamente a seguìtodell'assolvimento di un tale obbligo, si vedevano rilasciare un regolarepermesso di soggiorno (editto di Vicio Massimo de]]'anno ] 04, RLond.111 904= WIChr. 220).
Ma forse non si è lontani dal vero nell'ipotizzare che il caso appenaricordato dal papiro ossirinchita abbia rappresentato l'eccezione e che glieditti prefettizi in argomento fossero destinati a cadere nel nulla, nella real-tà concreta. Quale luogo infatti, avrebbe potuto ordre occasioni più favo-revoli della città di Alessandria, aHollatissima megalopoli, all'interno dellaquale era problematico -- come leggiamo in molti documenti -- rintracciare
61
Sergio Dans
persino chi non si nascondeva di proposito, a quanti fossero intenzionatia sottrarsi ai doveri del vivere collettivo e trovare rifugio all'interno di unamassa di individui, che incontrollabile nel numero, ne avrebbe garantital'impunità? Gli esempi di simili comportamenti non mancano; ma lafuga per sfuggire alle possibili rivendicazioni dello Stato non significava diper sé certezze di una vita facile; al contrario c'è da credere che, a questopunto, scattasse la spirale di una dura realtà quotidiana e di una lottaper la sopravvivenza, nel cuore della capitale, che non concedeva di certoall'uomo della strada momenti per abbandoni contemplativi.
62