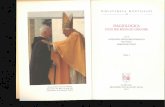La fonte e i rivolei. Dalle metafore letterarie alla storia sociale del sapere, in Saperi a...
Transcript of La fonte e i rivolei. Dalle metafore letterarie alla storia sociale del sapere, in Saperi a...
Indice
Introduzione:La fonte ed i rivoli, dalle metafore letterarie alla storia sociale del sapereMaria Pia Paoli ix
Prima sessione. luoghi, figure e usi del sapere: non solo scuole
Education and Society in Tuscany from the 13th to the 15th CenturyRobert Black 3
Lettere, libri e testi ad hoc per la formazione delle élites: uno studio di casi fra Quattrocento e SettecentoMonica Ferrari 27
Skill and Commonwealth in Early Modern English Cities Philip Withington 57
Offerta e domanda di istruzione: processi di alfabetizzazione a confronto Marina Roggero 83
Il mercante filosofo nell’Olanda di fine Seicento: una formazione ‘senza canone’Camilla Hermanin 103
Tra erudizione e politica: biblioteche a Venezia nel Settecento Antonella Barzazi 117
Au-delà du collège: un nouveau rôle pédagogique pour le vernaculaire dans les projets d’académies pour la noblesse (France, 1577-1640)Andrea Bruschi 137
Seconda sessione. saperi in movimento
Compétence internationale, émergence d’une ‘profession’ et circulation des savoirs: le tuteur aristocratique dans l’Angleterre du XVIIe siècleJean Boutier 151
Precettori e allievi nel Settecento: la circolazione dei saperi in Italia e in EuropaPatrizia Delpiano 181
Comici dell’arte e ‘musici di fortuna’. Le compagnie itineranti e la trasformazione dei testi teatrali Nicola Michelassi 197
Professional Missionary and Orientalist Curator; Paulinus a S. Bartholomaeo in India and Rome (18th-19th Century)Ines G. Županov 205
Terza sessione. saperi eccentrici, saperi antichi, saperi nuovi
A proposito di ‘saperi alternativi’: la propaganda del Cinquecento tra opuscoli, fogli volanti e altri ephemera Chiara Lastraioli 225
Teologia ‘vissuta’, teologia professata tra Medioevo ed Età modernaSimona Negruzzo 241
Una professione al servizio della Restaurazione cattolica: teologia e teologi ‘romani’ tra Cinque e Seicento Paolo Broggio 265
Un sapere ‘eccentrico’: la cultura dell’entusiasmo nell’Inghilterra di metà Seicento Dario Pfanner 295
Fra diritto comune e pratiche del diritto: i saperi dei giuristi nella Spagna del Seicento, saperi nuovi?Paola Volpini 311
Un sapere giuridico nuovo: aspetti della cultura costituzionale nell’Italia del Settecento Antonio Trampus 331
Il matematico nel Cinquecento. Il caso franceseGiovanna Cifoletti 353
Il sapere ciarlatanesco. Ciarlatani, «fogli volanti» e medicina nell’Italia moderna David Gentilcore 375
(Re)naissance de l’obstétricien/ne: une nouvelle ‘profession’ dans l’Europe des Lumières? Exemple de deux régions habsbourgeoises: la Toscane et la Bohême (ca. 1750-1820)Daniela Tinková 395
La prassi dell’educazione pratica. Studenti uomini e apprendiste donne nella clinica ostetrica dell’Università di Gottinga, 1792-1815Jürgen Schlumbohm 413
Musicisti, musica e diletto in Europa tra Sei e Settecento: un sapere familiare?Antonella Bartoloni 465
I loci communes della musica rinascimentale: sintagmi di un sapere metaforologicoStefano Lorenzetti 481
Saperi di saperi: una postfazione con interrogativiEgle Becchi 503
Indice dei nomi 511
Illustrazioni 533
Introduzione. La fonte ed i rivoli, dalle metafore letterarie alla storia sociale del sapere
Una fonte di schietto vino del Reno fu quella che nel giugno 1533 sgorgò a Londra dal finto monte Elicona eretto sullo sfondo ispirato al disegno di Hans Holbein il giovane, raffigurante Apollo protetto da un baldacchino e circondato dalle nove Muse. L’allestimento effimero di cui estatici testimoni oculari riportavano i particolari si collegava alle feste organizzate in occasione dell’incoronazione della nuova mo-glie del re Enrico VIII, Anna Bolena. Artefici della suggestiva inven-zione furono i rappresentanti della comunità dei mercanti tedeschi a Londra1.
Non casualmente il disegno di Holbein, con i suoi colori appena accennati, quasi evanescenti, è stato scelto ad emblema di questo convegno sui saperi a confronto, delineati in alcune loro diramazioni, eccentricità e somiglianze; ne emerge un quadro ampio, ma non certo esaustivo, tratteggiato, proprio come l’Apollo fra le Muse di Holbein. Diversamente, infatti, dalle altre pitture dell’artista di Augsburg, cele-bre per il dettaglio della sua ritrattistica, questo disegno evoca molto bene l’astrazione dei personaggi mitici cui è demandato il compito di rendere la complessità del sapere, della sua origine e diffusione, dalla fonte ai rivoli, verso il mare della conoscenza, secondo metafore lette-rarie ricorrenti e ispirate ai testi biblici�.
1 In generale cfr. R.N. Wornum, Some account of the life and works of Hans Hol-bein, painter of Augsburg, London, Chapman and Hall 1867 e Holbein and the Court of Henry VIII, London, H.M. the Queen of the United Kingdom 1978.
� La simbologia dell’acqua come fons sapientiae si ritrova anche in molte imprese del Cinque-Seicento: cfr. A. Henkel, A. Schöne, Emblemata Handbuch zur sinnibild-kunst des XVI und XVII Jahrhunderts, Stuttgart, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhanlung 1967, p. 108 e Mondo simbolico formato d’imprese scelte spiegate ed illustrate con sentenze ed erudizioni sacre e profane…, studiosi diporti dell’abbate Filippo Piccinelli…, In Milano, Nella Stampa di Francesco Vipara, 1669, p. 106; cfr. in generale J-M Chatelain, Livres d’emblèmes et devise. Une antologie (1531-1735), Paris, Kliencksieck 1993.
� Introduzione
Mentre a bassorilievi e codici miniati dei secoli XIV-XV era affidata la rappresentazione del lavoro artigiano e agricolo, di quei mestieri umili fissati nell’atto concreto del loro svolgersi, non si rinunciava a rendere visivamente l’origine e la gerarchia del sapere dotto, come appare dalle raffigurazioni dell’arbor scientiae di Raymond Lull3 o dalla stampa contenuta nel libro dell’erudito olandese Johan Meurss, Athe-nae Bathavae (Leiden 16�5)�; la festosa messa in scena dell’inaugura-zione dell’anno accademico nella giovane Università di Leida, di cui Meurss fa la storia, è affidata all’immagine di un’imbarcazione con a bordo le Muse accompagnate da Nettuno e Apollo, seguita da una processione di personaggi in abiti coevi, muniti di spade, tamburi, trombe e altri oggetti simbolici identificati da brevi didascalie che al-ludono alle classiche discipline e auctoritates, dalla teologia al diritto, da san Tommaso a Galeno. Una stampa che tutto sommato non dava ragione agli occhi dei contemporanei delle novità didattiche che ani-mavano l’università di Leida arricchita di un teatro anatomico, di un gabinetto di curiosità, di un orto botanico e di lezioni in olandese oltre che in latino5.
Nel secolo della ‘crisi del sapere’ dominato dalle ‘novità celesti’6 e dai rapporti sempre più fitti col Nuovo Mondo numerose, tuttavia, sa-rebbero state le occasioni per inserire nei frontespizi di libri immagini efficaci e insolite di scoperte botaniche, astronomiche o etnografiche, ovvero di un ‘sapere in movimento’ costretto a rivedere la sua conce-zione di unità; sia testi che immagini, infatti, come ha ben dimostrato Anthony Grafton, risentivano ancora di modelli e parametri culturali antichi, era insomma the power of tradition che si sprigionava, sotto
3 Dell’opera di Ramón Lull (1�3�-1316) Arbor scientiae si può vedere l’edizione lionese del 1515 [in domo Francisci Fradin impressoris, 1515 IIII nonas Maij]; in generale cfr. L. Bolzoni, La stanza della memoria, Modelli letterari e iconografici nell’età della stampa, Torino, Einaudi 1995.
� Cfr. Ioannis Meursi, Athenae Batavae. Sive de urbe Leidensi, & Academia, vi-risque claris, qui utramque ingenio suo, atque scriptis, illustrarunt, libri duo, Lugduni Batavorum, apud Andream Cloucquium et Elseviros, 16�5.
5 Cfr. A. Grafton, A. Shelford, N. Siraisi, New worlds, Ancient texts. The Pow-er of Tradition and the Shock of discovery, Cambridge, Massachussets, Belknap Press 1995, pp. �17-��9.
6 Cfr. ‘Novità celesti’ e crisi del sapere. Atti del convegno internazionale di studi galileiani (Pisa-Venezia-Padova-Firenze, 18-�6 marzo 1983), a cura di P. Galluzzi, Firenze, Giunti-Barbera 198�.
�i Introduzione
nuove spoglie, davanti allo shock of discovery di un Occidente messo davanti al resto del mondo7.
Tornando per un momento ad Holbein, è dalla biografia stessa del-l’artista che si possono trarre ulteriori spunti di riflessione storica per-tinenti ai temi del convegno: primo fra tutti quello dell’appartenenza stessa del pittore tedesco ad una dinastia di pittori che da subito in-troduce il tema dell’apprendistato familiare in campo artistico8, colle-gandolo a quello altrettanto pregnante della mobilità, in questo caso di una peregrinatio non accademica, ma a metà fra la religionis causa dell’incipiente Riforma protestante e la convenienza pratica del pitto-re che lascia moglie e figli a Basilea per recarsi a Londra alla corte di Enrico VIII e lì finire i suoi giorni nel 15�3.
L’Europa di Holbein era quella della Respublica Christiana di Era-smo, e anche della Repubblica delle lettere evocata nel celebre ritrat-to dell’umanista di Rotterdam seduto davanti al suo scrittoio e alla voluminosa corrispondenza epistolare che lo mise in contatto coi dotti europei del tempo. Muovendosi sul fronte di profonde trasformazioni religiose e culturali, Holbein affidò la sua fama anche all’illustrazione di libri e in particolare della Bibbia tradotta in tedesco da Martin Lu-tero. Ma al di là delle occasioni che le cesure epocali e le congiunture della propria esistenza fornivano all’artista, quello che colpisce è che alla fine di tutto fosse la sua tekne a predominare, consentendogli di passare agilmente dalle rappresentazioni delle danze macabre ai ritrat-ti dei mercanti tedeschi o dei personaggi più eminenti della corte dei Tudor. Si pone così il tema della ‘neutralità’ e della libertà legata al possesso di un mestiere, di una tekne e delle molte variabili introdotte al riguardo dalla crisi religiosa del Cinquecento e dal crescente con-trollo statale sulla società corporativa.
Costanti e variabili delineano il percorso del sapere così come è sta-to vissuto e teorizzato nel mondo occidentale riassumibile in quattro parole chiave: trasmettere, uniformare, sperimentare, esportare. A quest’ultimo termine, esportare, si lega la sfida più ardua e ambiziosa di questo paradigma, laddove per esportare si intenda un’esportazio-
7 Grafton, Shelford, Siraisi, New worlds cit., pp. 1-1�.8 Un altro esempio illustre di collaborazione artistica familiare è quello dei Tiepo-
lo, ovvero tra il padre Giambattista e il figlio Giandomenico: cfr. A. Zorzi, L’Olimpo sul soffitto. I due Tiepolo tra Venezia e l’Europa, Milano, Mondadori �006.
�ii Introduzione
ne non solo occasionale, fortuita, avventurosa, ma un’esportazione programmata, consapevole, quella che si condensò, soprattutto dalla metà del Cinquecento, nella fase postridentina delle missioni e del-l’internazionale pedagogica della Compagnia di Gesù9.
Volendo tracciare una storia sociale del sapere, resta da approfon-dire come e quando nella lingua italiana e francese il termine sape-re sia diventato declinabile al plurale in saperi/savoirs; in un primo momento sarebbe venuto spontaneo intravedervi l’influsso pervasivo della storiografia delle Annales che ha ispirato al chimico Pierre Laszlo una storia culturale del sale, Chemins et savoirs du sel10; ma facendo qualche ricerca mirata si scopre che savoir al plurale è anche in fran-cese uso recente e che Lucien Febvre lo usò in un articolo del 19�911. Non altrettanto, però, accade con il termine inglese knowledge né con quello tedesco wissen o con quello spagnolo conocimiento che hanno mantenuto fino ad oggi la sola forma singolare. Proprio dai linguisti gli storici hanno mutuato il metodo comparativo che Peter Burke ha ripreso per ricostruire una storia sociale della lingua nell’Europa mo-derna, mostrando le cause e i contesti di conservazione o contamina-zione di vocaboli ed espressioni fra una lingua e l’altra1�. Non è stato facile, infatti, come sottolinea Egle Becchi, in apertura del convegno e nella sua postfazione, trovare una traduzione inglese calzante per il titolo dell’incontro pisano del dicembre �006: la scelta iniziale di shapes of learning, in effetti, non avrebbe reso la polisemia implicita nel riferimento ai ‘saperi’ in cui si è inteso soprattutto sintetizzare la
9 Cfr. La pedagogia della Compagnia di Gesù. Atti del convegno internazionale (Messina, 1�-16 novembre 1991), a cura di F. Guerello e P. Schiavone, Messina, ESUR Ignatianum 199�.
10 Paris, Hachette Littérature 1998, trad. it. Storia del sale. Miti, cammini, saperi, Roma, Donzelli �00�; Laszlo concepisce la storia del sale come «un’utopia pedago-gica, come il sogno di un insegnamento pluridisciplinare che mette insieme analisi letteraria, storia, antropologia, biologia, economia, storia dell’arte, fisica, scienze po-litiche, chimica, etologia, linguistica».
11 Cfr. L. Febvre, Propos d’initiation: vivre l’histoire, in «Mélanges d’histoire so-ciale», III, 19�3, pp. 5-18; ringrazio Jean Boutier che mi ha fornito in merito utili notizie.
1� Cfr. P. Burke, Languages and Communities in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press �00�; trad. it, Lingue e comunità nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino �006.
�iii Introduzione
dimensione dinamica e duplice dell’apprendere e/o insegnare, e/o co-municare un’arte, un mestiere, una professione, o un mero comporta-mento. Senza cadere in forzature anacronistiche, si può prendere atto del passaggio dalle ‘dispute sulle arti’ dell’età umanistica13 agli attuali dibattiti sulla knowlege society e sulla gestione dei ‘saperi’ generati da un universo mentale non più unitario, ma improntato al relativismo sociale della conoscenza per cui ci si chiede: sapere è potere?1�
Ad un sapere alto, anzi ad una sorta di filosofia storica del sapere, fu dedicato nel 1991 gran parte del volume collettaneo curato da Donald Kelley e Richard Popkin dal titolo Shapes of Knowledge from the Renais-sance to the Enlightenment15. L’idea era nata da una conversazione di Kelley avvenuta nel 1985 con l’ultimo Charles Schmitt del Warburg Institute; entrambi allievi di Paul Oskar Kristeller, Schmitt e Kelley si interrogavano sulla complessa questione della classificazione delle scienze dall’epoca dello Studium medievale a quella dell’Encyclopedie francese; in questo arco cronologico si transitò, attraverso la stampa, dalla sapienza/wisdom, ad una crescente massa di knowledge, ovvero di ‘scienza’ nella quale trovarono posto anche le ‘basse arti liberali’, tra cui la grammatica, base poi della filologia e della critica, e la retorica che, almeno potenzialmente, fu un’espressione di civil science. E men-tre le vecchie scienze della legge e della medicina si ‘umanizzavano’, la filosofia entrava in contatto con le altre scienze e la stessa storia della filosofia diveniva nel Seicento una scienza vera e propria. Al colloquio del Warburg, cui partecipò nel 1989 anche Tullio Gregory, molti con-
13 Cfr. E. Garin, La disputa delle arti nel Quattrocento, Firenze, Vallecchi 19�7; N.W. Gilbert, The Early Italian Humanists and Disputation, in Renaissance Studies in Honour of Hans Baron, a cura di A. Mohlo e J.A. Tedeschi, Firenze, Sansoni 1971, pp. �03-��6 e A. Battistini, Il rasoio e lo scalpello: le forme della disputa delle Arti dal Medioevo all’Età moderna in Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell’uni-versità medievale e moderna: il caso bolognese a confronto, I, Forme e oggetti della disputa delle arti, a cura di L. Avellini, Bologna, Istituto per la storia di Bologna 1990, pp. 11-13.
1� Cfr. E. Doyle McCarthy, La conoscenza come cultura. La nuova sociologia della conoscenza, Roma, Meltemi �00�; ed. or. London-New York, Routledge 1996, e R. Robertson, Globalization. Social Theory and Global Culture, Newbury Park 199�; trad. it. Trieste, Asterios 1999.
15 Shapes of Knowledge from the Renaissance to the Enlightenment, ed. by D. Kelley, R. Popkin, Dordrecht-Boston-London, Kluwer Academic Publishers 1991.
�iv Introduzione
tributi furono rivolti all’interesse per le posizioni dotte che incisero sulle trasformazioni concettuali delle scienze speculative da Bacon a Galileo, da Gassendi a Diderot, sempre alla ricerca di una unità del sapere16. Non mancò tuttavia una parte dedicata alle institutions, ov-vero ad alcuni luoghi dove si potevano avvertire in maniera tangibile le ricadute delle secolari trasformazioni avvenute nella classificazione delle scienze; mi limito qui a ricordare i contributi di Robert Black, The curriculum of Italian Elementary and Grammar Schools 1350-1500 e di Susanna Åkerman, The forms of the Queen Christina’s Academies17. Di scuole e accademie, come vedremo, si tratta anche nel presente volume.
Una storiografia sempre più sensibile all’idea di una circolazione di esperienze e conoscenze che nell’età contemporanea hanno portato alla cosiddetta ‘globalizzazione’ ha indotto ad interrogarsi di nuovo sui termini di cultura/culture, civiltà/società così come consegnatici da una fiorente stagione di studi partita Jacob Burchardt e Johan Huizin-ga e approdata ancora alle riflessioni ultime di Peter Burke nell’altro suo recente libro What is cultural history (�00�)18. Ripercorrendo le tappe della New history e della Nouvelle histoire Burke fa qui il pun-to sugli sviluppi dell’interdisciplinarietà storica, della storia sociale, di quella vasta gamma di oggetti storici che dal corpo ai sentimenti hanno aperto molte finestre sulle ‘culture altre’, quelle per cui la per-
16 Una densa messa a punto dei dibattiti sette-ottocenteschi sui rapporti fra scien-za e potere, fra scienze dello spirito e scienze della natura, sulle riflessioni dei philo-sophes e degli illuministi sui limiti della natura umana attraverso le analisi condotte dagli storici e filosofi della scienza contemporanei da Karl Popper a Thomas Khun, è nella prefazione di Vincenzo Ferrone alla sua raccolta di saggi usciti nell’arco di un ventennio per cui cfr. V. Ferrone, Una scienza per l’uomo. Illuminismo e rivoluzione scientifica nell’Europa del Settecento, Torino, UTET �007, pp. vii sgg.
17 The shape of knowledge cit. pp. 1�3 sgg.18 New York, Blackwell Publishers �00�; trad. it, Storia culturale, Bologna, Il Muli-
no �006; ma si veda anche Id. Ibridismo, scambio, traduzione culturale. Riflessioni sulla globalizzazione della cultura in una prospettiva storica, Verona, QuiEdit, Editoria per l’Università italiana e internazionale �009; sempre stimolante anche per gli aspetti dei saperi e del mondo del lavoro femminile nel Cinquecento in rapporto alla crisi religiosa è N. Zemon Davis, Society and culture in Early Modern France, Stanford, Stanford University Press 1975; trad. it., Le culture del popolo. Sapere, rituali, resistenze nella Francia del Cinquecento, Torino, Einaudi 1980.
�v Introduzione
vasività occidentale ha sperimentato il duplice flusso di importazione-esportazione di valori, costumi, istituzioni, lingue, piante, alimenti. In omaggio alle ricerche di Burke dedicate alla storia della cultura (o storia culturale) nel maggio �007 Melissa Claresu, Filippo de Vivo e Joan-Paul Rubiès hanno organizzato a Cambridge un incontro sul tema Exploring cultural History: an International Conference in honour of Peter Burke. I vari contributi delle otto sessioni, tutti concentrati sul periodo del Cinque e Seicento, hanno riportato in superficie temi scivolosi come quello della cultura popolare, delle ‘identità’ (eccezio-nali?) di santi, streghe e criminali, degli ‘incontri culturali’, ovvero di quelle forme di contatto o di scoperte fortuite che vanno dalla danza dei selvaggi del Nuovo Mondo alla curiosità botanica che traghettò il pomodoro da «strange and horrible thing» a condimento alimentare diffuso nella cucina italiana19.
A prescindere dalle molte sollecitazioni esterne provenienti da una messe di pubblicazioni e convegni talvolta, ammettiamolo, ingoverna-bile, l’idea di questo convegno�0 è maturata all’interno della mia espe-rienza personale di studio e di ricerca svolta in una istituzione come la Scuola Normale dove più frequenti sono le occasioni di scambi in-terdisciplinari nella Classe di Lettere, ma anche nel proficuo contatto con la Classe di Scienze�1. Partendo, dunque, dai luoghi istituzionali del sapere (scuole, collegi, università, accademie, piccole e grandi cor-ti) non avremmo difficoltà a individuare da subito una preponderanza
19 Si vedano in particolare le comunicazioni di Alessandro Arcangeli, Dancing Savages:Stereotypes and Cultural Encounters in the Age of Discovery e di David Gentil-core, ‘Strange and Horrible Thing’: the Tomato from Curiosity to Condiment in Sixteenth and Seventeenth Century-Italy; per la notizia cfr. www.hist.cam.ac.uk/seminars events/conferences/programme.pdf. L’intervento di Gentilcore a Cambridge fu oggetto an-che della sua relazione al convegno pisano del dicembre �006; per il presente volume di atti l’autore ha poi deciso di sviluppare un suo studio sui medici ciarlatani e gli strumenti di cui si servivano per farsi conoscere e far conoscere i propri rimedi per cui cfr. infra.
�0 Un puntuale resoconto del convegno a cura di M. Grasselli è in «Annali di storia delle università italiane», XI, �007, pp. �63-�68.
�1 Sulla storia della Scuola Normale è in corso una ricerca di équipe coordinata dai proff. Daniele Menozzi e Mario Rosa in vista del bicentenario della sua fondazione napoleonica: cfr. intanto La storia della Scuola Normale Superiore di Pisa in una prospet-tiva comparativa, a cura di D. Menozzi e M. Rosa, Pisa, Edizioni della Normale �008.
�vi Introduzione
di contributi sulla storia dell’istruzione e dell’educazione che dagli anni Settanta in poi hanno caratterizzato molta produzione storiografica��.
L’identificazione di un luogo materiale e istituzionale in cui si è col-
tivato o trasmesso il sapere facilita solo apparentemente il compito dell’indagine storica; basti pensare ad esempio al problema concreto di avere una minima idea delle sedi disparate e talora improvvisate delle scuole elementari e delle scuole cosiddette ‘maggiori’ e che in antico regime furono oggetto di progetti utopici da parte di umani-sti di grido quali Filelfo e Filarete, finché la Compagnia di Gesù non contribuì ad accelerare ovunque quel processo di edilizia scolastica ad hoc completato tra Otto e Novecento nei vari stati nazionali�3. Se la diffusione stessa degli Studia coincise, all’inizio, con l’occupazione di spazi fisici ben precisi nei centri urbani di Bologna come di Padova o Parigi, dall’altro contribuì a formare in seguito l’idea dei ‘non-luoghi’, ovvero di spazi più estesi ispirati ad una koinè culturale che furono pro-prio i Gesuiti a richiamare come applicazione dell’antica licentia ubique docendi, e che presto sarebbe sfociata nel delineare gli spazi galattici di un’ideale Repubblica delle lettere��.
�� Fra gli studi classici cfr. E. Garin, L’educazione in Europa (1400-1600). Proble-mi e programmi, Roma-Bari, Laterza 19763; L. Stone, The Educational revolution in England, 1560-1640, Oxford, Past and Present Society 196�; R. Chartier, M.M. Compère, D. Julia, L’éducation en France du XVe au XVIIIe siècle, Paris, Société d’édi-tion d’enseignement 1976; sulle università la letteratura è ora molto vasta, ma tra gli studi più recenti cfr. European Universities in the Age of Reformation and Coun-ter Reformation, ed. by H. Robinson Hammerstein, Portland Or., Four Courts Press 1998; Le Università in Europa secoli XV-XIX, a cura di G.P. Brizzi e J. Verger, Soveria Mannelli, Rubbettino 1998; G.P. Brizzi, J. Verger, Le università in Europa dall’Uma-nesimo ai Lumi, Milano, Silvana Editoriale �00�; Gesuiti e Università in Europa, secoli XVI-XVIII. Atti del convegno di studi (Parma, 13-15 dicembre �001), a cura di G. P. Brizzi e R. Greci, Bologna, CLUEB �00�; G. di Renzo Villata, Università in Europa: un felice connubio attraverso i secoli (con qualche ombra…), in «Annali di Storia delle università italiane», X, �006, pp. 9-3�.
�3 Per alcune considerazioni generali sull’argomento mi permetto di rinviare a M.P. Paoli, Le strade del sapere. Scuole di comunità, collegi, università, accademie, in Storia della civiltà toscana, III, Il principato mediceo, a cura di E. Fasano Guarini, Firen-ze, Le Monnier �003, pp. �77-310.
�� Sulla Repubblica delle lettere cfr. H. Bots, F. Waquet, La République des Lettres, Paris-Berlin-Bruxelles, De Boeck 1997; trad. it., La Repubblica delle Lettere, Bologna, Il Mulino �005, con aggiornamento bibliografico a cura di L. Lazzerini e M.P. Paoli;
�vii Introduzione
Per scelta, tuttavia, le università non rientrano direttamente fra i contributi di questo convegno. Basti ricordare che fra le più antiche e durature radici storiche dell’Europa proprio le università occupano un posto di primo piano�5; si tratta di una storia complessa e articolata che denota una situazione concorrenziale di sedi, corpi, poteri giurisdizio-nali e metodi di apprendimento e insegnamento presenti nell’arco di almeno quattro secoli e di cui una efficace e profonda messa a punto critica viene dai contributi più recenti di Elena Brambilla�6. L’utilizzo di fonti sia istituzionali (bolle papali, diplomi imperiali, atti notarili, rotuli, curricula ecc.), che dottrinali e storico-narrative (trattati, libri di ricordi, memorie, diari, epistolari) ha consentito che attorno alla storia delle università si sia sviluppata da tempo una storiografia inter-nazionale comparata, mentre sono ancora fiorenti le storie di singole università, secondo una tradizione iniziata già nel XVII secolo.
Al fine di evitare generici riferimenti all’Europa, un breve richiamo
alla geografia universitaria consente di individuare i diversi termini dai quali partire, sgombrando subito il campo da un equivoco ricor-rente, quello legato all’idea che l’esigenza e l’opportunità di istruirsi fosse quasi atemporale, ovunque sentita e diffusa in quanto dettata da istanze superiori e non anche condizionata, anzi talvolta rifiutata, sulla base di scelte prosaiche e contingenti.
Les premiers siècles de La République européenne des Lettres, sous la direction de M. Fumaroli, Paris, Alain Baudry éditeur �005.
�5 Cfr. Le radici storiche dell’Europa. L’età moderna, a cura di M.A. Visceglia, Roma, Viella �007 e L. Pellegrini, L’incontro tra due invenzioni medievali: università e ordini mendicanti, Napoli, Liguori �005; nel �008 per il VII centenario della fondazione dello Studium generale di Perugia è stato organizzato un convegno internazionale sul tema: Dall’Università delle Nationes all’Università per l’Europa / From a University of Nationes to a University for Europe (Perugia, 8-10 settembre �008).
�6 Cfr. Genealogie del sapere, Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XII-XVII secolo). Con un saggio sull’arte della memoria, Milano, Unicopli �005 e la ricca bibliografia; nella prima parte del volume, Università e collegi dei dottori nell’Italia padana secoli XIII-XVI, l’autrice, dopo aver ripercorso le differenze tra le corporazioni universitarie di Arti e Teologia d’Oltralpe, in particolare di Parigi, e quelle di Diritto italiane, cerca di ovviare alla lacuna segnalata da John Davies riguardo al ruolo dei collegi dei doctores legum, a partire dai conflitti creatisi a Bologna nel XII secolo tra universitates scholarium da un lato, e collegi dei doctores ordinari, vertice della corpo-razione dei giuristi, dall’altro.
�viii Introduzione
Se consideriamo i vari tipi di scuole, cioè quelle di grammatica e di diritto, che fiorirono in vari periodi precedendo la nascita dello Studium generale, una storia comparata in tale direzione vanta sicura-mente un approccio di longue durée. Dopo la fine delle scuole antiche e le invasioni barbariche, l’Italia dell’VIII secolo conobbe una fioritura di scuole ecclesiastiche che formavano scribi, notai e chierici. Carlo Magno non esitò a riconoscere la superiorità culturale italiana in que-sto periodo. Una documentazione ad hoc risalente alla cosiddetta ‘ri-nascita carolingia’ ha consentito agli storici di affrontare l’evoluzione dalle scuole ecclesiastiche a quelle laiche�7.
Scarti e arretratezze nei paesi del nord come Finlandia e Svezia, a lungo privi di una letteratura volgare, fanno slittare in avanti nel tem-po il paragone con quei centri dell’Italia comunale dove fu precoce l’istituzione di scuole pubbliche gratuite che si affiancavano a quelle ecclesiastiche frequentate anche da laici. Nella seconda metà del XIII secolo nella piccola città vescovile di Turku in Finlandia esistevano delle scuole soltanto presso le chiese cattedrali nelle quali si insegna-va il latino, mentre per gli studi superiori di filosofia o teologia era necessario spostarsi nelle università di Parigi, Bologna, Praga Leipzig, Rostock, Colonia, Vienna, Erfurt. Nulla di nuovo, si potrebbe obietta-re; ma se la peregrinatio accademica è fenomeno ben noto e peculiare per i secoli XIV-XV, ciò non toglie che fosse un fenomeno alquanto complesso come le ricerche più recenti di storia sociale e quantitativa hanno dimostrato e certo da mettere in rapporto alle diverse cause di mobilità di chierici e laici, di studenti attratti con borse di studio ver-so i collegi di fondazione privata o verso le università più rinomate�8. Quello che è importante sottolineare è la crescente proliferazione dei luoghi di studio accademico, sia per motivi di prestigio municipale
�7 Cfr. P. Riché, Éducation et culture dans l’Occident barbare, Paris 196� (trad. it. Educazione e cultura nell’Occidente barbarico dal secolo VI al IX, Roma 1966) e anche Luoghi e metodi di insegnamento nell’Italia Medievale (secoli XII-XIV). Atti del conve-gno internazionale di studi (Lecce-Otranto, 6-8 ottobre 1986), a cura di L. Gargan e O. Limone, Galatina, Congedo Editore 1989.
�8 Una messa a punto storiografica sul tema della popolazione e della mobilità stu-dentesca nel Medioevo è in C. Frova, Population étudiantes dans l’Occident médiéval, in L’elaborazione del sapere tra IX e XIV secolo: esperienze nel mondo arabo e nell’area italiana / L’elaboration du savoir du IXe- au XIVe siècle: experiences dans le Monde arabe et italien. Atti del Seminario Internazionale (Palermo �-� dicembre 199�), Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 199�, pp. 97-10�.
�i� Introduzione
come nel caso della fondazione nel 1��8 di uno Studium nel piccolo centro di Vercelli�9, sia per esigenze economiche che nel 1�18 porta-rono a richiamare in Svezia professori dalle università tedesche per evitare i costi dei soggiorni all’estero; questo avvenne prima ancora che nel 1�77 lotte politiche e rigurgiti patriottici inducessero a fonda-re l’università di Upsala30. Motivazioni pratiche, dunque, condiziona-rono ben presto la circolazione del sapere legato ad un cursus honorum che solo gradualmente sfociò nell’acquisizione di un titolo accademico per poter esercitare una professione o una carica all’interno del pae-se d’origine; è ben dimostrato come, in seguito, fossero motivi con-fessionali e politici a consolidare in tutta Europa il fenomeno della ‘territorializzazione’ delle università sotto l’autorità dei vari principi; non a caso era vista con preoccupazione l’internazionale pedagogica della Compagnia di Gesù propensa a favorire la mobilità di studenti e professori nei vari noviziati e collegi31.
Premesso questo, resta ora da chiarire attraverso quali percorsi storio-grafici si registri oggi una crescita di interesse verso la trasmissione dei ‘saperi’ in chiave comparativa. Il tema è vasto e complesso e necessita di chiarimenti sui criteri adottati. Una prima presentazione critica della trasmissione del sapere come transmission of culture fu data da Anthony Grafton nel volume curato insieme ad Ann Blair nel 19903�; Grafton riprendendo i dibattiti sulla cultural history avviati nel Warburg Institu-te e in particolare citando gli studi di Ernest Gombrich, Felix Gilbert
�9 Cfr. Ead., Città e Studium a Vercelli, in Il pragmatismo degli intellettuali. Origini e primi sviluppi dell’istituzione universitaria, Torino, Paravia 1996, pp. 91-10�.
30 Per il caso finlandese Cfr. J. Nuorteva, Suomolaisten ulkomainen opinkäynti en-nen Turun Akatemian perustamista 1640, Helsinki 1997 (ringrazio Maiju Lehmijoki che mi ha segnalato una versione ridotta in lingua inglese di questo studio pubbli-cata sul sito www.lib.helsinki.fi/elektra/sumnuort.pdf) e per la Svezia o meglio per l’Unione Scandinava che dal 1397 al 15�1 comprendeva Svezia, Danimarca e Nor-vegia, cfr. S. Lindroth, Les chemins du Savoir en Suède. De la fondation de l’Université d’Upsal à Jacob Berzelius. Études et portraits, traduit du suédois, présenté et annoté par J.Fr. Battail avec une introduction sur Sten Lindroth par G. Ericksson, Dordrecht-Boston-Lancaster, M. Nijhoff Publishers 1988, in part. pp. 1�-16.
31 Cfr. D. Julia, De l’unité du corps à l’uniformation des pratiques enseignantes, in Gesuiti e Università in Europa cit., pp. �5-36 e in generale tutto il volume.
3� Cfr. The transmission of culture in Early Modern Europe, ed. by A. Grafton, A. Blair, Philadelphia, University of Pennsylvania Press 1990.
�� Introduzione
e Carlo Ginzburg, sottolineava quanto sarebbe stato difficile andare oltre la visione burchardtiana di un sapere inteso come un tutto, fatto di culture che «as coherent beings that could be studied in any social or individual manifestation», si esprimevano nelle feste, nella tassazione, nel gioco33; la visione romantica di un sapere apprezzato al momento della sua creazione più che della sua trasmissione interpretata come corruzione dell’originale, è, perciò, oggetto della revisione operata da Grafton e dagli autori del volume, senza però l’intenzione di rimpiaz-zarla. Il tentativo è stato quello di individuare i processi di trasmissione di pratiche e di idee come processi umani piuttosto che testuali. In questo senso risulta particolarmente significativo il contributo di Wil-liam Hunt, Civic chivalry and the English civil war nel quale, attraverso lo studio di testi teatrali, di regole di compagnie militari, di manuali di educazione, l’autore arriva a dimostrare come la sopravvivenza di antichi ideali cavallereschi fra la gioventù inglese del Seicento, porti a reinterpretare lo scoppio della Rivoluzione inglese generalmente vista come il trionfo della borghesia3�. In sostanza si pone il problema degli effetti della ricezione e della trasformazione di idee o pratiche di com-portamento, a prescindere dal loro legame con l’originale.
Negli anni Ottanta-Novanta del Novecento anche la storiografia italiana e in particolare la ‘microstoria’ del folklore, ovvero delle ‘cul-ture’, inaugurata dagli studi di Carlo Ginzburg e Edoardo Grendi, ha toccato da vicino l’esito delle contaminazioni fra saperi diversi il cui prodotto poteva essere , ad esempio, o l’esercizio illecito di un’arte nel caso dei falsari studiati da Grendi nel 198735, oppure la nascita della teologia medica o medicina teologica che si occupava degli stati pa-tologici della mente conciliando la medicina naturalista ippocratica con l’influsso degli spiriti maligni sull’organismo umano36. Il saggio di Grendi sulla falsa monetazione, costruito attraverso le fonti giudi-
33 Ibid., p. 3.3� Ibid., pp. �0�-�37.35 Cfr. E. Grendi, Falsa monetazione e strutture monetarie degli scambi fra Cinque e
Seicento, in «Quaderni storici», LXVI, 1987, pp. 803-837, ora in In altri termini. Sto-riografia e storia di una società di antico regime, a cura di O. Raggio e A. Torre, Milano, Feltrinelli �00�, pp. 166-�00.
36 Cfr. P. Lombardi, Estasi naturale, divino rapimento. Medici e teologi di fronte al fenomeno degli stati alterati di coscienza nel XVII secolo, in ‘È matto e tristo, pazzo e fasti-dioso’. I saperi nella follia. Magistrati, medici e inquisitori a Firenze e negli stati italiani del Seicento, a cura di V. Biotti, Firenze, Nicomp. L.E. �00�, pp. 191-19�.
��i Introduzione
ziarie genovesi, restituisce un quadro articolato popolato da svariate figure sociali tutte depositarie di una funzione, di un mestiere (princi-pi, signori feudali e nobili, orafi, artefici, artisti, alchimisti, preti, sol-dati, marinai, mulattieri, osti, medici, maestri di scuola, inquisitori, teologi, bargelli ecc.), portando a galla anche una serie di tecniche e strumenti (fornelli e crogioli, staffe, punzoni, stampi, lime e forbici) e dunque di ‘saperi’ orali e scritti mediati dai cosiddetti ‘libri di segreti’. Lo storico avvertito non può fare a meno di ribadire che tutto questo armamentario di conoscenze significa che i falsi monetari erano dei monetari veri e propri che attingevano a culture diverse.
Fra gli studiosi ‘di frontiera’ che hanno aperto piste stimolanti, in-crociando le fonti di storia sociale con quelle letterarie va ricordato Piero Camporesi e in particolare il suo libro La miniera del mondo. Artieri, inventori, impostori, del 199037. L’internazionale dei vagabondi studiata da Camporesi non conosceva confini, si riuniva in gruppi e consorterie, elaborava gerghi. Da Cornelio Agrippa a Leonardo Fio-ravanti a Tommaso Garzoni, col Cinquecento si aprirono le porte al riconoscimento dell’importanza delle arti vituperate, dei saperi della gente maledetta; mestieri umili, mobili e immobili (facchini, norcini, balie, spazzacamini) trovarono il loro specchio nel teatro popolare di strada, influenzando la letteratura colta testimoniata da alcune opere coeve che recano nel titolo vocaboli quali la ‘fiera’, la ‘piazza’, il ‘mer-cato’ e tra cui spicca per ampiezza e varietà di erudizione La piazza universale di tutte le professioni del mondo opera del canonico regolare lateranense Garzoni38. Parallelamente si sviluppava, come vedremo meglio dai contributi di Chiara Lastraioli e David Gentilcore, la let-teratura di piazza o di colportage fatta di opuscoli e fogli volanti diffusi dai ciarlatani fra i ceti popolari.
Il proficuo scambio di saperi tra campagna e città, tra pastori, con-tadini e artigiani itineranti veniva riscoperto ed esaltato dai detentori di un sapere dotto; si sfumava così l’dea di pericolo che da sempre comportava il binomio curiositas-mobilitas avversato dalla Chiesa e dai SS. Padri e in particolare da Agostino, finché Baltàsar Gracian con il Criticon e Galileo con Il saggiatore contribuirono a mutare la concezione trasgressiva implicita nella curiositas intesa negativamen-
37 Milano, Mondadori, 1990, e pp.71-78, 118-1�0 e �79-307.38 L’opera del Garzoni fra il 1585 e il 1675 ebbe �5 edizioni e varie traduzioni in la-
tino, tedesco, spagnolo ecc. Cfr. T. Garzoni, La piazza universale di tutte le professioni del mondo, a cura di P. Cherchi e B. Collina, Torino, Einaudi 1996, voll. I e II.
��ii Introduzione
te come cupiditas. Nelle ‘cose curiose’ rientravano le novelle, le poe-sie, le historie, le ‘frasche’, quelle che si suggeriva ai predicatori di evi-tare nelle loro prediche39. A questo riguardo per completare il quadro dei ‘saperi in movimento’ andrebbe ripreso il tema della predicazione e dello sviluppo della retorica cristiana non soltanto a contatto col Nuovo Mondo, ma col pubblico dei fedeli cattolici e protestanti sia nelle città che nelle campagne europee. Sappiamo, infatti, abbastan-za sulla predicazione medievale che faceva riferimento a molti aspetti della vita cittadina, intervenendo anche sugli aspetti dei saperi e del lavoro artigianale o professionale�0, ma meno sappiamo della predica-zione del clero secolare e regolare nell’età della Controriforma.
Nel campo della storia della comunicazione letteraria, iconografica, orale e/o scritta, molti passi avanti sono stati compiuti da storici e letterati alle prese con le arti della memoria, del significato di imprese ed emblemi considerati chiavi di lettura della società medievale e mo-derna�1. Da questo punto di vista un ulteriore esempio ci viene offerto dalla più giovane storiografia spagnola e in particolare dagli studi di Fernando Bouza che ha tentato di distillare al massimo le potenzialità dei testi scritti e delle immagini attraverso alcune fonti del siglo de oro, sia colte che popolari, stampe e fogli volanti appunto, dove è frequente percepire il valore attribuito all’oralità, alle parole della conversazione galante di uomini e donne, delle grida, delle preghiere o delle formule magiche ripetute come dei mantra e condannate dall’Inquisizione��.
Fatta uscire dalle porte della legittima ‘curiosità’ degli storici, la fonte scritta rientra alla fine da molte finestre obbligate, restando il
39 Cfr. S. Giombi, Libri e pulpiti. Letteratura, sapienza e storia religiosa nel Rinasci-mento, Roma, Carocci �001.
�0 Cfr. D. Nirit ben-Aryeh, Renaissance Florence in the rethoric of two popular preachers. Giovanni Dominici (1356-1419) and Bernardino da Siena (1380-1444), Turnhout, Brepols �001.
�1 Cfr. “Con parola brieve e con figura”. Emblemi e imprese fra antico e moderno, a cura di L. Bolzoni e S. Volterrani, Pisa, Edizioni della Normale �008.
�� Cfr. F. Bouza, Communication, Knowledge and Memory in Early modern Spain, Philadelphia, University of Pennsylavnia Press, �00�; ed. or., F. Bouza, Comuni-cación, Conicimiento y Memoria en la España de los Siglos XVI y XVII. Seminario de Estudios Medievales Y Renacientistas, Universidad de Salamanca 1999; Id., Corre manoscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia �001.
��iii Introduzione
filtro principale, la lente con cui leggere il passato. Il tema dell’alfa-betizzazione, della literacy, in antico regime, studiato nei suoi risvolti sociali e culturali grazie all’uso di fonti istituzionali, demografiche e letterarie, è stato infatti un altro proficuo terreno di confronto per gli storici europei, avendo al suo attivo una ricca messe di studi fioriti soprattutto in Inghilterra e Francia. Un primo incontro sui problemi di storia dell’educazione fra studiosi di varia formazione fu quello or-ganizzato dall’École francaise de Rome e dall’Università di Roma La Sapienza; in tale occasione Adriano Prosperi individuava nel clero secolare, nel parroco, prima e dopo il Concilio di Trento, un nuovo tipo di mediatore culturale che insieme ai maestri di scuola o ai pre-cettori privati era deputato a trasmettere un sapere, ma soprattutto ad educare all’obbedienza e alla sottomissione dopo averla appresa�3. Le fonti conciliari, e soprattutto quelle sinodali delle diocesi italiane del Cinquecento utilizzate da Prosperi, introducevano nell’orizzonte storiografico due tipi di problemi inerenti ai paesi di confessione catto-lica: quello dei limiti confessionali imposti alla trasmissione, ricezione del sapere vincolato al comportamento più che alla dottrina, e d’altro lato quello dell’educazione del clero e dei nobili in quanto mediatori sociali per eccellenza. Ma sull’effettivo divario di alfabetizzazione fra paesi cattolici e protestanti, nuovi elementi di riflessione verranno dal contributo di Marina Roggero in questo volume.
Dagli studi finora citati è emerso uno spazio europeo utilizzato come un contenitore per temi di ricerca trasversali analizzati poi nel detta-glio e nelle peculiarità di situazioni e realtà diverse. Un posto a sé in questo quadro occupa lo studio magistrale di Maringo Berengo dedi-cato all’Europa delle città tra Medioevo ed Età moderna, un grande affresco in cui ad essere protagoniste sono le città europee con le loro istituzioni e i loro abitanti, chierici e laici, che ci conducono nel vivo delle questioni legate all’apprendimento e allo svolgimento di mestieri e professioni dentro e fuori delle università��. C’è da chiedersi che cosa sia intervenuto poi, a detta dello stesso Berengo, a far giudicare ‘lon-
�3 Cfr. A. Prosperi, Educare gli educatori: il prete come professione intellettuale nel-l’Italia Tridentina, in Problèmes d’histoire de l’éducation. Actes du seminaire organisé par l’École francaise de Rome et l’Università di Roma La Sapienza (Janvier-Mai 1985), Rome, École francaise de Rome 1988, pp. 1�3-1�0.
�� Cfr. M. Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età modena, Torino, Einaudi 1999, pp. 339-519.
��iv Introduzione
tano’, forse superato quel suo studio di sintesi�5. Indubbiamente molto ha contribuito l’accelerazione storiografica su quei temi trasversali di cui si diceva e tra i quali spicca il fiorente filone di ricerca dedicato alle corti europee che possono considerarsi istituzioni sovracittadine.
Attorno all’internazionale nobiliare e principesca si è poi sviluppata una serie di studi sull’educazione di corte, sui modelli e sulle prati-che�6. Gli specula principum medievali e il trattato di Erasmo Institutio principis non sono che i punti di partenza di una letteratura secolare che ha riproposto o messo in discussione le qualità e i saperi di volta in volta ritenuti esemplari per il buon principe, soprattutto in presenza degli spazi sempre più ampi e definiti occupati dai giuristi in qualità di garanti della giustizia. Ci si è chiesti alla fine se esiste un ‘sapere del principe’. Anche qui la comparazione può evitare generalizzazioni; altra cosa è parlare dei re di Francia per i quali valeva un’educazio-ne intimamente connessa alla natura divina della sovranità e fondata sulla tradizione antica di un sapere clericale e sull’insegnamento di saperi profani; solo tra Cinque e Settecento si venne erodendo questa visione assoluta ed esclusiva del sapere reale in nome del principio illuministico di un diritto pubblico sottratto alla storia della regalità e sottomesso all’impero della ragione�7. Altra cosa è, invece, parlare delle piccole corti degli antichi stati italiani che, mentre costituirono un modello fondante per le altre corti europee, si trovarono anche a condividere l’esclusività propria del rango con gli stimoli e le offerte culturali della società circostante nobiliare e/o borghese�8.
Uscendo dal tema dell’educazione principesca e cortigiana, occorre ricordare che alcune corti europee fin dal Medioevo furono anche luo-
�5 Si veda a questo proposito l’intervista rilasciata da Marino Berengo a Simonetta Fiori su «Il Corriere della sera» del �9 dicembre 1999.
�6 Cfr. La società dei principi nell’Europa moderna (secoli XVI-XVII) / Die geselleschaft im Europa der Neuzeit 16.-17 Jahrundert, a cura di C. Dipper e M. Rosa, Bologna, Il Mulino �005 e Problème interculturel en Europe, XV-XVIIe siècles. Moeurs, maniere, comportements, gestuelle, codes et modèles, Études recueillis par E. Baumgartner, A. Fiorato, A. Redondo, Paris, Presse de la Sorbonne Nouvelle 1998.
�7 Cfr. Le Savoir du Prince du Moyen Âge aux Lumières, sous la direction de R. Halévi, Paris Fayard �00�.
�8 Per un esempio di questo mi permetto di rinviare a M.P. Paoli, Di madre in figlio. Per una storia dell’educazione alla corte dei Medici, in «Annali di storia di Firenze», III, �008, pp. 65-1�5.
��v Introduzione
ghi di trasmissione e di elaborazione di saperi nuovi. In questo senso un esempio calzante è quello della corte papale dei secoli XI-XIV studiata da Agostino Paravicini Bagliani che ha messo in luce come il con-vergere di conoscenze di ottica, alchimia, macrobiotica nella Viterbo del secolo XIII concorresse a sostenere la teoria della prolongatio vitae formulata da Ruggero Bacone; la novità era determinata anche dal suo obiettivo, non riguardando più soltanto il corpo del re ma quello papa, in quanto detentore di due poteri, spirituale e temporale�9.
Un altro fecondo settore di studi si è concentrato sulla nascita e sull’evoluzione di mestieri e professioni in antico regime, sulla loro struttura corporativa interna, sulla dipendenza da tradizioni familiari o cittadine50, sulla connessione col mondo del lavoro, della burocrazia e della politica statale. Gli approcci sono stati molteplici, da quelli teorico-giuridici a quelli di storia sociale ed economica; recentemente il tema delle professioni nel lungo periodo, partendo dalla discussio-ne della professione clericale come primo esempio di professione più vicina all’accezione attuale del termine, ha suscitato dibattiti interdi-sciplinari fra storici e pedagogisti dell’università di Pavia51. Fra i temi ricorrenti troviamo evidenziati nei vari studi quelli relativi alla mobi-lità di alcuni mestieri, al reclutamento di forestieri e al conseguente problema delle varie forme di immissione alla cittadinanza, ai conflitti interni non solo fra arti maggiori e minori, fra mestieri vili e profes-
�9 Cfr. A. Paravicini Bagliani, Il corpo del papa, Torino, Einaudi 199�, in part. pp. 300-316; si veda anche I saperi nelle corti / Knowledge at the courts, in «Microlo-gus», XVI, �008.
50 A questo riguardo sono pertinenti le relazioni tenute nella giornata di studio del 5 maggio �006 presso l’Università Bocconi di Milano sul tema del ruolo economico della famiglia in età moderna e contemporanea e in particolare la relazione di M. Cat-tini, Di padre in figlio. La trasmissione dei mestieri ad alta specializzazione fra manifattura e industria, ma cfr., Percorsi e modelli familiari in Italia tra Settecento e Novecento, a cura di F. Mazzonis, Roma, Bulzoni 1997; sui notai la cui formazione era basata sulla pratica e non sullo studio vero e proprio cfr. J.P. Pisson, Notaires et société. Travaux d’histoire et de sociologie notariales, Paris 1990, � voll. e S. Levati, Notai e società nello stato di Milano alla fine dell’antico regime (1751-1800). Reclutamento, strategie famigliari e ruolo sociale di un gruppo professionale, in Le regole dei mestieri e delle professioni secoli XV-XIX, a cura di M. Meriggi e A. Pastore, Milano Franco Angeli �000, pp. 1�0 e sgg.
51 Si tratta di un ciclo di seminari sulla storia della formazione delle professioni in età moderna e contemporanea coordinati nel maggio del �008 da Egle Becchi e Monica Ferrari presso il Collegio Ghislieri di Pavia.
��vi Introduzione
sioni onorate, ma all’interno di una stessa arte o di uno stesso collegio professionale dove il rapporto maestri-allievi era improntato ad una visione patriarcale causa di maltrattamenti e abusi tra superiori e in-feriori che spesso finivano in tribunale5�. E mentre col tempo cresceva il divario fra arti meccaniche e arti liberali, nel corso del Settecento si professionalizzavano i saperi tecnici di architetti e ingegneri ai quali si richiedeva un regolare curriculum formativo; le scienze applicate acqui-stavano una dignità sempre maggiore parallela al crescente controllo da parte dello stato sia sulle corporazioni più antiche, che sui nuovi settori del sapere strumentali alle politiche di conservazione ed espan-sione53. All’interno di questi campi di ricerca una particolare attenzio-ne è stata rivolta alle professioni mediche e alle pratiche sanitarie in antico regime, oggetto di dibattito fra gli storici anglosassoni e tema di un ciclo di seminari inaugurato presso l’École francaise di Roma, la Biblioteca di storia moderna e contemporanea e la Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco nel giugno �008, nell’ambito del programma dedica-to a Les savoirs. Construction, transformation, diffusion in collaborazione con CNRS-Universitè de Lyon �. Definendo la medicalizzazione come un concetto ambivalente che non si può identificare con un processo lineare e costante, gli organizzatori hanno criticamente valutato la tesi di Michel Foucault, mettendo in risalto le risposte e le resistenze dal basso alla medicalizzazione della malattia5�.
L’approccio al tema delle professioni ha destato interesse anche sot-to altri punti di vista: lo storico canadese George W. McClure ha pre-ferito, infatti, ricorrere a fonti letterarie, profane e teologico-morali, per ricostruire The culture of Profession in Late Reanaissance Italy. Il punto di partenza di questo studio è il classico esempio di Petrarca del De vita solitaria e della Lettera alla posterità che dette origine al genere letterario del racconto autobiografico scaturito dalla crisi vocazionale
5� Cfr. Conflitti nel mondo del lavoro, a cura di C. Poni e S. Cerutti, in «Quaderni storici», LXXX, 199�.
53 Cfr. La politica della scienza. Toscana e altri stati italiani nel tardo Settcento. Atti del convegno (Firenze, �7-�9 gennaio 199�), a cura di G. Barsanti, V. Becagli, R. Pasta, Firenze Olschki 1996.
5� Professions medicales et pratiques de santé du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Atelier I, La médicalisation: un concept ambivalent, Rome, École francaise de Rome, �7-�8 giugno �008.
��vii Introduzione
come scelta e lotta e che portò Petrarca e altri suoi epigoni a rigettare l’attività legale per abbracciare l’otium-negotium delle litterae55.
Quello che poi divenne un topos della cultura dotta, nella realtà cor-rispose al fatto che l’esercizio di un’arte non era quasi mai esclusivo e comportava soprattutto per gli uomini di lettere l’impegno su più fronti necessari per sbarcare il lunario. Gli esempi potrebbero essere molti: Diderot figlio di un orologiaio per guadagnarsi da vivere copiava spartiti musicali; l’attore Tristano Martinelli, celebre per aver portato al successo nei teatri europei il personaggio di Arlecchino, saltuaria-mente aveva un impiego di esattore delle tasse56. Già dalla fine del secolo XVII si erano avuti tentativi di dare un proprio statuto all’uomo di lettere, a prescindere che fosse o meno cooptato in qualche insegna-mento universitario o come precettore privato; la consapevolezza della professionalità di chi maneggiava codici greci e latini, rime provenzali o antiche cronache medievali, coincise non a caso con la richiesta di un compenso in denaro, quello che il celebre grecista fiorentino, l’aba-te Anton Maria Salvini, reclamò dopo aver fornito una consulenza ad un erudito inglese57. L’onore della professione doveva dunque coinci-dere con la sua remunerazione non a caso altrimenti detta ‘onorario’.
Un’accelerazione dell’interesse per il tema dei saperi e della loro trasmissione fra Medioevo ed Età moderna si è avuto in tre occasioni recenti frutto di altrettanti convegni internazionali di studi organizzati far il 1997 e il �005 a Nancy, Besancon e Pistoia. Nell’introduzione al convegno di Nancy dedicato ai tipi del sapere, alla pratica del sapere e alla sua circolazione, si avvertiva come la suddivisione fosse artificiale dato che ognuno di questi aspetti toccava inevitabilmente anche gli altri. Immagini e testi, classici veicoli di trasmissione del sapere, sono presenti in molti contributi che mettono in risalto l’alleanza umanista tra conoscenza e saggezza, tra science e conscience; gli effetti della Ri-forma cattolica attraversano le varie relazioni tenute a Nancy che trat-
55 Cfr. G. McClure, The Culture of profession in late Reanaissance Italy, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press �00�.
56 Cfr. S. Ferrone, Arlecchino. Vita e avventure di Tristano Martinelli attore, Roma-Bari, Laterza �006.
57 Cfr. M.P. Paoli, Anton Maria Salvini (1654-1729): il ritratto di un “letterato” nella Firenze di fine Seicento in Naples, Rome, Florence. Une Histoire comparée des milieux in-tellectuels italiens (XVIIe-XVIIIe siècles) sous la dir. de J. Boutier, B. Marin, A. Romano, Rome, École Francaise de Rome �005, pp. 501-5��.
��viii Introduzione
tano di collegi, università, teatro, sermoni, letture devote, di luoghi e strumenti, cioè, che servivano a ‘disciplinare’ l’ortodossia dell’uomo del popolo come dell’uomo dotto58. In questo senso un saggio emble-matico è quello di Estrella Ruiz-Gàalvez Priego, L’obbligation d’einse-gner et la nècessitè d’apprendre:l’enseignement familial e l’iconographie del sainte famille dove l’autrice, attraverso l’iconografia di sant’Anna e di Maria Vergine fanciulla e poi di san Giuseppe tramandata dai testi apocrifi, affronta il tema più generale dell’educazione di figlie e figli e dei diversi compiti educativi affidati alle madri e ai padri, compiti e ruoli che tutta una letteratura ad hoc avrebbe ben definito e divulgato soprattutto dopo il Concilio di Trento59.
La ricca storiografia sulla storia di genere e sulla storia delle donne e in particolare alcuni studi curati da Gabriella Zarri hanno fatto luce sugli ambiti circoscritti del sapere femminile che, tuttavia, anche in ambito claustrale registrava occasioni e forme originali di espressione artistica e letteraria60. Escluse dal sapere filosofico, teologico e giuridi-co, salvo casi eccezionali, le donne furono per lo più considerate come oggetto di precetti pedagogico-morali o spesso ritenute detentrici di ‘saperi’ al plurale, spesso allusivi all’apprendimento e all’esercizio di lavori manuali come il cucito e il ricamo o la pratica dell’arte ostetrica, ma anche ai risvolti più insidiosi delle arti magiche e dei poteri cari-smatici e profetici61. Dai contributi del convegno pisano verranno fuo-ri ulteriori esempi degli spazi e dei modi in cui le donne potevano agire in quanto detentrici di un qualche sapere tradizionale o rinnovato.
Nel colloquio del �003 organizzato dall’Université di Besancon e dall’Université Francois Rabelais di Tours6�, più che gli attori del sape-
58 Cfr. La transmission du savoir dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles, textes réunis par M. Roig-Miranda, Paris, Honoré Champion �000.
59 Ibid., pp. 309-330.60 Cfr. I monasteri femminili come centri di cultura fra Rinascimento ed età barocca, a
cura di G. Pomata e G. Zarri, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura �005.61 Cfr. Poteri carismatici e informali. Chiesa e società medievali, a cura di A. Paravici-
ni Bagliani e A.Vauchez, Palermo, Sellerio 199� e in part. J. Agrimi, C. Crisciani, Immagini e ruolo della “vetula” tra sapere medico e antropologia religiosa (secoli XIII-XV), pp. ���-�3�; Femmes savantes, savoirs des femmes. Du crépuscule de la Renaissance à l’aube des Lumières. Actes du colloque (Chantilly, ��-�� settembre 1995), éd. par C. Nativel, Genève, Droz 1999; Donne tra saperi e poteri nella storia delle religioni, a cura di S. Boesch Gajano-E. Pace, Brescia, Morcelliana �007.
6� Cfr. La transmission des savoirs au Moyen Age et à la Renaissance. Actes du colloque
��i� Introduzione
re, furono i testi e le immagini ad essere protagonisti; una delle sessioni più ricche di contributi fu infatti quella rivolta alle Langues et transla-tions des savoirs dal XII secolo al XVI secolo; sempre attraverso i testi si dava poi conto di una vasta gamma di trasmissione dei saperi, dalle tecniche della memoria ai trattati di pittura o artiglieria, ai trattati medici ed esoterici, alle relazioni di viaggio ecc.
Risulta a questo punto più raro l’approccio comparativo alla storia dei saperi dal punto di vista della storia sociale restituita da esperienze individuali e biografie esemplari o dall’analisi di ceti, gruppi, corpora-zioni che agiscono in un dato contesto. L’assenza di fonti scritte per comprendere certe dinamiche concrete di trasmissione e ricezione del sapere è spesso denunciata nel bel volume di atti del convegno or-ganizzato a Pistoia nel �003 su La trasmissione dei saperi nel Medioevo (secoli XII-XV)63. Giuliano Pinto, parlando delle trasmissione delle pratiche agricole, conclude che se dal XIII secolo in poi è ricchissi-ma la documentazione scritta sul mondo rurale, erede della letteratura georgica classica, marginale è lo spazio riservato alla trasmissione dei saperi pratici; alcuni elementi interessanti tuttavia vengono fuori dal-le fonti notarili, dai contratti agrari e dagli statuti comunali oltre che da quelli più rari rivolti espressamente ad un’attività agricola di cui un esempio è lo statuto dell’arte degli ortolani del 13796�. Occorre atten-dere la fine del Settecento perché si possa parlare di un ‘sapere agrono-mico’, ovvero di una scienza agraria con delle regole e delle tecniche trasmissibili nei trattati e nell’insegnamento accademico65.
Un altro oggetto di studio interessante per stabilire il rapporto fra teoria e pratica, ma che non è stato affrontato nel convegno pisano,
international organisé par l’Equipe Poétique des Genres et Spiritualité de l’Université de Franche Comté et le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de l’Université Franc¸ois Rabelais de Tours (Besanc¸on-Tours, ��-�9 mars �003), sous la dir. de P. Nobel, Besanc¸on, Presses Universitaires de Franche-Comté �005, � voll.
63 Cfr. La trasmissione dei saperi nel Medioevo, secoli 12-15. Diciannovesimo conve-gno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio �003), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’arte �005.
6� Cfr. G. Pinto, La trasmissione delle pratiche agricole (secoli XII-XV), in La trasmis-sione cit., pp. 3-�9
65 Cfr. M.P. Paoli, Da “grammatici a cittadini”. Modelli e progetti di educazione agraria nelle opere e nella corrispondenza di Marco Lastri (1774-1799), in Modelli da imitare / Modelli da evitare, atti del Convegno di studi (Pisa 11, 1�, 13 ottobre �007) a cura di A. Alimento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura �009, pp. �1-��.
��� Introduzione
è quello del mestiere delle armi che ha al suo attivo pregevoli studi. Esempio tipico di un sapere che si afferma all’inizio senza regole scritte in quanto vincolato all’osservanza del segreto circa le tattiche da usare in battaglia e dunque appreso per ‘imitazione’, il mestiere delle armi sarà codificato e descritto in trattati e diffuso attraverso scuole a parti-re dal XV secolo; ma anche in questo caso non mancano testimonian-ze letterarie sullo scarto fra prassi e teoria, come ci viene tramandato da una novella di Matteo Bandello, ironico verso L’arte della guerra di Machiavelli ed entusiasta dell’abilità strategica dimostrata da Gio-vanni delle Bande nere66. Le fonti statutarie, i libri di ricordanze o le cronache cittadine documentano l’esistenza di dinastie di condottieri e di artefici che per generazioni si trasmisero delle tecniche sui campi di battaglia o nelle botteghe di città dove si apprendeva il mestiere «rubando con gli occhi»; ma come è possibile coglierne l’evoluzione e la novità? L’inventio è un altro aspetto del sapere che anche in pas-sato produceva qualcosa di nuovo grazie al progresso di certe tecniche come ad esempio l’arte vetraria che dette adito all’invenzione degli occhiali67; a volte l’invenzione avveniva casualmente, a volte consa-pevolmente «ghiribizzando», come accadde a Luca della Robbia quan-do, abbandonato il marmo e il bronzo, trovò il modo di «difendere dall’ingiurie del tempo» i manufatti lavorati con la terra68.
Il ‘saper fare’, vuoi l’‘arte di arrangiarsi’ alla Bertoldo studiata da Ma-ria Serena Mazzi69, vuoi il savoir faire del buon cortigiano immerso nel-la ‘civil conversazione’, era dunque soggetto ad una serie di variabili che l’anelito costante verso un sapere unitario ed enciclopedico non avrebbe contenuto. Su tutto questo aleggia un’altra variabile che, a mio avviso, meriterebbe uno studio a sé stante: quella del sapere ge-
66 Cfr. A. Settia, Esperienza e dottrina nel mestiere delle armi, ibid., pp. 33-51 e in generale J. Keegan, La grande storia della guerra. Dalla preistoria ai nostri giorni, Mila-no, Mondadori 199�.
67 Cfr. C. Frugoni, Medioevo sul naso. Occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, Roma-Bari, Laterza �007.
68 Cfr. D. Degrassi, La trasmissione dei saperi: le botteghe artigiane, in La trasmissione cit. pp. 5�-86 e ibid. M. Collareta, La pittura, pp. ��9-�6�; per un utile paragone tra l’arte appresa in bottega, l’esperienza, personale, il talento e la fortuna che con-notano il lavoro dell’artista, del pittore, cfr. anche M. Vasselin, La transmission des savoirs artistiques à la Renaissance: Raphael, sa formation et son atelier, in La transmission du savoir cit., pp. 359-381;
69 Cfr. M.S. Mazzi, L’arte di arrangiarsi, in La trasmissione cit., pp. �63-�87.
���i Introduzione
niale, totalizzante, solitario, spesso enigmatico e contrastato. Efficace a questo riguardo il ritratto biografico-agiografico che Gilberte Périer dette del fratello Blaise Pascal educato dal padre «che lo metteva al corrente di tutto ciò di cui lo vedeva capace». Educazione e talento fino ad un certo punto agirono nel fanciullo in maniera osmotica; il padre gli mostrava come funzionavano le regole grammaticali delle lingue, incluse le eccezioni, e come in questo modo si fosse riusciti «a rendere ogni lingua comunicabile da un paese all’altro». «Questa regola generale – scrive Gilberte – gli schiuse la mente, facendogli comprendere la ragione delle regole grammaticali; cosicché, quando le imparò, seppe perché lo faceva, e si applicava con ordine alle cose che richiedevano maggiore impegno». Ma fu nella geometria euclidea, quella che il padre gli aveva proibito di studiare, che il giovane Blaise stupì il padre «con la grandezza e potenza del suo genio». La fama della genialità di Pascal transitò come noto nell’opera di Chateaubriand, Génie du Christianisme (180�), dove ad emergere era l’esperienza della conversione finale e del suo rapporto col giansenismo e coi solitaires di Port Royal70. Al di là delle comprensibili forzature, anche il racconto di Gilberte è una testimonianza diretta della trasmissione del sapere fra padri e figli maschi in nome di una prassi educativa ormai consoli-data e che qui è amplificata dall’amore fraterno. Fuori dall’enfasi e dal mito che accompagna la biografia di personaggi geniali si colloca uno studio del musicologo inglese Stanley Sadie che chiarisce gli aspetti della formazione del giovane Mozart fra il 1756 e il 1781. Uscito in versione italiana proprio nel �006, anno del centenario mozartiano, il libro di Sadie ricostruisce con scrupolo quello che è stato definito il capolavoro pedagogico di Leopold, padre di Wolfgang. Non la tiran-nia sul figlio prodigio, ma una sapiente regia formativa che includeva istruttivi itinerari di viaggio nelle corti italiane da Parma a Firenze71.
L’invenzione e la sperimentazione, il segreto e la comunicazione, la traduzione e la trasformazione sono, dunque, altrettante fasi del percorso del sapere che ritroviamo nelle varie relazioni presentate al
70 Il testo della biografia di Pascal, redatto una prima volta da Gilberte nel 168�, anno della morte del fratello, fu riedito anni dopo; su successiva versione è stata fatta la traduzione italiana per cui cfr. B. Pascal, Vita di Gesù Cristo e altri scritti spirituali, Casale Monferrato, Edizione PIEMME 1996, pp. 119-173.
71 Cfr. S. Sadie, Wolfgang Amadeus Mozart. Gli anni salisburghesi (1751-1784), Mi-lano, Bompiani �006.
���ii Introduzione
convegno e nei contributi di questo volume diviso in tre parti: luoghi, figure, usi del sapere: non solo scuole / saperi in movimento / saperi eccen-trici, saperi antichi, saperi nuovi.
Da subito va notato come il fil rouge che lo attraversa si fondi sul-la secolare tensione tra cultura orale e scritta, tra memoria e lettura, tra cultura dotta e cultura popolare, sull’uso e sulla conoscenza delle lingue volgari moderne, oltre che delle classiche e desuete, sulla tra-duzione nella sua duplice funzione di circolazione di testi e di conta-minazione che impegnò più intensamente gli intellettuali europei tra Sei e Settecento. Accanto a questi aspetti sono messe in risalto cause e casualità dell’affermazione di saperi nuovi o del rinnovamento di sa-peri antichi come la teologia, il diritto e l’ostetricia. Mancano invece contributi sul mondo degli artigiani, dei mestieri veri e propri condotti nelle botteghe di cui sarebbe stato interessante seguire l’evoluzione in rapporto ai flussi migratori di uomini e donne negli anni centrali del Seicento, scanditi dalla grande epidemia di peste del 1630 e dall’ina-sprirsi della spaccatura confessionale durante la guerra dei Trentanni. Ma altre occasioni di approfondimento non mancheranno.
La prospettiva di lungo termine adottata nel convegno ha come punto di partenza la Firenze del Tre-Quattrocento, luogo unanime-mente apprezzato dagli storici per la ricchezza e precocità delle sue fonti scritte e che inaugura la prima sessione. Nella sua relazione Edu-cation and Society in Tuscany from the 13th to the 15th Century, Robert Black, comparando quattro tipi di fonti, il magistrato dei Pupilli, i catasti del 1��7 e 1�80, i libri di ricordanze e documenti relativi ad al-cune confraternite, giunge alla conclusione che a Firenze solo verso la fine del Quattrocento crebbe il divario culturale fra élites e ceti popola-ri. Fino a quel momento in città era diffuso l’insegnamento impartito nelle numerose scuole di abaco, mentre languiva il latino a riprova della vocazione mercantile di Firenze che reclutava dalle sue città sog-gette maestri di grammatica, medici, giuristi, notai. Al di là del caso fiorentino, indubbiamente emblematico, Black fa una considerazione importante dal punto di vista della storia comparata, quando parla della «svolta etica» avvenuta nell’Italia del Trecento col declino delle scuole ecclesiastiche e la nascita di scuole comunali laiche dove i mae-stri, e talvolta anche delle maestre per le fanciulle, venivano pagati per insegnare.
Spostandoci dalla città alle corti italiane del Quattrocento, il con-tributo di Monica Ferrari Lettere, libri e testi ad hoc per la formazione delle élites: uno studio di casi fra Quattrocento e Settecento, individua
���iii Introduzione
delle costanti di lungo periodo nelle forme di apprendimento delle élites che perdurano fino al Sette-Ottocento. La traduzione in volgare della Ciropedia di Senofonte fatta nel 1�67 da Francesco Filelfo per gli Sforza di Milano, l’esperienza educativa totalizzante e quotidiana idea-ta a Mantova da Vittorino da Feltre (Cà Giocosa), sono aspetti di una paideia di corte che, partendo dalla rilettura dei classici, attua modelli fondativi per altre corti; quello che la Ferrari ha sottolineato come elemento peculiare di questa fase della trasmissione del sapere per dei futuri principi è la presenza a livello iconografico dei ritratti degli allie-vi e dei maestri posti l’uno di fronte all’altro, così come si presentano negli splendidi codici miniati sforzeschi destinati a Ludovico il Moro e poi a suo figlio Massimiliano. Oralità e scrittura che si esercitavano nella recita di orazioni o nella composizione di epistole in latino e in volgare completarono l’iter formativo di generazioni dei Gonzaga come degli Sforza. A proposito degli usi del sapere documentabili dai quaderni scolastici, Monica Ferrari ha indicato una pista di ricerca che porta alle soglie dell’Ottocento grazie alle fonti degli archivi familiari che, come vedremo dal contributo di Antonella Barzazi, fino ad una certa epoca erano tutt’uno con le biblioteche private patrizie dove, in mezzo a codici manoscritti e libri a stampa, è facile trovare appunti scolastici e note di lettura. L’esempio ricordato dalla Ferrari è quello della famiglia cremonese Biandrà Trecchi che mandò alcuni suoi ram-polli a studiare nel Collegio Cicognini di Prato. Una volta che le élites europee non gravitavano più soltanto attorno alle corti, furono come noto i collegi gesuitici il punto di riferimento formativo; restarono tut-tavia inalterati alcuni mezzi di educazione sperimentati dagli umanisti e fondati sulla forma dialogica fatta di domande e risposte fra maestro e allievi. Si decretava così il successo di lungo periodo dei catechismi più o meno figurati, fermo restando il connubio fra istruzione e morale in essi contenuto che ritroveremo in altri contributi del volume.
Si tocca così il tema dei ‘costumi educativi’ che, fondati su valori potremmo dire condivisi, registrano varianti significative maturate in contesti politici diversi come nel caso delle città inglesi del Cinque-Seicento, oggetto del contributo di Philip Withington, Skill and Com-monwealth in Early Modern English Cities. Un personaggio apparente-mente mediocre come il fornaio James Wright nato a York nel 1571 è presentato da Withington in quanto tipico esempio della politica sociale inglese fra il 1580 e il 16�0 che mirava a differenziare lo status dei capifamiglia, ritenuti ‘per bene’ o ‘migliori’, destinatari di una ricca trattatistica che raccomandava modi di vivere e di comportarsi con-
���iv Introduzione
soni ad un Commonwealth pacifico e di successo, fondato sulla lealtà al sovrano, ma anche sulla disciplina personale e civica. Attraverso questa letteratura e tramite il suo coinvolgimento attivo nella vita parrocchiale e pubblica, James raffinò e radicò le sue responsabilità nelle associazioni e corporazioni economiche, nel consiglio cittadi-no, negli assessorati e giurie di York. In questo modo un semplice e onesto fornaio aveva imparato ad essere civil, rafforzando in vita il suo empowerment all’interno della comunità e guadagnandosi dopo morto un epitaffio in cui si alludeva esplicitamente alle sue qualità di civiltà, temperanza, parsimonia, controllo.
Una vicenda emblematica inserita nel quadro articolato della socie-tà corporativa di antico regime, porta a galla anche i complessi temi della cittadinanza e delle diverse regole adottate da una città all’altra, da uno stato all’altro, sia per gli autoctoni che per i forestieri.
L’altro aspetto che viene fuori dal saggio di Withington si colle-ga bene al tema affrontato subito dopo da Marina Roggero, Offerta e domanda di istruzione: processi di alfabetizzazione a confronto. James Wright aveva, pare consapevolmente, manifestato e praticato la sua esigenza di istruzione; in quanto appartenente ad un piccolo-medio ceto urbano non ebbe difficoltà a mettere a frutto la sua domanda di sapere con l’offerta disponibile. Marina Roggero, attraverso un’ampia riflessione critica sulla storiografia inglese, francese e italiana che si è occupata di alfabetizzazione, di literacy, mette a fuoco le difficoltà di ricostruire i motivi e le fasi della domanda di istruzione che risulta più sfuggente, variabile a seconda del ceto sociale e del genere. Nello stesso tempo l’autrice fa notare come non sia così facile ricostruire una mappa degli istituti di istruzione in Europa, dato il proliferare dell’offerta di Chiesa e Stato, mentre percorsi di sapere non canoniz-zato, quelli indicati da Lévi Strauss e De Certeau, convissero a lungo insieme a forme di ‘autodidassia’ e di alfabetismo di gruppo che ritro-veremo nel contributo di Dario Pfanner sulla cultura dell’entusiasmo nell’Inghilterra del Seicento. Ancora nel primo Ottocento la tria-de leggere-scrivere-far di conto non era stata così pacifica. Esisteva piuttosto un ‘meticciato culturale’ che nasceva dall’apprendimento o della sola lettura e/o della scrittura e dell’abaco. Quello che l’autrice tiene infine a chiarire riguarda il luogo comune storiografico che ha attribuito alla maggiore alfabetizzazione di alcuni paesi europei, come Scozia e Olanda, la conseguente diffusione della Riforma protestan-te, laddove un ruolo preminente ebbe la dimensione dell’ascolto di prediche, sermoni, e letture della Bibbia. Guardando ad esempio al
���v Introduzione
caso olandese, nel tempo lungo è facile intravedervi degli scarti di alfabetizzazione fra il periodo quattrocentesco della devotio moderna, ad alta alfabetizzazione, e quello successivo al 1579 quando si verifi-cò un ritardo imputabile alla scomparsa del libro per chi era rimasto cattolico.
Dall’Olanda dei semialfabeti è possibile passare a quella di un secolo dopo, rifugio prediletto dei freethinkers inglesi e degli ugonotti francesi, grazie al saggio di Camilla Hermanin, Il mercante filosofo nell’Olanda di fine Seicento: una formazione ‘senza canone’. Anche qui abbiamo di fronte un personaggio chiave, un modello di impolite learning, ovvero di autodidatta come il mercante inglese Benjamin Furly finora studia-to più come quacchero che come mediatore culturale. Collezionista di libri Furly fa parte di quello che è stato definito l’anglodutch moment della cultura europea. La sua biblioteca, ricca di �.000 libri, era aperta al pubblico degli intellettuali impegnati del tempo, da Pierre Bayle ad William Penn. Furly stesso utilizzava i suoi libri convinto assertore di una knowledge into politics particolarmente sentita in quella società engagée priva di modelli di riferimento causati dal crescente provincia-lismo della cultura accademica e di corte. L’opera di Caspar Barleus, Mercator sapiens, già dal 163� aveva aperto la strada alla necessità di valorizzare anche i saperi tecnici e il commercio. La biblioteca di Furly metteva a disposizione dei dotti i testi necessari al ‘sapere di tutto’, promuovendo confronti su temi trasgressivi e attuali e dunque, come sottolinea la Hermanin, orientandosi diversamente dalle solite regole del commercium litterarium della Repubblica delle lettere.
Da questo esempio di bibliotheca universalis borghese è possibile stabilire delle analogie col caso delle biblioteche patrizie veneziane oggetto del contributo di Antonella Barzazi, Tra erudizione e politica: biblioteche a Venezia nel Settecento. Dopo la perdita di Candia nel 1669 nel patriziato veneziano subentrano nuove famiglie sia mercantili che di origine militare desiderose di fare nuove letture. Ma una svolta si-gnificativa è rappresentata dalla biblioteca dell’erudito Apostolo Zeno aperta al pubblico, luogo di formazione e di esperienze autodidatte e alternative a quelle scolastiche. La frequentazione che precettori ec-clesiastici avevano delle case patrizie veneziane e che giovani nobili avevano dei conventi, dove si tenevano lezioni pubbliche e private, attivò una sorta di circuito virtuoso fatto di letture, di scambi di libri che familiarizzavano laici ed ecclesiastici alle opere di Galileo o di Newton. Questa situazione si modificò col declino politico europeo di
���vi Introduzione
Venezia finché la crisi dell’erudizione non sfociò, dopo le soppressioni napoleoniche, nella formazione di librerie specializzate come avveni-va altrove. Una specializzazione che corrispondeva al progressivo inse-rimento nella società e negli apparati statali non solo delle tradizionali professioni liberali, giuridica o medica, ma anche dell’attività intel-lettuale umanistica e delle nuove professioni tecniche di architetti, ingegneri, agronomi.
Prima del 1773, anno della soppressione della Compagnia di Gesù gli esperimenti pedagogici della Compagnia fervevano a livello plane-tario, ma nella vecchia Europa cresceva già l’insofferenza per curricula di studi prestabiliti non più consoni alle esigenze di mutamenti sociali in atto; dopo essere partiti dalle scuole di abaco fiorentine, chiudiamo la sessione dedicata ai luoghi, figure ed usi del sapere con i progetti di accademie francesi analizzati da Andrea Bruschi nel saggio Au-delà du Collège: un nouveau rôle pédagogique pour le vernaculaire dans les projets d’académies pour la noblesse (France 1577-1640). Militari, ministri reali e nobili commercianti sono i nuovi attori sociali che Bruschi indica fra i destinatari di una serie di progetti di istituzioni accademiche at-tuati in Francia a partire dal 1577 con Pierre de la Primaudaye. Al centro dei vari progetti c’è la battaglia per l’introduzione della lingua volgare come utile al servizio della monarchia. Sarà il medico sacer-dote Nicolas Le Gras a condurla a buon fine dopo il 16��. Personag-gio inquieto, processato nel 1667 dall’inquisizione di Lima per avere tentato di fondare una setta di guaritori-predicatori ispirati a Cristo e agli Apostoli, Le Gras considerava latino e greco lingue morte e sosteneva l’apprendimento delle lingue non attraverso precetti, ma con l’uso.
Il tema della lingua e in particolare delle lingue moderne vis a vis con l’impero del latino delineato da Francoise Waquet7� ritorna con forza nella seconda sessione dedicata ai saperi in movimento. Ad inau-gurarla era stata la relazione di Adam Manikowski su Come rilasciare precise informazioni e soddisfare l’umana curiosità? Mercanti, diplomatici, élites aristocatiche tra Italia e Polonia nel XVI e XVII secolo; purtroppo Manikowski non ha potuto consegnare il suo contributo per la stampa che certo avrebbe chiarito quei meccanismi di comunicazione e di
7� Cfr. F. Waquet, Le latine ou l’Empire d’un signe (XV-XX siècle), Paris, Albin Michel 1998; trad.it, Latino. L’impero di un segno, Milano, Feltrinelli �00�.
���vii Introduzione
circolazione di notizie e lessici tecnici che derivano dalla necessità di riferire la realtà di società diverse da quella di origine73.
Il saggio di Jean Boutier, Compétence internationale, émergence d’une ‘profession’ et circulation des savoirs: le tuteur aristocratique dans l’An-gleterre du XVIIe siècle, esordisce con il riferimento a Francis Bacon sostenitore del viaggio come ‘scuola del mondo’, forma di istruzione per un giovane, viaggio che Bacon stesso compì recandosi in Francia dal 1576 al 1579. Boutier tiene subito a distinguere il precettore do-mestico dal tutor. I precettori privati, come abbiamo visto dagli studi di Black, erano presenti anche nelle famiglie mercantili fiorentine del Tre-Quattrocento, e ancor di più in quelle europee del Settecento stu-diate da Patrizia Del Piano e di cui tra poco parleremo. Prendendo spunto dal dipinto conservato al Louvre e attribuito a Claude Lefebre (1637-1675), Un précepteur et son élève, Boutier sottolinea il rapporto intenso fra maestro e allievo trasmesso dal gioco intenso di sguardi reso dal pittore; mutatis mutandis, lo stesso gioco di sguardi presente nei codici miniati degli Sforza sottolineava i valori dell’autorità e del-la sottomissione. In virtù del suo ruolo stanziale e autorevole il pre-cettore domestico formava uno scholar, mentre al tutor che seguiva il suo nobile pupillo nel Grand Tour erano richieste la conoscenza delle lingue, buone relazioni, conversazione brillante, conoscenze tecniche e geografiche. Boutier analizza alcune figure esemplari di tutors tra cui quella del barone prussiano Philip von Stosch, militare di stanza a Firenze nel 1757 e tutor apprezzato per essere detentore di un nuovo sapere, quello del connaisseur che si intende di arte, archeologia, anti-quaria. Un gruppo a sé occupano i tutori protestanti francesi emigrati in Inghilterra dopo la revoca dell’Editto di Nantes del 1683; tra questi Pierre Coste, il traduttore di Locke.
Tra Francia, Inghilterra e Olanda, a partire dalla prima rivoluzione inglese e dopo la revoca dell’editto di Nantes, si creò un fertile humus di circolazione di esperienze, di testi, di autori. Questa mobilità forzata produsse anche la nascita di una professione nuova, quella dell’intel-
73 Per una comparazione cfr. R. Mazzei, ‘Itinera mercatorum’. Circolazione di uo-mini e beni nell’Europa centro-orientale 1550-1650, Lucca, M. Pacini Fazzi 1999; un esempio di come si formassero figure di funzionari in grado di fornire informazioni tecniche utili al governo dello stato è in Il viaggio di istruzione di Pietro Guerrini 1682-1686. Edizione della corrispondenza e dei disegni di un inviato di Cosimo III dei Medici, a cura di F. Martelli, Firenze, Olschki �005.
���viii Introduzione
lettuale militante portata al successo da Bayle e dalle sue Nouvelles de la République des Lettres7�. Il saggio di Patrizia Delpiano, Precettori e allievi nel Settecento: la circolazione dei saperi in Italia e in Europa, integra le con-clusioni di Boutier, approfondendo il ruolo dei precettori domestici che le famiglie aristocratiche italiane continuavano a prediligere rispetto a spazi pubblici di apprendimento considerati possibili luoghi di deprava-zione. L’autrice solleva a questo riguardo il problema della censura che ancora nel pieno Settecento colpiva sia l’insegnamento privato che quello pubblico, mentre antiche motivazioni religiose e morali distin-guevano i percorsi formativi di uomini e donne. Come caso eccezionale viene ricordata Paolina Leopardi che fu educata alla stregua dei fratelli maschi, ma altrettanto potrebbe dirsi di quanto avveniva nelle corti italiane di fine Seicento, non ultima la corte dei Medici. Altro tema da approfondire quello della provenienza sociale e delle carriere dei pre-cettori privati che, se di umili origini e reclutati in famiglie altolocate e prestigiose, avevano buone chances di promozione. Anche la Delpiano sottolinea infine l’importanza della traduzione-circolazione di testi let-terari grazie a precettori che svolgevano la loro attività all’estero come nel caso di Paolo Rolli che esportò in lingua inglese Boccaccio, Areti-no, Ariosto, autori proibiti in Italia, mentre Ange Goudar a Napoli nel 1767 fece circolare una grammatica francese per italiani.
Il problema dei testi ritorna nel contributo di Nicola Michelassi Comici dell’arte e ‘musici di fortuna’. Le compagnie itineranti e la trasfor-mazione dei testi teatrali. Entriamo così nel campo dei mestieri di cui certamente l’attore è tra i più antichi sebbene privo di statuti, di re-gole codificate. Gli storici hanno definito il teatro «un’arte sociale» e il mestiere dell’attore «in continua relazione con tante altre istan-ze che intervengono nel processo»: la committenza, la compagnia, il drammaturgo, il pubblico, e anche il regista. Gli operatori teatrali sarebbero, perciò, i meno liberi di agire, condizionati dal meccanismo dell’organizzazione che produce lo spettacolo75. Michelassi si concen-
7� Cfr. F. Wild, Nouveau public, nouveaux savoirs à la fin du XVIIe siècle: les Nou-velles de la République de Lettres et le Dictionnaire de Bayle, in La transmission du savoir cit., pp. 501-51�; nella messe di studi su Bayle cfr. L’Europa religiosa in Pierre Bayle, a cura di M. Rosa, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», �007.
75 Cfr. L. Allegri, L’arte e il mestiere. L’attore teatrale dall’antichità a oggi, Roma, Carocci �005, in part. pp. �09-�11, e Allegri et al., Breve storia del teatro per imma-gini, Roma, Carocci �008.
���i� Introduzione
tra sulla commedia dell’arte e sull’opera in musica che costituirono il nucleo del teatro barocco in Italia per dimostrare che sia i canovacci della commedia che i libretti d’opera erano alla fine secondari all’al-lestimento e all’esecuzione dello spettacolo. I testi teatrali venivano trasformati a contatto col palcoscenico e con le varianti introdotte dalla memoria; l’autore ribadisce che di questo si deve tenere ben con-to nell’edizione critica dei testi; l’improvvisazione seguiva i gusti, gli umori di un pubblico sempre diverso come diverse erano le città e i paesi dove le compagnie itineravano in mezzo a mille peripezie.
L’itineranza e il contatto con altri popoli e culture è un tema che da tempo ha attratto gli storici impegnati su vari fronti a definire i proble-mi dell’alterità,di costumi, di idee, di fede religiosa76.
Un caso esemplare di come il vecchio continente si confrontasse non solo col Nuovo Mondo, ma con civiltà più antiche è quello ana-lizzato da Ines Županov, Professional Missionary and Orientalist Curator; Paulinus a S. Bartholomaeo in India and Rome (18th-19th Century).
Paolino (17�8-1806) carmelitano scalzo, missionario nel sud del’In-dia per la Congregazione di Propaganda fide fra il 1776 e il 1789, fu autore della prima grammatica di sanscrito stampata in Europa e del Viaggio alle Indie orientali pubblicato nel 1796. Il frate conosceva le lingue orientali prima di partire per Kerala dove si accorgerà della dif-ficoltà di rendere la traduzione lessicale, la fonetica e l’ortografia del sanscrito in altro alfabeto. Ines Zupanov compara l’orientalismo bri-tannico con quello dei missionari cattolici postridentini la cui cultura è stata generalmente giudicata obsoleta e decadente. Lo studio delle opere stampate e dei numerosi manoscritti lasciati da Paolino consen-tono all’autrice di ricostruire l’originalità di questa esperienza alla luce di altre testimonianze a cominciare da quella del mercante fiorentino Filippo Sassetti trasferitosi a Goa dal 1583. Il carmelitano sosteneva che arti e scienze fossero venute all’Europa dall’India; la conoscenza di antichi testi teologici e botanici in lingua originale gli consentì di raggiungere le conclusioni scientifiche dell’orientalista britannico William Jonse; unica differenza fra i due fu la possibiltità per Jones di studiare i materiali raccolti stando a Calcutta dove esisteva una learned society, mentre Paolino lo farà dopo il ritorno a Roma dove viveva il suo patrono, cardinale Stefano Borgia grande collezionista di
76 Tra i lavori più recenti e di ampio respiro cfr. Scoperta e conquista del Nuovo Mondo, a cura di F. Cantù, Roma, Viella �007.
�l Introduzione
documenti e oggetti indiani raccolti nel suo Museo di Velletri. L’indo-logia comparativa di Paolino non ebbe tuttavia seguito in Italia anche se il suo metodo misto, attaccato da Inglesi e Francesi, mirava da un lato a conciliare la tesi della concordanza delle idee filosofiche e reli-giose dell’India con la cronologia e l’etnologia mosaica e dall’altro a perseguire il metodo erudito sperimentato con successo anche dagli orientalisti britannici.
La vicenda e l’opera del missionario Paolino si collocano quasi alla fine di un percorso che aveva portato la teologia, regina delle scienze, a servirsi di materie ausiliarie, come la storia, l’antiquaria, la cronologia, la filologia. Ma chi era il teologo e come un antico sapere, ancorato all’immobilità, poteva inserirsi nell’evolversi delle conoscenze umane? Lo vedremo dai contributi di Simona Negruzzo e di Paolo Broggio che fanno parte della terza ed ultima sessione del convegno e del volume, inaugurata dalla relazione di Chiara Lastraioli, A proposito di ‘saperi alternativi’: la propaganda del Cinquecento tra opuscoli, fogli volanti ed altri ephemera. Subito l’autrice cerca di chiarire che cosa significhi sapere alternativo, stampa alternativa, badando a sottolineare come tutto fosse abbastanza relativo tanto che se il libello luterano Pasquil-lus germanicus, apparso in Germania nel 15�6, non fu alternativo in quel contesto lo fu nella traduzione francese Le Pasquille d’Alemagne comparsa nello stesso anno raggiungendo un pubblico di cattolici e calvinisti. Dopo aver ricordato una solida tradizione storiografica euro-pea che si è occupata della cultura scritta fra semialfabeti e analfabeti – da Armando Petrucci, a Antonio Rotondò, a Ugo Rozzo, a Ottavia Niccoli a Raymund Wilhelm – Chiara Lastraioli fa notare come in area fiamminga e italiana i libelli di propaganda religiosa fossero meno diffusi, mentre lo erano gli opuscoli giuridici, medici, farmacologici, astronomici, encomiastici, satirici, rivolti ad un pubblico non sempre colto di cui facevano parte anche le donne come destinatarie di ope-rette devozionali o di santini, abachi, manuali di cucito e ricamo, di cosmetica. Testi di divertissement o di volgarizzazione di saperi diversi ebbero un fiorente mercato editoriale a Venezia, Lione, Parigi, Roma e Ginevra. Fogli a stampa e manoscritti non sempre veicolavano, come si è accennato, saperi davvero innovativi o alternativi al sapere dotto, ma in certe occasioni servirono a scatenare dei veri e propri dibattiti a distanza come quello scoppiato tra il 15�1 e il 15�9 fra medici italiani e francesi sull’uso e gli effetti terapeutico-dietetici dell’aceto; dibattito che culminò nel Pasquil antiparadoxhe del medico lionese Pierre Tolet difensore dell’inventio contro le auctoritates.
�li Introduzione
Nell’agone europeo animato dalle guerre degli uomini di lettere, non furono infrequenti rivendicazioni fra opposte scuole di pensiero che facevano capo anche al progressivo affermarsi di malcelate iden-tità nazionali. La teologia, stessa conobbe questo processo dovendo ad un certo punto decidere se essere romana, spagnola o altro ancora. Simona Negruzzo ci introduce nel percorso di questo sapere antico a proposito di Teologia ‘vissuta’, teologia professata tra Medioevo ed Età moderna. Un percorso che, cominciato con l’apostolo Giovanni, defi-nito ‘teologo’, arriva attraverso sant’Anselmo, Abelardo, Alberto Ma-gno e san Tommaso a fare della teologia una disciplina insegnata, e del teologo qualcuno che insegna la scienza di Dio ‘professandola’. Grazie anche ad un ricco apparato iconografico, Simona Negruzzo fa vedere come si sia evoluta l’immagine dei teologi sia protestanti che cattolici che in virtù della professionalizzazione della disciplina si trovarono assimilati a giuristi, avvocati, medici nell’adozione dell’abito di colo-re nero. Uniformità, compromessi, cambiamenti segnarono la storia del sapere teologico che registrò ad esempio significative differenze tra Francia e Italia a proposito della funzione svolta dai teologi-giuristi nei tribunali.
Il contributo di Paolo Broggio, Una professione al servizio della Re-staurazione cattolica: teologia e teologi ‘romani’ tra Cinquecento e Seicento, ci riporta nel vivo delle screpolature provocate nel tempo in un sapere che pareva monolitico e decisamente subalterno solo alla rivelazione divina. Nel clima del neoguelfismo del pontificato di Leone XIII il gesuita Giovanni Cornoldi volle ridefinire la paternità italiana, anzi romana, della filosofia e della teologia partendo da san Tommaso sen-za considerare il rinnovamento prodotto dalla seconda scolastica del Seicento soprattutto in Francia e Spagna. Broggio sottolinea come la teologia romana del secondo Cinquecento mirasse ad arginare la Riforma e l’evangelismo italiano creando con Pio V, domenicano, e Sisto V, francescano, due poli di riferimento con la proclamazione di san Tommaso e di san Bonaventura dottori della chiesa. Successiva-mente attorno alle dispute teologiche relative alla dottrina de auxiliis, nuove controversie insorsero tra Roma e la Spagna dove una nutrita schiera di consultori teologi di corte agiva anche contro le istanze cu-riali romane. Si pose così il problema di scegliere teologi adatti per una ‘teologia romanizzata’, che sapessero risolvere situazioni di contenzio-so dottrinale e giuridico, evitando l’intervento del clero regolare fin troppo coinvolto nei conflitti insorti attorno al dogma dell’Immaco-lata concezione.
�lii Introduzione
Il rapporto col divino non implicò tuttavia solo cimenti dottrinali ai livelli più alti soggetti ad un incrocio serrato di saperi e competen-ze, ma suscitò anche aspirazioni verso un sapere autodidatta fondato soltanto sulla conoscenza del testo biblico. È questo il caso analizzato da Dario Pfanner, Un sapere ‘eccentrico’: la cultura dell’entusiasmo nel-l’Inghilterra di metà Seicento. L’entusiasmo, la cui etimologia significa ‘ispirazione divina’, tra Cinque e Seicento coincise o si confuse con l’invasamento religioso settario che in Inghilterra contraddistinse trinitari, ‘mortalisti’, avversari della proprietà privata ecc. Formatisi sulla Bibbia, gli autodidatti entusiasti inglesi avevano comunque delle conoscenze di base di latino, ebraico, teologia, filosofia, mentre il 70% della popolazione maschile inglese era quasi del tutto analfabeta. Il pulpito e la stampa, le traduzioni di testi mistici, la circolazione di vo-lantini attivavano quel flusso costante fra comunicazione orale e scrit-ta che abbiamo visto attraversare molte situazioni, ma che in questo caso si colorava di tinte più forti nella prospettiva di un rinnovamento civile realizzabile tramite l’illuminazione interiore.
Dal sapere eccentrico di un Inghilterra nel pieno di rivolgimenti politici interni, alla Spagna dei letrados ci conduce il saggio di Paola Volpini Fra diritto comune e pratiche del diritto: i saperi dei giuristi nella Spagna del Seicento, saperi nuovi? Nonostante che con le leggi di Toro del 1505 si proibisse il riferimento al diritto comune europeo, i giuristi spagnoli, sia nei loro trattati che nelle aule universitarie continuavano ad applicarlo. Il diritto regio, d’altra parte, entrava ormai più spesso in conflitto col diritto comune anche se nella pratica in uso nei tribunali era il diritto regio ad essere seguito. Una fiorente letteratura spagnola sull’insegnamento del diritto a Salamanca ed una serie di studi inter-nazionali sul tema del diritto patrio77 fanno da sfondo alla ricerca di Paola Volpini che bene mette in risalto la figura e l’opera del letrado Juan Bautista Larrea; attraverso fogli volanti in lingua castigliana, Lar-rea produsse allegazioni dette porcones (pro/contro), a difesa dei diritti regi in questioni fiscali o militari, appellandosi spesso a regole e doveri desueti. Lo scollamento fra diritto comune e patrio si sancì soprattutto nella pratica criminale, ma in Spagna, a differenza che in altri stati, cattedre di diritto patrio nacquero soltanto dal 1807.
77 Cfr. Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), Roma, Viel-la �006.
�liii Introduzione
Fra continuità e resistenze, fra teoria e prassi, il sapere giuridico re-gistrava delle novità che Antonio Trampus ha illustrato nel suo con-tributo Un sapere giuridico nuovo: aspetti della cultura costituzionale nel-l’Italia del Settecento. Notando la caratteristica di sacralità attribuita alla carta costituzionale come insieme di norme superiori e inviolabili rispetto alle leggi ordinarie, Trampus ci riporta in quel contesto de-lineato da Pfanner e da Marina Roggero nel suo libro Le carte piene di sogni (�006) a proposito delle leggi dell’Antico Testamento ispira-te da Dio fino a Mosè, tanto da indurre alcuni a mangiare le pagine della Bibbia per assimilare al meglio tale ispirazione. Dal legislatore sacerdote al legislatore laico la scrittura della legge rispondeva ad una missione pedagogica tanto che nell’Assemblea costituente francese la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino fu alla fine formulata come un testo catechistico preceduto da un breve preambolo. Scrit-tura, catechismi, fogli volanti ritornano, dunque, sotto forme diverse come veicoli di trasmissione di saperi nuovi che non potevano tutta-via non richiamarsi ad antichi modelli, come appunto la legge mo-saica dei dieci comandamenti che, per ordine e brevità, ispirò anche i dibattiti degli intellettuali e i progetti costituzionali del Settecento italiano. L’esperienza della rivoluzione corsa di Pasquale Paoli e del suo progetto di costituzione furono un modello, insieme alla costitu-zione americana, per analoghi progetti ideati dal granduca di Toscana Pietro Leopoldo a partire dal 1778. Nell’orizzonte del sapere giuridico entravano ora nuovi riferimenti e si stabilivano terreni di confronto tra opinione pubblica e governi, tra vecchio e Nuovo Mondo.
La geografia dei saperi a questo punto appare davvero frastagliata, mostrando scarti e varie linee di fuga che poi ritornano ad un punto comune. In questo senso il saggio di Giovanna Cifoletti, Il matematico nel Cinquecento. Il caso francese, ci mostra come in Francia ci fosse un ritardo della matematica algebrica e dell’astronomia, che in qualche caso era praticata anche dalle donne. Un svolta si ebbe da quando Oronce Finé fu incaricato di insegnare matematica applicata nel Col-lège Royal fondato nel 1531 dal re Francesco I. Finé, prima medico e cosmografo, si rifaceva a dei modelli: il matematico toscano Luca Pacioli e lo spagnolo Juan Martines Pedernales Siliceo che aveva stu-diato a Parigi. Un passo importante compiuto da Finé e dal suo allievo Peletier fu la traduzione dal latino in francese umanistico di opere scientifiche destinate alla corte, all’aristocrazia, ai mercanti colti e alle accademie di cui ha trattato Andrea Bruschi. A Peletier va anche il merito di avere fatto precedere le sue tre opere algebriche composte
�liv Introduzione
tra il 15�9 e il 1555 da riflessioni riguardanti la storia della matematica e del suo declino come parte del declino generale del sapere. Il mate-matico francese portava come esempio attuale il caso della medicina scaduta nella ‘ciarlataneria’.
Ma chi era il ‘ciarlatano’? Era davvero un impostore? Davide Gentil-core dà una risposta al quesito nel suo contributo Il sapere ciarlatanesco. Ciarlatani, «fogli volanti» e medicina nell’Italia moderna. I documenti d’archivio studiati da Gentilcore, in particolare quelli dell’archivio di Mantova, mostrano come il ciarlatano fosse tutt’altro che ignorante di medicina, ma potesse considerarsi un semiletterato. Il lessico usato nei volantini per pubblicizzare i farmaci è l’italiano e non il dialetto e i te-sti sono composti per fare sfoggio di sapere come fosse quello dei dotti veri. Si tratta di un’ostentazione calcolata per fare colpo e per vendere rimedi, ma le patenti e i privilegi che i ciarlatani elencano nei loro volantini sono autentici come Gentilcore ha potuto verificare sulle fonti. L’approccio verso il pubblico è quello teatrale dei comici dell’ar-te, le parole ripetute, gli schemi dei volantini fissi per tre secoli come accadeva nei lunari e almanacchi. In sostanza il sapere ciarlatanesco era un sapere conservatore dimostrato anche dai soliti ingredienti usa-ti nei rimedi propagandati.
Sulla possibilità di rinnovarsi in senso professionale per un sapere da sempre considerato un sottoprodotto di saperi superstiziosi, l’oste-tricia, si interroga Daniela Tinková ne La (Re)naissance de l’obstréti-cien/ne:une nouvelle ‘profession’ dans l’Europe des Lumières? Exemple de deux régions habsbourgeoises: la Toscane et la Bohême (ca. 1750-1820). Fu con l’affermarsi delle tesi popolazioniste dell’epoca dei Lumi che si cominciò a considerare l’ostetricia come funzionale al controllo sulla quantità e qualità dei cittadini. Iniziarono così i Grands tours degli stu-denti di medicina verso le scuole europee di ostetricia, a Parigi, Stra-sburgo, Göttingen, Kassel, Vienna, Bologna, Firenze. Non solo donne, ma anche uomini intrapresero lo studio di quest’arte che prevedeva ora degli esami di profitto; motivazioni morali fecero sì che a Firenze i corsi seguiti da uomini e donne fossero separati, mentre a Praga si atti-varono corsi misti in lingua cèca, dato che le allieve non conoscevano né il latino, né il tedesco. Il problema della lingua è dunque ricorrente come quello della tipologia dei testi adottati per insegnare, che in ge-nere, sia a Praga che a Firenze, erano dei catechismi e dialoghetti da apprendere a memoria. Altro dato comune, a parte alcune differenze culturali fra le due città segnalate dall’autrice, riguarda la diversa op-
�lv Introduzione
portunità che le levatrici e gli ostetrici avevano di intervenire sulle partorienti a seconda della difficoltà del caso.
Il saggio di Jürgen Schlumbohm, tradotto dal’inglese da Adelisa Malena, e dedicato a La prassi dell’educazione pratica. Studenti uomi-ni e apprendiste donne nella clinica ostetrica dell’Università di Gottinga, 1792-1815, aggiunge ulteriori elementi ai temi trattati dalla Tinková attraverso l’analisi delle ricche fonti della clinica ostetrica di Göt-tingen sorta nel 1751, Schlumbohm si pone il problema di come avvenisse l’educazione clinica diffusa in Europa dai primi anni del-l’Ottocento e oggetto di studio dal 1995. Dai registri e dai diari con-servati riesce a ricostruire in dettaglio orari, modalità, frequenza delle lezioni, assistenza ai travagli e ai parti, soprattutto a partire dal pe-riodo dell’insegnamento ostetrico del professor Friedrick Benjamin Osiander (1759-18��) Se le differenze di genere già riscontrate a Praga e a Firenze si riproponevano a Göttingen, e soltanto agli stu-denti uomini era consentito di fare interventi col forcipe, alla fine era alle aspiranti levatrici che capitava più spesso di assistere ai parti. Schlumbohm giudica questo un dato sorprendente anche se sottoli-nea l’esemplarità dell’ospedale di Göttingen rispetto a quello francese di Port Royal dove nessun studente uomo fu ammesso fino alla fine dell’Ottocento.
Non caratterizzato da differenze di genere così spiccate, il sapere musicale prima della nascita dei conservatori era improntato soprat-tutto all’intenso rapporto fra maestri e allievi. Ce ne parla Antonella Bartoloni in Musicisti, musica e diletto in Europa tra Sei e Settecento: un sapere familiare? L’educazione musicale avveniva per lo più in ambito familiare coinvolgendo vari strati sociali, uomini e donne, mentre era il mecenatismo di corte a fornire il consueto trampolino di lan-cio per musicisti di talento. Come nella pittura, ci furono dinastie di musicisti che tennero scuole, mentre tra XV e XVIII secolo si raffinò anche la trattatistica, passando da semplice grammatica per suonare uno strumento a guida di interpretazione musicale rivolta a professio-nisti. L’autrice a questo riguardo illustra il trattato di Giuseppe Tartini sul suono del violino, arricchito di parti tecniche sull’abbellimento del trillo.
Il contributo di Stefano Lorenzetti, I loci communes della musica rinascimentale: sintagmi di un sapere metaforologico, chiude idealmente questo volume, rievocando il mito e le metafore da cui ero partita. Leggendo in profondità alcuni testi del Cinque-Seicento Lorenzetti
�lvi Introduzione
trae da parole e immagini la «metastoria del sapere musicale», sape-re metafisico, sapere immobile, la cui natura simbolica è in grado di riscrivere altri saperi, filosofici, religiosi, politici, matematici. Non a caso cita il trattato di Innocenzo Ringhieri, Cento giuochi liberali et d’ingegno (1551), per il parallelo tra la musica e la virtù della tempe-ranza intesa come armonia di corde. È proprio nel come che sta il nes-so fra metafore e suono; ‘sentire come’ significava che l’ascolto della musica poteva essere influenzato dalla sua natura simbolica, cosa che si accentuò nell’epoca della Controriforma. L’educazione musicale e il governo dell’anima, secondo Lorenzetti, concorrevano a formare la mentalità musicale di antico regime.
Sulla dimensione rarefatta evocata da musica e memoria, da ascolto e da immaginazione, si chiude e si riapre anche il cerchio largo dei percorsi del sapere che sono stati affrontati con originalità da studiosi di varia formazione; mi auguro che la lettura del volume susciti il de-siderio di saperne di più.
RingraziamentiUn sentito grazie va al professor Mario Rosa che ha in certo senso ‘ispirato’
il convegno frutto anche di molti anni di lavoro comune nei seminari di Storia moderna della Scuola Normale.
Con gratitudine voglio infine ricordare tutti coloro che sia nell’organizza-zione del convegno che nella redazione del volume sono stati con me gene-rosi di consigli e aiuti:
Luigi Allegri, Rita Bacchiddu, Egle Becchi, Lina Bolzoni, Elena Brambilla, Stefano Calonaci, Maria Teresa Ciampolini, Giuliana Crevatin, Marie Ma-dleine Compère, Anthony Grafton, Giulia Gray, Martina Grasselli, Niccolò Guasti, Adelisa Malena, Giovanni Malpelo, Rolando Minuti, Alessandro Pa-store, Isabella Ricco, Antonella Romano, Paola Volpini, Francoise Waquet.
Ringrazio la Scuola Normale che ha approvato e finanziato il convegno, consentendone la pubblicazione degli atti nelle Edizioni della Normale al cui staff va la mia riconoscenza.
Sulla pagina web http://saperi-a-confronto.sns.it sono disponibili gli abstracts in ita-liano e inglese delle varie relazioni e i curricula degli autori e dei presidenti di sessione.
Dedico questo libro a Giulia e a Marcello ancora in cammino sulle strade del sa-pere...
Maria Pia Paoli