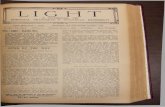Un viaggio estatico nell’aldilà nel processo per la canonizzazione di Nicola da Tolentino, in...
Transcript of Un viaggio estatico nell’aldilà nel processo per la canonizzazione di Nicola da Tolentino, in...
HAGIOLOGICASTUDI PER RÉGINALD GRÉGOIRE
a cura di
ALESSANDRA BARTOLOMEI ROMAGNOLI
UGO PAOLI
PIERANTONIO PIATTI
Tomo II
B I B L I O T H E C A M O N T I S F A N I31
F A B R I A N OMONASTERO SAN SILVESTRO ABATE
2 0 1 2
BIBLIOTHECA MONTISFANI
Direttore
Lorenzo Sena
Segretario
Ugo Paoli
Comitato Di reDazione
Giuseppe Avarucci, Bruno Bianchi, Leonardo Bux, Pio Cartechini, VincenzoFattorini, Manuela Morosin, Emilia Saracco Previdi, Cleto Tuderti
ISBN 978-88-87151-48-0
Tutti i diritti riservati
© Copyright by monaStero San SilveStro abate - fabriano
printeD in italy
Luigi Canetti
UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀNEL PROCESSO PER LA CANONIZZAZIONE
DI NICOLA DA TOLENTINO
I sogni o meglio i racconti di sogni e visioni sono a tutti gli ef-fetti vettori della memoria culturale, e quindi fonti di prim’ordine per lo storico (1). È una funzione che si evidenzia in modo particolare nel caso dei sogni iatromantici, una tra le modalità più diffuse dell’incuba-zione terapeutica, il sonno finalizzato al conseguimento della salute e ritualmente indotto presso un santuario, anche se negli ultimi secoli del Medioevo la visione iatromantica tendeva più spesso a manifestarsi al paziente anche altrove (solitamente nella sua casa), e quindi la visita al luogo sacro veniva a coincidere con l’eventuale scioglimento del voto (2). In ogni caso, come avveniva nel mondo antico e presso altre civiltà, la guarigione si riteneva propiziata dalle indicazioni fornite in sogno
(1) Tra i lavori più significativi degli ultimi decenni segnalo, in particolare, le miscellanee Il sogno e le civiltà umane, a cura di V. Lanternari, Bari 1966; I linguaggi del sogno, a cura di V. BranCa - C. OssOLa - s. resnik, Firenze 1984; I sogni nel Medioevo, a cura di t. gregOry, Roma 1985 (Lessico intellettuale europeo, 35); Il sogno in Grecia, a cura di g. guidOrizzi, Roma-Bari 1988; Sogni, visioni e profezie nell’antico cristianesimo. Atti del XVII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, in « Augustinianum », 29 (1989); Dream Cultures. Explorations in the Comparative History of Dreaming, eds. d. shuLman - g. g. strOumsa, New York-Oxford 1999; Sogni e visioni nel mondo indo-mediterraneo / Dreams and Visions in the Indo-Mediterranean World, a cura di d. BOCCassini, Alessandria 2009; nonché gli studi di C. BriLLante, Studi sulla rappresentazione del sogno nella Grecia antica, Palermo 1991; s. F. kruger, Dreaming in the Middle Ages, Cambridge 1992 (trad. it., Il sogno nel Medioevo, Mila-no 1996); J.-CL. sChmitt, Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d’anthropologie médiévale, Paris 2001; P. COx miLLer, Il sogno nella tarda antichità, trad. it. Roma 2004 (ed. originale 1994); W. harris, Dreams and Experience in Classical Antiquity, Cambridge (Mass.) - London 2009. Sul concetto di memoria culturale, cf. J. assmann, La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche (1992), trad. it. Torino 1997.
(2) Questa tendenza viene esaminata in L. Canetti, « Le divinazioni de’ nostri so-gni » (Conv. II, viii, 13). Forme di oniromantica nelle culture del Medioevo, in Il mondo errante. Dante fra letteratura, eresia e storia. Atti del convegno internazionale (Bertinoro, 13-16 settembre 2010), a cura di L. PaOLini - m. VegLia, in corso di stampa.
994 LUIGI CANETTI
al devoto da un operatore divino – nel Medioevo era in genere un santo o la Vergine, nell’Antichità erano Asclepio, Iside e altre divinità guaritrici – e poi messe in atto da quest’ultimo in stato di veglia (3). Se è quasi inevitabile affrontare un tema come questo in un’ottica compa-rativa molto ampia (ritorno più avanti su questo punto di metodo), è tuttavia opportuno dislocare ogni volta l’esame delle fonti all’interno di serie e contesti ben determinati.
Il caso di cui vado a occuparmi affiora per la prima volta in forma scritta, e in versioni divergenti per alcuni dettagli non trascurabili, negli atti del processo per la canonizzazione del frate agostiniano Nicola da Tolentino (1245-1305), svoltosi nelle Marche tra il luglio e il settembre 1325. Si tratta di un autentico psicodramma escatologico e visionario; diciamo pure il racconto di un viaggio dell’anima nell’altro mondo (4). La vicenda riguarda ser Venturino da Parma, un notaio attivo a Peru-gia ma, a quanto è dato capire dalla sua stessa deposizione e da quella del padre di lui (raccolte entrambe a Camerino, nel refettorio dei frati agostiniani, il 24 agosto 1325) (5), ammalatosi quand’era residente a Ma-cerata in veste di « officialis domini marchionis » ossia notaio al servizio di Amelio di Lautrec, rettore della Marca anconetana e promotore, fra gli altri, della causa per la canonizzazione di frate Nicola (6). I parenti
(3) L’altra modalità caratteristica dell’incubazione iatrica fin dall’antichità è quel-la – meno diffusa nell’Occidente latino ma ancora assai praticata a Bisanzio e nel Sud Italia – in cui la guarigione viene attribuita all’intervento diretto del santo medico durante il sogno, e che però si ritrova occasionalmente anche nell’agiografia dell’Occidente latino e ancora nei processi di canonizzazione del basso Medioevo e dell’età moderna. Rinvio per tutto questo ad alcuni miei lavori recenti dedicati alle funzioni ermeneutiche e te-rapeutiche delle visioni in sogno nella cultura medievale, nei quali si discutono a fondo le fonti, la metodologia e la bibliografia sull’incubazione: cf. L. Canetti, L’incubazione cristiana tra Antichità e Medioevo, in « Rivista di Storia del Cristianesimo », 7 (2010), 1, pp. 149-180; id., Sogno e terapia nel Medioevo latino, in Terapie e guarigioni. Atti del Convegno internazionale (Ariano Irpino, 5-7 ottobre 2008), a cura di a. ParaviCini Ba-gLiani, Firenze 2010 (Edizione Nazionale « La Scuola Medica Salernitana », 6), pp. 25-54.
(4) Su questo tipo di esperienze e di documenti letterari, cf. J. amat, Songes et visions: l’au-delà dans la littérature latine tardive, Paris 1985; Visioni del’aldilà in Occi-dente. Fonti, modelli, testi, a cura di m. P. CiCCarese, Firenze 1987 (Biblioteca patri-stica, 8); i. P. COuLianO, Esperienze dell’estasi dall’Ellenismo al Medioevo (1984), trad. it. Bari 1989; id., I viaggi dell’anima. Sogni, visioni, estasi, Milano 1991; I viaggiatori del Paradiso, Mistici, visionari, sognatori alla ricerca dell’aldilà prima di Dante, a cura di G. tardiOLa, Firenze 1993; CL. CarOzzi, Le voyage de l’âme dans l’au-delà d’après la littérature latine (Ve-XIIIe siècle), Rome 1994 (CÉFR, 189).
(5) Cf. Il processo di canonizzazione di S. Nicola da Tolentino, a cura di n. OC-ChiOni, Roma 1984 (d’ora in poi: PCNT), pp. 152-154 (XXXII testis); pp. 155-159 (XXXIII testis).
(6) In base a queste due deposizioni non è possibile precisare l’anno della malattia: si veda PCNT, p. 154, r. 66, p. 156, r. 65 (« anno Domini MCCC... », con lacune e/o rasure nei mss.). Sullo svolgimento e gli esiti dell’inchiesta fa ora il punto Le. PeLLe-
995UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀ
di lui e lo stesso protagonista credono e dichiarano che Venturino sia stato miracolosamente richiamato in vita (o quantomeno sottratto alla condizione di moribondo) per intercessione della Vergine e di Nicola da Tolentino. Dopo un mese di malattia (quattro mesi, invece, secondo la moglie Nicoluccia Cardoli detta Coluccia, testimone dello stesso evento in un’altra seduta del processo) (7), tutti l’avevano dato per spacciato. Si parla di « apostemata » nella zona inguinale e di « parasismus fe-bris », cioè di febbre acuta, e si descrivono nel dettaglio tutti i sintomi – perdita dei sensi e delle pulsazioni, naso e piedi congelati – che agli occhi dei tre medici che l’avevano visitato, tutti ricordati per nome, fa-cevano ormai apparire Venturino « ut mortuus » suggerendo di allestire i preparativi per le esequie, descritti anch’essi con insolita dovizia di dettagli (8). Si trattava, in effetti, di una famiglia dell’alta borghesia fun-zionariale umbro-marchigiana (9). Il padre, il notaio perugino Gigliolo, com’egli stesso dichiara di fronte alla commissione d’indagine (10), aveva già predisposto ogni cosa per i funerali e per la sepoltura nella chiesa di S. Francesco a Macerata, anche se in quei frangenti, insieme alla nuora, si rivolse alla Vergine Maria affinché, per i meriti e le preghiere del beato Nicola, gli venisse restituito il figlio vivo, se non era ancora morto, o addirittura risorto, nel caso già fosse morto. In cambio pro-mise di offrire sull’arca sepolcrale di Nicola « unam ymaginem cere ad similitudinem ipsius ser Venturini », oltre agli abiti di lana e di lino del figlio stesso e al digiuno perpetuo ad ogni vigilia dell’anniversario della morte del beato (11). La mattina dopo Venturino riprese a respirare e a parlare chiedendo anche di mangiare qualcosa (12).
grini, Nicola da Tolentino: dalle origini del culto alla canonizzazione (1305-1446), in San Nicola da Tolentino nell’arte. Corpus iconografico, I, a cura di V. PaCe - r. tOLLO, Tolentino 2005, pp. 103-113; sulle immediate circostanze del processo del 1325, e il suo contesto sociale e istituzionale, cf. ora d. Lett, Un procès de canonisation au Moyen Âge. Essai d’histoire sociale, Paris 2008.
(7) Cf. PCNT, pp. 473-476 (CCXIX testis).(8) Dalla cera ai panni neri vedovili, dalla convocazione dei frati Minori di Ma-
cerata per l’ufficio della veglia funebre allo scavo della fossa per il rito di sepoltura (cf. PCNT, p. 153).
(9) Cf. P. L. FaLasChi, Società e istituzioni nella Marca attraverso il processo di canonizzazione di San Nicola da Tolentino (1325), in San Nicola, Tolentino, le Marche. Contributi e ricerche sul Processo (a. 1325) per la canonizzazione di San Nicola da To-lentino. Atti del Convegno internazionale di studi (Tolentino, 4-6 settembre 1985), Tolentino 1987, pp. 97-126, in part. 116 sgg.; Lett, Un procès de canonisation, pp. 300 sgg., 317 sg.
(10) I vescovi Federico di Senigallia e Tommaso da Cesena.(11) Cf. PCNT, p. 153; Nicoluccia si limita invece a ricordare il voto dei panni
che aveva indosso il marito il marito (ibid., p. 474).(12) Ibid., p. 154.
996 LUIGI CANETTI
Nella successiva deposizione, dopo aver confermato i dettagli del-la malattia, dello svenimento, dei funerali e del voto così come se li era sentiti raccontare dal padre e dalla moglie, è lo stesso Venturino a rievocare sotto giuramento la sua straordinaria esperienza (13). Sono proprio i commissari – si badi – che lo sollecitano a riferire se « gli era successo qualcosa » (« aliquid scit sibi contigisse ») e « dov’era stato il suo spirito » (« ubi stetisse spiritus eius ») nelle ore intercorse tra la sua morte apparente e quella in cui si diceva che era stato resuscitato (14). Dopo aver perso i sensi a séguito del parossismo influenzale, verso l’ora vespertina, ebbe la sensazione di trovarsi o meglio vide se stesso, nudo, in un autentico giardino di delizie sensoriali – all’elemento topico dell’erba verdeggiante si aggiunge l’insistita sottolineatura della gloria e del piacere di camminare in quel viridario. Qui, dopo parecchio tempo, gli si manifesta una figura, che poi si palesa come l’arcangelo Gabriele, annunciandogli che Dio lo salverà. Il nunzio divino si pone poi sopra la spalla destra del protagonista, che ringraziando Dio per tanta grazia e gloria ricevuta ha l’impressione di genuflettersi e di piangere per la gioia. A quel punto il peso dell’angelo sulla sua spalla diventa insosteni-bile, quasi – dice – stesse reggendo una torre; e allora l’angelo si fa così leggero che al teste non sembra di avere in spalla nemmeno « unam par-vam avem » (15). Dopo avere precisato a Venturino che è stato inviato da Dio per dargli gioia e sollievo, l’angelo intona un canto talmente soave da fargli quasi dimenticare il piacere provato sino ad allora nel giardino. Lui lo implora di continuare con quella musica e l’angelo lo asseconda ancora per parecchio tempo ma, alla fine, ricorda a Venturino che or-mai deve fare ritorno al suo Dio. Il nostro, allora, prova a trattenergli un piede afferrandosi una spalla, ma l’angelo si dilegua augurandogli di restare con Dio. In quel momento Venturino ha l’impressione di ve-dere una grande luce che dura per qualche tempo, dopodiché si sente liberato dalla malattia e resuscitato dalla morte alla vita. Crede « pro firmo et certam fidem » che Dio gli abbia fatto e mostrato tutto ciò per i meriti, le preghiere e la santità del beato Nicola, e dice di avere raccontato queste cose alla moglie e ai presenti non appena riavutosi da quel sonno (16). Ricorda infine che a sua moglie Nicoluccia, come lei stessa gli aveva raccontato, mentre pregava quella notte stessa dinnanzi
(13) Ibid., pp. 155 sgg. (è la medesima seduta del processo: Camerino, refettorio dei frati agostiniani, 24 agosto 1325).
(14) Ibid., p. 157, r. 87 sg.(15) Ibid., p. 158, r. 113. Si ricordi questo dettaglio dell’uccello, perché poi, anche
se in forma molto diversa, ritornerà nella deposizione della moglie.(16) Ibid., p. 158, r. 139 sgg.
997UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀ
a una « tabula depicta » del Signore e della Madonna implorati da lei di liberare il marito per l’intercessione e i meriti del beato Nicola, apparve un gran bagliore di luce, e una voce la rassicurò dicendole che Nicola le aveva restituito il marito (17).
Fra tutte la più concreta, e ricca di dettagli inediti, è la versione della moglie Nicoluccia, alla quale fu concesso, insieme a un altro testimone come lei gravemente infermo, di deporre in via eccezionale a Perugia, il 26 agosto, di fronte all’abate Ugolino di S. Pietro (18). Il privilegio sembra peraltro dovuto anche alla consapevolezza della straor-dinarietà del miracolo, che i commissari non a caso compendiano nella lettera d’incarico al sottocommissario perugino, data a San Ginesio il 22 di agosto (19). La stessa Coluccia afferma che il marito e il suocero si erano messi in viaggio quattro giorni prima per recarsi a testimoniare a Camerino; si tratta infatti di un’inchiesta itinerante, e oltre che a To-lentino la commissione operò a San Ginesio, Camerino, San Severino e Macerata (20). Nemmeno la donna ricorda di preciso l’anno il mese e il giorno dell’episodio che riferisce ai commissari; ricorda bene soltanto la casa, la sua ubicazione e i nomi dei presenti alle varie fasi della vicenda, ma poi afferma che sono passati già ormai quattro anni da quando, a Macerata, si verificarono quegli eventi straordinari (e databili, dunque, al 1321). Altri dettagli inediti sono, fra l’altro, il ricordo dell’arrivo dei familiares del rettore della Marca per sigillare i libri del marito, secon-do la prassi dovuta in caso di morte di un pubblico ufficiale (21). Più che un dettaglio psicologico, e quasi un sintomo, direi, dell’incipiente assunzione di un abito rituale, di cui la donna non sembra o meglio non risulta affatto consapevole, è il rilievo secondo cui, entrata nella sua camera dopo il disbrigo degli ultimi preparativi funebri, Nicoluccia « sibi videbatur in corde tristitiam, et inter se ipsam plurimum videbatur quomodo non tristabatur in corde suo de morte sui viri predicti; et in hac admiratione – che renderei: in questo stato d’animo di sconcerto
(17) Di grande interesse, in questa descrizione, è l’uso insistito della forma « visum sibi est » o « visum sibi fuit » (ibid., p. 157 sg.), tipico dei racconti in prima persona delle visioni oniriche di carattere estatico e incubatorio.
(18) Cf. PCNT, p. 8, n. 212.(19) Per il particolare della commissione rogatoria e la lettera d’incarico, cf. ibid.,
p. 467 sg.(20) « Interrogata quanto tempore vixit et sanus fuit ser Venturinus predictus post
predicta, respondit quod vixit per IV annos post predicta et adhuc vivit ut creditur quia non vidit eum iam sunt IV dies, quia ipse et pater ipsius iverunt ad dominos Senogaliensem et Cesanatem episcopos inquisitores presentis negotii ad perhibendum testimonium super miraculo supradicto fratris Nicolai » (PCNT, p. 476, rr. 89 sgg.).
(21) PCNT, p. 474, rr. 34-36.
998 LUIGI CANETTI
per l’assenza di un vero cordoglio – aliqualiter obdormivit » (22). Dunque la donna si addormenta. Allora, « ut sibi videbatur », un uccello (« que-dam avis ») le si avvicina e le percuote violentemente la faccia e il naso, e per molto tempo dopo l’accaduto lei dice di avere conservato sul naso i segni di quell’urto; e in quel momento ha l’impressione di udire una voce che le annuncia che Nicola e l’arcangelo Gabriele le stanno riportando il marito (23). Risvegliatasi, stupefatta della visione, si dirige ancora trasognata verso il cadavere dell’uomo (non ha ancora motivo di non pensarlo morto), e sulle prime non sa bene cosa fare; ma poi, preso coraggio, gli si avvicina e pone una guancia accanto a quella di lui: una goccia di cera fusa, dalla candela che lei regge, scivola sulla mano del cadavere, che la ritira « quasi lexum » (come si fosse scotta-to, direi) (24); e a quel punto ser Venturino apre la bocca sospirando e sbavando, al punto che lei gli infila una mano in bocca per liberarlo da tutta quella « spuma » (25). È assai dettagliata anche la descrizione delle fasi successive al primo risveglio: il marito non parla per cinque giorni; lei tenta di nutrirlo con zucchero mischiato a « man(nam) Christi » (26), che lui assorbe di buon grado; l’uomo prende a manipolare e – sembra d’intendere – a tentare di strapparsi i vestiti di dosso, e lei teme che lui lo faccia per la paura di morire (forse, chissà, stava ancora tentando di trattenere l’angelo o avvertiva il fastidio degli abiti dopo quella singolare esperienza di felice nudità). Lui, parlando ancora a fatica, si lamenta per essere stato strappato da quel « pulzerimo prato » (27) pieno di rose e di fiori profumati, in compagnia della Vergine Maria, dell’angelo Gabriele e del santo frate Nicola. Poi la moglie elenca per nome tutti coloro, soprattutto frati, che erano stati presenti al suo dialogo con il marito redivivo (28).
(22) PCNT, p. 474 sg., rr. 37-40.(23) PCNT, p. 475, rr. 40-42. Una avis era già apparsa nella testimonianza di
Venturino (ibid., p. 158, r. 113), ma a proposito dell’angelo che insisteva sulla sua spalla quando, da pesante che era, divenne leggero come un uccello. Nella abbreviatio curiale degli atti del processo viene obliterato il particolare del dolore persistente, e la comparsa improvvisa dell’uccello che percuote il naso di Coluccia sembra quasi pre-figurare l’azione dell’angelo Gabriele, che insieme a san Nicola le riporta l’anima del marito, quasi che l’animale-guida della viaggiatrice sciamanica venga sostituito con il più rassicurante angelo ‘rivelatore’ (quello, si badi, che nei Vangeli visita in sogno Giusep-pe dopo aver annunciato a Maria il concepimento divino), qui tuttavia sotto mentite spoglie micaeliche di psicopompo; cf. Il Compendio del processo di canonizzazione di san Nicola, a cura di r. CiCCOni, Tolentino 2002, p. 56.
(24) PCNT, p. 475, r. 52.(25) Ibid., r. 57.(26) Ibid., r. 61.(27) Ibid., r. 69 sg. (meno vulgariter, è un « pulchro viridario » a r. 67).(28) Cf. PCNT, p. 476.
999UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀ
Se in questa versione dell’episodio Nicoluccia indossa le vesti di mediatrice visionaria o addirittura di agente sciamanica nel processo di guarigione del marito (29), nulla di tutto ciò traspare nella Storia di san Nicola compilata da frate Pietro da Monterubbiano a pochi mesi di distanza (1326), e parte anch’essa del dossier ufficiale inoltrato al papa per la fase curiale del processo (30). Il suo racconto è una versione edulcorata e molto succinta del miracolo di Venturino (31): non si parla dell’assopimento della moglie né tantomeno dell’uccello che l’avrebbe ri-svegliata, ma si accenna soltanto al gran bagliore di luce che entrò dalla finestra nella camera mentre la donna pregava Nicola per la resurrezione del marito; prodigio di cui fu avvertita dalle persone che vegliavano il morto nella sala adiacente. Il marito ‘risorto’ racconta della visione perché sollecitato da alcuni « curiosi magnates » a riferire loro dov’era stato mentre la sua anima era uscita dal corpo (32). Non tradurrei però curiosi con ‘saccenti’ (33), perché la curiositas poteva forse essere sincera, tutt’al più vagamente maliziosa, e forse perfino teologicamente motivata dall’alta frequenza di discussioni scolastiche, nonché di sermoni, exempla e raffigurazioni istoriate, che in quegli anni tentavano di rappresentare la condizione delle anime dei trapassati in attesa del giudizio finale (34). Semmai, si può notare l’aggiunta del particolare dei magnates, per cui la domanda, secondo l’agiografo, non fu rivolta a Venturino dai giudici inquirenti bensì da alcuni laici potenti, il che forse poteva consentire a Pietro di dislocare su un fronte sociologico meno imbarazzante, più prevedibile e più gestibile, una curiositas intorno ad argomenti troppo delicati per non rimanere confinati alle disquisizioni dei chierici, an-che se poi l’agiografo, coerente al fine della sua opera, sembra quasi derubricare l’indiscrezione alla malizia di quanti, contrariamente al miracolato, si ostinano a non credere all’intervento del santo (35). Tant’è
(29) Ritorno fra poco su questo punto cruciale.(30) L’opera dell’agiografo agostiniano si può ora finalmente leggere nell’eccellente
edizione critica, con traduzione italiana e commento, procurata da Francesco Santi: Petrus de mOnte ruBianO, Historia beati Nicolai de Tolentino, a cura di F. santi, Tolentino 2007 (Monografie storiche agostiniane, n. s. 6); d’ora in avanti = HBN.
(31) HBN, cap. XVII, 27-48, pp. 166 sgg.(32) HBN, p. 168 sg. (39-40).(33) HBN, p. 169 e nota 13 (Santi).(34) Basterà qui il rinvio all’opera monumentale di C. trOttmann, La vision béati-
fique des disputes scolastiques à sa définition par Benoît XII, Rome 1995 (BÉFAR, 289); per l’iconografia, si veda almeno J. BasChet, Les justices de l’au-delà: les représentations de l’enfer en France et en Italie, XII e-XV e siècles, Rome 1993 (BÉFAR, 279).
(35) Tant’è che Pietro si lascia sfuggire (o forse ostenta) tutti i suoi pregiudizi in una tipica e compiaciuta deplorazione agiografica: « O incredulitas stulta et stultae incredulitatis praesumptio » (HBN, p. 168.39).
1000 LUIGI CANETTI
che Pietro, dopo aver deplorato la presunzione e l’incredulità dei ma-gnates, afferma che la domanda si tramutò in occasione edificante atta a manifestare la potenza divina tramite la grazia accordata al santo, ciò di cui il racconto paradisiaco e floreale di Venturino – fiori e profumi sono quasi un inserto di genere – reca ora testimonianza. La descrizione del locus amoenus e dell’incontro con quello che diventa un bellissimo fanciullo poi palesatosi come semplice angelo affidato alla sua custodia, dalla cui bocca usciva un canto di lode, appare filtrata dall’esigenza di abbreviare, allegorizzare e smussare. Sul particolare del peso dell’angelo sulla spalla di Venturino si sorvola dicendo però che era stato un an-nuncio della pesantezza della vita a cui il nostro stava per essere ricon-dotto (36); e la luce apparsa alla finestra della moglie avrebbe coinciso con l’ora in cui l’angelo (si badi) ricondusse Venturino al mondo « cum splendore nimio » (37).
Questo nucleo di documenti mi sembra già un buon viatico per sollevare qualche domanda inquietante sulle stratificazioni e gli intrec-ci di tempi, spazi, agenti e vettori della memoria culturale in seno a una determinata tradizione etnolinguistica ed etnoscientifica (38). Cosa significa la persistenza (quantomeno apparente) di schemi e dispositivi onirici molto simili anche a grande distanza di spazio e di tempo? Come dobbiamo coniugare, e come dislocare nello spazio sociale e/o letterario, il riproporsi e, al tempo stesso, il trasformarsi di una partitura rituale per quanto elastica essa si presenti? E questa elasticità, questo grado debole di codificazione, che cosa può indicare? Forza o debolezza di un paradigma? Capacità strategica di adattamento? Marginalità sociale e/o culturale? Tale elasticità, oltre a indurmi da qualche tempo a rifiutare definizioni strette e perciò fuorvianti di cosa sia l’incubazione rituale (39), esprime invero un carattere strutturale dei dispositivi onirico-visionari e divinatorî in quanto strumenti di accertamento dei segni divini e in quanto dispositivi mnemostorici di controllo e interpretazione della realtà sociale e del vissuto individuale, specie nei momenti critici di interfaccia con l’altro mondo (la nascita, la malattia, la morte). I riti divinatorî presuppongono e, al tempo stesso, hanno lo scopo preci-puo di reinstaurare ogni volta il mondo invisibile rendendo tangibile
(36) HBN, p. 170.44.(37) Ibid., 48.(38) Per una riflessione più ampia su questi concetti, introdotti da Giorgio Raimon-
do Cardona, si veda ora g. COsta, La sirena di Archimede. Etnolinguistica comparata e tradizione preplatonica, Alessandria 2008, pp. 63-72.
(39) Rinvio ai miei studi citt. supra, note 2-3; e al lavoro in preparazione, per « Hagiographica », 20 (2013), Rituali e storia. L’incubazione dal Tardoantico al Medioevo.
1001UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀ
l’interfaccia con l’universo visibile (40). Questa funzione strutturante e cosmologica della divinazione (ma si potrebbe dire della religione tout court) noi moderni tendiamo a sottovalutarla a discapito di una più superficiale, ossia l’utilizzo ideologico dei segni divini come strumento di lotta politico-religiosa, dimenticando che quest’ultima possibilità è sempre e comunque subordinata alla prima (41).
Partirei subito con un rilievo quasi scontato, la ridondanza agiogra-fica del carisma profetico-visionario di san Nicola in vita e in morte. In vita: visione presaga dei genitori; apparizioni di angeli, visioni estatiche delle anime del Purgatorio (e, in un caso, addirittura dell’Inferno) per liberare le anime in pena di un confratello e di un cugino malemor-to; premonizioni e indizi luminosi (la visione dell’astro apparsogli una prima volta in sogno, che avrebbe infine indicato a tutti il luogo della sepoltura del santo) (42). In morte: oltre al caso di Venturino, si regi-strano due grandi miracoli oniromantici (si parla di visio e di apparitio in sompniis) a beneficio della cieca Anfelixia (Anfelisia Adambi da To-lentino) e della morta apparente Filippa, figlia di Barraca da Fermo (43), entrambi rappresentati a Tolentino negli affreschi delle pareti Nord e Ovest del cappellone della basilica del santo (44). Insomma, fin da vivo
(40) Cf. t. nathan, Manifesto per una psicopatologia scientifica (1995), trad. it. in t. nathan - i. stengers, Medici e stregoni, Torino 1996, pp. 24, 65.
(41) Si vedano ancora i contributi di J.-P. Vernant et al., raccolti in Divination et rationalité, Paris 1974; e il fasc. monografico dedicato a Divination et révelation dans le monde grec et romain (a cura di n. BeLayChe - J. rüPke) della « Revue de l’histoire des religions », 224 (2007), 2, pp. 139-271. Per l’epoca medievale e moderna, con proiezioni anche sul mondo contemporaneo, rinvio all’importante miscellanea The “Vision Thing”. Studing Divine Intervention, ed. by W. a. Christian Jr. - g. kLaniCzay, Budapest 2009 (Collegium Budapest Workshops Series, 18).
(42) Cf. HBN, pp. 98 sgg., 106 sgg., 112 sgg., 127 sgg. (43) Cf. PCNT, pp. 91 sgg., 214, 232, 566; e pp. 378 sgg., 418 sg. (la clamorosa
resurrezione di Filippa, figlia di Barraca da Fermo, viene datata al 1306 dal frate che racconta l’episodio: la madre, nonostante la febbre continua che annunciava il prossimo decesso, l’aveva votata a san Nicola, che di notte le appare in sogno e le annuncia che la figlia non sarebbe morta facendola poi clamorosamente risorgere durante il funerale). Altri miracoli post mortem di ‘resurrezione’: Mita moglie di Lippo (HBN, pp. 164 sgg.); il fanciullo Cicco (PCNT, p. 331 sg.; HBN, p. 166); il neonato non ancora battezzato da Tommaso da Tolentino (PCNT, pp. 551sgg.; HBN, p. 164); il figlioletto di Nina e Ranaldo di Macerata (HBN, p. 166); il bimbo della donna di San Genesio finito nel canale del mulino (HBN, pp. 170 sgg.); l’impiccato (suicida) di Belforte (cf. PCNT, pp. 279 sgg.; HBN, p. 172).
(44) Rinvio alle superbe riproduzioni a piena pagina contenute nel volume Il Cap-pellone di San Nicola a Tolentino, a cura del Centro studi Agostino Trapé, Prefazione di m. BOskOvits, testi di P. BeLLini et al., Cinisello Balsamo 1992; cf. a. dunLOP, Gli affreschi del Cappellone di San Nicola: un modello mancato?, in San Nicola da Tolentino nell’arte, pp. 47-63, in part. 48, 52-53; cenni anche in Lett, Un procès de canonisation, p. 59 sg. Ritorno fra poco sulla questione delle immagini.
1002 LUIGI CANETTI
frate Nicola aveva una particolare familiarità visionaria con il mondo dei morti e con le anime del Purgatorio. Va però precisato che la qualità iatromantica in morte di un santo non è necessariamente correlata ai suoi carismi divinatorî in vita, anche se una relazione analogica, più che causale, poteva pur sempre esserci, e ciò vale in maniera particolare per l’età bassomedievale. Sogni e visioni premonitrici, riferiti non solo al futuro ma anche al presente e al passato, rappresentano la cauzione agiografica che attesta ed esprime la dimensione profetica e sciamanica dell’uomo divino: sogni ammonitorî e divinatorî in vita, visioni prenatali e premortuarie, viaggi estatici nell’aldilà. Il sogno oracolare può espri-mere l’efficacia e l’accresciuto potere d’intercessione del santo dopo la morte, ma sul piano teologico o antropologico non sussiste alcuna relazione necessaria, per quanto occasionalmente documentabile, tra il carisma visionario in vita e l’attitudine ad apparire in sogno dopo la morte (45).
Gli anni Venti e Trenta del Trecento sono segnati da un acceso di-battito teologico sull’aldilà e, in particolare, sui temi della visione beatifica e del potere d’intercessione della chiesa e dei santi a favore delle anime del Purgatorio (46). Ad Avignone, negli anni di Giovanni XXII (1316-1334), quando in curia papale si prendevano in esame gli atti dei pro-cessi si dava grande importanza alle apparizioni post mortem del santo, tanto più se accompagnate da un miracolo – è il caso di Venturino – come indizio sicuro di santità (47). Lo dimostrano, fra l’altro, alcune an-notazioni a margine dei manoscritti contenenti l’abbreviatio del processo di Nicola da Tolentino, una delle quali si riferisce proprio al prodigio occorso a Venturino (48). Le grandi raccolte di exempla, le vite dei santi e i sermoni di quest’epoca – e ormai sempre più anche i grandi cicli di affreschi delle chiese mendicanti e le tavole istoriate – ridondano di
(45) Fonti e discussioni sul punto nel mio studio citato Le « divinazioni de’ nostri sogni ».
(46) Cf. trOttmann, La vision béatifique, e il volume miscellaneo Escatologia, aldilà, purgatorio, culto dei morti. L’esperienza di san Nicola da Tolentino. Contesto culturale, evoluzione teologica, testimonianze iconografiche e prassi pastorale, a cura della Biblioteca Egidiana, Presentazione di C. D. FOnseCa, Tolentino 2006.
(47) A patto che si trattasse di un personaggio ‘cauzionato’; del resto, i processi di canonizzazione riguardavano a quell’epoca ormai quasi esclusivamente candidati di tal fatta; cf. a. VauChez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age d’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Rome 1981, 19882 (BÉFAR, 241), pp. 408 sg., 455 sgg., 472 sgg.; g. BarOne, La santità nei processi di canonizzazione del Trecento, in Santi e santità nel secolo XIV, Assisi 1989 (Convegni SISF, 15), pp. 55-78.
(48) Cf. Il Compendio del processo di canonizzazione, pp. 56-57: « ... (miraculum) cum apparitione... »; cf. Lett, Un procès de canonisation, p. 387 sg.
1003UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀ
episodi che mettono in scena le più svariate modalità di comunicazione tra i vivi e i morti (specie attraverso il sogno e la visione), e al centro delle preoccupazioni pastorali sembra essere proprio il problema della gestione e del controllo dell’intercessione a favore delle anime in pena da parte del ceto clericale (49). Sempre in quest’epoca – lo documenta bene il processo per san Nicola – l’offerta di oggetti votivi a carattere mimetico (come statuette in cera a grandezza naturale o in miniatura, definite ymagines), e non più dunque soltanto metonimico (abiti, cintu-re, stampelle, ceri mensurati ecc.), sembra esprimere un’istanza di ne-goziazione diretta con il santo del proprio destino individuale in questo e nell’altro mondo (50). I voti si depongono ormai sempre più anche di fronte all’immagine dipinta del santo, e non più necessariamente sulla sua tomba. Un certo Paolo di Alegio afferma che nella chiesa degli Agostiniani di Norcia si conservava una cona, ossia una pala d’altare (ancona) o una tavola mobile (icona) in cui era stata dipinta l’immagine di frate Nicola, e di fronte ad essa venivano deposte continuamente im-magini votive di cera. Per liberare il suo figliolo da una spina di pesce che aveva ingoiato, il fedele umbro aveva fatto voto di recarsi presso la tomba di Nicola a Tolentino e deporvi una ymago di cera, cioè una statuetta antropomorfa che rappresentava il bambino (51). Una donna di Macerata promette di deporre una camicia del figliolo risanato su una figura dipinta a somiglianza del santo, che si trovava nella chiesa degli agostiniani a Tolentino (52). Il voto, in un altro caso, consiste nella pro-
(49) Con particolare attenzione al contesto religioso e istituzionale della devozione per san Nicola da Tolentino nei secoli XIV e XV, segnalo il saggio di P. Piatti, « Mi-serere turbae tam miserae ». Purgatorio e mitopoiesi mendicante: Agostiniani e Carmelitani garanti del suffragio, in Escatologia, aldilà, purgatorio, pp. 185-195. Più in generale, sono ancora fondamentali per questi temi i libri di J. ChiFFOLeau, La comptabilité de l’au-delà, les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320 – vers 1480), Rome 1980, nuova ed. Paris 2011, pp. 369 sgg., 402 sgg.; e di J. Le gOFF, La nascita del Purgatorio (1981), trad. it. Torino 1982, pp. 327 sgg.
(50) Si fa ora il punto in L. Canetti, « Facendosi fare di cera ». Euristica dell’eccedenza e della somiglianza tra Medioevo ed Età moderna, in « Micrologus. Nature, Sciences, and Medieval Societies », 20 (2012), pp. 323-356, ill. 40.
(51) Cf. PCNT, p. 455, r. 8. I restauri dei primi anni Ottanta del Novecento ci hanno fortunatamente restituito alcune di queste sagome votive cerate, che in origine comprendevano anche raffigurazioni di arti, di mani, di piedi, di organi, e perfino di animali e di navi; cf. F. BisOgni, La scultura in cera nel Medioevo, in « Iconographica », 1 (2000), pp. 1-15, in part. 1, 6-8, 12; Lett, Un procès de canonisation, p. 58. Si offri-vano anche i tradizionali ceri mensurati sull’arca del santo e, assai più di rado, pani di cera bruta del peso del malato, oltre ai suoi indumenti e talvolta anche piccole somme di denaro; sulle tipologie votive caratteristiche di quei decenni, si veda l’indagine siste-matica condotta da P. A. sigaL, L’ex-voto au Moyen Âge dans les regions du Nord-Ouest de la Méditerranée (XIIe-XVe siècles), in « Provence historique », 33 (1983), pp. 13-29.
(52) PCNT, p. 412.
1004 LUIGI CANETTI
messa di far eseguire e appendere una pictura a somiglianza (similitudo) di san Nicola (53).
Non va poi dimenticato che sono questi gli anni della prima dif-fusione del poema dantesco nell’Italia centro-settentrionale; e si sa che la Commedia avrebbe esercitato un influsso cospicuo, anche attraverso la sua mediazione iconografica, sulla riplasmazione dell’immaginario dell’aldilà anche tra i laici colti (ceto mercantile e notarile, quello cui appartiene il nostro Venturino) e tra gli illetterati (54).
Il miracolo di Venturino non è raffigurato negli affreschi del cap-pellone; se nel processo il rapporto tra miracoli in vita e in morte è di 26 a 275, delle tredici scene dipinte relative a Nicola cinque sono dedicate alla sua infanzia e giovinezza (ricordo quella dell’angelo che gli porge la corona della virtù e quella, purtroppo lacunosa, dell’angelo che libera dalle fiamme del Purgatorio l’anima di frate Pellegrino in seguito alle preghiere di san Nicola) (55); la sesta è quella dei funerali del santo, mentre le sette seguenti raffigurano miracoli post mortem, compresi i due che ho ricordato prima. Alcuni episodi sono databili intorno al 1306: questa evidenza, che Fabio Bisogni assumeva come un indizio a sostegno dell’ipotesi che gli affreschi precedano il processo e siano quin-di da ritenersi la prima ‘agiografia’ del santo (56), non osta però a una datazione dei dipinti posteriore agli anni Trenta/Quaranta del Trecento, e comunque successiva alla diffusione del culto e al processo di cano-nizzazione (57). Il miracolo di Venturino, al di là di probabili difficoltà tecniche e compositive (58), sarebbe stato inadatto a una raffigurazione in contesto ufficiale visto il carattere poco convenzionale del dispositivo terapeutico e dell’immaginario salvifico che vi si mettono in scena: già
(53) Ibid., p. 421.(54) Oltre a BasChet, Les justices de l’au-delà, si vedrà ora l’eccellente monografia
di r. Pini, Le giustizie dipinte. La raffigurazione della giustizia nella Bologna rinasci-mentale, Bologna 2011.
(55) Cf. L. marshaLL, Visualizzare l’intercessione: san Nicola da Tolentino e il Pur-gatorio nell’arte italiana prima del Concilio di Trento, in Escatologia, aldilà, purgatorio, pp. 137-148.
(56) Cf. F. BisOgni, Gli inizi dell’iconografia di Nicola a Tolentino e gli affreschi del Cappellone, in San Nicola, Tolentino, le Marche, pp. 255-296, in part. 288 sgg.
(57) Mi sembrano convincenti, in proposito, le argomentazioni di s. rOmanO, Gli affreschi del Cappellone: il programma, in Arte e spiritualità negli ordini mendicanti: gli agostiniani e il Cappellone di San Nicola a Tolentino, a cura del Centro Studi Agostino Trapè, Tolentino 1992, pp. 257-270.
(58) Del resto, se tra i miracoli post mortem furono scelti quelli più rappresentativi delle varie tipologie taumaturgiche, tra gli episodi di ‘resurrezione’ si volle dare grande rilievo al caso di Filippa, e forse su tale scelta influì anche un tentativo di emulazione dei miracoli di s. Nicola di Bari, come ha ben rilevato la Romano, Gli affreschi del Cappellone, p. 261.
1005UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀ
in Pietro di Monterubbiano (1326), l’arcangelo Gabriele, con il quale Venturino interagisce durante il suo soggiorno nell’aldilà, diventa un angelo qualsiasi, forse, come ben suggerisce Santi, in ottemperanza all’angelologia tomista ormai diffusa in quegli anni, che escludeva dalla funzione di custodia personale le potenze angeliche superiori (59).
In ogni caso, come ha rilevato Didier Lett, la diffusione popolare del culto, anzi, la conoscenza e l’interesse stesso per questo frate, non sembrano anteriori alla promozione, diciamo pure all’invenzione della sua memoria (1324) da parte degli Agostiniani in vista del processo di canonizzazione (1325). È stato dunque il processo ad instaurare (o se vogliamo, a rigenerare) la memoria e quindi la santità di Nicola, non viceversa (60). Quindi – possiamo forse azzardare – l’iniziativa dei frati, delle autorità locali e del papato ha involontariamente contribuito a riattivare anche i circuiti e i cronotopi di una memoria culturale più profonda, quella legata ai sogni iniziatici e ai sogni oracolari con finalità iatromantica, l’antichissimo dispositivo incubatorio, insomma. Nella memoria culturale esistono strati latenti, che hanno bisogno di un reagente, di un catalizzatore anche esterno per riaccendersi. Veicolati e trasmessi dalla parola, dall’immagine e dalla scrittura, quegli strati interagiscono, con i loro mitemi e iconemi, adattandosi a loro volta ma anche riplasmando quelli che possiamo ritenere adstrati (più che substrati e sovrastrati) depositatisi più di recente nella tradizione etno-linguistica e nella tradizione colta di una determinata società. Ciò che dimostra, io credo, una volta di più, come tra queste ultime non sussista un’opposizione assoluta ma si instaurino ogni volta relazioni complesse e multidirezionali. (E le azioni giudiziarie ecclesiastiche, da questo punto di vista, si rivelano quasi sempre un reagente e un catalizzatore ecce-zionalmente fertile; si pensi soltanto ai processi per stregoneria). Qui, un possibile strato latente sembra affiorare dal racconto di un sogno-visione che richiama, per molti versi, il viaggio onirico di iniziazione sciamanica (nel caso del marito), viaggio che spesso si verifica proprio in occasione di una malattia; ovvero (nel caso della moglie) il viaggio sciamanico nell’aldilà finalizzato alla cura della malattia o della posses-sione: l’uccello-guida o l’uccello-anima (angelo nel primo caso, spirito ritornante nell’altro) (61), il canto maliardo e sublime, e soprattutto il
(59) Cf. S. Theol. I, q. 112, a. 2; cf. santi in HBN, p. 171, n. 15. Esiste tutta-via una raffigurazione piuttosto anodina dell’episodio (ed ora molto lacunosa) negli affreschi seicenteschi del chiostro trecentesco, dovuti al pittore senigagliese Giovanni Anastasi (1653-1704).
(60) Così anche Lett, Un procès de canonisation, p. 64.(61) Vedi supra, nota 23 e contesto.
1006 LUIGI CANETTI
viaggio estatico nell’aldilà e la contesa con le potenze demoniache o il contatto con spiriti benevoli per conseguire la guarigione di un malato strappando il suo spirito periclitante ad una sorte avversa (62). C’è però, in effetti, un curioso sdoppiamento di funzione tra i due veggenti, ma-rito e moglie: nel caso di lei, se la cautela non ci ammonisse sul rischio di frettolose assimilazioni, sarebbe tentante pensare a uno sciamano con il suo uccello-guida o magari a un avatära medievale di una sirena o di un’arpia (63). Lo sdoppiamento, talvolta, può rintracciarsi anche in agiografia, per esempio nell’incubazione vicaria, dove il custode del santuario, come accadeva talvolta nel mondo antico, ovvero un monaco o un parente (spesso il genitore di un bambino) in ambiente cristiano, sogna ritualmente per conto del malato oppure vede semplicemente il malato mentre viene guarito dal santo o vede in sogno il santo che gli annuncia la guarigione del congiunto (64).
(62) Su questi temi la bibliografia è sterminata; oltre al classico m. eLiade, Lo scia-manismo e le tecniche dell’estasi (1952), trad. it. Roma 1974, pp. 53 sgg., 110 sgg., 239 sgg., segnalo soltanto la monografia di K. E. müLLer, Sciamanesimo. Guaritori, spiriti, rituali (1997), trad. it. Torino 2001, e la sintesi critica di E. COmBa, Antropologia delle religioni. Un’introduzione, Roma-Bari 2008, pp. 149-181; per la definitiva acquisizione del complesso mitico-rituale sciamanico alle culture autoctone dell’Europa protostorica, classica e medievale, è ora fondamentale COsta, La sirena di Archimede, pp. 96-160; cf. anche C. COrradi musi, Sciamanesimo in Eurasia. Dal mito alla tradizione, Roma 2008; sull’animale-guida e il viaggio nell’altro mondo è una miniera di temi e di fonti il libro di C. dOnà, Per le vie dell’altro mondo. L’animale guida e il mito del viaggio, Soveria Mannelli (Cz) 2003.
(63) « L’icona della donna uccello è un « segno » polivalente, che si presta a rappre-sentare diversi soggetti (Sirene, Arpie, Chere, incubi ecc.) », come osserva L. manCini, Il rovinoso incanto. Storie di Sirene antiche, Bologna 2005, p. 177 (ma si vedano anche le pp. 178-195, 199 sgg., sulle donne-uccello nel folklore mediterraneo classico, semitico e medievale: entità demoniche, ora seducenti ora mortali, si aggirano nelle zone liminali e spesso appaiono tra il sonno e la veglia, e fin dalla grecità più arcaica poterono assumere connotazioni psicofore e legate alla malìa del canto); dunque, non è detto che tale imma-gine si fosse reincarnata esclusivamente nel mostro giustiziere dei suicidi codificato nel XIII canto (vv. 10-15) dell’Inferno dantesco, che ne offre peraltro una trascrizione polimorfa, come ha mostrato S. gentiLi, « Ut canes infernales »: Cerbero e le Arpie in Dante, in I « monstra » nell’Inferno dantesco: tradizione e simbologie. Atti del XXXIII Convegno storico internazionale (Todi, 13-16 ottobre 1996), Spoleto 1997, pp. 177-203, in part. 194 sgg.
(64) Una ventina di anni prima, a Tolosa, durante il processo di canonizzazione per san Ludovico d’Angiò (1308), ricco anch’esso di attestazioni di miracoli incubatorii, fu registrata una singolare deposizione. Un mercante marsigliese diretto a Genova per vendere le sue anguille fu salvato dalla tempesta invocando san Ludovico; la moglie del naufrago, sempre durante le deposizione, sostiene che, proprio in quei frangenti (il sabato prima di Natale del 1297), lei stessa – a quanto è dato capire, in casa propria – « sompniaverat seu panteyzaverat quod eodem sero dictum maritum suum » e tutti quelli che si trovavano con lui sulla nave venissero sommersi dai flutti; il giorno successivo promise a san Ludovico che, se lui avesse salvato il marito dai marosi, gli avrebbe fatto dono di una barca di cera con tante immagini di cera (cioè statuette) quanti erano
1007UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀ
Già nel mondo antico il doppio sogno (o addirittura il sogno di-vinatorio fatto o meglio visto da un’intera comunità) aveva soprattutto una funzione probatoria rispetto alla veridicità del messaggio e all’og-gettività dell’esperienza onirica (65). Si ha l’impressione che il viaggio estatico di Venturino, che rivela molti tratti dell’itineranza sciamanica nell’altro mondo (anche il risveglio sembra richiamare il lento processo di ritorno dell’anima dello sciamano nel suo corpo addormentato), ven-ga vissuto in qualche modo in presa diretta, anche se inconsciamente, dalla moglie, anche lei dotata di una seconda vista: prima ella propizia con le sue preghiere, e poi registra come un sismografo sensibilissimo la concreta realizzazione di quegli eventi onirici, tant’è che su di lei si imprime fisicamente la traccia, direi la prova o meglio, freudianamente, l’apporto del viaggio quando l’uccello-anima del marito le va a sbattere in fronte e la ridesta dal sonno. Anche i racconti agiografici dei sogni incubatorî e oniromantici ostentano spesso questo elemento dell’appor-to, di una traccia reale dell’esperienza di un incontro con le potenze invisibili: le contusioni sul corpo del santo che ha lottato con i demoni, l’odore celestiale o sulfureo (a seconda dei casi), le cicatrici o le suture dell’intervento chirurgico dei santi medici, i calcoli renali espulsi e poi offerti come ex voto sull’altare del santo; e infine, la stessa evidenza di una guarigione vissuta e ostentata come traccia diretta dell’intervento risanatore degli agenti soprannaturali (66). Un elemento che accomuna questo racconto (soprattutto nella versione autoptica dovuta allo stesso Venturino) ai racconti di sogni iatromantici e oracolari è l’uso insistito della perifrasi « visum fuit sibi » o « videbatur sibi/ipsi » (67), da intendere non nel senso di ‘gli sembrava’ ma nel significato passivo di ‘vedeva se stesso mentre’, tipico dei contesti narrativi onirici, anche nella Comme-dia dantesca, come ha rilevato di recente Andrea Fassò (68). Secondo
gli uomini dell’equipaggio. E questo ella fece ed eseguì come aveva promesso. Qui certamente non si tratta di incubazione, ma è interessante che la veggente contribuisca al salvataggio del marito sintonizzandosi, per così dire, sulla stessa lunghezza d’onda miracolosa, facente capo al santo, alla quale si era affidato il marito; cf. Processus ca-nonizationis S. Ludovici episcopi Tholosani, cap. CLXXVII, in « Analecta Franciscana », VII, Ad Claras Aquas 1951, p. 229.
(65) Cf. m. dOrati - g. guidOrizzi, La letteratura incubatoria, in La letteratura di consumo nel mondo greco-latino, a cura di O. PeCere - a. stramagLia, Cassino 1996, pp. 343-371, in part. 363 sg.; m. Bettini, Alle porte dei sogni, Palermo 2009, pp. 142-144.
(66) Cf. Canetti, Sogno e terapia, p. 29.(67) Cf. PCNT, p. 157.(68) a. Fassò, Il letargo e il descensus: sull’ultimo canto del Paradiso (Bologna,
12 giugno 2009); ringrazio il collega Fassò per avere generosamente messo a mia disposizione il testo-base, ancora inedito, del seminario. Nella Commedia (ma già nella
1008 LUIGI CANETTI
Maurizio Bettini, inoltre, la costruzione personale ‘mi sembra’ derive-rebbe precisamente dall’esperienza onirica, in cui l’uso passivo di videor ha il senso di ‘mi vedevo’, ‘sono visto’, o anche ‘il tale o la tal cosa è visto/a da me’ (69). Indice, sul piano psicodinamico, di una esperienza di sdoppiamento e di uscita da sé come quella ritualmente vissuta dagli sciamani ovvero dai viaggiatori cristiani nell’aldilà, anche a prescindere da un eventuale incontro salvifico-terapeutico con potenze oracolari e taumaturgiche – e tali sono sono, in effetti, quei morti/non morti che il culto cristiano definisce santi.
Per decifrare la trama e i dettagli paesistici del viaggio estatico di Venturino non si devono trascurare i modelli letterari, purché la questione non si esaurisca nella ricerca di citazioni testuali ma venga declinata come elemento di una più vasta problematica: quella, cioè, di una una tradizione al cui interno andrà tenuta aperta l’ipotesi di una circolazione o meglio, di un’interazione fattiva dei molteplici piani dell’immaginario (testi scritti, racconti orali, immagini figurate, immagini oniriche). Si sogna quello che si vede (e quello che si crede), e si vede (o si crede di vedere) quello che si è sognato, come attestano fin dal mondo antico i sogni divinatorî i cui protagonisti, al risveglio, ricono-scono in un’immagine dipinta o scolpita il soggetto o i soggetti sognati ovvero sognano gli dèi e i santi così come rappresentati nelle statue, nei dipinti e nei mosaici (70).
Certo, nel nostro caso non è possibile fare il gioco delle parti tra i ricordi sognati (elaborazione onirica di letture, prediche e immagini),
Vita Nova) è assai frequente il ricorso ai verbi sembrare, apparire e vedere in contesti onirico-visionari, cui è sotteso probabilmente il videor latino.
(69) Cf. Bettini, Alle porte dei sogni, p. 209 sg.(70) L’immagine materiale da un lato fissava e condizionava i tratti perspicui del
dio (e del santo) sognato, dall’altro certificava a posteriori l’identità del personaggio ap-parso in visione. Il motivo, assai diffuso nelle aretalogie pagane, fa la sua comparsa, tra la fine del V e i primi anni del VI secolo, negli Actus Silvestri, laddove all’imperatore Costantino, prima del suo battesimo, appaiono in sogno gli apostoli Pietro e Paolo, i cui ritratti gli vengono poi mostrati da papa Silvestro a garanzia della loro identità e dell’autenticità del sogno; si veda in proposito t. CaneLLa, Gli Actus Silvestri. Genesi di una leggenda su Costantino imperatore, Spoleto 2006, pp. 9-10, 52 sg. È in corso di elaborazione un mio studio su Immagine e visione tra Antichità e Medioevo, dove la questione del rapporto tra immagini oniriche e immagini devozionali verrà affrontata in maniera sistematica; cf. h. maguire, The Icons of their Bodies. Saints and their Images in Byzantium, Princeton 1996, pp. 12 sgg., 42 sgg.; L. Canetti, « Olea sanctorum ». Reliquie e miracoli fra Tardoantico e alto Medioevo, in Olio e vino nell’alto Medioevo. Atti della LIV Settimana di studio (Spoleto, 20-26 aprile 2006), Spoleto 2007, pp. 1335-1415, in part. 1382 sgg.; J. eLsner, Roman Eyes. Visuality and Subjectivity in Art and Text, Princeton-Oxford 2007, pp. 225-252; G. dagrOn, Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique, Paris 2008, pp. 206-211.
1009UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀ
i sogni ricordati (cioè rielaborati dalla memoria individuale e culturale di Venturino) e un certo grado di stilizzazione colta da parte della commissione dei chierici che ascoltarono facendo redigere in latino notarile la sua deposizione. Il problema della stilizzazione, si badi, non è però soltanto letterario, perché si pone comunque già a livello di autoenunciazione e poi di rielaborazione narrativa del sogno da parte del protagonista; e si situa già sul piano della messa in atto e della declinazione soggettiva di una partitura rituale (71). Un modello illustre, per esempio, potrebbe essere rintracciato nell’episodio della resurrezio-ne del catecumeno da parte di Martino di Tours, narrato per la prima volta da Sulpicio Severo (72): il morto apparente, dopo il suo risveglio, racconta che, uscito dal corpo, si era trovato di fronte al tribunale del Giudice supremo, e come poi era stato scagionato per intercessione di Martino (73). Tale episodio, a sua volta, ha però dietro di sé il famoso racconto del sogno di san Girolamo narrato dal protagonista nella let-tera ad Eustochio (74); e soprattutto, io credo, il profetismo sciamanico di Elia ed Eliseo (I e II Libro dei Re). Si può pensare anche al sogno edenico incluso nel superbo racconto autobiografico della martire Per-petua (75); e certo non andranno trascurati i richiami al rapimento in cielo di san Paolo (II Cor. 12, 2-4) e l’antica letteratura apocalittica ca-nonica e apocrifa (Libro di Enoch, Apocalisse di Pietro, ma specialmente la Visio Pauli nelle sue molte redazioni e adattamenti) relativa al tema del viaggio nell’aldilà (76).
Il motivo del morto apparente, dal cui corpo esanime – a seguito di una lunga malattia o di un accesso di febbre – l’anima, durante un sogno/visione verace, si distacca per raggiungere l’aldilà e subirvi un qualche tipo di prova o di giudizio, è ben attestato nella tradizione let-
(71) Cf. Canetti, Sogno e terapia, pp. 45-48.(72) suLP. sev., Vita Martini 7, 1-6; cf. suLPiCe sévère, Vie de saint Martin, I, éd.
par J. FOntaine, Paris 1967 (SCh 133), pp. 266-268; e il superbo Commentaire dello stesso FOntaine, ibid., II (SCh 134), pp. 608-631.
(73) Si veda in proposito anche l’utile antologia Visioni dell’aldilà in Occidente. Fonti, modelli, testi, a cura di m.P. CiCCarese, Firenze 1987 (Biblioteca patristica, 8), pp. 95-103.
(74) hier. Ep. 22, 30, ed. I. hiLBerg in CSEL 54, Vindobonae-Lipsiae 1910, p. 190 sg.; cf. CiCCarese, Visioni dell’aldilà, pp. 84-94.
(75) Cf. Passio Perpetuae et Felicitatis, 11-13; cf. Passion de Perpétue et de Félicité suivi des Actes, éd. par J. amat, Paris 1996 (SCh 417), pp. 142-152 (Commentaire, pp. 230-242).
(76) Oltre all’antologia della CiCCarese, Visioni dell’aldilà, pp. 17-57, rinvio all’am-pia trattazione di CarOzzi, Le voyage de l’âme dans l’au-delà, pp. 3-8, 105-112, 208-212, 262-279, 449-452 e passim.
1010 LUIGI CANETTI
teraria latino-cristiana (77). Ho già menzionato il sogno di Girolamo e la resurrezione del catecumeno da parte di san Martino; ma si potrebbero ricordare anche l’episodio di Salvio narrato da Gregorio di Tours, con il tema della resistenza a ritornare in vita dopo aver esperito le gioie pa-radisiache (78), e molti racconti dei Dialogi di Gregorio Magno, il quale, in almeno due casi, testimonia la diffusione della credenza nell’anima-uccello, visibile in forma di colomba (79). E ancora, la Vita Fursei (VII secolo), con l’insistita associazione tra malattia e visione dell’aldilà, e il motivo profetico del messaggio da riportare ai vivi (80); la Visio Baronti e lo stesso Beda, con il quale sembra fare la sua comparsa il tema del Purgatorio (81).
Il motivo dell’anima-uccello costituisce uno dei grandi paradigmi mitico-rituali delle culture sciamaniche, compresa la grecità pre-platoni-ca (82). Esso si radica probabilmente nell’esperienza arcaica del distacco del morto e della morte stessa concepita come volo o come ‘strappo’ dell’anima ovvero come trasporto di essa da parte di un volatile verso il regno dei defunti (83). L’anima-uccello è poi attestata anche nella tra-
(77) Il tema, peraltro, s’intreccia spesso con quello dello scambio del morto, che poi ritorna in vita: è il celebre caso di Curma narrato da Agostino in De cura pro mort. 12, 15 (cf. CiCCarese, Visioni dell’aldilà, pp. 104-114).
(78) greg. tur. Libri historiarum VII, 1; cf. sempre CiCCarese, Visioni dell’aldilà, pp. 149-165.
(79) greg. magni Dial. II 34, 1; IV 11, 4; cf. gregOriO magnO, Storie di santi e di diavoli, a cura di S. PriCOCO - m. simOnetti, I, Milano 2005, pp. 204 sg., 363 sg.; ibid. II, Milano 2006, pp. 198-201, 455 sg.; ma v. sempre anche CiCCarese, Visioni dell’aldilà, pp. 115-147.
(80) Cf. CiCCarese, Visioni dell’aldilà, pp. 184-229 (con il testo integrale dell’opusco-lo); CarOzzi, Le voyage de l’âme, pp. 99-138 e 677-692 (con una nuova ed. del testo).
(81) Si vedano sempre CiCCarese, Visioni dell’aldilà, pp. 231-275; e CarOzzi, Le voyage de l’âme, pp. 139-186. Per i passi di Beda (in part. Hist. eccl. V, 12-14, con la famosa visione di Drythelm, ripresa ancora nei secoli XI-XII da autori di primaria importanza), cf. Le gOFF, La nascita del Purgatorio, 126-131; CiCCarese, pp. 302-336; CarOzzi, pp. 226-258 e passim; v. ora Beda, Storia degli Inglesi, a cura di m. LaPidge, II, Milano 2010, pp. 372-395, 674-684 (commento).
(82) Sugli iatromanteis della grecità arcaica (Aristea di Proconneso, Abaris, Epi-menide di Creta, Empedocle, forse gli stessi Pitagora e Parmenide), oltre al classico e. dOdds, The Greeks and the Irrational, Berkeley-Los Angeles-London 1951, pp. 135-178(trad. it., I Greci e l’Irrazionale, Firenze 1959, pp. 159-209), cf. COuLianO, Esperienze dell’estasi, pp. 19-38; id., I viaggi dell’anima, pp. 120-130; P. kingLseLy, Nei luoghi oscuri della saggezza (1999), trad. it. Milano 2001, pp. 97-108; J. n. Bremmer, The Rise and Fall of the Afterlife, London-New York 2002, pp. 27-40. Il tema è ben presente anche nella mitologia celtica e in quella germanica (v. p. es. snOrri, Ynglingasaga, VII, dove Odino vola in forma di uccello mentre il suo corpo giace come morto); eccellente rassegna analitica della fonti in COsta, La Sirena di Archimede, pp. 98, 107 sgg.
(83) Nelle civiltà antiche del Vicino Oriente e dell’Egitto (mentre più ambiguo e complesso è il caso della grecità) era in genere l’anima-vita o ‘vegetativa’, e non lo
1011UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀ
dizione cristiana: si pensi soltanto al martirio di Eulalia (84), e ai racconti della morte di santa Scolastica e dell’abate Speranza narrati da Gregorio Magno (85): il primo episodio è poi connotato in senso divinatorio poi-ché Benedetto, stando nel suo monastero, vede l’anima-colomba della sorella salire al cielo, ne comprende il destino di gloria e poi fa portare il cadavere per la sepoltura (86).
È dunque lecito ipotizzare una continuità di simbolizzazione dell’e-sperienza psichica a così grande distanza di spazio e di tempo? E se sì, quali sono i vettori privilegiati della trasmissione di segni e di simboli, che anche in forme differenziate e fortemente destrutturate, sembrano riproporre l’efficacia di un antichissimo dispositivo rituale? Il viaggio dell’anima nell’aldilà si sostanzia di immagini, gesti e parole di valore iniziatico, terapeutico e divinatorio, e mette in atto saperi etnoscientifici risalenti a fasi remote della civiltà. In che misura è possibile formula-re uno schema di relazioni strutturali tra forme di rappresentazione e forme di esperienza onirico-visionaria ricorrenti in spazi e tempi anche molto distanti fra loro?
Nelle culture tradizionali, e certo ancora nella civiltà europea trecentesca, i racconti di sogni non investono una mera questione di topica o retorica letteraria né di sociologia della ricezione: siamo in-vece nell’ordine del discorso di verità, sul piano di alétheia (87). Nella cultura cristiana, espressione ed erede anche in questo senso delle ci-
spettro cioè il doppio del morto, a venire rappresentata simbolicamente in forma di uccello; oltre al classico e. rOhde, Psiche. Culto delle anime e fede nell’immortalità presso i Greci (1890-94), nuova ed. it. a cura di s. givOne, Roma-Bari 2006, pp. 12 sgg., 203, 564 e passim, cf. ancora F. CumOnt, Lux perpetua (1949), nuova ed. a cura di B. rOChette - a. mOtte, Roma-Torino 2009 (Bibliotheca Cumontiana. Scripta maiora, 2), pp. 342 sgg., secondo il quale l’idea primitiva dell’anima-uccello si trasforma nella concezione dell’anima trasportata da un uccello; tesi poi accolta da e. PanOFsky, La scultura funeraria dall’Antico Egitto a Bernini (1964), ed. it. a cura di P. COnte, Torino 2011, pp. 7, 11, 23; una buona rassegna estesa al folklore medievale e moderno in a. m. di nOLa, La nera signora. Antropologia della morte, Roma 1995, pp. 264-267; si veda ora manCini, Il rovinoso incanto, p. 186 sg.
(84) Cf. PrudenziO, Peristephanon III, pp. 161-165; su questo passo e il suo Fortleben medievale rinvio a P. drOnke, Imagination in Late Pagan and Early Christian World. The First Nine Century A. D., Firenze 2003 (Millennio Medievale. Strumenti e studi, n. s. 4), p. 150 sg. (ma v. tutte le pp. 149-156, sul tema del volo dell’anima nella tradizione filosofica; cf. anche manCini, Il rovinoso incanto, pp. 100-103).
(85) Vedi supra, nota 79.(86) Nell’altro caso, invece, quello dell’abate Speranza, Gregorio Magno commenta
allegoricamente, con scontato richiamo evangelico, che la colomba raffigurava la sim-plicitas dell’uomo di Dio; cf. drOnke, Imagination in Late Pagan and Early Christian World, p. 151.
(87) Cf. m. detienne, I maestri di verità nella Grecia arcaica (1967), trad. it. Roma-Bari 1977, pp. 17-33.
1012 LUIGI CANETTI
viltà antiche, il registro onirico-visionario aveva conservato il suo valore di strumento di certificazione. Anche se non tutti i sogni, e non tutti i sognatori, potevano sempre e comunque attingere a un tale statuto di autorità, nel Medioevo la visio in somniis costituiva un dispositivo retorico e narrativo in grado di conferire autenticità, e perciò autorità probatoria, a un episodio o ad una situazione, talvolta a prescindere dalla qualità dei testimoni e dalla verifica empirica delle testimonianze stesse. Con Patricia Cox Miller, si può dire che i sogni costituiscono tropi (ovvero crono-tropi) che consentono al mondo di venire rappre-sentato (88). Se alcuni sogni potevano modificare la storia, anche la loro giusta interpretazione rappresentava una posta in gioco cruciale per decifrare il senso della storia individuale e collettiva, un dispositivo ermeneutico per interpretare il mondo (89). Il sogno, come notava Gian Paolo Caprettini, è sempre il racconto di un sogno, il ricordo, la testi-monianza orale o la trascrizione di un’esperienza in sé irripetibile (90). In questo senso, potremmo aggiungere, ogni testualità onirica è davvero metafora e paradigma tanto dell’esperienza storica, che può essere rie-vocata soltanto in forma narrativa ma giammai rivissuta o ricostruita in laboratorio, quanto della storia personale di ciascuno di noi, poiché la nostra identità, la nostra biografia, come scrisse Pierre Bourdieu, non è altro che l’insieme delle storie che sappiamo raccontare su di noi per ricucire gli occasionali frammenti di quella che altrimenti sarebbe solo un’antistoria, il rumoroso frastuono di quell’idiota shakespeariano di cui si parla alla fine del Macbeth (91).
I decenni a cavallo tra Duecento e Trecento segnano l’avvio di una grande svolta nella storia dell’immaginario, l’inizio di un’autentica rivo-luzione del visuale, che interessò in primo luogo la dimensione visiona-ria e pertanto anche l’ambito onirico e onirologico. I tramiti e i vettori di comunicazione tra il visibile e l’invisibile, nell’arco di poche genera-zioni, si trasformarono poiché la diffusione sociale e il cambiamento di status delle nuove immagini religiose accompagnò e accelerò il processo stesso di mutamento dei tramiti del sacro. Fu un processo assai lungo e
(88) Cf. COx miLLer, Il sogno nella tarda antichità, p. 13; v. anche Ch. steWart, Ritual Dreams and Historical Orders: Incubation between Paganism and Christianity, in Greek Ritual Poetics, eds. D. yatrOmanOLakis - P. rOiLOs, Cambridge-London 2004 (Hellenic Studies, 3), pp. 338-355, in part. 340.
(89) In pratica, anche il sogno incubatorio era una forma di storia « in the guise of ritually induced dream » (steWart, Ritual Dreams, p. 355).
(90) g. P. CaPrettini, Il sogno e l’intelligibilità narrativa, in id., Semiologia del racconto, Roma-Bari 1992 (19972), pp. 73-93, in part. p. 74.
(91) Cf. P. BOurdieu, L’illusione biografica (1986), trad. it. in id., Ragioni pratiche, Bologna 1995, pp. 71-79.
1013UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀ
tortuoso, che culminò con l’invenzione rinascimentale dell’arte e con la creazione di un gusto e di un mercato di oggetti svincolati dall’antica funzione di ornamenta ecclesiae (icone, reliquie, reliquiari, arredi sacri), i quali non erano opere d’arte nel senso moderno ma sintagmi e fram-menti della gloria celeste, epifenomeni dell’incarnazione e anticipazioni del futuro escatologico (92). La visione estatica e la visione onirica certo non scomparvero, ma molteplici sono gli indizi atti a suggerire l’impres-sione che, tra la fine del XIII e la metà del XIV secolo, il loro ruolo e la loro funzione in quanto vettori di comunicazione con l’invisibile muti di segno e si ridefinisca in relazione ai nuovi media visuali (93). La visio-ne estatica e il sogno incubatorio, da sempre mal tollerati dalle autorità ecclesiastiche, appaiono vieppiù filtrati dalle maglie strette della nuova ratio procedurale dei sistemi di accertamento testimoniale e di filtro selettivo della santità canonizzata, e non si può escludere che l’inasprir-si dei sistemi di censura (e il correlativo rarefarsi delle testimonianze scritte e orali sulla iatromantica incubatoria, da sempre decisive per la trasmissione dei gesti rituali che la connotavano fin dalla più remota antichità) abbia contribuito a sradicare queste antiche forme rituali di comunicazione con il mondo dei morti, pur con significative eccezioni. In questo senso, alcune fonti processuali dell’età di Dante – in partico-lare, il dossier taumaturgico relativo a san Ludovico d’Angiò, tra 1297 e 1308; le deposizioni al primo processo per Chiara da Montefalco, nel 1309; e soprattutto le straordinarie testimonianze raccolte nell’estate del 1325 per la causa di canonizzazione di Nicola da Tolentino – segnano i termini di una svolta cruciale, per la tensione e la compresenza in esse delle più varie modalità di intervento onirico-visionario dei santi taumaturghi: da quelle, ormai sempre più rare, radicate nella più arcaica ritualità iatromantica praticata presso il luogo ctonio in cui riposano le sacre spoglie; a quelle, sempre più frequenti, che inscenano la visione premonitrice e risanatrice del santo a cui il fedele si vota ormai presso casa propria (94).
(92) Se ne discute in L. Canetti, Rappresentare e vedere l’invisibile. Una semantica storica degli « ornamenta ecclesiae », in Reli giosità e civiltà. Le comunicazioni simboliche (secoli IX-XIII), a cura di g. andenna, Milano 2009 (Settimane internazionali della Mendola. Nuova serie, 2007-2011), pp. 345-405. Il saggio viene ripreso nel IV capitolo del mio libro Impronte di gloria. Ornamento e reliquia nell’Europa cristiana, Roma 2012.
(93) Cf. Canetti, « Le divinazioni de’ nostri sogni ».(94) Unico, a quanto mi consta, ma non meno significativo per l’epoca e il luogo, il
caso della discussione, registrata per autorità notarile poco dopo il 1297, tra un medico marsigliese affetto da cecità e la devota moglie di lui: la donna, vedendolo titubante nei pressi del santuario, e deprecando l’inutile ricorso alle cure mediche, lo esorta ad addormentarsi senza tante storie, come facevano tutti gli altri malati, presso la tomba
1014 LUIGI CANETTI
La visione estatica e quella profetico-premonitrice non rappresenta-vano certo una novità assoluta nella storia della spiritualità cristiana. Ma dagli ultimi decenni del XIII secolo e per tutta l’età avignonese, forse anche in relazione alla nuova stretta disciplinare sulla santità e sulla vita religiosa esercitata dal papato, dalla teologia, dal diritto e dagli ordini religiosi, quelle manifestazioni estatiche tendono a concentrarsi verso figure eccezionali di mistici e carismatici, con una netta prevalenza delle mulieres religiosae che beneficiano in vita, sotto il controllo disci-plinare delle autorità ecclesiastiche, dei loro pericolosi carismi visionari. La santità simulata e la possessione diabolica – oramai dilaganti anche in agiografia (95) – potevano arginarsi anche attraverso un più serrato controllo pastorale e disciplinare delle visioni; e le visioni oniriche, come tali assai poco addomesticabili, dovevano probabilmente subire una stretta censoria ancor più decisa, specie nel caso di sognatori che, per ruolo sociale e per grado di istruzione, non parevano autorizzati ad accreditare le loro esperienze visionarie, tanto più nella fattispecie dei sogni con possibili risvolti iatromantici o addirittura sciamanici.
Il caso qui esaminato costituisce dunque, per molti aspetti, una straor-dinaria eccezione benché l’insieme delle testimonianze al processo per san Nicola confermi alcune tendenze tipiche di quegli anni: la medicina laica e universitaria comincia a fare concorrenza alle cure miracolose dei santi, e i medici professionisti appaiono con sempre maggior frequenza nelle vesti di testimoni ed esperti nei processi di canonizzazione (diagno-si, esami delle urine, interventi chirurgici ecc.), e non più come semplici maschere involontarie nel tribunale fallimentare del sapere profano, allo scopo di esaltare la virtus risanatrice dell’uomo di Dio, che ormai
di san Ludovico; se poi avesse incontrato qualche difficoltà a prender sonno, anche una buona bottiglia di vino schietto avrebbe potuto servire alla bisogna. Il medico, con tono piccato, replicò alla moglie che lei evidentemente non aveva fede nel potere dei santi, il quale può manifestarsi ovunque tanto durante il sonno quanto in stato di veglia (« ... quia virtus sancti ita bene potest me iuvare hic sicut ibi, et in vigilia sicut et in sompno »); cf. Liber miraculorum S. Ludovici episcopi Tholosani, § 139, in Analecta Franciscana, VII, p. 310.
(95) Dalla fine del Duecento, anche l’agiografia e i processi di canonizzazione co-minciano a tradire una crescente irruzione del demoniaco: alle tradizionali fenomenolo-gie della possessione diabolica si aggiunge la fattiva presenza di Satana e dei suoi agenti terreni nelle più svariate circostanze quotidiane, e la demonomania clericale e inquisito-riale si concentra con particolare acribìa intorno all’universo della religiosità femminile, alla ricerca di quel discrimine tra vera e falsa santità, che i fenomeni estatico-visionari rendevano particolarmente soggetto all’intervento diabolico, e in ogni caso esposto alla deriva superstiziosa; cf. A. VauChez, La nascita del sospetto: vera e falsa santità negli ultimi secoli del medioevo, in Finzione e santità tra medioevo ed età moderna, a cura di g. zarri, Torino 1991, pp. 39-51 (rist. in id., Santi, profeti e visionari. Il soprannaturale nel medioevo, Bologna 2000, pp. 235-247).
1015UN VIAGGIO ESTATICO NELL’ALDILÀ
si esprime sempre meno esclusivamente nel clamore della guarigione improvvisa stemperandosi nella più cauta registrazione dei modi e dei tempi di una prosaica convalescenza (96). Sono gli stessi fedeli, ormai, a rifiutare di riconoscere come prodigio un miglioramento della salute che si manifestava oltre la soglia critica degli otto giorni dalla formulazione del voto (97). Quest’ultimo caso è quasi costante nell’imponente inchiesta sui miracoli di Nicola da Tolentino, e ciò non può che indurre un’estrema prudenza nel dislocare l’episodio di Venturino all’interno di una serie pur cospicua di evidenze relative a fenomeni estatico-visionari, di cui appare ancora molto arduo stabilire una possibile linea di evoluzione storica.
(96) È invero a partire dalla metà del Duecento che nei processi di canonizzazione dell’Europa mediterranea appare sempre più frequente il ricorso ai medici professionisti in qualità di testimoni qualificati a giudicare il carattere naturale ovvero miracoloso della guarigione; si veda in proposito J. ziegLer, Pratictioners and Saints: Medical Men in Canonization Processes in the Thirteenth to Fifteenth Centuries, in « Social History of Medicine », 12 (1999), 2, pp. 191-225.
(97) Lo ha ben rilevato J. PauL, Miracles et mentalité religieuse populaire à Mar-seille au début du XIVe siècle (1976), ora in id., Du monde et des hommes. Essais sur la perception médiévale, Aix-en-Provence 2003, pp. 201-222, in part. 205.
INDICE GENERALE
Premessa Pag. v
Walter Card. Brandmüller, Presentazione » vii
TESTIMONIANZE
Bernard ardura, Presidente del Pontificio Comitato di ScienzeStoriche » xiii
Charles Ghislain, Ambasciatore del Belgio presso la Santa Sede » xvi
notker Wolf, Abate Primate della Confederazione Benedettina » xvii
miChael kelly, Abate Generale della Congregazione Silvestrina » xix
dieGo maria rosa, Abate Generale della Congregazione Olivetana » xxi
Pietro vittorelli, Abate di Montecassino » xxii
lorenzo russo, Abate Generale Emerito di Vallombrosa » xxiv
franCesCo G. B. trolese, Direttore del Centro Storico BenedettinoItaliano » xxvi
lorenzo sena, Priore conventuale del monastero di S. Silvestrodi Fabriano » xxix
GiorGio PiCasso, Monastero di S. Benedetto, Seregno » xxxii
Cosimo damiano fonseCa, Accademico dei Lincei » xxxiv
roBert GoddinG, Société des Bollandistes » xxxvii
franCesCo sCorza BarCellona, Presidente dell’AISSCA » xxxix
BIBLIOGRAFIA DI RÉGINALD GRÉGOIRE » xliii
STORIOGRAFIA ED ERUDIZIONE ECCLESIASTICA
enriCo dal Covolo, Appunti sulla teologia della santità e sulleprocedure di canonizzazione nella storia della Chiesa » 3
roBerto rusConi, Santo Padre, Padre Santo: a proposito delriconoscimento della santità dei romani pontefici » 11
GianluCa Pilara, Una nota in merito al potere giuridico dei ve-scovi nel diritto giustinianeo » 25
1556 INDICE GENERALE
nadia toGni, Un Passionario atlantico umbro-romano a Zagabria Pag. 35
aGostino ParaviCini BaGliani, Innocenzo III e la venalitàdella Curia Romana. Per una rilettura dei Gesta Innocentii III » 61
massimiliano vidili, Le nomine vescovili in Sardegna tra elezionicapitolari e riserva pontificia (1198-1352) » 73
faustino avaGliano, Contributo alla cronotassi abbazialedel monastero di S. Angelo di Gaeta dall’ingresso nellaCongregazione de Unitate fino al 1504 » 89
marina Caffiero, I processi di canonizzazione come fonte perla storia dei rapporti tra ebrei e cristiani e delle conversioni » 115
Walter CaPezzali, Gli archivi celestini nel XVII secolo. Per unastoria della Congregazione » 127
amleto sPiCCiani, Storiografia agiografica lucchese del Seicento:Francesco Maria Fiorentini » 145
Pietro de leo, Legere, orare, et operari oportet. Il patrimoniolibrario del Convento dei Minori Osservanti di MoranoCalabro agli inizi del secolo XVII » 169
antonio alemanno - vito fumarola, La diocesi di Mottola agliinizi del ’700 » 191
tommaso di CarPeGna falConieri, Appunti sullo « Spoglio dellepergamene urbinati » di Antonio Corradini e su un cospicuofondo diplomatico » 205
filiPPo lovison, Il cattolicesimo italiano dalla grande guerra alfascismo: suggestioni barnabitiche sul “secondo Risorgimento” » 215
TESTI
edoardo d’anGelo, Il dossier latino su san Cassio vescovo diNarni (BHL 1638, 1639, 1639a) » 237
antonio vuolo, Dall’Epilogo della Vita S. Nicolai di GiovanniDiacono agli inediti Miracula dell’Obitus Nicolai di Giovannid’Amalfi (BHL 6107-6108 e 6156h) 255
mariano dell’omo, Per la storia di un culto tardivo. Il carmeDe sancto Berthario martyre casinensi di Giovanni EvangelistaMormile e la memoria liturgica del primo martire e abatedi Montecassino » 283
marina soriani innoCenti, Chiara, santa claritate meritorum,premiorum, miraculorum: edizione di tre prediche anonime » 297
silvia noCentini, L’opera agiografica di Baldovino de’ Baldovini:proposta per l’analisi di un leggendario volgare fiorentino » 315
1557INDICE GENERALE
ESEGESI E CRITICA DEL TESTO
fortunato frezza, Agiologia, agiografia, agionomia. Il codice deldiscepolo in Mt 19 « Se vuoi essere perfetto, va’ » (Mt 19, 21) Pag. 333
GiusePPe Caruso, Il Testimoniorum Liber di Pelagio tra Girola-mo e Agostino » 357
sofia BoesCh Gajano, Agiografia di confine: il Liber Pontificalisdella Chiesa romana » 375
marCello Garzaniti, Sacre Scritture ed esegesi patristica nellaVita di Metodio » 385
franCesCo mosetti Casaretto, « Dilectio proximi »? La polemicadissimulata di Ermenrico di Ellwangen » 393
roBerto nardin, Prospettive metodologiche in Anselmo d’Aosta » 417
Pietro maranesi, Beato il servo che... Il linguaggio sapienzialedi Francesco di Assisi nelle Ammonizioni » 431
stefano defraia, A proposito delle Quaestiones Henrico de Gan-davo adscriptae (Roma, Biblioteca Angelica, ms. 750) » 463
alessandra Bartolomei romaGnoli, L’immagine di Maria negliscritti delle donne medioevali » 491
daniele solvi, Maria nel corpus agiografico francescano » 521
massimo vedova, Considerazioni sull’Instructio XXXVII delcorpus angelano » 537
franCesCo santi, Caterina da Siena, lettrice di Dante? » 551
luiGi Gioia, Il segreto dell’osservanza monastica in due Cronacheolivetane del XV secolo » 569
MODELLI DI SANTITÀ
elena zoCCa, Mutazioni della tipologia martiriale in età vanda-lica: un diverso punto di osservazione sulla “persecutio”anticattolica » 597
Pierantonio Piatti, Per speculum. Considerazioni sul typus agio-grafico della santa follia tra Oriente e Occidente » 633
GiusePPe CremasColi, I viri Dei di Gregorio Magno fra tenta-zioni e prodigi » 659
antonella deGl’innoCenti, Aspetti dell’agiografia gregoriana(da Whitby a Roma) » 677
1558 INDICE GENERALE
faBio Cusimano, La biografia di Benedetto di Aniane tra storiae topoi agiografici Pag. 693
rosa maria Parrinello, Percorsi della santità nei « Racconti utiliall’anima » di Paolo di Monembasia » 727
massimo oldoni, Un’agiografia tradita? Da San Vincenzo alVolturno a Tibhirine » 747
mirko vaGnoni, Evocazioni davidiche nella regalità di Guglielmo IIdi Sicilia » 771
adriana valerio, Laica, visionaria, brigidina: Marina di Escobarnella Spagna di Filippo IV » 789
elisaBetta lurGo, Maria Ludovica da Cossombrato. Misticismoe profezia alla corte di Vittorio Amedeo II » 801
GLI SPAZI DEL SACRO
Benedetto vetere, Culto delle reliquie e virtus dei santi. Sacroe spazi del sacro nella Gallia merovingia di Gregorio di Tours » 827
Giulia Barone, Religione e culto dei santi nell’Italia longobarda:una rilettura » 895
marina montesano, Le “Memorie” dei santi Stefano e Tecla ela prima diffusione del cristianesimo nelle Marche » 913
niColanGelo d’aCunto, Esiste un monachesimo appenninico?Esempi dall’area umbro-marchigiana nei secoli X e XI » 927
mario sensi, Santa Caterina d’Alessandria. Transfert di sacralitàdal Monte Sinai all’Italia mediana » 939
franCo Cardini, Dante e la peregrinatio animae » 977
luiGi Canetti, Un viaggio estatico nell’aldilà nel processo per lacanonizzazione di Nicola da Tolentino » 993
Giovanna CasaGrande - eleonora rava, Santa Rosa e il feno-meno della reclusione volontaria a Viterbo » 1017
isaBella GaGliardi, Mistiche, pie convertite e clientele. Gli spazidei “poteri non formalizzati” nelle città italiane tra XIII eXV secolo » 1033
BeatriCe Cirulli, Per meglio “ascoltare” la messa dal coro: l’al-tare del signore di Tolfa Vecchia e il trittico di Lippo Vanniin Santa Aurea » 1049
federiCo Gallo, Da Köln, dalla Sardegna e dall’Urbe: reliquiedi martiri a Milano alla metà del Seicento » 1063
1559INDICE GENERALE
STORIA DEI CULTI
PierluiGi liCCiardello, I martiri aretini Gaudenzio e Columato:agiografia e culto dal Medioevo all’Età moderna Pag. 1083
Paolo nardi, Alle origini del culto dei Senesi per s. Ansano ela Madonna Assunta » 1109
roCCo ronzani, Il rito e le fonti della Laus cerei e il testo dell’Ita-lia meridionale longobarda » 1123
franCesCo salvestrini, ‘Furti’ di identità e ambigue semantiz-zazioni agiografiche: Verdiana da Castelfiorentino santavallombrosana » 1143
Claudio PalumBo, Le ragioni di Isernia quale patria natale diCelestino V. Per un contributo allo status quaestionis sto-riografico » 1187
massimiliano Ghilardi, Lac pro sanguine fluxit passiones antiche,inventiones moderne: intersezioni tra agiografia e archeologia » 1209
Benedetto Clausi, “Recentiora non deteriora”. Ancora sui cosid-detti Martiri argentanesi » 1223
serGio PaGano, Una controversia cinquecentesca sulla cappelladi S. Caterina da Siena in S. Maria sopra Minerva (1573) » 1245
luCiano Cinelli, Le confraternite del Rosario fra XVI e XVIIsecolo » 1259
luiGi miChele de Palma, Il sepolcro di san Corrado il Guelfo:un antico santuario micaelico? » 1277
liana Bertoldi lenoCi, La devozione confraternale a san Rocco daVenezia ad Ampezzo di Cadore. Un percorso documentale » 1307
alessandra Cusinato, San Rocco: note sull’iconografia devozio-nale tra Venezia e Ampezzo » 1361
matteo da dePPo, Immagini devozionali di san Rocco nell’AltoCadore da Calalzo di Cadore a Sappada » 1383
josé sánChez herrero, San Roque. Su devoción en España » 1399
jan mikrut, La politica religiosa e il culto dei santi degli Asburgo:la Pietas austriaca » 1421
anna Benvenuti, Postfazione » 1467
INDICI
Indice dei nomi, a cura di alessandro valentini » 1475