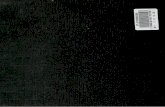F. MARIANO, Gli anni d’oro della conoscenza geografica tra progresso scientifico ed Instrumentum...
Transcript of F. MARIANO, Gli anni d’oro della conoscenza geografica tra progresso scientifico ed Instrumentum...
FABIo MARIAno
Gli anni d’oro della conoscenza geografica tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
Un’ampia epigrafe posta sopra il busto marmoreo algardiano di FabioChigi, opera del carrarese Domenico Guidi, che inquadra oggi il fonda-le del bel Salone monumentale borrominiano nella nuova ala del Palaz-zo della Sapienza, recita:“LIBRoS oMnIGEnAE ERUDITIonIS A FRAnCESCo MARIA IIURBInI DUCE SUMMo STUDIo ConQUISIToS ALEXAnDERVII PonT. MAX. UT SPLEnDIDIoRI ILLoRUM CULTUI ET REI-PUBLICAE LITTERARIAE Bono ConSULERET CUM HISQUEConSoCIAToS ET PERMIXToS In RoMAnAE SAPIEnTIAE AR-CHIGYMnASIo A SE ConDUCATA InSTRUCTAQUE BIBLIo-THECA PUBLICA LUCE DonAVIT”.
Qui, tra gli scuri legni appositamente disegnati dal Borromini nel 1667,l’anno stesso del suo trasloco, era ospitata la prestigiosa “libraria im-pressa” di Francesco Maria II della Rovere proveniente dalla sua cullaoriginaria nel Palazzo Ducale in Urbania. Un fondo di oltre 13.000 vo-lumi, a costituire circa un terzo della intera prestigiosa raccolta romana.Una collezione bibliografica fortemente desiderata, autoritariamente
9
Il Salone monumentale dello Studium Urbis alla Sapienza di Roma, disegnato da Francesco Bor-romini. Al centro il busto marmoreo di Alessandro VII Chigi.
confiscata e qui collocata dal coltissimo Urbano VIII per arricchire loStudium Urbis romano, quando i territori già feltreschi ricadevano defi-nitivamente sotto il diretto dominio della Chiesa. Da sottolineare come singolare il meritato privilegio di questa famosaraccolta di venir ospitata sempre nelle scansie di monumentali scaffala-ture firmate da grandi artisti: qui a Roma per opera di Francesco Borro-mini e, nella sua sede iniziale, per opera del maestro riconosciuto dellascenografia barocca, il pesarese niccolò Sabbatini, che l’aveva proget-tata per il Duca nel 1609: un capolavoro ligneo questo purtroppo ormailontano dal suo luogo d’origine, ma rimontato nel 1915 e conservato og-gi in una residenza privata di new York.Un privilegio questo indubbiamente più ché giustificato se si considerila fama e l’ammirazione che ha sempre accompagnato questa fantasti-ca collezione libraria, citata sin dal 1581 da Michel de Montaigne (manon vista nel palazzo di Urbino) nel suo Journal du voyage, vista ed am-mirata, invece, dal grande geografo ed umanista amburghese Lukas Hol-ste (Holstenius), curatore della Biblioteca Vaticana. Questi volumi, “omnigenae eruditionis”, raccolti da Francesco MariaII° ben rispecchiano le ambizioni culturali di un signore del tardo Rina-scimento, stimolato ed avido di una vastità singolare di interessi; tutta-via mosso da spirito ben diverso da quello del suo avo Federico, noto perraccogliere ed esibire volentieri nella sua “libraria vecchia” di Urbinomonumenti bibliografici esclusivamente manoscritti. Prodotti rari, con-tinuamente ricercati in originale e talvolta copiati dal suo libraio fioren-tino Vespasiano da Bisticci, spesso contesi alla Laurenziana di Cosimode’ Medici allora in formazione. non da finalità di mero conseguimen-to di uno status symbol o di adeguamento ai modelli cortesi dei suoi tem-pi sembrava mosso Francesco Maria nella sua raccolta; piuttosto da unaricerca di acclaramento culturale tutto personale, da un motore intimoche lo attirava verso un bisogno di certezze ricercate attraverso il con-fronto tra una perseguita verità teologica ed una desiderata – e forse ir-raggiungibile - conferma “scientifica” della fede. negli anni della suaformazione, in un’Europa divisata dai contrasti e dai sospetti della Con-troriforma, il Duca voleva abbeverarsi direttamente ai testi contempo-ranei aggiornati – e quindi divulgati oramai prevalentemente a stampa– che affrontassero anche, e soprattutto, i contenuti sperimentali dellescienze note. Tra queste, quelle che affrontassero metodicamente e – co-me spesso accadeva in quegli anni di scorcio del XVI secolo – manua-listicamente, la conoscenza tecnica in ambiti speculativi concreti, comel’architettura, l’arte militare, la meccanica, la fisica e la conoscenza geo-grafica. In questo senso – come ha acutamente sottolineato Alfredo Ser-rai (2008) - la sua biblioteca può considerarsi “la prima bibliotecadell’età moderna in quanto età della rivoluzione scientifica”.
10
Fabio Mariano
La crescente attenzione per la rappresentazione a stampa delle terre co-nosciute caratterizza il “secolo d’oro” della rinascenza cartografica, co-me può a ragione esser definito il Cinquecento. Rinascenza stimolatasia dalle nuove acquisizioni tecnico scientifiche in campo mensorio ecosmografico che lo caratterizzarono, sia dal perfezionamento dellastampa piana da lastre di rame, che rivoluzionò la produzione editoria-le, consentendo ad una massa sempre più nutrita di fruitori privilegiatidi raccogliere, collezionare e fruire direttamente i prodotti cartograficiche andavano illustrando il mondo allora conosciuto. Produzione chegodette di vasto successo non solo in quanto adatta a soddisfare la cu-riosità per la documentazione geografica generale, indiretta ed a relati-vo basso costo, ma anche a rendere accessibili notizie e corografie delmondo, utili alla programmazione di spedizioni militari e scientifiche, al-la conoscenza dei possedimenti e dei loro confini con l’ausilio di atten-dibili misurazioni delle distanze e dei luoghi, mutuate dalla messe, incontinua crescita, delle informazioni accumulate dalla cartografia nau-tica quattrocentesca del cabotaggio costiero - i portolani, di cui diven-nero famosi produttori a Venezia gli anconitani Grazioso Benincasa esuo figlio Andrea - sino alle nuove scoperte in atto relative alle nuovefrontiere della navigazione transoceanica. In particolare, nonostante sto-ricamente l’Italia apparisse ancora divisa in stati e staterelli, nelle “tavolenuove” essa appariva per la prima volta, ed in forme sempre più preci-se, nella sua naturale integrità territoriale, già definita dai Romani nel pe-riodo di massima espansione dell’impero, dalla Savoia all’Istria. Erano trascorsi i lunghi secoli del disinteresse per la speculazione scien-tifica che caratterizzarono il medioevo, quando i padri della Chiesa pri-migenia avevano dimostrato poca e scarsa attenzione nel perseguiresforzi intellettualistici all’infuori di obbiettivi teologici. Cosa infatti po-tevano guadagnare dalla scienza i cristiani? Perfino San Francesco nonpoteva sottrarsi all’attitudine di stigmatizzare quell’inconsueto deside-rio di scienza di certi isolati religiosi: “Ci sono molti fratelli che si af-fannano alla ricerca della conoscenza . . . Questi fratelli che la curiositàspinge alla scienza, nel Giorno del Giudizio si troveranno con le manivuote”. Ma dal tardo Medioevo fino al XV secolo la cortina di oscuritàa poco a poco si dissipò. Molti fattori vi contribuirono: il consolida-mento della Cristianità e la sua diffusione territoriale, la formulazione si-stematica della dottrina cattolica su basi filosofiche, l’affermarsi deglistati nazionali, il sorgere e l’espandersi di nuove e antiche città, la sco-perta di reliquie bibliografiche del passato classico, preservate e copia-te negli scriptoria delle biblioteche di monasteri o tradotte dal greco edall’arabo.La scintilla di questa rivoluzione culturale viene spesso individuata nel-la “riscoperta” della Geographia di Claudio Tolomeo, astronomo vissu-
11
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
to ad Alessandria d’Egitto nel II° secolo: una delle opere scientifichepiù influenti dell'antichità ed un testo classico che aveva subìto duranteil Medioevo una progressiva obsolescenza, dovuta al coevo disinteres-se per la speculazione scientifica, anche in campo geografico. La sua oi-
koumenè (la rappresentazione dell'intero mondo abitato) si basava per laprima volta sul sistema delle coordinate della latitudine e della longitu-dine, strumento geometrico indispensabile per la precisa individuazio-ne dei luoghi sulla superficie terrestre, attraverso quella che oggi vienedefinita la proiezione conica. Essa consisteva, secondo l’interpretazio-ne di Tolomeo, nel proiettare i punti della sfera rappresentativa terrestresu una superficie conica il cui asse coincideva con quello terrestre, essadoveva essere secante alla superficie terrestre stessa, intersecandola incorrispondenza dei paralleli passanti – secondo Tolomeo - per l’isola diRodi e per la località di Thule, in Islanda. Riconsegnata compiutamen-te alla cultura occidentale tramite i codici arabi e bizantini, recuperatinell’ambito costantinopolitano e poi alla caduta dell’Impero d’oriente,l’opera tolemaica era stata tradotta dal greco al latino già nel 1406-09 daJacopo d’Angiolo da Scarperia, che ne aveva omaggiato l’antipapa Ales-sandro V. Quando, dopo la sua morte, Francesco di Lapacino e Leonar-do Boninsegni allegarono al suo originario manoscritto le carte graficheda loro appositamente disegnate, la versione di Jacopo d’Angiolo diven-ne poi una vera e propria bibbia geografica del Rinascimento, con un suc-cesso alimentato dall’incipiente clima umanistico del ritorno all’antico.nel 1466 il miniaturista tedesco Dominus nicholaus presentò a Borsod’Este, duca di Ferrara, il manoscritto (oggi conservato nella Bibliote-ca Estense di Modena). Esso venne arricchito da una serie ulteriore di in-terpretazioni delle mappe tolemaiche, modificandone gli errori esostituendovi alla proiezione rettangolare una più veritiera proiezionetrapezoidale, rendendo così sia i meridiani che i paralleli in una formarettilinea e meglio fruibile. Queste tabulae novae iniziarono ad essere ri-stampate a partire dal 1477, con la prima edizione tolemaica europea diBologna, curata dal ferrarese Taddeo Crivelli e stampata in 500 copieda lastre di rame e in caratteri mobili da Hyeronimus Manfredus e Pe-trus Bonus. Era la prima carta stampata in Europa, nonostante fossezeppa di errori e con inclinazioni innaturali. Konrad Schweynheim di Magonza, che aveva impiantato la prima stam-peria in Italia (a Subiaco nel 1465 e a Roma dopo il 1467), nel 1478pubblicò anch’egli la sua edizione tolemaica assieme al suo successoreArnoldus Buckinck, nella sua nuova bottega romana. A questa seguì poiquella ben importante curata dal fiorentino Francesco Berlinghieri, nel1482 a Firenze col titolo di Geographia, la prima col commento in vol-gare ed in terza rima (la Novella Italia era il titolo della carta riguar-dante il nostro paese), di cui abbiamo anche una rara copia nella
12
Fabio Mariano
biblioteca durantina, dedicata “allo illustrissimo Federigo duca durbi-
no”. Questa costituiva di fatto la prima carta “moderna” dell’Italia, piùcorretta nell’inclinata a 45° della penisola. Fra le tante edizioni ed “ag-giornamenti” si segnala quella curata da Bernardo Silvano da Eboli e daJacopo Pentio, edita a Venezia nel 1511, in quanto essa costituisce l’uni-ca carta incisa su legno a due colori della tradizione italiana, che – va sot-tolineato - si contraddistinse sempre per l’alta qualità delle incisioni surame. Fra le successive carte “moderne” d’Italia non tolemaiche va ri-cordata quella del piemontese Giacomo Gastaldi del 1561, uno dei piùinfluenti cartografi del XVI secolo, il quale conseguì per l’Italia un pri-mato conservato per mezzo secolo e particolarmente importante per noiin quanto il Gastaldi si applicò a migliorare la rappresentazione dellalongitudine, correggendone lo “stiramento” del Mar Mediterraneo e so-prattutto rendendo particolarmente esatto l’allineamento della costaadriatica e quindi della costa che confina la regione delle Marche.Il tentativo di resuscitare il metodo tolemaico recuperandolo alle mo-derne acquisizioni cartografiche si esaurirà tuttavia ben presto al vaglio
delle scoperte geografiche ed al filosofo alessandrino verrà destinato ilruolo filologico di mero testimone nobile delle conoscenze geografichedel mondo antico. Il termine ricorrente di “nova”, applicato spesso aqueste carte cinquecentesche va inteso quindi come un tentativo di di-stinguere il continuo aggiornamento rispetto alle carte tolemaiche. nel-la biblioteca durantina troviamo varie edizioni (quattro) dell’opera
13
Claudius Ptolomaeus. Geografia cioè descrittione vniuersale della terra partita in due vo-lumi. Venezia; Giorgio Galignani & Giovanni Battista Galignani. 1597-1598. Fol.Biblioteca Universitaria Alessandrina, Roma.
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
tolemaica: a partire dalla Geographia universalis vetus et nova edita aBasilea da Heinrich Petri (1545), sino all’edizione di Venezia di Giorgioe G.B. Galignani (1597-98). Va inoltre qui segnalata una copia della fa-mosa Cosmographia Universale di Sebastian Münster, edita a Colonianel 1575. Le carte divennero, dagli inizi del XVI secolo, un vero e proprio stru-mento politico, diplomatico e militare (quando non addirittura spioni-stico) per sovrani e governanti, da questi ricercate e ben pagate ad unanascente industria editoriale che non mancava di competere aggressiva-mente nel loro continuo aggiornamento tecnico ed ampliamento rap-presentativo, di pari passo col crescente, inarrestabile interesse corteseper l’ imago mundi. Dopo la coraggiosa prima spedizione verso occidente di Colombo, iviaggi di Sebastiano Caboto in Canada e di Vasco de Gama in India, ela successiva fondamentale intuizione di Amerigo Vespucci di trovarsi– di fronte all’estensione del Brasile - non nelle Indie bensì di fronte adun “nuovo Mondo”, accuratamente relazionata al suo signore Lorenzodi Pier Francesco de' Medici, la speculazione geografica subirà uno scat-to speculativo ed un interesse conoscitivo senza pari. Forte delle nuoveacquisizioni dei cartografi portoghesi - edotti dalle scoperte della primacompleta circumnavigazione planetaria di Ferdinando Magellano(1522), relazionate dal vicentino Pigafetta, mediate con la puntualizza-zione del meridiano fisso e l’apporto dello strumento della declinazionemagnetica - toccherà poi al grande geografo fiammingo Gerhard Kremer(Rupelmonde, 1512 – Duisburg, 1594), noto come il Mercatore, con lasua Nova et accurata orbis terrae descriptio ad usum navigantium emen-
data et accomodata” del 1569, il compito di fornire la prima cartografiaaggiornata dell’intero ecumene. Egli inventa e propone il metodo grafi-co per proiettare la superficie sferica del mondo sul piano di un cilindro;nota come la “proiezione di Mercatore”: era questo il primo tentativo em-pirico di costruire una carta che consentisse di tracciarvi una rotta conuna semplice retta. Qui egli proponeva la sua prima soluzione di proie-zione cilindrica a latitudini crescenti la quale, tenendo conto delle op-portune modificazioni date dalla sfericità della Terra, risultavapraticamente più attendibile, specialmente per la sicurezza della naviga-zione oceanica: la cartografia poteva finalmente assumere l'attributo di ri-cerca scientifica. Del Mercatore la biblioteca roveresca possiede quattroedizioni. Dalle Galliae tabulae… (Duisburg, 1585) alle Italiae, Sclavo-
niae et Graeciae tabulae…(Duisburg, 1589), dall’Atlas minor (Amster-dam, 1607) all’ Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi
et fabricati figura (Amsterdam, 1632), quest’ultima verosimilmente trale ultime acquisizioni bibliografiche di Francesco Maria II.Mercatore, inoltre, si era contemporaneamente specializzato nella tec-
14
Fabio Mariano
15
nica dell'incisione su rame, divenendone così abile da venir incaricato daGaspard van der Heyden, presso la cui bottega agli inizi lavorava, diprodurre le lastre di rame per la stampa di carte su porzioni di sfera daapplicare a spicchi su elaborati “globi” terrestri; tecnica questa che uti-lizzò anche per un noto globo celeste, raffigurante pianeti e costella-zioni, elaborato dal famoso matematico olandese Rainer GemmaFrisius, professore all’università di Lovanio che si era dedicato alla co-smografia matematica e alla produzione di mappe e strumentazionegeodetica e nautica. Entrambe queste prime opere, firmate ed apparseintorno al 1537, aprivano così un nuovo mercato collezionistico comeraffinate e contese opere da esporre nei vasti saloni delle corti come ve-ri e propri oggetti d’arredamento, oltre ché curiosità di esibito aggior-namento culturale divenute immediatamente alla moda.nel 1541 il Mercatore realizzò un raffinatissimo globo terrestre illu-strato, dedicato a nicola Perrenot de Granvelle cancelliere di CarloV, seguito poi nel 1551 da un globo celeste, dedicato a Giorgio d'Au-stria arcivescovo di Valenza e vescovo di Liegi. Acquisiti in circo-stanze non ancora chiarite alla collezione di Francesco Maria II,entrambi i due prestigiosi globi, veri cimeli cartografici del XVI se-colo, scamparono miracolosamente alla devoluzione romana della bi-blioteca ducale e sono oggi custoditi nel Museo civico di Urbaniaassieme ad uno più piccolo (e di qualche anno successivo) attribuitoa François de Mongenet.
Petrus aPianus - Reinerus Gemma FRisius. Cosmographia, siue Descriptio vniuersi orbis, Pe-tri Apiani & Gemmae Frisij, iam demùm integritati suae restituta. Antwerp; Jean Bellère 1, Jan Ver-withagen. 1584. 4°. Biblioteca Universitaria Alessandrina, Roma.
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
16
Gerhard Kremer (Rupelmonde 1512 - Duisburg 1594), noto come Gerardo Mercatore Sfera Celeste, 1551 (sopra) e Sfera Terrestre, 1541 (sotto), Urbania, Biblioteca Comunale.
Fabio Mariano
nel corso della seconda metà del XVI secolo si era venuto progressiva-mente modificando il sistema economico politico europeo ed in parti-colare il controllo dei traffici sia verso il nuovo Mondo sia verso le Indieorientali. Ristretto il secolare controllo commerciale di Venezia all’am-bito dell’oriente mediterraneo, mentre la Spagna ed il Portogallo anda-vano consolidando il loro controllo sulle immense ricchezze minerariedel centro America, le provincie protestanti dei Paesi Bassi, affrancate-si dal 1555 dal regno cattolico di Carlo V e di Filippo II, sviluppavanogli aumentati traffici di merci intercontinentali accentrandoli nei loroporti, ed il Mediterraneo - assieme alle città italiane - ne veniva semprepiù emarginato. Iniziava così il “secolo d’oro” delle città fiamminghe, fra le quali spic-cava il crescente sviluppo economico e culturale di Anversa, legato auna vivace ed abile imprenditorialità e al commercio delle spezie colo-niali, agevolato da una politica governativa liberista e spregiudicata, con-solidato dalla creazione delle prime “borse” commerciali (Anversa 1531)che diminuivano e distribuivano sugli “azionisti” i rischi delle spedi-zioni e dei trasporti. Aumentava così l’interesse finalizzato alla semprepiù esatta conoscenza dei confini del mondo, certamente spinto da mo-tivi scientifici, ma soprattutto dettato da finalità strettamente commer-ciali e di controllo politico coloniale.Qui si consolidavano eccezionali officine editoriali: Christophe Plantinad Anversa e Lodewijk Elzevier a Leida stampavano testi per la presti-giosa università fiamminga di Lovanio ma anche per le maggiori uni-versità europee. In questo clima di intraprendenza commerciale siformano e si consolidano anche le più importanti case editrici di carto-grafia che domineranno, con conduzione familiare, i mercati del mon-do per almeno un secolo e mezzo. Le botteghe dei Mercatore, ortelius,Blaeu, Janszoon, Hondius, Vischer, Schenk, quindi dei De Wit, ottens,Dankerts, in concorrenza o talvolta in sinergia fra di loro, dalla secondametà del XVI secolo sino alla metà del XVII secolo, strapperanno defi-nitivamente il primato del mercato cartografico mondiale all’Italia, ed inparticolare a Venezia e a Roma. Proprio a Roma, nel 1544, si era inse-diata la bottega del francese Antoine du Perac Lafréry, considerato (for-se a torto) l’antesignano della particolare produzione commerciale di“atlanti”, a partire dal 1570 a Roma, caratterizzati dalle sue raccolte car-tografiche rilegate in miscellanea a fini collezionistici, costituite da car-te di incisioni eterogenee e di diverso formato, provenienti da diversiincisori produttori, contenenti mappe ma anche vedute di città famose,stampate su fogli volanti ed assemblate su richiesta dei clienti. In que-ste miscellanee, note come “lafreriane” - precedute solitamente da unfrontespizio che riproduceva la figura allegorica di “Atlante” che sor-regge il mondo - sono state salvate dalla dispersione numerose carte
17
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
sciolte di vari autori (Bertelli, Ligorio, Gastaldi, Forlani, ecc.), oggi di-venute rarissime ed altrimenti a noi oggi sconosciute. nella bibliotecadurantina osserviamo, di questa tipologia editoriale e di questi autori: ilTheatrum Urbium Italicarum di Pietro Bertelli (Venezia, 1599); il Libro
di M. Pyrrho Ligori napolitano, delle antichità di Roma (Venezia, 1533),la raccolta di Francesco Valesio, Teatro delle più illustri et famose città
del mondo (Venezia, 1599); oltre all’atlante di Georg Braun e Frans Ho-gemberg, Civitates orbis terrarum, edito a Colonia nel 1633; e, per l’Ita-lia, la Nova et accurata Italiae hodiernae descriptio di Jodocus Hondius,edita ad Amsterdam nel 1626.Tuttavia il primo vero “atlante” moderno è oggi unanimemente attri-buito ad Abraham Hortelius (Anversa, 1527-1598) , il quale – a diffe-renza del Lafrery - curava di pubblicare carte dello stesso formato, conla stessa minuziosa ed elegante cura grafica ricca di decorazioni, carti-gli ed emblemi, che riuniva carte possibilmente dello stesso autore, delquale dichiarava sempre e correttamente la paternità. La sua prima ope-ra editoriale di questo tipo, incisa da Frans Hogemberg, fu il famosoTheatrum Orbis Terrarum (Anversa 1570), composto di settanta carte:un prodotto di tale qualità editoriale e successo commerciale da essereristampato in ben quarantuno edizioni sino al 1612. L’interessante figu-ra dell’ortelio delinea quella di un originale intellettuale europeo delXVI secolo: antiquario, mercante, geografo e cartografo, dalle vaste equalificate amicizie intessute con le migliori intelligenze umanistiche,scientifiche ed artistiche della cultura europea del suo secolo, non sce-vro dall’appartenenza a cenacoli filosofici che si ponevano illuminata-mente equidistanti dalle questioni teologiche e spirituali checontrapponevano allora in Europa il mondo cattolico e quello prote-stante. Per l’esegesi di questo eminente e complesso intellettuale fiam-mingo e del suo mondo si rimanda qui all’approfondita e documentatapubblicazione a lui dedicata da Giorgio Mangani (Il “mondo” di Abra-
mo Ortelio. Misticismo, geografia e collezionismo nel Rinascimento dei
Paesi Bassi, Modena 1998).nella biblioteca durantina compaiono due edizioni orteliane del Thea-
trum:, quella del 1585 e quella in piccolo formato del 1593, assieme adaltre due opere dell’ortelio: la Synonimya geographica del 1578 e l’Iti-nerarium per nonnullas Galliae Belgicae partes, del 1584. In questo rapido contesto evolutivo della cartografia europea si svilup-pano inoltre, ben fiorenti sul mercato europeo, le botteghe di cartografiolandesi specializzati nella produzione di carte murali e di atlanti di gran-de formato, eseguiti spesso su ordinazione; possiamo ammirare la loroproduzione appesa sui muri delle case della ricca borghesia mercantileolandese, immortalata in molti noti dipinti di Jan Vermeer di Delft. Com-petendo in qualità e ricchezza di dettagli e toponimi, gli editori fiam-
18
Fabio Mariano
minghi elaborarono una notevole capacità artigianale e soprattutto com-merciale. I rami incisi delle loro carte, spesso ceduti ad altre famiglie dieditori attraverso oculati contratti matrimoniali, sono accurate, stampa-te su carta robusta e durevole, di bella coloritura e disegno, abilmente ecostantemente aggiornate reincidendo le correzioni sui rami di base.Forse solo il grande astronomo, matematico e cartografo padovano Gio-van Antonio Magini, dall’alto del suo prestigio scientifico, riuscirà acontenere i danni della concorrenza degli olandesi in Italia, i quali anzifurono i primi a copiarne spesso le belle carte, purtroppo non protette danoi dal privilegio imperiale come accadeva invece nei Paesi Bassi. Stu-dioso universalmente stimato, egli tenne costante corrispondenza conTycho Brahe, Clavius, Abraham ortelius, e Johannes Kepler, disputan-do col polacco nikolaus Kopernikus sul primato del sistema eliocentri-co, parteggiando per quello geocentrico. nel 1588, dopo la morte diEgnazio Danti, Magini fu – forse per ciò - persino preferito a Galileoper occupare la cattedra di matematica presso l'Università di Bologna. Dopo la sua morte Fabio Magini pubblicherà nel 1620 l'opera cartogra-fica del padre: si tratta del primo lavoro organico relativo alla regionegeografica italiana. L'atlante, opera di una vita, era stato progettato daGiovan Antonio per fornire le mappe accurate di ogni regione italiana,arricchite con la nomenclatura esatta dei toponimi e le relative note sto-riche allegate: un vasto progetto per il quale ebbe come convinto mece-nate Vincenzo I Gonzaga, duca di Mantova. Le sue prestigiose carterimarranno apprezzati esempi fondamentali per tutto il XVII secolo. DelMagini troviamo nella nostra libreria durantina l’Italia, proprio nella ci-tata edizione di Bologna del 1620.Seppur superato dai fiamminghi sul piano del commercio editoriale, tut-tavia rimase ancora vivo il privilegio italiano nei grandi cicli cartogra-fici pubblici. Il cosiddetto “mondo in parete” brillerà in Italia nel PalazzoDucale di Venezia, a Roma, a Mantova, a Caprarola, a Firenze. La Saladel Mappamondo di Palazzo Venezia a Roma ricorda solo nel nome glisplendidi planisferi affrescati (oggi purtroppo scomparsi) voluti da Pa-pa Paolo II Barbo nel 1464-69. Il Belvedere Vaticano di Innocenzo VIIIe la Villa dei Gonzaga di Francesco II a Mantova vennero entrambe de-corate nell’ultimo ventennio del XV secolo con vedute geografiche. Ilcartografo Jacopo Gastaldi e Giambattista Ramusio appronteranno, trail 1549 ed il 1553, due carte emisferiche del Mondo nella Sala delleUdienze del Palazzo della Serenissima a Venezia. Giovanni Antonio daVarese, Giovanni de’ Vecchi e Raffaellino da Reggio decoreranno poi,nel 1573-74, la Sala del Mappamondo del Palazzo Farnese a Caprarola.Dal 1562 al 1574 anche Cosimo I° de’ Medici volle che la decorazionemurale della sua Guardaroba nuova in Palazzo Vecchio fosse abbellita,sotto la regia di Giorgio Vasari, con rappresentazioni geografiche di tut-
19
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
to il mondo sul modello tolemaico, con “cose del cielo e della terra giu-stissime e senza errori”. Affinché la sua Sala delle Carte Geografichesimboleggiasse il dominio del cosmo (cosmo=Cosimo) sul mondo, incelebrazione dell’idea che quella perfezione con la quale Dio ha ordinatol’intero universo fosse privilegio riservato a chi direttamente da Dio ave-va ricevuto il diritto di governare. Il capolavoro, compiuto nel 1586 incinquantatré tavole a pannello di armadi, fu realizzato dal cosmografodomenicano Egnazio Danti coadiuvato dall’olivetano Stefano Bonsi-gnori. In altre sale il Vasari, in collaborazione col fiammingo GiovanniStradano, realizzerà poi una vasta serie di rappresentazioni della città diFirenze, dei borghi e dei castelli di possedimento del signore mediceo:una vera e propria esibizione della geografia come Instrumentum regni.
Ma il ciclo più rappresentativo della cultura cartografica italiana di que-gli anni rimane senz’altro quello della Galleria delle Carte Geografichein Vaticano, nella Terza Loggia, in un ciclo di quaranta cartografie in af-fresco dello Stato della Chiesa completato da vedute particolari di città.Voluta dal papa bolognese Gregorio XIII Boncompagni nel nuovo cor-ridore fatto realizzare dal 1578 al 1580 dall’architetto bolognese otta-viano Mascarino, la faraonica impresa artistica e scientifica venne anchequi affidata al cosmografo perugino Egnazio Danti, che la progettò e laportò a termine con grande piglio organizzativo fra il 1580 ed il 1582,avvalendosi di numerosi collaboratori che la dipinsero sulla base di suoicartoni. Fra questi si ricordano: per l’aspetto geografico il varesino Gio-vanni Antonio Varosino e il veneto Sabaoth De Dentibus, per quello ve-dutistico i fratelli fiamminghi Paul e Matthijs Bril, per gli apparatifigurativi delle volte Girolamo Muziano e Cesare nebbia. La dimensio-ne dell’intervento e la originalità della concezione rendono il progettogregoriano un originalissimo unicum, invidiabile e mai raggiunto altro-ve. Così scrive il Danti all’insigne cartografo olandese Abraham Horte-lius, il 24 dicembre 1580, descrivendo la sua concezione: ”havendodivisa l’Italia per il mezzo del Monte Appennino, ho posta da una ban-da della Galleria quella parte che è bagnata dal Mare Ligustico et Tirre-no, et dall’altra quella che è cinta dall’Adriatico e dall’Alpi, dividendolapoi secondo gli Stati et le prefetture de’ governi in quaranta parti”.La Galleria misura ben 120m di lunghezza per 6m di larghezza, le pit-
ture vi furono distribuite sui due lati del corridore realizzando una sor-ta di metafora dello spartiacque appenninico dell’Italia: a est le regionidella costa adriatica e ad ovest quelle tirreniche, disposte lungo l’assenord-sud, come in un modello tridimensionale della penisola. L’illu-strazione delle quaranta tavole geografiche (delle quali otto con vedutedei porti e delle isole) sulle pareti e delle cinquantuno storie pittorichesulla volta - integrando storia religiosa e conoscenza geografica - per-segue il duplice intento di mostrare l’idea di uno Stato unificante, sal-
20
Fabio Mariano
damente capace di controllare, rappresentandolo, il territorio della cri-stianità (direttamente quello Pontificio ed idealmente quello italiano) e,tramite il suo potere temporale, consolidare il primato di quello dottri-nario religioso, rafforzato e definito col Concilio di Trento contrappostoall’eresia protestante. La costante raffigurazione delle difese militari del-le città si pone inoltre a deterrente verso le incursioni del pericolo otto-mano, già pesantemente respinto e battuto dalla lega cristiana a Malta(1565) ed a Lepanto (1571). La consulenza dottrinale sull’iconografia venne verosimilmente curatadall’insigne storico oratoriano: il cardinale Cesare Baronio, che proprioin quegli anni stava iniziando su incarico del Papa la sua monumentaleopera controriformistica degli Annales Ecclesiastici. La regione mar-chigiana è qui rappresentata ampiamente in tre corografie (Urbini Du-
catus, Picenum, Anconitanus Ager), in quattro vedute di città (Urbino,Pesaro, Macerata, Loreto), più in una grande veduta del porto di Anco-na. nella volta a botte, dove compaiono i cicli pittorici delle Virtù cri-
stiane, dei Miracoli e dei Sacrifici, si fa riferimento vedutistico direttoad almeno due località delle Marche nei riquadri de: Il trasporto della
Santa Casa di Loreto e San Marcellino Vescovo salva la città da un in-
cendio. Gli affreschi vennero restaurati ed aggiornati più volte nel tem-po, sia per la loro conservazione che per le correzioni e le aggiunte dipossessi sotto vari papi (dei quali tre marchigiani): Sisto V, ClementeVIII, Urbano VIII, quindi Innocenzo X, Clemente XI, sino a Pio IX. Mafurono quelli del papa Barberini certamente i restauri più consistenti,come si evince dalla distribuzione araldica delle numerosi api che si af-fiancano ai dragoni Boncompagni nei cartigli e nelle epigrafi. I restau-ri, voluti appunto da Urbano VIII all’ Ambulatio Gregoriana dal 1630fino ad almeno il 1637, furono eseguiti sotto la direzione cartograficadell’umanista tedesco Lucas Holstenio ed il magistero artistico di nu-merosi pittori importanti. Dall’Holstenio stesso vennero allora riscritti icartigli ed aggiornati i toponimi dell’Anconitanus Ager, del Picenum e,ovviamente, del Ducato di Urbino dopo la sua devoluzione ai Barberi-ni nel 1631. Venne inoltre riveduta l’iconografia di Humana antica (nu-mana) e la veduta di Loreto, modificata per gli interventi urbanisticisistini; vennero inoltre rifatte le vedute di Urbino e di Pesaro dal pitto-re Simone Lagi. Mentre la veduta di Urbino – direttamente ripresa daquella dei disegni di Francesco Mingucci del 1626 - presenta sia la cu-pola del Duomo eretta nel 1604 da Muzio oddi sia la nuova Porta diValbona (1621) attribuibile forse anch’essa all’oddi. Quella di Pesaro ri-mane peraltro veduta molto approssimativa, si veda la errata e somma-ria forma della Rocca Costanza, oppure la planimetria sforzesca ancoraconformata “ad quadratum” e senza la cinta muraria pentagonale am-pliata dai Della Rovere, una conformazione che non teneva stranamen-
21
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
te neanche in conto la nota stupenda incisione del fiammingo Georg Ho-efnagle, inserita dal 1572 nel citato popolarissimo atlante Civitates or-
bis Terrarum edita a Colonia da Georg Braun e Frans Hogemberg. Mainfine, e soprattutto, nel 1632, venne poi ridisegnata completamente lagrande veduta del Porto di Ancona, resasi necessaria per aggiornarla ainuovi lavori di fortificazione costiera ed a quelli per il nuovo Lazzaret-to voluti da Urbano VIII sulla cinta a mare, ben evidenziati nelle visto-se epigrafi dipinte. Il nome dell’artista che la ridipinse ex novo, andrebbericondotto a quello del noto pittore perugino Agostino Tassi, discepolodi Paul Bril e maestro di Lorrain e di Gellée, impegnato nello stesso an-no assieme col bolognese Giovan Francesco Grimaldi a dipingere vedutedi città (ed anche di Ancona) nella Galleria del Quirinale.La prestigiosa realizzazione vaticana influenzerà grandemente la carto-grafia italiana a venire, specialmente le successive carte della Marca diAncona, dal Luchino all’orlandi, ma fu ripresa anche, in forma legger-mente ridotta, dall’ortelius, da Petrus Bertius, da Hendrick van Schoele dallo stesso Magini.Strettamente legata all’avvenimento della devoluzione del Ducato urbi-nate è la produzione di raccolte cartografiche manoscritte realizzate instretta concomitanza con l’acquisizione delle nuove terre da parte delpontificato romano. Annettere lo Stato di Urbino fu la prima pervicaceambizione manifesta di Maffeo Barberini, eletto papa col nome di Ur-bano VIII il 6 agosto del 1623, nella cui stessa calcolata scelta del no-me già sembrava insita la volontà di rendere indiscussa l'autorità centraledell'Urbe capitolina rispetto alle periferie dello Stato Pontificio. PapaUrbano, il colto mecenate di Gian Lorenzo Bernini e di Pietro da Cor-tona, raggiunse il suo scopo senza eserciti né colpi di cannone, bensì at-traverso un sospinto atto “spontaneo” di devoluzione da parte dell'ultimoDuca della Rovere, nella cui famiglia si era già rifusa l'indiretta discen-denza e l'incombente eredità morale del grande Federico di Montefeltro.nel 1623 infatti, a Francesco Maria II della Rovere - esausto settanta-quattrenne – parve: "meglio obbedire che cozzare", oppure: "megliosmontare che cadere", quando decise di abdicare a favore del diciotten-ne figliolo Federico Ubaldo, il quale due anni prima aveva sposato Clau-dia dei Medici, la diciassettenne figlia del Granduca di Toscana. Ilgiorno del loro matrimonio, il 29 aprile del 1621, le città maggiori delDucato - in particolare Urbino e Pesaro, ma anche Casteldurante e San-t'Angelo in Vado - vennero addobbate con archi trionfali ed apparati ef-fimeri progettati e dipinti dai maggiori artisti dello Stato, fra i qualispiccavano il pittore veronese Claudio Ridolfi ed il suo allievo diretto ecollaboratore Girolamo Cialdieri. Le soverchie attese e le trepidazioni dicui tale evento venne caricato rispondevano, come noto, alle preoccu-pazioni dell'anziano Duca per ottenere una discendenza maschile, indi-
22
Fabio Mariano
spensabile per la salvezza del suo Stato. La nascita di una femmina do-po poco più di nove mesi: la piccola Vittoria, non sembrò di buon au-spicio per Francesco Maria, ed ancor meno lo era il comportamentodissoluto ed intemperante tenuto da Federico Ubaldo, che non facevapresagire nulla di buono al vecchio principe. Ma la improvvisa e preco-ce morte del figlio diciottenne, la notte del 28 giugno del 1623, stroncòper sempre le flebili speranze paterne di dare un erede al suo regno, re-cidendo per sempre le antiche radici della quercia roveresca nelle terredel Ducato.Il papa, al secolo Maffeo Barberini, conosceva bene le Marche, dove lasua famiglia di origine fiorentina si era arricchita coi commerci nel por-to di Ancona e dove lui stesso vi era stato Governatore di Fano. Egliconsiderava il Ducato di Urbino una "frattura", un cuneo da svellere al-l'interno dei possedimenti dello Stato Pontificio; ciò nonostante le pre-tese che su di esso esercitava il Granducato di Toscana, sia per antichidiritti dinastici risalenti a Caterina de' Medici sia per la tempestiva mos-sa di Francesco Maria di fidanzare la neonata nipotina Vittoria - di ap-pena un anno - col cugino tredicenne: il Granduca Ferdinando II, nellapalese speranza di rinsaldare con un improbabile matrimonio il suo so-gno di salvare il suo Stato riunificando Urbino con la Toscana. Ma nonerano certo questi impedimenti consistenti, non tali comunque da potercontrastare la ferma volontà del papa. Ed infatti Urbano VIII, tacitatecon convincenti armi diplomatiche la Spagna, la Francia, l'Imperatore te-desco e Venezia, smorzate le flebili pretese della Toscana, isolato infinelo scoraggiato Francesco Maria, poté nel dicembre del 1623 comunica-re al Concistoro dei suoi cardinali la pattuita dichiarazione di resa delDuca. A metà dell'anno successivo fu firmata la convenzione che con-segnava al papa tutti i governatori ed i capi delle milizie delle roccafor-ti roveresche, con un formale rimborso di 100.000 ducati per leartiglierie e le munizioni. Con la umiliante ed intollerabile sensazione diesser divenuto "uomo vendibile a chi aveva saputo profittarsi delle suesciagure", Francesco Maria II chiese di affrettare i tempi della devolu-zione, non sopportando l'ambigua condizione di "avere i fastidi del po-tere senza gustarne i piaceri". Il Duca si sentiva in effetti oramai isolatoed abbandonato, pervaso costantemente da pessimistici pensieri di mor-te, vedendo oramai i suoi sudditi sempre più inclini a rivolgere oppor-tunisticamente i propri interessi verso il potere di Roma. La sua morte,avvenuta il 28 aprile del 1631 ad ottantatré anni e dopo sessanta di re-gno su queste terre, concludeva un epoca aprendone una nuova, simbo-licamente stigmatizzata dall'atto di modifica del nome antico diCasteldurante - amatissima dimora di Francesco Maria - in quello, vo-luto dal papa, di Urbania: quasi una consapevole e beffarda damnatio
memoriae nei confronti dell'immagine avita del vecchio Duca.
23
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
In questo drammatico contesto di stravolgimento politico dei territoridelle Marche settentrionali, si inserisce la produzione di una serie di re-lazioni geografiche di committenza governativa, manoscritte ed illu-strate pittoricamente con planimetrie e vedute panoramiche del territorioroveresco e dei suoi castelli, che si contestualizzano fra le produzionicartografiche più originali del Seicento marchigiano: quasi una risul-tanza sintomatica in campo artistico di quel mutato rapporto fra scienzae natura, fra uomo ed ambiente, che si colloca fra le fonti originarie del-la nuova visione dello spazio barocco e del suo rapporto con la natura.Queste relazioni - che confermano l'interesse diretto dei Barberini per inuovi territori acquisiti - furono estese da pittori ed architetti marchi-giani con finalità di censimento del patrimonio fondiario ed urbano odanche soltanto con l'intento di divulgare visioni idilliache delle terre, deicastelli e ville dell' ex Ducato roveresco; per dimostrare quale salubri,fertili e doviziosi possedimenti spettassero d'ora in poi alla apostolicafamiglia dei nuovi padroni.Fra queste relazioni geografiche illustrate del territorio ducale, ne vor-rei qui segnalare tre, in ordine cronologico (tutte conservate nei codiciBarberiniani Latini della Biblioteca Apostolica Vaticana), delle qualisolo una, quella del Mingucci, è stata recentemente integralmente edita. La prima in ordine di tempo risale al novembre del 1623, a tre mesi ap-pena dall'elezione di Urbano VIII. Fu commissionata all'architetto mili-tare senigalliese Giulio Buratti (1577-1652), Generale comandantedell’Artiglieria pontificia, attivo nella ristrutturazione del Castel S. An-gelo e che fu anche Soprintendente alle Fortezze ed ai Porti dello StatoPontificio per i Barberini. Si tratta del Ms. Barberiniano Latino 6333:una ricognizione illustrata da viste e planimetrie dei circuiti fortificatiprincipali dello Stato, ordinata con indubbia tempestività anche in vistadella probabile devoluzione del Ducato dopo la morte di Federico Ubal-do avvenuta alla fine del giugno precedente. Il Buratti inizia la sua ricognizione il 23 novembre, mentre il papa sol-tanto il 18 di dicembre potrà comunicare ufficialmente ai cardinali riu-niti nel Concistoro la avvenuta dichiarazione di resa di Francesco MariaII, della quale - significativamente - egli era evidentemente già più chesicuro. Già ci si preoccupava infatti di valutare lo stato di efficienza delle for-tezze e di programmare eventuali interventi di adeguamento e rafforza-mento delle principali piazzeforti e rocche dello scacchiere dello Stato.I disegni del Buratti risultano particolarmente interessanti per docu-mentare la forma urbana e lo stato delle difese di alcuni complessi for-tificati nodali (come ad esempio San Leo), alcuni dei quali oggiscomparsi come ad esempio quello di Maiolo e la sua rocca, che crolla-rono a valle col terremoto nella notte del 29 maggio del 1770.
24
Fabio Mariano
notissimo è invece l’album manoscritto (Codice Barberiniano Latino
4434, presso la Biblioteca Vaticana), illustrato dal pittore pesarese Fran-cesco Mingucci. Questi è citato dal Malvasia come collaboratore di Gio-vanni Lanfranco negli affreschi della cupola di Sant'Andrea della Valle;l'Antaldi lo ricorda come assiduo consulente del pittore pesarese Simo-ne Cantarini in quanto, lo dice, "pittore più felice nel pensare che nel-l'eseguire". Partecipò anch'egli - con Claudio Ridolfi, Gian GiacomoPandolfi e Girolamo Cialdieri - alla realizzazione degli apparati per lenozze di Federico Ubaldo della Rovere con Claudia de’ Medici nel 1621.Il suo manoscritto, intitolato: "Stati, Dominii, Città, Terre, e Castella dei
Serenissimi Duchi e Prencipi Della Rovere tratti dal naturale...", data-to 2 aprile 1626, venne iniziato ancora sotto il governo di Francesco Ma-ria II ma, su interessato consiglio verosimilmente dei suoi oppositori,venne però dedicato ad Urbano VIII e donato al suo cardinal nepoteFrancesco Barberini. E' con cinica cortigianeria che il pittore illustrerà
25
Francesco Mingucci (Pesaro 1580 circa - 1642 post.), carta generale del Ducato Roveresco da: Sta-ti Dominii, Città, Terre, e Castella dei Serenissimi Duchi e Prencipi Della Rovere tratti dal natu-rale..., 1626, (Ms. Codice Barberiniano Latino, 4434), Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma.
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
infatti, nel frontespizio della dedica offerta al padrone venturo, una quer-cia roveresca oramai disseccata e sterile attorno alla quale ronzano treapi barberine, col motto: "Non glandes sed mella dabit". L'album con-tiene una ricchissima serie di vedute di città, castelli e ville del territo-rio roveresco, rappresentate a penna e campite con tempere ed acquerellibrillanti e vivaci. Le località raffigurate sono novantuno (incluso S. Ma-rino e alcune città umbre), quindi sette viste particolari di ville patriziea Pesaro ed una del Ponte sul fiume Foglia. Molto interessante ai finicartografici è l’inserimento nell’album di numerose planimetrie parzia-li di territori e di due vedute cartografiche generali degli “Stati dei Se-
renissimi della Rovere”.
Le prime dieci vedute comprendono i territori di: Pesaro, Urbino, Gub-bio, Senigallia, Cagli, Fossombrone, S. Leo e Macerata Feltria, il Vica-riato, Castel Durante e Massa Trabaria. Le due bellissime carte generalidello Stato - che aprono e chiudono il volume - sono pressoché identi-che e coprono la costa dalla foce del Rubicone a quella del nivola (Ni-
gola, oggi Misa), in particolare sino a Tor Feltresca. L’orografia el’idrografia sono ben rilevate e campìte, i toponimi sono numerosissimie corredati da vedutine delle città in dimensione e dettaglio gerarchico,i confini delle varie giurisdizioni politiche ed amministrative sono evi-denziati a colori diversi e molto precisi, la qualità grafica è superiore edarricchita anche da raffinati cartigli e figurazioni (alcuni navigli e unabussola con la rosa dei venti), l’orientamento è a sud-ovest, col nord-est
26
Francesco Mingucci, veduta di Gradara, dal codice Barberiniano Latino 4434, Biblioteca Aposto-lica Vaticana, Roma.
Fabio Mariano
in basso, dove quindi si allinea la costa adriatica parallela alla cornice diinquadramento. Il volume del Mingucci, conosciuto ed apprezzato anchedall’Holstenio – oltre a contenere forse fra le più eleganti cartografiedelle Marche settentrionali del secolo - resta anche un documento stori-co iconografico interessantissimo di rappresentazione paesaggistica trat-ta dal vero, non solo per le coloratissime e quasi sempre realistichevedute ma anche per il dettaglio e la cura con le quali sono illustrate leparticolari colture e l'uso del terreno agricolo in uso nelle Marche delSeicento.Infine veniamo al manoscritto del Cialdieri, il Barberiniano Latino 9911
della Vaticana, in gran parte inedito e pubblicato per la prima volta dal-lo scrivente nel 1997. non voglio qui soffermarmi sulla biografia artisti-ca di Girolamo Cialdieri, ricorderò soltanto, brevemente, che egli nascead Urbino nel 1593 e vi muore nel 1680, che fu allievo diretto di Clau-dio Ridolfi col quale collaborò a lungo - e col quale talvolta si sovrappose- prima di rendersi indipendente ed anche artisticamente riconoscibilenelle sue opere. Segnalo anche la sua rara attività di architetto - oltre ainoti disegni per i due archi trionfali effimeri in Pian di Mercato a Ca-steldurante (Urbania) realizzati per i citati apparati nuziali ducali del 1621- nell' aver dato nel 1628 disegni e progetti per il palazzo della Confra-ternita del Corpus Domini ad Urbino (poi demolito agli inizi del XVIIIsecolo); nella Chiesa di Santo Spirito in Urbino dove, oltre agli affreschidel soffitto, disegnò anche le finte paraste delle pareti; infine negli sfon-di architettonici degli affreschi nella Chiesa di San Giuseppe a Cagli.Cialdieri, in quest’ambito, risulta occupato anche, intorno al 1628, nelladivisione catastale dei terreni del Barco Ducale di Urbania, posti tra quel-li dei Frati Zoccolanti e quelli del Duca Francesco Maria II.Il nostro taccuino di disegni è datato 1632, a devoluzione avvenuta quin-di, ed è titolato: "Piante e vedute di diversi luoghi del Vicariato..."; fucommissionato al Cialdieri dal Prefetto di Roma Taddeo Barberini., ni-pote del papa ed anche comandante della guarnigione di Castel S. An-gelo. La datazione ci dà conto di una delle primissime commesseautonome del Cialdieri seguite alle collaborazioni col Ridolfi, certa-mente antecedente a quella più nota di documentare fedelmente l'esu-mazione delle spoglie del duca Francesco Maria I avvenuta il 22 lugliodel 1633 per volere di Urbano VIII e di Taddeo Barberini. L'album car-taceo è rilegato in pergamena, con le armi dei Barberini al piatto in-quartate assieme all'emblema dei Colonna, verosimilmente a seguito delmatrimonio di Taddeo con Anna Colonna. Molto interessante si mostrail frontespizio figurato, con l'epigrafe centrale sormontata da due che-rubini musicanti porta stemma e da due altri recanti i simboli del pote-re del Cardinale, affiancata da due grandi figure simboleggianti laPittura e l'Architettura. Sullo sfondo compare una veduta di Urbino.
27
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
Sul gusto del Cialdieri per gli sfondi architettonici vorrei qui segnalarela stretta analogia fra la veduta urbinate del frontespizio del nostro ma-noscritto e quella sullo sfondo del noto quadro votivo dell' Assunta e San
Crescentino (oggi al Museo Albani di Urbino), databile subito dopo lapeste del 1630, e che quindi può dirsi pressoché coevo al nostro mano-scritto, il quale può di fatto averne tenuto conto nella composizione. Visi raffigura infatti lo stesso punto di vista: con la Porta Valbona e il cam-panile a cono cèstile del San Francesco a sinistra, quindi il Duomo quat-trocentesco con la cupola progettata da Muzio oddi ed il Palazzo Ducalea destra. Il manoscritto è composto di 25 carte che rappresentano vedutee planimetrie di alcuni centri del territorio del Vicariato ex roveresco. Lapresenza delle planimetrie con l'indicazione dei casamenti ne suggerisceforse la funzione di allegato illustrativo ad un regesto catastale urbano. I paesi raffigurati sono: Torre (La Torre), Barchio (Barchi), Mondavio,
orciano, Monte il Porco (Monteporzio), Castelvecchio, Monte Rado,Tomba, Ripe, Staciola (Stacciola), San Costanzo e Mondolfo. Risultaevidente anche qui il valore storico documentario di tali vedute: bastipensare all'importanza di quella di Mondolfo dove compare intatta lacinta muraria ed in particolare la scomparsa rocca di Francesco di Gior-gio Martini. Si tratta qui infatti della prima rappresentazione dal vero -sinora l'unica nota - del manufatto prima della sua demolizione otto-centesca, dove ben se ne coglie l'articolata complessità compositiva cherivaleggia senza tema di confronti con quella intatta di Mondavio. Ed an-cora: la comparazione della grafia delle planimetrie urbane inserite nelmanoscritto ci porta ad attribuire al Cialdieri la pianta di S. Angelo in Va-
28
Girolamo Cialdieri, (Urbino 1593-1680) ,veduta di Mondavio, da: Piante e vedute di diversi luoghi delVicariato..., 1632 (Ms. Codice Barberiniano Latino, 9911), Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma.
Fabio Mariano
do oggi conservata presso la Biblioteca Comunale di Urbania. Altret-tanto dicasi della allegata bella veduta della città di S. Angelo in Vado(sempre nella biblioteca durantina), incorniciata dallo stemma Barberi-ni, che può anch'essa con calzante attendibilità essere ascritta alla manodi Girolamo Cialdieri. Anche se evidentemente contenuto può dirsi ilvalore di queste opere secondarie del Cialdieri ai fini dell'esegesi delsuo linguaggio artistico, purtuttavia rimane interessante, a mio avviso,la conoscenza di queste committenze secondarie sia come testimonian-za di un particolare clima e costume sociale che viene a stimolare que-sta serie di singolari prodotti artistici, proprio nelle Marche settentrionalied in questo particolare, drammatico momento della loro storia politica.Sia, inoltre e più in generale, come testimonianza di un 'incipiente espan-dersi dell'interesse, e financo della moda, per la rappresentazione delpaesaggio e della cartografia, così tipico dell'evoluzione del linguaggioe delle tematiche dell'arte barocca, anche nelle Marche fin dai primi an-ni del '600.La diffusione della cartografia regionale, a partire dalla metà del XVI se-colo, è la diretta conseguenza della struttura frammentaria del potere po-litico nell’Italia post rinascimentale. I governi locali - ducati, signorie elo stesso Stato Pontificio ancora in via di definizione territoriale sul suofronte settentrionale, a partire dall’acquisizione di Ancona, Perugia, Fer-rara, fino al Ducato di Urbino - avevano necessità di un controllo diret-to, politico e amministrativo sulle loro terre le quali, anche per la lororidotta estensione, consentivano progetti di rilievo cartografico com-plessivi.non esisteva ancora all’epoca in Italia, e tantomeno nelle Marche, unavera e propria scuola di rilevamento topografico, bisognava quindi crea-re un punto di contatto fra discipline che, seppur diverse, fossero co-munque in qualche modo concorrenti alle finalità preposte. In effetti essepotevano ben configurarsi nella collaborazione fra gli studiosi della teo-ria matematico geometrica ed i tecnici della misurazione e del control-lo dello spazio, ovvero gli architetti. nelle Marche, e specificatamentenel Ducato di Urbino, si era venuta a creare una particolare congiuntu-ra culturale nella quale questa collaborazione poteva attuarsi, anzi giàconviveva negli esiti tardi e nel lascito della mitica fucina umanisticaformatasi nella corte feltresca del Duca Federico già nel secolo prece-dente. Urbino è, nel XVI e XVII secolo, ospite di uno dei principali ce-nacoli del cosiddetto “umanesimo matematico”, un convivio in cui lamatematica si incrociava spesso con la simbologia, con i volumi archi-tettonici, con le armonie celesti dell’astronomia e dell’astrologia, del di-segno del territorio. La corte, feltresca e poi roveresca, attorno a cuigravitavano le “cerchie dotte” dei nobili locali - dove non mancavanooccasioni di pianificare ambienti urbani e nuove fortificazioni, oltreché
29
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
di disquisire d’arte e di scienza, e patrocinare una fiorente officina mec-canica di strumenti matematici e mensori fondata da Simone Barocci ecurata da validi artigiani – fu infatti uno dei poli europei privilegiati didiscussione critica del sapere matematico e geometrico dell’epoca.Concludendo, credo utile delineare in questo contesto alcune figure coe-ve di artisti, scienziati ed architetti i quali, con le loro opere particolari,possano contribuire a chiarire il clima culturale nel quale la raccolta geo-grafica del duca Francesco Maria II possa aver trovato un humus fe-condo al suo sviluppo, a testimonianza di un non occasionale interessedi ricerca e di produzione in questo ambito disciplinare, che aveva nelterritorio ducale fondato solide basi negli anni di scorcio tra XVI e XVIIsecolo.Fra gli architetti rovereschi impegnati anche in campo topografico e geo-grafico va ricordato l’urbinate Baldassarre Lanci (1510 – 1571), reviso-re delle fortificazioni pontificie per Pio IV, che nel 1557 realizzerà –probabilmente proprio nell’officina urbinate - uno strumento a gnomo-ne solare per il rilievo topografico. Anche urbinate fu l’architetto e to-pografo Giambattista Clarici (1542-1602): "Architetto et pigliator didistanze, altezze e profondità di monti, colli ed acque" lo definisce Gio-vanni Paolo Lomazzo. Sembra che a Milano dal 1586 succedesse a Pel-legrino Tibaldi come ingegnere di corte; si hanno notizie di suoi collaudiper opere nel Palazzo ducale col Tibaldi dal 1585 e di lavori in palazzoMarino nel 1595. Il Clarici eseguì una carta del Ducato di Urbino (pri-ma del 1580, oggi scomparsa), mai stampata, in base a “nuove misurefatte per terra”, ricca di particolari e di ben 534 toponimi, che servì daprototipo per la successiva e più famosa cartografia a stampa del Duca-to e forse anche per l’affresco dell’ Urbini Ducatus nella Galleria delleCarte Geografiche in Vaticano. Il durantino Cipriano Piccolpasso (1523-1579), già provveditore della Rocca Paolina dal 1558, collaboratore diCesare Guasco alle fortificazioni di Ancona (1566), sarà anche l’autore,dal 1565 su incarico del Governatore Apostolico di Perugia, di una ri-cognizione amministrativo-militare del territorio umbro, che egli rac-colse nel “ Il Libro delle piante et i ritratti delle città e terre dell’Umbria
sottoposte al Governo di Perugia” dove, oltre a trattare nelle sue anno-tazioni alcuni problemi topografici, raccoglie fra l’altro anche due ine-dite piante e viste di città marchigiane allora ricadenti nel territorioumbro, raffiguranti Visso e Sassoferrato. Del pittore fanese Giovan Fran-cesco Morganti (notizie dal 1553-1581), fratello del più noto Pompeo,si ha notizia di una commessa da parte del Comune di Fano per una co-rografia della sua città e del territorio nel 1581, da inviare per docu-mentazione a Roma, dove il Danti stava allestendo i cartoni per la suacitata Galleria geografica in Vaticano.Fra le prime figure di “scienziati”, nell’etimo moderno di specialisti del-
30
Fabio Mariano
la conoscenza, non pochi nascono nelle Marche o qui operano signifi-cativamente. Il primo fra questi è senza dubbio Guidubaldo dal Monte(1545-1607), brillante studioso di nobile famiglia pesarese, amico delTasso che lo dichiarò “misurator de’ gran celesti campi e de’ moti del so-le e della luna”. Fu marchese di Mombaroccio, compagno di studi a Pa-dova di Francesco Maria II della Rovere, dell’umanista urbinateBernardino Baldi (1553-1617) – il primo storico moderno della scienzacome biografo principe di Copernico ed autore nel 1578 del poemettoL’invenzione del bossolo da navigare – compagno dello stesso Torqua-to Tasso, e tutti assieme allievi della scuola urbinate fondata dal mate-matico e umanista Federico Commandino (Urbino, 1509-1575), autorequesti, fra l’altro, di una fondamentale versione degli Elementi di Geo-
metria di Euclide (Pesaro, 1572), ma importante qui per noi per il suo InPtolemaei Planisphaerium Commentarius. In quo universa Scenogra-
phices ratio quam brevissime traditur, ac demonstrationibus confirma-
tur, (Venezia, Paolo Manuzio, 1558) dedicato al planisfero di Tolomeo.Guidubaldo, cosmografo, geometra, meccanico, architetto militare, fuuno dei maggiori scienziati europei del ‘500. A lui si deve il privilegiodi aver intuito il talento di Galileo e di presentarlo personalmente - gra-zie ai suoi rapporti con la corte - al Granduca di Toscana Ferdinando I,consentendogli di ottenere in seguito la prestigiosa cattedra di matema-tica all'Università di Pisa. Il Dal Monte fu anche Ispettore Generale ditutte le città e fortezze del Granducato di Toscana, lavorò allo studio peril porto di Pesaro e qui, nel 1600, proprio allo scoccar del secolo, pub-blicò il suo volume Perspectivae Libri Sex: un testo fondamentale perla storia della geometria descrittiva, allora ancora non tracciata comescienza, che sarà poi alla base dei successivi fondamenti di Desàrgues.Ma, soprattutto per il nostro discorso, va ricordata la sua opera Plani-
sphaeriorum Universalium Theorica, pubblicata a Pesaro nel 1579, do-ve nel I° Libro espone la sua “teoria del planisfero”, basata sempre sullaproiezione stereografica tolemaica ma col centro di proiezione posto sulcerchio equinoziale, in uno dei due punti dove lo intercetta l’eclittica, ot-tenendo risultati grafici ben diversi per il metodo di genesi proiettiva enel rapporto che si viene così ad aprire fra planisfero e scienza prospet-tica, teoria che molto lo avvicina a quella dell’ Astrolabium nostrum delmatematico olandese Rainer Gemma Frisius. Un altro marchigiano di fama europea compare fra i grandi personaggidell’entourage scientifico del Ducato roveresco: Giovanni Branca(1571-1645) da S. Angelo in Lizzola. Fu ingegnere militare e dal 1614Architetto della Santa Casa di Loreto, dove spiccò (1621-22) i baluardipentagonali sulla cinta muraria del Sangallo e dove tracciò l'acquedottoper condurre l'acqua dalle colline di Recanati sino alla Fontana dellaMadonna nella piazza della Basilica. Branca era principalmente un tec-
31
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
nico e divenne famoso soprattutto per i suoi trattati, editi ambedue nel1629: il Manuale di Architettura, pubblicato ad Ascoli e divenuto pre-sto il "livre de chevet" dei praticanti di architettura, raggiungendo le set-te edizioni in 160 anni; quindi il ben più importante e corposo trattato Le
machine: volume nuovo et di molto artificio da fare effetti maravigliosi
tanto spirituali quanto di animale operatione.. pubblicato a Roma, do-ve si passano in rassegna le conoscenze delle macchine antiche filtrateattraverso la cultura tecnica e teorica, specialmente idraulica, dei Grecie dei Romani.notevole, infine, fu anche l’apporto alla scuola roveresca dell’architet-to e matematico urbinate Muzio oddi (1569-1639), allievo del Com-mandino, amico e corrispondente del famoso cartografo bologneseGiovan Antonio Magini e di Cristoforo Clavius. L’oddi, personalità con-trastata ed inquieta, realizzò fra l’altro la prima cupola del Duomo diUrbino e il Duomo di Fabriano, oltre ad aver dato i disegni per l’am-pliamento della Chiesa della Croce di Senigallia, dove veniva allora col-locata la famosa Deposizione di Federico Barocci, pittore del quale erastato allievo. Arrestato per presunti intrighi a corte e quindi esiliato dal-la patria, si rifugiò a Venezia per essere poi nominato Architetto della S.Casa di Loreto (1631-36). nel 1626, nominato per cinque anni inge-gnere militare al servizio della Repubblica di Lucca spiccò su suo dise-gno, ed inizialmente assieme al fratello Matteo (morto quell’anno), laterza ed ultima cinta delle mura della città e la nuova Porta di S. Dona-to. A Lucca ebbe anche committenze per lavori di abbellimento all’in-terno della Cattedrale di S. Martino e per alcune nobili residenze dicampagna tra le quali Villa Cenami Mansi a Segromigno in Monte(1634). Pubblicò anche lui trattati: in particolare ebbe un certo succes-so quello sugli orologi solari (De gli horologi solari nelle superficie pia-
ne trattato di Mutio Oddi da Urbino,) pubblicato nel 1614 a Milano perGiacomo Lantoni, dove viveva in esilio, dedicato al conte GiangiacomoTeodoro Trivulzio suo locale protettore. Pubblicò poi quello sullo squa-dro per le misurazioni topografiche e agrimensorie dedicato al conteFrancesco Bernardino Marliani (Dello Squadro, Trattato, Milano 1625);quindi nel 1633 quello sulla Fabrica et uso del compasso polimetro edi-to, sempre a Milano presso Francesco Fobella. nel 1636, rientrato fi-nalmente nella sua Urbino, pubblica la sua ultima opera: Degli Horologi
Solari (Venezia, 1638).Va considerata l’ipotesi che possa appartenere all’oddi il disegno ar-chitettonico iniziale dei locali della “libreria impressa”, voluta colloca-re dal duca Francesco Maria II nel suo palazzo di Casteldurante. Lanuova fabbrica fu iniziata nel 1607 e portata a termine dal collega Pie-tro Vanni, dopo l’arresto di Muzio avvenuto nel 1606 per ordine dellostesso Duca, del quale era stato per anni il suo principale architetto.
32
Fabio Mariano
Bibliografia essenziale
LoMAZZo G.P., Trattato dell'arte della pittura, scultura et architettura, Milano 1585.GRoSSI C., Degli Uomini Illustri di Urbino Commentario, Urbino, 1819.DEL BADIA J., Egnazio Danti, cosmografo e matematico e le sue opere in Firenze, in“Rassegna nazionale”, VI, 1881, pp.621-631; VII, 1881, pp. 434-474.ALMAGIà R., L’Italia di Giovanni Antonio Magini e la cartografia dell’Italia nei seco-
li XVI e XVIII, Ed. F. Perrella, napoli 1922.FISCHER J. (a cura di), Claudii Ptolemaei Geographiae codex urbinas grecus 82, Leida-Lipsia 1932.ALMAGIà R., L'opera geografica di Luca Holstenio, Città del Vaticano, Biblioteca Apo-stolica Vaticana, 1942.GALLo R., Le mappe geografiche del Palazzo Ducale di Venezia, in “Archivio veneto”,XXXII, 1943, pp.47-89.ALMAGIà R., Monumenta Cartographica Vaticana, 4 voll., Città del Vaticano, Roma1948-52.TooLEY R.V., Maps and map-makers, Batsford, London 1949, II° ed. London 1987.BonASERA F., La raccolta di antiche carte geografiche presso la Galleria Nazionale del-
le Marche di Urbino, in “Studia Picena”, 1955, pp.156-157.BARBERI F., Libri e stampatori nella Roma dei papi, Istituto di Studi Romani, Roma 1965.VoET L., L’age d’or d’Anvers. Essor et gloire de la Metropole au seizième siècle, Anversa 1976.BATTISTELLI F., PAnICALI R., Il territorio di Fano nella cartografia delle Marche, dalla
metà del XVI ai primi del XIX secolo, Ed. Cassa di Risparmio di Fano, Fano 1979.LEonARDI C., Cipriano Piccolpasso, Pro Loco Casteldurante, Urbania 1981.JACoBELLI P., MAnGAnI G. (a cura di), Atlante storico del territorio marchigiano, 2 voll.,Ed. Cassa di Risparmio di Ancona, Ancona 1983.GAMBA E., MonTEBELLI V., Le scienze a Urbino nel tardo Rinascimento, Ed. Quattro-venti, Urbino 1988.BRoC n., La geografia del Rinascimento. Cartografi, cosmografi, viaggiatori 1460-
1620, Ed. Franco Cosimo Panini, Modena 1989.MARIAno F., Architettura militare del Cinquecento in Ancona. Dal Sangallo al Fonta-
na. Con la trascrizione del Codice Vat. Lat. 13325 di Giacomo Fontana (1588/89), Ed.Quattroventi, Urbino 1990.SCHULZ J., La cartografia tra scienza e arte, Edizioni Franco Cosimo Panini, Modena 1990.TonGIoRGI ToMASI L., Francesco Mingucci e il manoscritto vaticano degli “Stati, Do-
minii, Città, Terre e Castella dei Serenissimi Duchi e Principi della Rovere”, in “Cittàe castella”, 1991, pp. XIV-XLVIII.AA. VV., Città e castella (1626). Tempere di Francesco Mingucci Pesarese, Ed. nuovaEri, Torino 1991.MARIAno F., Documenti e notizie sulle fortificazioni di Ancona da Paolo III a Sisto V e
gli studi di Giacomo Fontana (1588), in Aa. Vv., Sisto V. Le Marche. II, Ed. Poligrafi-co dello Stato, Roma 1992, pp.127-150.VALERIo V., Atlanti italiani dall’invenzione della stampa all’affermazione della lito-
grafia, in “Institut Cartogràfic de Catalunya”, Barcelona 1993, pp.149-201.SInISGALLI R., La teoria sui planisferi universali di Guidobaldo del Monte, Ed. Cadmo,Fiesole 1994.MARIAno F., Architettura e scena urbana nelle Marche dalla Controriforma al Tardo ba-
rocco, in: Aa.Vv., Il '600 nelle Marche, Quaderni del Centro BB.CC. Regione Marche,Ancona 1994.WATELET M., Gérard Mercator Cosmographie, le temps et l’espace, Fonds Mercator Pa-ribas, Anversa 1994.GAMBI L., PInELLI A., La Galleria delle Carte geografiche in Vaticano, 3 voll., Ed. Fran-co Cosimo Panini, Modena 1994.MARIAno F., L’Architettura e gli architetti militari, in F. Mariano, Architettura nelle
Marche. Dall’Età classica al Liberty, Edizioni nardini, Fiesole 1995, pp.206-212.
33
Gli anni d’oro della conoscenza geografica, tra progresso scientifico ed Instrumentum Regni
WooDWARD D., Maps as Prints in the Italian Renaissance, British Library, London 1995.MARIAno F., La rappresentazione cartografica del territorio. Le Marche da rivisitare,in AA.VV., Cartografia storica delle Marche, (a cura di G. nepi), XVII Esposizionedell’editoria marchigiana, Biblioteca Egidiana, Tolentino 1996, pp.13-21.PAoLI F., Le collezioni di geografia e cartografia della Biblioteca Comunale di Urba-
nia, in Mangani G., Paoli F. (a cura di), Gerardo Mercatore. Sulle tracce di geografi e
viaggiatori nelle Marche, Edizioni Biblioteca e Civico Museo di Urbania, Il Lavoro edi-toriale, Ancona 1996, pp. 31-33.MARIAno F., Mercatore per le Marche. Fra Urbania e Tolentino, in “Le Cento Città”,n.4, Il lavoro Editoriale, Ancona 1996, pp.59-60.ALLEGRETTI G., Mercanti, agricoltori, pittori: i Mingucci di Pesaro negli anni della de-
voluzione, in: "Pesaro città e contà" n. 7, 1996, pp. 45-56.MARIAno F., (a cura di), La Città marchigiana. Architettura e Urbanistica per un'iden-
tità regionale, Atti del Convegno (29-30 giugno 1993), Quaderni del Centro Studi D.Grandi, n.4, Ed. Quattroventi, Urbino 1997.MARIAno F., Un taccuino di disegni inedito di Girolamo Cialdieri, in Claudio Ridolfi.
Un pittore veneto nelle Marche del Seicento, (a cura di C. Costanzi, F. Mariano, M. Mas-sa), Atti del Convegno (Corinaldo 24 settembre 1994), Centro Studi D. Grandi, Ed. Quat-troventi, Urbino 1997, pp. 137-147.MARIAno F., L’immagine delle Marche fra storia e cartografia, in AA.VV. , La scena
marchigiana tra immagine e immaginario (a cura di n. Ricci), Comune di Sarnano,1997, pp. 15-46.CECInI n., Le città marchigiane nel mito del “Voyage en Italy” con un primo saggio di
bibliografia sui viaggi nelle Marche dal XVI al XX secolo, in La Città Marchigiana, ar-
chitettura e urbanistica per un’identità regionale, (a cura di F. Mariano), Ed. Quattro-venti, Urbino 1997, pp.109-121MoCHI o. L., Inediti disegni del Ridolfi e del Cialdieri, pittori della corte urbinate, in
Claudio Ridolfi. Un pittore veneto nelle Marche del Seicento, (a cura di C. Costanzi, F.Mariano, M. Massa), Atti del Convegno (Corinaldo 24 settembre 1994), Centro Studi D.Grandi, Ed. Quattroventi, Urbino 1997, pp. 117-135.MARIAno F., Il Disegno del Territorio. Storia della cartografia delle Marche, (con G.Mangani), Il Lavoro editoriale, Ancona 1998. MAnGAnI G., Il “mondo” di Abramo Ortelio. Misticismo, geografia e collezionismo nel
Rinascimento dei Paesi Bassi, Edizioni Franco Cosimo Panini, Modena 1998.MARIAno F., L'immagine delle città. La Provincia di Ancona tra vedutismo e cartogra-
fia, Il Lavoro editoriale, Ancona 2001. MARIAno F., Giacomo Fontana, Pianta prospettica di Ancona (1569), in Collectio The-
sauri. Dalle Marche tesori nascosti di un collezionismo illustre (a cura di M. Mei), vol.I, tomo II, Regione Marche, Edifir, Firenze 2005.MARIAno F., Una Mappa della Bassa Valle dell'Esino, in Collectio Thesauri. Dalle Mar-
che tesori nascosti di un collezionismo illustre (a cura di M .Mei), vol. I, tomo I, RegioneMarche, Edifir, Firenze 2005.PACETTI P. (a cura di), La Sala delle Carte geografiche in Palazzo Vecchio. Capriccio et
invenzione nata dal Duca Cosimo, Edizioni Polistampa, Firenze 2007.MARIAno F., Le Marche nella cartografia. XVI-XIX secolo, Catalogo della Mostra (osi-mo, Chiesa di S. Silvestro, 6-15 giugno 2008), (con A. Volpini). Edizioni Il lavoro edi-toriale, Ancona 2008. MEI M., PAoLI F. (a cura di), La libraria di Francesco Maria II della Rovere a Castelduran-
te da collezione ducale a biblioteca della città, Edizioni Quattroventi, Urbino 2008.ConnoRS J., La seconda vita della libraria di Urbania di Francesco Maria II della Ro-
vere a Manhattan, in Mei, Paoli, op.cit., Urbino 2008, pp.87-93.SERRAI A., La Biblioteca di Francesco Maria II a Casteldurante, in Mei, Paoli, op.cit.,
Urbino 2008, pp.15-40.MARR A., Between Raphael and Galileo: Mutio Oddi and the Mathematical Culture of
Late Renaissance Italy, University of Chicago Press, Chicago 2011.
34
Fabio Mariano