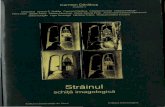L'insediamento neolitico nella media valle ofantina: l'area di Palata (Canosa di Puglia)
4.08-Fattore L., Nava A. et Al., L'area sacra di Daba (Musandam, Oman, II-I millennio a.C.). I morti...
Transcript of 4.08-Fattore L., Nava A. et Al., L'area sacra di Daba (Musandam, Oman, II-I millennio a.C.). I morti...
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
1
L’AREA SACRA DI DABA (MUSANDAM, OMAN, II-I MILLENNIO a.C.). I MORTI OLTRE LA MORTE. L’ANALISI TAFONOMICA E L’INTERPRETAZIONE DEI PROCESSI CULTURALI E NATURALI SULLE
OSSA DI LCG2
Introduzione
Il complesso funerario di Daba1 è attualmente costituito da due grandi tombe collettive (LCG1 ed LCG2)2, da una tomba partica e da diverse fosse rituali ricche di oggetti in bronzo3. LCG2 è stata usata in un arco di tempo che va dal Late Bronze Age (1600-1350 a.C.) fino all’Iron Age II/III (circa 600 a.C.). Quest’area sacra si inserisce nel panorama archeologico degli Emirati ed è circondata da molti altri siti, sia a carattere abitativo (Tel Abrak, Masafi e Hili) che funerario (Jebel Buhais, Shimal e Asimah) risalenti all’età del Ferro4. Le evidenze archeologiche suggeriscono che tutta l’area funeraria possa essere stata utilizzata come tributo monumentale ad alleanze tribali risalenti alla fine del II millennio a.C. (Bortolini, Tosi 2011). Le tombe collettive sono state indagate durante due campagne di scavo (dal 2013 al 2015). Durante la seconda missione sono emerse le strutture più elevate e le fasi d’uso più tarde della LGC2, che, seppure non ancora completamente indagata, ha restituito un numero cospicuo di oggetti e contesti deposizionali per lo più intatti5. Mentre la prima tomba collettiva (14x3,5 metri) ha fornito principalmente dati quantitativi sugli oggetti e sui reperti osteologici6, la LCG2 (23x6 metri) ha permesso valutazioni e ipotesi su quello che appare un complesso rituale funerario che poteva implicare un trattamento dei cadaveri prima della sepoltura definitiva, lo spostamento di corpi o parte di essi e il riuso delle strutture principali della tomba. Al momento LCG2 ha restituito migliaia di oggetti (più di 2000 quelli di pregio), spesso in stretta associazione con resti umani e animali e in essa sono state riconosciute diverse fasi di frequentazione, restauro e riorganizzazione delle strutture come l’aggiunta di camere esterne o localizzate lungo il perimetro originale7. La grande camera rettangolare è semi sotterranea, circondata da una corona di pietre che si innalzano fino a 1,5 metri dal piano di calpestio. L’entrata originaria della tomba è stata, in un momento successivo, arricchita da un recinto rettangolare, la cosiddetta entrance hall, che ospitava alcune delle deposizioni più interessanti tra cui 6 primarie (solo 2 riferibili ad individui adulti, entrambi di sesso femminile).
1 La città di Daba sorge all’incrocio di un Sultanato (quello dell’Oman, di cui il Musandam è un exclave in
territorio degli Emirati) con due degli Emirati che fanno parte degli UAE (Sharjah e Fujairah). La sua posizione, sulla costa araba dello stretto di Hormuz, all’imbocco del golfo Persico ma protesa nell’oceano Indiano, le ha conferito un ruolo primario negli scambi culturali e commerciali tra la Penisola araba da un lato e Iran e subcontinente indiano dall’altro.
2 Prospezioni geofisiche hanno evidenziato la presenza di quelle che sono state interpretate come ulteriori tombe collettive.
3 Si tratta di vasellame e armi in ottime condizioni di conservazione e di pregevole fattura. 4 L’Età del Ferro in Arabia orientale è stata definita sulla base della cronologia iraniana ed è suddivisa in tre fasi:
Iron Age I (1200 – 1000 BC), un periodo di transizione tra la tarda Età del Bronzo e l’Età del Ferro propriamente detta e che è stata evidenziata solo in pochi siti (Shimal, Tell Abraq, Kalba); Iron Age II (1000 BC – Circa 600-550 BC), che è la fase principale dell’Età del Ferro locale; Iron Age III (600-550 – 250 BC), una fase tarda, poco rappresentata e pochissimo compresa, forse contemporanea della Iron Age III Iraniana. Le fasi più antiche sono caratterizzate, in realtà, da un uso occasionale di oggetti in ferro per lo più di importazione.
5 A differenza dei siti vicini, le tombe di Daba sono ben conservate e per lo più inviolate. 6 Si tratta dei resti di almeno 188 individui e quasi 2000 oggetti di fattura pregiata tra vasellame in bronzo e steatite,
daghe, bracciali, punte di freccia, medaglioni decorati in conchiglia e numerose perline e collane di materiali diversi. 7 Le strutture accessorie a quella principale sono tutte poste ad est della LCG2. Si tratta di recinti, circoli e altarini
probabilmente edificati con le stesse pietre della LCG2
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
2
L’ampio spazio della Large Collective Grave 2 e strutture accessorie ha restituito diverse tipologie di sepolture classificabili in base alla loro organizzazione spaziale, alla quantità di elementi scheletrici presenti e all’associazione con il corredo e resti animali. Le fasi più recenti e superficiali, probabilmente di abbandono, sono caratterizzate da ossa sparse e frammentate non interpretabili come deposizioni intenzionali. Gli strati sottostanti hanno restituito gruppi di ossa umane, spesso riferibili ad azioni antropiche volontarie, che sono stati definiti Bone Clusters (BC). Le fasi più antiche sono caratterizzate dalla prevalenza di sepolture primarie in stretta associazione con le strutture murarie.
Le tipologie di Bone Clusters
I raggruppamenti di ossa umane caratterizzanti l’interno e le aree circostanti LCG2 sono stati classificati, per necessità operative, in base alle diverse modalità di deposizione secondaria osservate. Alcuni gruppi mostrano limiti indefiniti e, in linea generale, la lunghezza e la larghezza del deposito sono molto maggiori rispetto allo spessore. Questi sono i cosiddetti BC dispersi, propri delle fasi più recenti di frequentazione della tomba. Le ossa lunghe sono numerose, a differenza di quelle piccole, e spesso allineate con l’asse maggiore della tomba. La loro origine non è chiara. I BC puntiformi, ossa singole o gruppi di pochi elementi, spesso crani e sempre isolati, sono caratteristici anch’essi delle fasi di frequentazione più recenti ed occupavano angoli della struttura o anfratti tra le lastre. Un rinvenimento di rilievo, all’interno della entrance hall, è costituito da un omero umano intenzionalmente modellato a richiamare la forma di un serpente, da mettere in relazione con il ben documentato culto del serpente caratterizzante l’area del golfo (Benoist 2007). I BC tridimensionali sono deposizioni secondarie di ossa strettamente associate con materiale archeologico e fauna, caratterizzati da una precisa organizzazione spaziale nelle tre dimensioni. All’interno di alcuni di questi clusters, nonostante la mancanza di connessioni anatomiche strette, sono stati riconosciuti, per maturità scheletrica o per caratteristiche di robustezza e/o stress biomeccanico, elementi appartenenti a singoli individui, suggerendo che i raggruppamenti siano il risultato di uno spostamento da contesti primari8. Laddove la commistione delle ossa è tale da non permetterne l’attribuzione, è stata ipotizzata la loro provenienza da altre sepolture secondarie o da molteplici primarie solo parzialmente svuotate. Alcuni clusters mostrano una precisa forma che, in assenza di una fossa deposizionale, sembra essere compatibile con contenitori, in materiale deperibile, usati forse per trasportare o sistemare in maniera ordinata le ossa, già scheletrizzate, dentro e intorno ad LCG29.
8 Le deposizioni primarie sono quelle per cui si può dimostrare che, al momento della collocazione nella tomba,
pelle, tendini e legamenti, erano ancora in grado di impedire la dislocazione di ossa contigue. Per questo si valuta principalmente lo stato delle articolazioni labili (mani, parte distale dei piedi, colonna cervicale) per stabilire la tipologia di una deposizione. Le sepolture secondarie, invece, prevedono una fase di scarnificazione non necessariamente antropica, in un luogo diverso da quello della sepoltura definitiva (DUDAY, GUILLON 2006). In realtà in ambienti aridi può capitare che articolazioni labili come quelle di mani e piedi, ma anche tratti di colonna vertebrale o arti interi, assumano lo status di persistenti a causa dei processi di mummificazione naturale causati dal clima e da concomitanti pratiche di esposizione del cadavere in ambienti areati. In questi casi una corretta valutazione della tipologia di deposizione non può prescindere da queste condizioni ambientali e culturali.
9 Un esempio ben caratterizzato si ha con il BC 24, dove l’insieme delle ossa, disposte circolarmente e verticalmente, ha una forma a tronco di cono rovesciato, che ricorda la forma di un cesto.
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
3
Le deposizioni primarie
Ad oggi, associate a LCG2, sono state rinvenute 28 inumazioni relative a 21 tombe. Nei livelli di frequentazione più antichi le deposizioni primarie si presentano in stretta associazione con le strutture murarie, spesso modificate per accogliere l’inumato e con evidenze di riutilizzo degli spazi deposizionali10, a sottolineare lo sfruttamento intensivo della tomba collettiva. Quasi tutti gli individui giacciono su di un lato (indifferentemente il destro o il sinistro) con le mani davanti al volto e le gambe sempre flesse, a dimostrazione di un rituale ben consolidato. Il grado di contrazione degli arti è inversamente proporzionale allo spazio disponibile per l’inumazione11. In tutti i casi il disfacimento dei tessuti molli si è completato in uno spazio pieno riempitosi progressivamente. Un caso particolare è quello relativo alla chamber B, una struttura circolare di poco più di 1 metro di raggio, dove, in circa 50 cm di profondità, trovano posto almeno 8 individui sepolti contemporaneamente, proni e con braccia e gambe flesse e intrecciate. Un’analisi demografica preliminare evidenzia che tra gli individui in giacitura primaria sono presenti 14 adulti (7 femmine, 4 maschi, 3 non determinabili) e altrettanti individui infantili (di cui ben 7 sotto l’anno di vita). La presenza di individui di entrambi i generi e appartenenti a tutte le classi di età indica l’assenza di una selezione degli individui sepolti nella LCG2. Per i contesti di giacitura secondaria, una prima valutazione attesta il Numero Minimo di Individui (NMI) rinvenuti nell’ultima stagione di scavo ad un valore pari a 119, di cui 84 adulti e 35 subadulti. Se consideriamo i dati aggregati delle due campagne di scavo, la stima raggiunge il valore di 199.
Le evidenze tafonomiche
Il rinvenimento di mani, piedi e alcuni tratti di colonna vertebrale in connessione all’interno di giaciture secondarie, può essere correlato a fenomeni di mummificazione naturale, compatibili con il clima arido della zona12, osservato anche in altri contesti dell’area (Salvatori 1996); questo ci permette di ipotizzare che i cadaveri, almeno in alcuni casi, venissero esposti in ambienti aperti ma protetti, prima della definitiva inumazione13. Questa ipotesi di lavoro è rafforzata dall’osservazione che le parti più fragili dei crani sono ben conservate, indicando una provenienza da contesti di spazio vuoto e non da inumazioni precedenti14. Considerato anche che non si osservano
10 Frequentemente sono stati rinvenuti elementi scheletrici non riferibili all’individuo in giacitura primaria, al di
sotto ed intorno ad esso. Nel caso di una deposizione in posizione molto contratta, in uno spazio deposizionale angusto, a pochi centimetri dalle ginocchia dell’inumato, è stata rinvenuta una terza rotula che è stato possibile distinguere dalle altre due solo perché queste erano in connessione con i condili femorali.
11 In alcuni casi il grado di compressione del corpo è tale da far supporre che la deposizione debba essere stata necessariamente effettuata solo al termine del rigor mortis e in concomitanza con una parziale degradazione delle masse muscolari.
12 La mummificazione naturale è un processo che necessità di un clima secco per permettere ai tessuti di deidratarsi con una minima azione dei batteri decompositori. Relativamente comune è la mummificazione solo di alcune parti del corpo; ad esempio le estremità di mani e piedi mummificano facilmente, in condizioni di aridità relativamente alta, a prescindere dalla temperatura ambientale (DIX, GRAHAM 2000).
13 Anche in ambienti aridi, la mummificazione è comunque più probabile negli spazi aperti che in quelli chiusi (GALLOWAY ET AL 1989).
14 Il prelievo dei crani da una deposizione in piena terra avrebbe danneggiato i reperti nella maggior parte dei casi e l’assenza di segni di predazione animale sulle ossa fornisce l’indicazione che il contesto primario delle deposizioni doveva essere protetto, anche in relazione alla mancanza di ossa sbiancate ed esfoliate, tipiche di una prolungata esposizione “open air” del corpo dopo la morte (GALLOWAY ET AL 1989). All’interno del deposito ghiaioso US 2021, contenente il bone cluster 32, caratteristico di una specifica zona della tomba e in generale di una specifica fase
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
4
decomposizioni in spazio vuoto nelle primarie all’interno di LCG2, è molto probabile che la fase di esposizione avvenisse esternamente alla tomba.
Le indagini archeozoologiche
Una parte dei reperti osteologici recuperati riguarda fauna. Sono state rinvenute numerose ossa animali, prevalentemente capre, ma anche buoi, pecore, cani, cavalli e pesci sono rappresentati. Scarsissimi sono camelidi e suini15. A livello anatomico, si nota una scelta preferenziale per i resti relativi al cranio (soprattutto mandibole) e alla parte distale delle zampe, che sono le porzioni meno ricche di carne; spesso si trovano in stretta relazione con le ossa umane, tanto da lasciare supporre l’esistenza di un rituale che prevedeva un’offerta di precise porzioni di animali16. Sono inoltre presenti resti faunistici espressione della deposizione di elementi legati alla ritualità, come il gruppo di astragali di capra e pecora ricoperti di ocra rossa all’interno del bone cluster 3317.
Conclusioni
Le dimensioni della grande tomba collettiva, insieme all’alto numero di individui e alla grande quantità di reperti archeologici contenuti in essa, sottolineano l’importanza di Daba come area sacra. L’assenza di una selezione per genere ed età degli inumati, sia per quanto riguarda le deposizioni primarie che per quelle secondarie, testimonia inoltre la grande valenza aggregativa della struttura funeraria. La complessità del rituale funerario è in relazione con l’utilizzo prolungato e continuativo di LCG2, scandito dal passaggio da deposizioni primarie alle diverse tipologie di secondarie. Il denominatore comune è rappresentato dall’esposizione dei corpi in altro luogo (con la conseguente parziale mummificazione naturale) prima del seppellimento formale dei resti umani all’interno della tomba monumentale. Queste modalità, registrate anche in contesti più antichi dell’Arabia orientale (Charpentier, Méry 2010), testimoniano quindi una continuità nel tempo del rituale. Alla fine del II millennio a.C., in mancanza di un organo centralizzato di governo, Daba potrebbe essere stato un punto di aggregazione inter tribale, come ipotizzato dall’analisi dei complessi funerari del sud-est della penisola arabica (Salvatori 1996; Bortolini, Tosi 2011). L’inserimento nella grande tomba collettiva di elementi ossei, non necessariamente collegato ad attività di inumazione, conferisce loro uno nuovo status che li trasforma da oggetti di culto in oggetti per il culto. Le ossa vengono manipolate, trasformate e ostentate senza alcun timore necrofobico, diventando dei veri e propri strumenti rituali.
stratigrafia del sito, è stato rinvenuto un cranio infantile, isolato, riempito dallo stesso sedimento circostante. Questa situazione è compatibile con il fatto che il cranio fosse vuoto al momento della rideposizione e si sia colmato solo una volta collocato nello strato di rinvenimento.
15 Il 77% ca. dei resti è riferibile a ovicaprini fra cui soprattutto capre, mentre l’11% delle faune sono bovidi. Il restante 12% è suddiviso fra le altre specie di fatto scarsamente rappresentate.
16 Sono presenti numerosi resti in connessione anatomica, tanto da ipotizzare una parziale mummificazione di alcune porzioni.
17 Gli astragali poggianti direttamente sulle ossa umane del bone cluster 33, dovevano probabilmente essere stati contenuti in una sacca di materiale deperibile, come ad esempio il cuoio, ed essere stati deposti assieme alla ossa umane con un qualche significato magico religioso. Astragali connessi al gioco o a pratiche di divinazione sono elementi che ricorrono, solitamente in piccoli gruppi, in diverse culture in tutto il mondo (AFFANNI 2008; GILMOUR 1997).
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
5
LUCIANO FATTORE Sezione di Bioarcheologia, Museo Nazionale Preistorico Etnografico ‘‘L. Pigorini’’
ALESSIA NAVA Dipartimento di Biologia Ambientale Università di Roma La Sapienza
FRANCESCO GENCHI Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
DOMENICO MANCINELLI Università degli Studi dell'Aquila, Dipartimento MESVA [email protected]
ELENA MAINI
ArcheoLaBio,Centro di Ricerche di Bioarcheologia, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
BIBLIOGRAFIA
AFFANI 2008: G. AFFANI, Astragalus bone in Ancient Near East: Ritual depositions in Iron Age in Tell Afis in
Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East Madrid, April 3-8 2006, Actas del V Congreso Internacional de Arqueología del Oriente Próximo Antiguo VOL. I, UAM ediciones
BENOIST 2007: A. BENOIST, An Iron Age II snake cult in the Oman peninsula: evidence from Bithnah (Emirate of Fujairah), Arabian Archaeology and Epigraphy, 2007, 18, pp. 34-54
BORTOLINI, TOSI 2011: E. BORTOLINI, M. TOSI, “Dal Kinship al Kinship: Le tombe collettive nell’Oman del terzo millennio A.C. e la costruzione della civiltà di Magan”, in V. Nizzo (a cura di), Dalla nascita alla morte: antropologia e archeologia a confronto. Atti dell'incontro internazionale di studi in onore di Claude Lévi--Strauss, Roma 2011, pp. 287-317
CHARPENTIER, MÉRY 2010: V. CHARPENTIER, S. MÉRY, “On Neolithic funerary practices: were there “necrophobic” manipulations in 5th-4th millennium BC Arabia?” , in L. WEEKS (a cura di), Death and Burial in Arabia and Beyond: Multidisciplinary Perspectives, Oxford 2010, pp. 17-24
DIX, GRAHAM 2000: J. DIX, M. GRAHAM, Time of death, decomposition and identification: an atlas, Boca Raton 2000, pp. 13-14
DUDAY, GUILLON 2006: H. Duday, M. GUILLON “Understanding the Circumstances of Decomposition When the Body Is Skeletonized”, in A. SCHMITT, E. CUNHA, and J. PINHEIRO (a cura di), Forensic Anthropology and Medicine: Complementary Sciences From Recovery to Cause of Death, Totowa 2006, pp. 117-157
GALLOWAY et al 1989: A. GALLOWAY, W. H. BIRKBY, A. M. JONES, T. E. HENRY, B. O. PARKS “Decay rates of human remains in an arid environment”, Journal of Forensic Sciences, 1989, n. 34(3), pp. 607-616
GILMOUR 1997: H.H. GILMOUR” The nature and function of astragalus bones from archaological contexts in the levant andeastern Mediterranean” in Oxford Journal of Archaology.
GROSS 2003: C. G. GROSS, “Trepanation from the Paleolithic to the internet”, in R. ARNOTT, S. FINGER, C. U. M. SMITH (a cura di), Trapanation History, Discovery, Theory, Lisse 2003, pp. 307-322
ORTNER 2003: D. J. ORTNER, “Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains”, New York 2003 SALVATORI 1996: S. SALVATORI, “Death and ritual in a population of coastal food foragers in Oman”, in G. AFANAS'EV,
S. CLEUZIOU, R. LUKACS, M. TOSI (a cura di) The Prehistory of Asia and Oceania, Colloquium XXXII, Trade
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
6
as a Subsistence Strategy. PostPleistocene Adaptations in Arabia and Early Maritime Trade in Indian Ocean. XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, 1996, Forli, pp. 205-222
ABSTRACT
The site of Daba is a burial complex of great importance formed by numerous large collective graves containing hundreds of individuals each, accompanied by thousands of valuable goods. Daba is located on the east coast of Musandam Peninsula (Oman) and is surrounded by several Iron Age sites including both settlements and burial complex, as Tel Abrak, Masafi and Hili as settlements, Jebel Buhais, Shimal and Asimah as burial complex. The Daba site is, to date, represented by two Large Collective Graves (LCG1 and LCG2), by a later Parthian grave and by several pits used as ritual offering. Unlike other sites of the area, Daba collective graves are very well preserved and quite undisturbed. The archaeological evidence suggests that the whole area could have been a monumental tribute to tribal alliance dating to the end of II millennium BC. The first burial monument is of rectangular shape, with a length of about 14 m and a width of 3,5 m. LCG1 returned human remains referable at least to 188 individuals and nearly 2000 precious goods, including bronze and steatite vessels, daggers, bracelets, arrowheads, decorated shell medallions and numerous beads and necklaces made in various materials. LCG2, continuously used from the Late Bronze Age (1600-1350 BC) until the Iron Age II/III Period (around 600 BC), is bigger than the first one (23 meters in length and 6 in width, included the outer arrangements). Thousands of objects have been recovered during the exploration of the grave, frequently associated to human remains referable to 28 individuals from primary burials and a minimum number of 202 individuals from secondary depositions. Many phases of frequentation have been recognized, as well as different phases of restoration and reorganization of the building. During the last phase the structure was almost completely filled and the stone walls partially collapsed. Moreover, several secondary assemblages of human bones were located all around the structure, while scattered bones associated with archaeological materials and faunal remains have been found inside the monumental grave . The second phase testify a continuity of frequentation from the top of the structure: many secondary depositions have been found over the walls and the secondary bone clusters have often a clear structural organization. The first, and last excavated, phase is characterized by the collapse of the west wall and by the reuse of the slabs to construct circular funerary chambers. In the outer eastern area the original entrance hall lose its primary function, becoming a closed chamber with several primary burials. Although not entirely investigated, LCG2 provided some interesting evidence related to the funerary practices and the offering rituals in the Daba sacred area. Several typologies of deposition of skeletal materials have been identified, that differ in reference to their organization, to the quantity of bones, to the number of individuals represented in them and to their association with grave goods and animal bones. Peculiar typologies of secondary depositions emerged in Daba, like bone assemblages with a clear structured shape that suggests the use of perishable containers to settle the already skeletonized individuals inside or around the large collective grave. To underline the multifaceted habits that took place at Daba, several case have been documented in the secondary depositions that likely could be interpreted as naturally mummified skeletal districts, as well as a single case of an entire bone artificially modified in its shape for ritual purposes. Archaeozoological analysis shows that the majority of faunal remains belongs to goats, but also cattle, sheep, dogs, horses and fish are represented. Rare are camelids and pigs. The preferential choice of specific meat portions, often discovered in close relation with human bones, suggests the funerary ritual involved offerings of entire animals or certain parts of them. All these evidence point out that the Daba sacred area is of fundamental importance for the understanding of the tribal societies of the Iron Age in the whole Arabian Peninsula and the site assumes a role of great significance for the funerary rituals. In Daba burial complex the bones of ancestors acquired a role that seems to go beyond the simple interment, sometimes turning the focus of the ritual into an object for the ritual itself.
KEY-WORDS
Taphonomy, collective graves, Arabian peninsula, funerary practices, mummification, late bronze age, iron age, Oman