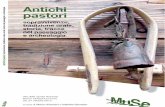L'area nord-lucana nella Prima Età del Ferro: formazione e struttura degli insediamenti
Transcript of L'area nord-lucana nella Prima Età del Ferro: formazione e struttura degli insediamenti
Editorial BoardProf.dr. Harald HendrixDr. Marieke van den DoelDr. Jeremia PelgromDr. Arthur Weststeijn
Editorial StaffMalena B. McGrathCarla M. Summers
Bibliographical abbreviations follow the American Journal of Archaeology guidelines and the Oxford Classical Dictionary (3rd edition) for classical texts.
Correspondence regarding editorial material and contributions should be addressed to:
Papers of the Royal Netherlands Institute in RomeRoyal Netherlands Institute in Rome (KNIR)Via Omero 10/12 - 00197 Romawww.knir.ite-mail: [email protected]
Subscription and order of single volumes:
Palombi & Partner SrlVia Gregorio VII, 22400165 Romawww.palombieditori.it
Papers of the Royal Netherlands Institute in Rome
Mededelingen van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome
Early Iron Age Communities of Southern Italy
edited by
Giulia Saltini Semerari and Gert-Jan Burgers
PAPERS Of tHE ROyAl NEtHERlANDS INStItutE IN ROME - VOluME 63 - 2015
L’area nord-lucana nella Prima Età del Ferro:
formazione e struttura degli insediamenti
Massimo Osanna
AbstractThis paper focuses on a territory located in the mountains of the Lucanian Apennines where Iron Age settlements
can be traced from the end of Iron Age I (the middle decades of the 8th c. B.C), relatively late compared to other
Southern Italian regions. The aim of the paper is to understand the emergence and spatial configuration of these new
settlements (with a particular focus on Torre di Satriano, Serra di Vaglio and Baragiano) and more in general to
reconstruct regional settlement dynamics. It is argued that similarities in material culture (i.e. matt-painted pottery) and
other aspects of social life point to close contacts between this inland region, the Ionian coastal areas (e.g. Incoronata)
and the middle valley of the river Bradano (e.g. Matera, Gravina and other sites).
Il presente contributo vuole portare l’attenzione su un cantone del territorio italico ubicato all’internodell’Appennino lucano, ove le forme di popolamento nel I millennio a.C. si definiscono in un’epocarelativamente più recente rispetto ad altre realtà di Italia meridionale, ossia verso la fine della Prima Età delFerro, intorno ai decenni centrali dell’VIII sec. a.C. Scopo della disamina è di comprendere le origini di talefenomeno insediativo, la provenienza delle genti e le modalità di organizzazione degli abitati.
Il territorio in questione è compreso a nord dall’asse costituito dal medio corso del fiume Ofanto e dalmassiccio del monte Vulture, a est dall’alto corso del fiume Bradano, a sud dall’alto corso del Basento e daimassicci che si sviluppano a ridosso di questo, a ovest dalla catena di rilievi lungo un asse nord-sud che sidiparte dalla sella di Conza e dagli Alburni fino a raggiungere Roscigno1 (fig. 1). Tale frastagliato territorio,dalla morfologia relativamente omogenea, caratterizzato com’è dalla presenza di catene montuose rilevanti,con cime che superano di frequente i mille metri s.l.m. e da una serie di corsi d’acqua che incidono in manieraramificata i rilievi, manifesta a partire dal VII sec. a.C. tratti culturali peculiari e beni distinguibili rispetto aicantoni finitimi. Gli elementi maggiormente caratterizzanti di tale cultura si possono individuare nel ritofunerario, che predilige la posizione rannicchiata del cadavere e più in generale nel rapporto stretto tra tombae abitazione, e inoltre nelle produzioni specializzate, in primis le ceramiche matt-painted prodotte in tutto ilterritorio, dall’Yntema seriate e distinte dalle coeve serie prodotte negli altri comprensori indigeni di ItaliaMeridionale e inquadrate nel gruppo della ‘North-Lucanian matt-painted’.2 All’interno di questo gruppo è stataindividuata una classe di ceramiche dai tratti fortemente omogenei (nella forma e nella sintassi decorativa),prodotta secondo lo studioso olandese tra ultimo quarto del VII e inizio V sec. a.C., denominata ‘The Ruvo-Satriano Class’, richiamando nel nome i due centri di produzione allora noti, diffusa in tutto il comprensoriooggetto della nostra disamina3 (fig. 2). Se, alla luce di una conoscenza più approfondita della classe, resa
1 In generale sull’area ‘nord-lucana’: Bottini 1986a; id.
1986b; id. 1989; id. 1999; D’Agostino 1989, 191-246; id.
1999, 25-57; Tagliente 1999a; id. 1999b; Horsnaes 2002.2 Al riguardo si rimanda alle riflessioni già presentate da
chi scrive e alla relativa bibliografia ivi citata in Carollo
e Osanna 2009, 383-90.3 Yntema 1990, 186-96; cfr. Herring 1998, 81-84.
possibile da nuovi scavi e dall’edizione di diversicontesti, è possibile allargare lo spettro di fabbrichenote e forse anche retrodatare l’apparizione dellaclasse già alla metà del VII sec. a.C. se non addiritturaal secondo quarto del secolo,4 resta comunque validala classificazione proposta da Yntema, che hapermesso di distinguere le produzioni di quest’areada quelle di territori finitimi di Puglia e Basilicata.5
Se la definizione di tratti culturali omogenei, checaratterizzano tutto il territorio in questione,rendendolo immediatamente distinguibile dagli altricantoni del mondo italico, avviene, come anticipato,nel corso del VII sec. a.C., la frequentazione delterritorio è ovviamente ben più antica, diventandodiffusamente percepibile a livello archeologico nelcorso del II millennio a.C. e, più precisamente, nellasua seconda metà.6 Tale vicenda umana che si aprein più casi nella Media Età del Bronzo è però innessun caso destinata a dar vita a fenomeni dicontinuità o di crescita progressiva. Ridotti nucleiabitativi dalla breve vita, all’insegna di una spiccatamobilità, caratterizzano un paesaggio che non pare
ancora sottoposto a strategie di sfruttamento economico complesso. Gli unici siti che hanno restituito documentazione al riguardo sono non a caso quelli meglio noti di tutto il
comprensorio, Torre di Satriano e Vaglio di Basilicata. Nel primo tracce di presenza umana sono state individuatein punti diversi, scaglionati a non grande distanza uno dall’altro, tutti sul versante meridionale di quell’alturache ospiterà l’abitato dell’Età del Ferro.7 Nel secondo, manufatti appenninici furono rinvenuti in passato incontrada Ciscarella, una terrazza posta sul versante sud del pendio della Serra San Bernardo, occupatadall’insediamento dell’Età del Ferro.8
Non si tratta in entrambi i casi di dati restituiti da indagini stratigrafiche, ma di rinvenimenti da
4 Sulla fabbrica di Ripacandida: Setari 1998-99. Verso una
retrodatazione della classe già alla metà dei VII sec. a.C.
sembra spingere l’analisi tuttora in corso del manufatti
matt-painted della residenza ad abside di Torre di Sa-
triano, frequentata tra il pieno VII e il secondo quarto
del VI sec. a.C. (ma impiantata in un’area già occupata
da una struttura abitativa nella seconda metà dell’VIII
sec. a.C.), ove la quasi totalità di manufatti matt-painted
appartiene già alla ‘Ruvo-Satriano class’: per ora ved.
Bertesago e Bruscella 2009. Si consideri inoltre al ri-
guardo la T. 49 di Baragiano, datata agli inizi del VI sec.
a.C., una cronologia senza dubbio troppo bassa, in Bru-
scella 2009, 25-27. La associazione di due vasi-kantharos
e due brocche dalle forme e decori già tipici della ‘Ruvo-
Satriano class’, con una anforetta in impasto di tradizione
tirrenica e una fibula ad occhiali in avorio proveniente
dall’Egeo, non sembra far scendere il corredo oltre la
metà/terzo quarto del VII sec. a.C.5 Probabilmente la ‘Ruvo-Satriano class’ si definisce con-
temporaneamente all’emergere nei centri della Valle del
Bradano (Timmari, Matera, Gravina, Altamura, Sante-
ramo, Laterza, Ginosa) della c.d. ‘classe bicroma’ della
ceramica peuceta, secondo la classificazione di De Juliis,
inquadrata cronologicamente a partire dalla metà del VII
sec. a.C. (Subgeometrico Peucezio I: 650-575 a.C.): De
Juliis 1995, 79-80.6 In generale sulla media Età del Bronzo in Basilicata: Ci-
polloni Sampò 1999, 100-23.7 Cipolloni Sampò 1999, 120, con bibl.; sulle indagini più
ecenti: Di Lieto, Osanna e Serio 2005, 13-14; Osanna
2008, 143-47.8 Greco 1991, 10-13.
FIG. 2. Torre di Satriano, corredo vascolare della tomba 38
(disegni P. Palese).
ricognizione di superficie o di manufatti recuperati in giacitura secondaria - dunque l’attendibilità storica,soprattutto per quel che riguarda consistenza e durata della frequentazione, rimane tutta da verificare. Inogni caso appare significativo che le ceramiche rinvenute, siano tutte tipiche della facies appenninica – sitratta della peculiare ceramica decorata ad incisione e intaglio – e si concentrano dunque nella media Etàdel Bronzo.
Il ristretto arco cronologico dei manufatti e la loro distribuzione non consente di leggere nel territoriola presenza di un insediamento significativo, strutturato e stabile. Considerando la vocazione pastoraledell’area sembra plausibile supporre un fenomeno di occupazione di breve durata, con piccoli nuclei (forsepoche capanne isolate, dislocate in un comprensorio ampio del versante meridionale dell’altura), databilientro il XIV sec. a.C. Tali effimere esperienze della media Età del Bronzo rimangono in ogni caso le unicheforme di frequentazione leggibili per tutto il II millennio, unica eccezione nel quadro di ‘vuoto’ generalizzato,è ancora il territorio di Vaglio, dove scarsi manufatti del Bronzo finale sono attestati sia sul terrazzo dicontrada Ciscarella, che sul pianoro sommitale della Serra.9 Dopo il XIV secolo non si hanno invece piùdati, né a Torre di Satriano né negli altri territori del comprensorio, da Ruvo del Monte a Buccino.
Va comunque segnalato che non esiste finora uno studio sistematico su tali insediamenti e si lamentasoprattutto l’assenza di pubblicazioni esaustive che riguardino le fasi più antiche di popolamento delterritorio: del resto fino all’avvio delle ricerche sistematiche a Torre di Satriano, intraprese nel 2000, nessuninsediamento era stato oggetto di una ricerca di archeologica globale.10 Grazie alle ricerche a Torre diSatriano, un centro indagato a più riprese in passato, dove un survey intensivo ha interessato tuttol’insediamento e il territorio circostante, coprendo 20 kmq, e dove scavi estensivi hanno riguardato più areedell’abitato policentrico, è possibile avanzare con relativa certezza che da tutto il comprensorio nonprovengono manufatti più antichi della Prima Età del Ferro avanzata. Tale ricognizione dei materiali rinvenutinel survey e verificata con il confronto di quanto emerso dai contesti scavati si deve a Lara Cossalter,11 cheha potuto stabilire che la ceramica matt-painted più antica non risale oltre la metà dell’VIII sec. a.C. Proprioquesto dato, recuperato passando al vaglio tutto quanto la ricerca pluriennale ha restituito, sia quella avviatasistematicamente nel 2000, sia quella che ha interessato a più riprese il sito a partire dagli anni ’40 del secoloscorso, ha stimolato l’avvio di una ricognizione su vasta scala di quanto noto in tutto in comprensorio, inmodo da verificare se tale acquisizione sul fenomeno insediativo più antico riguardasse solo Torre di Satrianoo anche i centri gravitanti nello stesso cantone dell’Appennino lucano.
Il regesto di quanto edito affiancata da una verifica in corso presso la Scuola di Specializzazione in BeniArcheologici di Matera di manufatti e contesti inediti, permette ora di inquadrare nel corso dell’VIII sec. a.C.non solo la fase più antica di Torre di Satriano, ma anche quella dei centri vicini. In particolare datisignificativi al riguardo emergono dalla verifica dei materiali più antichi di Baragiano, di recente presentatida Antonio Bruscella,12 dove nulla risale oltre la metà dell’VIII sec. a.C., e da quelli di Serra di Vaglio, studiatida Giuliana Soppelsa, nell’ambito di una dissertazione dottorale, dove i pochi manufatti ben databiliattribuibili alla Prima Età del Ferro, rimandano ancora ai decenni centrali dell’VIII sec. a.C.13
In base a tale messa a punto della documentazione materiale è possibile stabilire che un fenomeno
9 Greco 1991, 13-14.10 Sul progetto in corso a Torre di Satriano, da parte della
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Ma-
tera (Università della Basilicata), si rimanda alle pubbli-
cazioni più recenti: Osanna, Colangelo e Carollo 2009;
Osanna et al. 2011; Osanna e Capozzoli 2012. 11 Dati inediti: Archivio Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici di Matera. Ringrazio l’amica Lara Cossalter
con la quale ho più volte discusso sulle problematiche qui
presentate, il cui contributo all’avanzamento della ricerca
a Torre di Satriano è stato sempre assai prezioso. Prime
riflessioni su tale lavoro comune sono state presentate in
Cossalter e Osanna 2008.12 Bruscella 2008.13 Soppelsa 2011.
insediativo che porterà allo sviluppo dei grandi centri di età arcaica, almeno per il settore meridionale delcomprensorio, quello del potentino, si avvii in maniera grosso modo simultanea intorno alla metà dell’VIIIsecolo. In quest’epoca si assiste all’occupazione di alture ben difese (fig. 3), servite da sorgenti, poste pressocorsi fluviali che assicurano facilità di transito attraverso gli impervi rilievi, in un’area che per vari secolinon era stata più occupata se non in maniera discontinua, concludendo nel caso di alcuni territori un lungoperiodo di frequentazione sporadica e ‘mobile’.
Se cominciamo dal sito meglio noto, quello di Torre di Satriano, lo studio approfondito degli ingentimanufatti recuperati a più riprese permette ora di tracciare un quadro cronologico più preciso e soprattuttoben più articolato della distribuzione antropica nell’area, rispetto a quanto presentato finora (fig. 4). Neiprimi lavori dedicati alle fasi più antiche di popolamento, i piccoli nuclei di abitato inquadrabiligenericamente tra seconda metà dell’VIII e primo quarto del VII sec. a.C., riconosciuti allora passando inmaniera preliminare al vaglio dati di vecchie e nuove indagini, si riferivano essenzialmente a tre ‘siti’: unoposto sull’acropoli naturale occupata dal centro demico medievale, gli altri due su plateaux posti alle pendici,il primo a sud-est, l’altro presso il versante sud-ovest.14 I documenti a disposizione riguardavano tanto lasfera funeraria quanto quella abitativa, permettendo già di intravedere in nuce la ‘forma’ riconoscibile perl’insediamento di età arcaica: se il segmento posto presso la sommità del rilievo era documentato solo daframmenti ceramici residuali, tra cui manufatti con decorazione ‘a tenda’, recuperati nelle indagini degli anni’60 dirette da Robert Ross Holloway,15 ben più ricca si presentava la documentazione dalle due terrazze
14 Carollo e Osanna 2009, 390-94; Cossalter e Osanna 2008
con bibliografia.
15 Holloway 1970.
FIG. 3. Veduta della collina di Torre di Satriano da nord.
sottostanti, grazie agli scavi effettuati da Emanuele Greco negli anni ’80 e alle più recenti indagini dellaScuola di Specializzazione materana.16 Nel segmento di abitato di cui si sono individuate le tracce presso ilversante sud-occidentale dell’altura, un’area in lieve declivio che guarda verso la catena della Maddalena ele possibilità di transito per la Val d’Agri e il Vallo di Diano, le testimonianze più antiche di occupazione
16 Greco 1988; Cossalter e Osanna 2008.
FIG. 4. L’insediamento di Torre di Satriano: distribuzione dei siti della Prima Età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.).
provengono oltre che da materiali residuali, da tre tombe a fossa e da lacerti di strutture e lembi di strati (inparticolare uno strato intercettato al di sotto dei livelli del successivo santuario lucano, che si sovrapponesu una parte del nucleo insediativo). Delle tre tombe, una è priva di corredo, ma in base ai materiali inassociazione rinvenuti nel riempimento è riferibile all’VIII secolo, la seconda sconvolta ha restituito solo unamphoriskos in impasto a corpo globulare, decorato da gruppi di solcature verticali, con anse a nastro efondo piatto, vicino ai tipi campano-laziali, che rimanda ad analoga cronologia (fig. 5); la terza, ben piùinteressante, risponde ad una tomba di guerriero armato di lancia in ferro e ornato di una fibula in bronzodi tipo siciliano, con corredo integro costituito dalla coppia rituale olla/amphoriskos (fig. 6). Tale associazionedi vasi è particolarmente significativa, in quanto affianca ad un vaso contenitore a decorazione geometrica,su alto piede fenestrato con anse a maniglia e apofisi a bottone, un vaso per attingere/bere d’impasto (similea quello dell’altra tomba). I due manufatti associati provengono da tradizioni artigianali del tutto diverse,riflettendo già in queste fasi di ‘origine’ le due direttrici di contatti che contraddistingueranno la nostra area:l’amphoriskos proviene dell’area tirrenica campano-laziale, mentre l’olla su piede dalla c.d. area ‘enotria’,come attestano i confronti che rimandano alla Sibaritide (Francavilla Marittima) e al Vallo di Diano (SalaConsilina). Anche gli altri materiali, verosimilmente di abitato, rinvenuti nell’area annoverano sia ceramichedi impasto che matt-painted, spesso con forme interscambiabili tra le due classi.17 In impasto un grupporidotto di frammenti si riferisce a forme databili tra VIII e VII sec. a.C. quali la brocca, la scodella, la situla;la matt-painted presenta invece in generale frammenti pertinenti a forme non ricostruibili, con decorazionitipiche dell’area ‘enotria’ (West Lucanian Geometric) e soprattutto dell’area bradanica del materano (Middleand Late Bradano Geometric).18 Per quanto riguarda l’altro sito individuato presso il plateau sud-orientale,i frammenti riferibili alla Prima Età del Ferro sono stati recuperati nel corso delle recenti indagini di superficiee poi nello scavo che è seguito che ha portato alla luce una grande residenza ad abside.19 Gli orizzonti piùantichi di frequentazione in quest’area, riportabili ancora una volta all’epoca a cavallo tra secondo e terzoquarto dell’VIII sec. a.C. si riferiscono soprattutto a olle e brocche, recanti su labbro il tipico motivo atriangoli radiali a campitura piena, con i lati leggermente inflessi, ma sono attestate, seppure in misuraminore, anche le forme aperte, in particolare scodelle, del tipo già attestato sul versante sud-ovest, decorate
17 Cossalter e Osanna 2008, 107-8.18 Yntema 1990, 125-32; 144-65.
19 Osanna, Colangelo e Carollo 2009, 19-113.
FIG. 5. Torre di Satriano, corredo vascolare della tomba
36, amphoriskos ad impasto (disegno P. Palese).
FIG. 6. Torre di Satriano, corredo vascolare della tomba 37
(foto N. Figliuolo).
con il classico motivo a linguette sull’orlo (fig. 7). Anche in questo caso i confronti rimandano verso ilcomparto meridionale della regione, gravitante sullo Ionio, in particolare alle produzioni del Bradano Middleand Late Geometric e in minor misura al West Lucanian Geometric. Tra i vari manufatti rinvenuti colpisce,dunque, senza dubbio, la presenza di forme e motivi decorativi che richiamano produzioni dell’entroterraionico della Basilicata, a cominciare dai frammenti con decorazione ‘a tenda’ elegante, analoghi a qualirinvenuti da Holloway sulla sommità dell’altura. Se questa era la situazione ricostruibile fino a qualche annoorsono per l’VIII e l’inizio del VII sec. a.C., grazie all’avanzamento della ricerca nel comprensorio, esoprattutto a ricontrolli di superficie dei siti già individuati nonché allo studio puntuale delle classi ceramiche,è ora possibile definire un quadro ben più articolato: se la considerazione di tutto il dossier confermaampiamente la presenza delle tradizioni artigianali dell’entroterra della costa ionica e in particolare dell’areabradanica, interessa notare che il quadro di distribuzioni dei manufatti nell’area ne viene notevolmenteampliato. In base alla diffusione dei reperti diventa chiaro come l’occupazione complessiva di tutta l’areache sarà pertinente all’insediamento di età arcaica non è frutto dell’impressionante incremento demograficodi fine VII-VI sec. a.C., ma avviene già nel corso dell’VIII sec. a.C. quando sembrano già frequentati – seppurin maniera assai più ridotta che nei secoli successivi – tutti i segmenti abitativi che si dispongono sui plateauxpiù idonei dislocati a raggiera intorno all’altura.20 Le ricognizioni permettono infatti di individuare ben 10siti che hanno restituito manufatti databili in quest’epoca (Fig. 8).21 La distribuzione spaziale di tali evidenze,
20 Osanna 2008.21 Archivio Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
di Matera. È in corso di ultimazione il volume Torre di
Satriano II. c.s.
FIG. 7. Torre di Satriano, ceramica matt-painted dalla
residenza absidata (disegni A. Bruscella).
FIG. 8. Torre di Satriano, ceramica matt-painted dalla
ricognizione dell’area (disegni L. Cossalter).
coincide con gli stessi pianori dove si addensano isiti della Seconda Età del Ferro, defininendo veri epropri nuclei insediativi posti a non grande distanzauno dall’altro.
Tale quadro che è stato possibile tracciare aTorre di Satriano, ha trovato di recente unaconferma significativa a Baragiano, grazie allarecente pubblicazione di nuove e vecchie indagini.22
Sebbene la documentazione più antica provengasolo da due contesti dislocati in aree diversedell’articolato rilievo che sarà occupatodall’insediamento arcaico, la distribuzione esoprattutto la ricchezza dei materiali permette dileggere un quadro sostanzialmente analogo a quelloricostruito nel centro vicino e arricchire al contempoil dossier relativo alle produzioni specializzate in usonell’VIII sec. a.C. Il primo sito che ha restituito traccedi occupazione riferibile a quest’epoca è il plateaudi Toppo S. Antonio, una terrazza che si allunga adoccidente dell’altura occupata dal paese moderno.23
Qui lo scavo ha rivelato un lembo di abitato dellaSeconda Età del Ferro, occupato da capanne etombe databili tra VII e VI sec. a.C. (fig. 9). Unpozzo in particolare restituisce dati significativi aifini del nostro discorso, caratterizzato com’è da unriempimento dalla complessa sequenza stratigrafica:dei cinque livelli individuati, i quali si scaglionanoentro un ampio arco cronologico, quello più basso,ha restituito resti provenienti dallo smantellamento
di un contesto della Prima Età del Ferro. Si segnalano in particolare numerosi frammenti di rivestimentoparietale in argilla riferibili ad una struttura capannicola associati ad un’olletta biconica a decorazionegeometrica.24 La forma e il tipo di sintassi decorativa, inquadrabili nell’ultimo venticinquennio dell’VIII sec.a.C. trovano confronti stringenti a Gravina, Monte Irsi, Matera e all’Incoronata, ossia proprio al mondo dacui promanano le produzioni del Middle and Late Bradano Geometric documentato anche a Torre diSatriano.25 A queste tracce di abitato della collina di Toppo Sant’Antonio, si possono affiancare alcunimanufatti provenienti da uno scavo degli anni ’90 di un nucleo di capanne arcaiche nell’attigua loc.Belvedere26 che hanno restituito manufatti matt-painted di grande interesse (fig. 10): si segnala in particolarela diffusa presenza nella sintassi decorativa dei frammenti ceramici del motivo a linea ondulata,accompagnata da linee e bande orizzontali, posto al punto di passaggio tra collo e spalla di forme biconiche,un motivo presente su olle di Matera della seconda metà dell’VIII secolo a.C.27 Anche la sintassitardogeometrica che utilizza elementi miniaturistici (triangoli e rombi disposti su registro orizzontale sullametà superiore del vaso e raggi a reticolo che pendono sul ventre) su forme di piccole dimensioni, come
22 Quadro di sintesi aggiornato su Baragiano in Russo e
Di Giuseppe 2008, 29-113.23 Ibid., 93, fig. 5. 24 Bruscella 2008.
25 Yntema 1990, 154 ss., in part. 156, fig. 138, n. 1, fig. 139,
nn. 28-29; Herring 1998, 73-75, fig. 70, n. 1, figg. 72, 74.26 Bruscella 2008, 23, fig. 4.27 Cossalter 2009, figg. 2-4.
FIG. 9. Baragiano. Toppo S. Antonio, olletta biconica in
ceramica matt-painted (disegni A. Bruscella).
l’olletta, avvicina in maniera significativa queste produzioni con quelle di area bradanica. Inoltre sonoattestate scodelle con una sintassi caratterizzata da gruppi di tratti verticali marginati da coppie di linee ofasce orizzontali, una decorazione che riconduce sia alle produzioni tardogeometriche della Sibaritide sia,ancora una volta ai centri bradanici (da Monte Serico all’Incoronata).28 Anche le scodelle ad orlo rientrantedecorato da triangolo a reticolo sulla parte superiore della vasca sono documentate a Monte Sannace,Gravina, Matera, Cozzo Presepe, Incoronata, come anche le scodelle con gruppi di tratti obliqui, sfalsati,sulla parte superiore della vasca, appena sotto l’orlo. Significativo infine il caso del motivo decorativocomposto da tre elementi a zig zag verticali, un motivo recepito dal Geometrico corinzio che ritornadiffusamente nei repertori della ceramica di area bradanica e dalla costa jonica.
Un quadro del tutto simile emerge dagli scavi fortunati realizzati a più riprese a Serra di Vaglio fino aglianni ’90 del secolo scorso.29 Se la distribuzione dei rinvenimenti e in particolare delle tombe permette diricostruire, come nel caso di Torre di Satriano e Baragiano, un abitato policentrico, articolato in nucleidistribuiti sul pianoro di Serra e sulle sue pendici più dolci, i sondaggi effettuati al centro del pianorosommitale, al di sotto delle strutture dell’insediamento della Seconda Età del Ferro, hanno permesso diconoscere un lembo di abitato della Prima Età del Ferro. Si tratta di un gruppo di strutture capannicole, apianta circolare o polilobata (estese circa 50-60 mq), aperte su aree esterne che fungono da raccordo tra leabitazioni, le quali, accuratamente sistemate con acciottolato dovevano essere destinate allo svolgimento diattività plurime, sia produttive che cerimoniali, come mostra il distribuirsi al di fuori delle capanne di fornaciper ceramica e di tombe, sia a fossa di adulti che ad enchytrismos per infanti. La cultura materiale checontraddistingue questo gruppo di capanne, nonché la composizione dei corredi delle tombe rimanda adun nucleo di rilievo dell’abitato. Per quanto riguarda l’arredo interno, oltre alle classi ceramiche in impastogrezzo e fine, ai grandi contenitori, si segnala la abbondante ceramica matt-painted, che annovera produzionidel tutto analoghe a quelle documentate nei centri vicini: anche qui ricorre soprattutto le forme chiuse dellaBradano Middle and Late Geometric, con forme quali le olle biconiche o globulari, brocche biconiche,
28 E.g. Ciriello, Cossalter e Sodo 2009, 331, n. 15, fig. 13.15.29 Greco 1991; Greco e Soppelsa 2009; Soppelsa 2011, 12-
13; 25-29.
FIG. 10. Baragiano. Loc.
Belvedere, ceramica
matt-painted da un
nucleo di capanne
arcaiche (disegni A.
Bruscella).
ollette, associate con scodelle ad orlo rientrante. Spicca soprattutto tra i decori attestati il motivo ‘a tenda’elegante, il quale si rivela identico a quello noto a Torre di Satriano, lasciando presupporre una stessaproduzione. Per Serra, del resto, un dato di grande rilievo è la scoperta sul pianoro centrale di una fornaceassociata ad una capanna, la quale ha restituito frammenti di ceramica ‘a tenda’, documentandone così laproduzione in loco.30
Se dunque consideriamo da vicino le più antiche manifestazioni artigianali note a Torre di Satriano,Baragiano e Serra di Vaglio, in tutti e tre i siti è documentata la presenza di omogenee produzioni specializzatedi ceramica figulina matt-painted in argilla molto depurata, a pasta fine, dalle superfici accuratamente lisciatee ingobbiate, realizzata a ruota lenta. Sia nella scelta delle forme che nella sintassi decorativa tale ceramicamostra fortissime affinità con le produzioni dell’area bradanica riferibili al Geometrico Medio e Tardo:31 nellospecifico ricorrono, come si è visto, olle biconiche a collo troncoconico rigonfio o a parete rigida, nonchéolle globulari; brocche a collo troncoconico e corpo globulare, brocchette piriformi; attingitoi globulari conansa sopraelevata; tazze globulari; scodelle ad orlo rientrante dal profilo angolare o convesso. Il repertoriodecorativo presenta motivi, inquadrabili in un arco cronologico compreso tra secondo quarto/metà dell’VIIIe inizio del VII sec. a.C., i quali ritornano diffusamente nelle produzioni del materano e dell’area costieraionica. Il motivo ricorrente maggiormente caratterizzante è senza dubbio quello ‘a tenda’, l’elemento piùsignificativo di questa fase di tutta l’area, come del resto di un vasto territorio compreso tra Bradano, Sibaritidee Vallo di Diano. Considerato un motivo ‘inventato’ nel secondo quarto dell’VIII secolo nel retroterra dellacosta ionica, tra valle del Bradano e del Basento (o già alla fine del IX a Sala Consilina, secondo la propostadi Fabio Galeandro), il sistema decorativo ‘a tenda’ si rivela appannaggio di una pluralità di officineimparentate distribuite su una vasta area, anche se senza dubbio un ruolo importante nello sviluppo dellasintassi decorativa hanno avuto le officine bradaniche.32 Se dunque per quanto riguarda in generale le formeattestate e il sistema decorativo centrato sulla ‘tenda’ la ceramica nota in area nord-lucana si può inquadrarein maniera generica all’interno di un diffuso orizzonte bradanico-‘enotrio’ (circostanza che non cipermetterebbe di riconoscere sia pure approssimativamente una più ristretta matrice culturale), a ben guardarele maggiori affinità formali e stilistiche si rinvengono per tutti i pezzi finora documentati proprio con ilmaterano (intendendo con ciò il territorio compreso tra l’immediato entroterra ionico del metapontino e ilmedio corso del Bradano fino a Gravina). E questo è percepibile già a partire dai casi di ‘tenda elegante’ noti,di cui sono attestati due tipi leggermente diversi, entrambi riferibili a produzioni mediogeometriche (775-25):uno con lati leggermente inflessi, trova confronti su una vasta area di gravitazione tutta bradanica (da MonteIrsi, a Matera, da Cozzo Presepe all’Incoronata, Craco, San Leonardo di Pisticci, fino ad inoltrarsi a SantaMaria d’Anglona); l’altro, caratterizzato dal lato rigido, trova confronti ancora all’Incoronata.
Se dai centri del settore meridionale del comprensorio passiamo a considerare quelli del settoresettentrionale, dell’area ofantina del Melfese, la situazione che si riscontra è abbastanza diversa. Se un sitoimportante della Seconda Età del Ferro come Ruvo del Monte non ha restituito manufatti più antichi del VIIsecolo avanzato, dati interessanti per il nostro discorso sono stati ricuperati a Ripacandida, un centro postoimmediatamente a sud-est del Monte Vulture, al limite della regione montuosa dell’Appennino e a ridossodei territori collinari che si dispiegano verso oriente degradando progressivamente fino alla pianura delTavoliere.33 Qui in sintonia con le forme di popolamento che caratterizzano tutto il territorio della Pugliasettentrionale, dove si definirà il cantone culturale ‘daunio’,34 l’occupazione dell’altura si avvia in un epocapiù antica a giudicare dai manufatti rinvenuti da Angelo Bottini nell’area della necropoli di Seconda Età delFerro di S. Donato.35 Qui lo scavo ha intercettato anche un lembo dell’abitato di Prima Età del Ferro, i cui i
30 Greco 1991, 15-17.31 Oltre alla documentazione raccolta da Yntema 1990,
144-64, cfr. Cossalter 2009.32 Galeandro 1999; Cossalter 2009.
33 Carollo e Osanna 2009.34 De Juliis 1977; id. 1984.35 Bottini 1986b; Carollo e Osanna 2009, 394-409.
dati più significativi provengono dallo scavo di due pozzi (pozzo 1 e 2), ubicati ad una distanza di circa 50m – i quali furono colmati verso la metà del VII sec. a.C. con materiali pertinenti all’insediamento più antico,nonché di un fondo di una capanna circolare (diametro di m 3 circa), delimitato da sette buche di palodislocate lungo il suo perimetro – posta nei pressi del pozzo 1. Nel riempimento particolarmente variegatodei pozzi, accanto a manufatti databili al Bronzo Medio, sono stati recuperati pochi frammenti di ceramicaprotogeometrica che potrebbero inquadrare una ripresa di frequentazione dell’area già a partire dal X sec.a.C. I manufatti più significativi riguardano però il periodo successivo, ossia quello che va dalla fine delIX/inizi dell’VIII fino alla metà del VII sec. a.C. circa, epoca a cui risale anche la capanna, nonché tutta unaserie di altre tracce pertinenti ad un abitato che sembra essere stato distrutto e livellato intorno alla metàdel VII sec. a.C., per ospitare in seguito, entro lo scadere del secolo, una nuova esperienza insediativa. Taledistruzione/abbandono ha portato al riempimento dei pozzi che oltre ai materiali ceramici contenevanosignificativamente oltre agli ingenti frammenti ceramici, elementi in pisè pertinenti all’elevato di capanne,nonché di un diaframma di fornace, dato importante che documenta la produzione in loco di ceramiche.
Per quanto riguarda i manufatti che ha restituito questo lembo di insediamento, significativa è l’elevatonumero di olle, biconiche e globulari, matt-painted, cui si affiancano analoghe forme in impasto. Le formechiuse costituiscono la maggior parte delle attestazioni, mentre limitate sono le forme per versare e le formeaperte. Tale enfasi sulla conservazione di dettate è sottolineata anche dal rinvenimento di frammenti di doliicordonati di tradizione egea, una categoria da riferire probabilmente all’opera di artigiani itineranti, che aBroglio di Trebisacce è stata connessa con la conservazione dell’olio, e che a Ripacandida sembrerebbeancora in uso nell’VIII sec. a.C. Al vino potrebbero rimandare invece oltre alle olle biconiche, le pochebrocche documentate, anche se in assenza di analisi è difficile pronunciarsi in merito. Il contesto dellacapanna con il vicino pozzo documenta in ogni caso la presenza di elites che giovano già di produzionispecializzate in un contesto di incipiente articolazione sociale.
Il dato più interessante riguarda comunque i manufatti matt-painted rinvenuti, i quali documentano lacompresenza di produzioni locali e di importazioni. Interessa notare che da un lato emerge un rapportostretto con le produzioni geometriche della Puglia settentrionale, dall’altro con quelle dell’area medio-bradanica, una spia importante dei contatti intrattenuti da queste genti con i territori vicini. La cultura cheemerge si rivela dunque come ibrida, rispondendo ad una vocazione di questo territorio di confine, postoa contatto diretto, sia con le aree di cultura ‘daunia’ del Tavoliere, sia con quello di area medio-bradanicadel Materano.
Mentre dunque a Ripacandida la cultura materiale, che comprende anche manufatti protogeomerici,rimanda ad un insediamento le cui fasi più antiche risalgono all’inizio della Prima Età del Ferro se non nelBronzo Finale, mostrando forme di contatto stretto tanto con il comprensorio ‘daunio’ quanto con quellomedio-bradanico, nel settore opposto del cantone, quello meridionale, la nascita degli insediamenti vaconsiderata un fenomeno recenziore, che non sembra più antico della metà dell’VIII secolo, mentre lacultura materiale mostra affinità spiccate soprattutto con il materano.
Trarre ipotesi interpretative da un regesto così lacunoso e ridotto di dati potrebbe sembrare azzardato,conforta comunque riguardo alla liceità del procedimento, il fatto che il ‘linguaggio’ della cultura materialedelle prime genti stanziate nel potentino nell’VIII sec. a.C., risulta del tutto omogeneo. Se infatti nel caso diRipacandida la compresenza di tradizioni diverse, evidente soprattutto nelle produzioni di manufatti matt-painted, non permette di leggere il rapporto privilegiato con un’area piuttosto che l’altra (laddove le direttricidi contatto sono evidenti in particolare in direzione della fascia adriatica e bradanica), in quest’area compresatra alta valle del Basento e il Marmo-Platano, i manufatti rinvenuti rimandano insistentemente verso la mediae bassa valle del Bradano, ossia verso quel territorio compreso tra la costa ionica (Incoronata, Cozzo Presepe)e il materano (Matera, Gravina), dove nell’VIII sec. a.C. si sviluppano le produzioni matt-painted del‘Bradanic Middle-Geometric’.
È evidente che tali dinamiche insediative in atto nel potentino siano da leggere all’interno dei fenomenidi strutturazione degli abitati che caratterizzano molte aree dell’Italia meridionale nel corso dell’VIII sec.
a.C., un’epoca contraddistinta da un estremo dinamismo delle genti indigene, coinvolte in dinamichecomplesse di strutturazione sociale all’interno delle varie comunità e parallelamente da fenomeni di mobilità,colonizzazione interna e ‘fondazione’ di nuovi insediamenti.36
In base a tali stringenti rapporti delle prime produzioni attestate nei nostri centri e quelli di areabradanica non sembra inverosimile attribuire il popolamento del montuoso entroterra della Basilicatacentro-settentrionale, che avviene pressoché simultaneamente in una serie di centri del potentino, a queifenomeni di mobilità ben attestati nell’VIII secolo per vari gruppi umani di Italia meridionale. Tale ‘mobilità’che si concretizza nella nascita di numerosi nuovi insediamenti in tutto il comparto del sud-est dellapenisola, dal Salento alla Basilicata e Calabria costiera e interna, sembra avviarsi parallelamente al definirsidi articolazioni sociali all’interno dei gruppi e significativamente all’emergere di una maggiore riconoscibilitàdei tratti culturali dei vari comprensori, come mostrano gli stili ceramici. L’apparire di produzionibradaniche/enotrie a Torre di Satriano, Vaglio e Baragiano, ci indirizzano già verso quell’area per coglierele ‘origini’ del popolamento del nostro cantone. Tale supposizione può essere corroborata anche dallaconsiderazione di un altro tratto culturale particolarmente importante: nonostante la presenza di alcunielementi che ritornano anche nelle vicine fasce di tradizione ‘enotria’, vicine alla fossa-Kultur di tradizionetirrenica (si pensi alle affinità con produzioni documentate anche a sala Consilina) il ricorrere sin dalleprime tombe documentate (terzo quarto dell’VIII secolo) della deposizione contratta del cadavere, nonsolo avvicinano ancora una volta la nostra enclave alla koinè bradanico-ionica, ma permettono al contempodi escludere un rapporto stretto con la Sibaritide o l’entroterra ionico delle vallate del Sinni e dell’Agri sinoal Vallo di Diano.
Si potrebbe trattare insomma di una forma di ‘colonizzazione’ interna che promanerebbe dalcomprensorio particolarmente avanzato posto tra costa ionica e medio corso del Bradano, dove siti qualiMatera, Timmari, Gravina, Incoronata sono in pieno rigoglio e sviluppo nella Prima Età del Ferro. Si pensitra gli altri casi all’insediamento dell’Incoronata, un insediamento posto su un sistema articolato di collineche si dislocano a ridosso della costa ionica, presso la riva destra del Basento.37 Qui è stanziata una comunitàil cui rilievo ed elevato standard culturale è percepibile dalla ricca necropoli che si disloca sul pianoro diS. Teodoro e dall’esteso abitato, distribuito tra le colline limitrofe, c.d. dell’Incoronata indigena edell’Incoronata greca, di cui restano soprattutto ‘fosse’ pertinenti a capanne semi-infossate o ad attivitàproduttive. Nel corso dell’VIII sec. a.C. manufatti del medio e tardo geometrico segnalano qui l’avviarsi deiprimi, sporadici, contatti con i Greci, da inquadrare nel più ampio movimento di genti euboiche che interessatutto il Mediterraneo centro-occidentale, attirate dal particolare dinamismo delle comunità stanziate inquest’area, preludio di una presenza ben più significativa di manufatti di tradizione greca che caratterizzeràtutto il VII secolo. Lo sviluppo intenso di tali comunità nel corso dell’VIII secolo potrebbe aver portatoall’avviarsi di fenomeni di mobilità e al distacco di alcuni nuclei dalle proprie sedi originarie, alla ricerca dinuovi luoghi da occupare e sfruttare. Non è escluso che i contatti tra l’entroterra montuoso del potentino ei territori collinari bradanici si siano avviati e siano poi proseguiti grazie alle complementari vocazioniecologiche dei due ambienti, del tutto adatti all’alternanza dei pascoli estivi e invernali. Se infatti fino ad etàcontemporanea sono attestate in questa regione transiti di greggi tra le due micro-regioni del territoriolucano, d’altro canto la rilevanza della pastorizia per lo sfruttamento economico del territorio potentino èben documentata ora dalle analisi polliniche effettuate a Torre di Satriano, dove almeno a partire dal VII
36 Sui territori della Basilicata e della Calabria settentrio-
nale ionica ha portato l’attenzione il convegno materano
edito in Bettelli, De Faveri e Osanna 2009. Interessanti
dati al riguardi emergono anche dalle nuove rircerche
portate avanti nel Salento: Semeraro 2009 con biblio-
grafia.
37 La bibliografia sul centro è vasta: si rimanda ai contributi
di Denti 2009, 111-38 e di Cossalter e De Faveri 2009,
75-109 e alla bibliografia ivi citata.
sec. a.C. l’economia dominante – in particolare con aree di residenza di elites, come quella del c.d. anaktoron– è senza dubbio l’allevamento di capri-ovini, affiancata da quello del maiale.38
Tornando all’area ‘nord-lucana’, a giudicare in particolare dalla ceramica matt-painted in uso in granparte del territorio e dal rituale funebre, entrambi aspetti culturali direttamente imparentati con le coevemanifestazioni della finitima area bradanica del materano, non è inverosimile ipotizzare, dunque, che lanascita degli insediamenti sia da attribuire a genti originariamente stanziate più a sud-est, ossia proprio inquell’area che già nella Prima Età del Ferro, ma in alcuni casi con continuità dall’Età del Bronzo, mostravasegni di grande rigoglio e sviluppo. Ovviamente qui non si vuole in maniera acritica riproporre teorie, ormaida tempo superate, di quanti volevano riconoscere attraverso la diffusione della ceramica il movimento digenti, invasioni e migrazioni, ma piuttosto di porre l’accento su fenomeni di occupazione di nuove aree,che anche altrove in Italia meridionale si verifica nel corso dell’VIII secolo.39 Del resto non è solo la ceramica,nel nostro caso, a rimandare ad un determinato comprensorio culturale, ma anche tratti più complessi, comela tradizione funeraria del rannicchiamento, di cui l’area ‘nord-Lucana’ diventa l’attestazione più occidentale,e in definitiva anche la maniera di concepire l’organizzazione degli insediamenti, ove tra tombe e case simantiene sempre un rapporto strettissimo.
L’occupazione nel corso dell’VIII sec. a.C. dell’area montuosa del potentino, fino ad allora disabitata,deve essere stata accompagnata dalla laboriosa definizione di una nuova economia consona al peculiareecosistema in cui nuove genti si sono venute a installare, e dunque alla strutturazione di una societàadeguata ai nuovi stimoli dell’ambiente: è interessante notare come queste novità si verifichino nell’epocacruciale che si apre a partire dal secondo quarto dell’VIII secolo. Secondo quanto sottolineato da EdwardHerring, le ceramiche matt-painted rivelano infatti il definirsi di ‘native identities’ soprattutto nel corso delc.d. ‘Middle Geometric’ (circa 775-700 a.C.):40 è proprio in quest’epoca che si definiscono in manieraconsapevole e perfettamente riconoscibile gli stili regionali delle tre aree che coincidono con il ‘Salento’,il ‘Bradano’ e la ‘West Lucanian’ della classificazione di Douwe Yntema. Tale trasformazione ‘epocale’ nonsolo coincide con altri fenomeni di cambiamento più generali nelle dinamiche insediative delle regioni,ma avviene in un’epoca in cui i nostri siti prendono l’avvio, per dar vita nel corso di poche generazioni ainsediamenti che prospereranno a lungo, fino alla ‘romanizzazione’. Questo da un lato ci permette didefinire in maniera puntuale affinità e differenze nelle produzioni artigianali, riconoscendo in manieratangibile da dove promanano le prime attestazione artigianali note nel comprensorio, dall’altro cipermettono di inquadrare i fenomeni insediativi di area nord-lucana all’interno di un quadro dalledimensioni più ampie e di trasformazioni di vasta portata che interessano buona parte dell’Italiameridionale.
38 I dati ancora inediti che confluiranno nel volume Torre
di Satriano II, sono stati presentati da A. M. Mercuri al
convegno di studi “Nuove ricerche a Torre di Satriano”,
tenutosi nell’ottobre 2012 a Tito.39 Cfr. Morgan 1999: “ethnic significance lies not in the ex-
istence of regional styles but in their manipulation, re-
quiring to search beneath simple classifications for
fine-grained shifts in style and shape preferences which
are more likely to old social meaning”. Sulla scia di
quanto elaborato dalla studiosa britannica non si in-
tende dunque valorizzare la documentazione della cul-
tura materiale, partendo dalla falsa premessa che ai vari
stili regionali si possano tout court sovrapporre nomi
‘etnici’, formulando meccanicamente una equazione
tipo di ceramica = popolo. La definizione di una enclave
culturale/‘etnica’ è a nostro avviso possibile solo incro-
ciando vari aspetti delle manifestazioni di un gruppo,
come ad esempio quelli relativi al rito funerario, che in
quest’area si rivela particolarmente solido e longevo,
nonché la forma data all’insediamento nel complesso.
Per quanto riguarda le produzioni artigianali specializ-
zate, del resto, sono soprattutto quelle a forte carattere
‘rituale’, come senz’altro sono da considerare le cerami-
che matt-painted, che possono aiutare nella definizione
di un gruppo, puntando l’attenzione su come il gruppo
stesso si è voluto presentare all’interno e soprattutto
all’esterno. 40 Herring 1998.
Bibliografia
Adamesteanu, D. (ed.) 1999. Storia dellaBasilicata, vol 1: L’antichità (Roma).
Bertesago, S. e A. Bruscella 2009. “La ceramica adecorazione subgeometrica,” in M. Osanna, L.Colangelo e G. Carollo (edd.), Lo Spazio delPotere. La residenza ad abside, l’anaktoron,l’episcopio a Torre di Satriano: atti del secondoconvegno di studi su Torre di Satriano (Tito,27-28 settembre 2008) (Archeologia; Venosa)57-71.
Bettelli, M., C. De Faveri e M. Osanna (edd.) 2009.Prima delle Colonie. Organizzazioneterritoriale e produzioni ceramichespecializzate in Basilicata e in Calabriasettentrionale ionica nella prima età del ferro:atti delle giornate di studio, Matera, 20-21novembre 2007 (Archeologia; Venosa).
Bottini, A. 1981. “Ruvo Del Monte (Potenza).Necropoli in contrada S. Antonio. Scavi 1977,”NSc 35, 184-288.
Bottini, A. 1986a. “I popoli indigeni fino al Vsecolo,” in C. Ampolo, A. Bottini e P. G. Guzzo(edd.), Greci e indigeni nel sud della penisoladall’VIII secolo a.C. alla conquista romana(Popoli e civiltà dell’Italia Antica 8; Roma) 171-237.
Bottini, A. 1986b. “Il mondo indigeno dellaBasilicata nel VII secolo,” in A. De Siena (ed.),Siris Polieion. Fonti letterarie e nuovadocumentazione Archeologica, Policoro, 8 – 10giugno 1984 (Galatina) 157-66.
Bottini, A. 1989. “Il mondo indigeno nel V secoloa.C. Due studi,” BBasil 5, 161-79.
Bottini, A. 1999. “Gli indigeni nel V secolo,” in D.Adamesteanu (ed.), Storia della Basilicata, vol1: L’antichità (Roma) 419-53.
Bruscella, A. 2008. “L’insediamento arcaico diBaragiano: stato e prospettive di ricerca,”BBasil 24, 21-48.
Bruscella, A. 2009. “La necropoli arcaica di loc.Toppo S. Antonio a Baragiano: un nuovo casodi studio,” in Siris 10. Studi e ricerche dellascuola di specializzazione in archeologia diMatera (Bari) 21-35.
Carollo, G. e M. Osanna 2009. “Organizzazioneterritoriale e produzioni ceramiche
specializzate in area nord-lucana: Torre diSatriano e Ripacandida,” in M. Bettelli, C. DeFaveri e M. Osanna (edd.), Prima delle colonie.Organizzazione territoriale e produzioniceramiche specializzate in Basilicata e inCalabria settentrionale ionica nella prima etàdel Ferro: atti delle Giornate di Studio Matera,20-21 novembre 2007 (Archeologia; Venosa)383-420.
Cipolloni Sampò, M. 1999. “L’Eneolitico e l’Età delBronzo,” in D. Adamesteanu (ed.), Storia dellaBasilicata, vol 1: L’antichità (Roma), 67-136.
Ciriello, R., L. Cossalter e M. Sodo 2009. “Ricercherecenti in area mediobradanica. L’insediamentodi Monteserico nella prima età del ferro,” in M.Bettelli, C. De Faveri e M. Osanna (edd.),Prima delle colonie. Organizzazioneterritoriale e produzioni ceramichespecializzate in Basilicata e in Calabriasettentrionale ionica nella prima età del Ferro:atti delle Giornate di Studio Matera, 20-21novembre 2007 (Archeologia; Venosa) 309-38.
Cossalter, L. 2009. “Ceramica matt-painted in areabradanica. Il sito rupestre di San Nicola deiGreci – Matera,” in M. Bettelli, C. De Faveri eM. Osanna (edd.), Prima delle colonie.Organizzazione territoriale e produzioniceramiche specializzate in Basilicata e inCalabria settentrionale ionica nella prima etàdel Ferro: atti delle Giornate di Studio Matera,20-21 novembre 2007 (Archeologia; Venosa)339-64.
Cossalter, L. e C. De Faveri 2009. “Incoronata diMetaponto: nuovi dati per la conoscenza dellacultura materiale nella prima età del ferro,” inM. Bettelli, C. De Faveri e M. Osanna (edd.),Prima delle Colonie. Organizzazioneterritoriale e produzioni ceramichespecializzate in Basilicata e in Calabriasettentrionale ionica nella prima età del ferro(Venosa) 75-109.
Cossalter, L. e M. Osanna 2008. “La nascita di unnuovo insediamento: Torre di Satriano tra VIIIe V sec. a.C,” in M. Osanna, B. Serio e I.Battiloro (edd.), Progetti di archeologia Progettidi archeologia in Basilicata: Banzi e Tito (Siris
studi e ricerche della Scuola dispecializzazione in archeologia di MateraSuppl. 2; Bari) 103-11.
D’Agostino, B. 1989. “Le genti della Basilicataantica,” in G. Pugliese Carratelli (ed.), Italiaomnium terrarum parens (Milano) 191-246.
D’Agostino, B. 1999. “Greci e indigeni in Basilicatadall’VIII al III secolo a.C.,” in M. L. Nava, Tesoridell’Italia del sud (Milano) 25-57.
De Juliis, E. M. 1977. La ceramica geometrica dellaDaunia (Studi e materiali di etruscologia eantichità italiche 16; Firenze).
De Juliis, E. M. 1984. “L’età del Ferro,” in M. Mazzei(ed.), La Daunia antica: dalla preistoriaall’altomedioevo (Milano) 137-84.
De Juliis, E. M. 1995. La ceramica geometrica dellaPeucezia (Terra Italia 4; Roma).
Denti, M. 2009. “Un contesto produttivo enotriodella prima metà del VII secolo a.C.all’incoronata,” in M. Bettelli, C. De Faveri e M.Osanna (edd.), Prima delle Colonie.Organizzazione territoriale e produzioniceramiche specializzate in Basilicata e inCalabria settentrionale ionica nella prima etàdel ferro (Venosa) 111-38.
Di Lieto, M., M. Osanna e B. Serio 2005. “Ilprogetto di indagine territoriale a Torre diSatriano (PZ). Dati preliminari,” in Siris 6. Studie ricerche della Scuola di Specializzazione inArcheologia di Matera, 117-46.
Galeandro, F. 1999. “La ceramica a tenda:diffusione e cronologia,” Taras 19-2, 173-215.
Greco, E. 1988. Satriano 1987-1988. Un biennio diricerche archeologiche (Potenza).
Greco, G. 1991. Serra di Vaglio: La casa dei pithoi(Modena).
Greco, G. e G. Soppelsa 2009. “Serra di Vaglio: ilvillaggio dell’età del ferro,” in M. Bettelli, C. DeFaveri e M. Osanna (edd.), Prima delle colonie.Organizzazione territoriale e produzioniceramiche specializzate in Basilicata e inCalabria settentrionale ionica nella prima etàdel Ferro: atti delle Giornate di Studio Matera,20-21 novembre 2007 (Archeologia; Venosa),421-55.
Herring, E. 1998. Explaining Change in the Matt-Painted Pottery of Southern Italy. Social andcultural explanations for ceramic development
from the 11th to the 4th centuries B.C. (BAR-IS722; Oxford).
Holloway, R. R. 1970. Satrianum (Providence, RI).Horsnæs, H. W. 2002. The Cultural Development in
North Western Lucania c. 600-273 BC (ARIDSuppl. 28; Roma).
Morgan, C. 1999. “The archaeology of ethnicity inthe colonial world of the eighth to sixthcenturies B.C.: approaches and prospects,” inConfini e frontiere nella grecità di occidente(AttiTaranto 37; Taranto) 85-145.
Osanna, M. 2008. “Torre di Satriano. Morfologia estruttura di un insediamento della Lucanianord-occidentale dall’età del Ferro allaconquista romana,” in A. Russo e H. DiGiuseppe (edd.), Felicitas Temporum. Dallaterra alle genti: la Basilicata settentrionale traarcheologia e storia (Lavello) 143-67.
Osanna, M. e V. Capozzoli (edd.) 2012. Lo spaziodel potere II. Nuove ricerche nell’areadell’anaktoron a Torre di Satriano: atti delterzo e quarto convegno di studi su Torre diSatriano, Tito, 16-17 ottobre 2009, 29-30settembre 2010 (Archeologia; Venosa).
Osanna, M. e M. M. Sica (edd.) 2005. Torre diSatriano I. Il santuario lucano (Quaderniarcheologici (Deputazione di storia patria dellaLucania) 11; Venosa).
Osanna, M., L. Colangelo e G. Carollo (edd.) 2009.Lo spazio del potere. La residenza ad abside,l’anaktoron, l’episcopio a Torre di Satriano:atti del secondo convegno di studi su Torre diSatriano, Tito, 27-28 settembre 2008(Archeologia; Venosa).
Osanna, M. et al. 2011. “Sedi del potere di uninsediamento italico nell’Appennino lucaco:Torre di Satriano in età arcaica,” BdA 11, 1-26.
Russo, A. e H. Di Guseppe (edd.) 2008. Felicitastemporum. Dalla terra alle genti: la Basilicatasettentrionale tra archeologia e storia(Potenza).
Semeraro, G. 2009. “Castelluccio e il sistemaabitativo dall’età del Ferro all’età arcaica,” inG.-J. Burgers e G. Recchia (edd.), Ricognizioniarcheologiche sull’altopiano delle Murge. Lacarta archeologica del territorio di Cisternino(BR) (Foggia) 72-87.
Setari, E. 1988-89. “Produzioni artigianali indigene.La ‘fabbrica’ di Ripacandida,” in “Siris” I Studi ericerche della Scuola di Specializzazione inarcheologia di Matera, 69-119.
Soppelsa, G. 2011. Serra di Vaglio (PZ). Modi eforme dell’insediamento tra VIII e III sec. a.C.(Dottorato di ricerca in Scienze archeologiche estorico-artistiche, Univ. di Napoli “Federico II”).
Tagliente, M. 1999a. “Il mondo indigeno dellaBasilicata in età arcaica. Realtà a confronto eprospettive di ricerca,” in M. Barra Bagnasco,E. De Miro e A. Pinzone (edd.), Magna Greciae Sicilia. Stato degli studi e prospettive. Messina
2-4 dicembre 1996 (Pelorias, 4; Messina) 13-21.Tagliente, M. 1999b. La Basilicata centro-
settentrionale in età arcaica,” in D.Adamesteanu (ed.), Storia della Basilicata, vol1: L’antichità (Roma) 391-418.
Torre di Satriano II. c.s. Torre di Satriano II.L’insediamento e il territorio, dalla preistoriaall’età moderna.
Yntema, D. G. 1990. The matt-painted pottery ofSouthern Italy. A general survey of the matt-painted pottery styles of Southern Italy duringthe Final Bronze Age and the Early Iron Age(Collana del Dipartimento 4; Galatina).