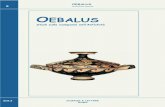"Barisanus...me fecit". Nuovi documenti sull'officina di Barisano da Trani
L'area palaziale e termale. I nuovi scavi
Transcript of L'area palaziale e termale. I nuovi scavi
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Archeologia
Comune di Galeata
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna
NUovE RiCERChE E SCAvi NEll’AREA
DEllA villA Di TEoDERiCo A GAlEATA
Atti della Giornata di StudiRavenna 26 marzo 2002
a cura di
Sandro De Maria
ESTRATTO
Volume realizzato con il contributo di:Comune di GaleataUniversità degli Studi di Bologna, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali (sede di Ravenna)
© 2004 Ante Quem piccola società cooperativa a r. l.© 2004 Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna
Ante Quem piccola società cooperativa a r. l. Via C. Ranzani 13/3, 40127 Bolognatel. e fax +39 051 4211109sede legale: Strada Maggiore 46, 40125 Bolognawww.antequem.it
redazione e impaginazione: Marco Destro, Azzurra Galeazzi, Flavia Ippolitoimpianti: Color Dimension, Villanova di Castenaso (Bo)
ISBN 88-7849-001-6
5
IndIcE
PresentazioniPiergiuseppe Mainetti 7Antonio Panaino 9Giuseppe Sassatelli 11Luigi Malnati 13
IntroduzioneSandro De Maria 15
Il sito, le ricerche, le nuove scoperte. Cinque anni di studi e scavinella villa di Teoderico a GaleataSandro De Maria 21
Il progetto preliminare del “Parco Archeologico di Teoderico e Mevaniola”Paolo Bolzani 49
Il luogo monastico di sant’ElleroAlba Maria Orselli 59
Gli scavi del 1942: materiali e nuovi dati d’archivioAnna Gamberini 67
La fase romanaGiuseppe Lepore 85
La fornace romanaMirco Zaccaria 99
Analisi di un campione di materiali ceramici provenienti dalla fornaceSimone Rambaldi 117
L’area palaziale e termale: i nuovi scaviRiccardo Villicich 121
Circolazione di manufatti e dati cronologici dallo studio dei materialiLuisa Mazzeo Saracino 135
Metodi di rilevamento e documentazioneEnrico Giorgi 157
Prospezioni geofisicheAntonio Edoardo Bracci 169
Intonaci decorativi e malte di allettamento presenti nella villa di Teodericoa Galeata (FC): caratterizzazione mineralogica e petrograficaGian Carlo Grillini-Vanna Minguzzi-Francesca Carletti 177
Tavole 183
Il complesso “palazIale”: I nuovI scavI
Riccardo Villicich*
Gli scavi condotti nel 1942 dall’équipe tedesca diretta da Sigfried Fuchs1 porta-rono al rinvenimento di una serie di strutture murarie riferibili, nella loro fase piùtarda, ad un vasto complesso residenziale tardoantico, in cui si vollero riconoscere,senza troppi dubbi, le rovine di uno dei numerosi palazzi fatti costruire in Italiasettentrionale dal re goto Teoderico2. In realtà, l’interpretazione di questi resti, rin-terrati diverso tempo dopo la conclusione della campagna di scavo, ha costituitoargomento di discussione per archeologi e studiosi nel corso dei successivi ses-sant’anni. Le ipotesi ricostruttive del c.d. “palazzo” proposte dall’architettoFriedrich Krischen sono parse ai più decisamente forzate e in parte non prive di una‘motivazione’ ideologica. Il particolare periodo storico in cui si svolsero gli scavicostituì evidentemente la ‘radice determinante’ della ferrea volontà con cui si vollericonoscere una matrice germanica nelle strutture messe in luce in localitàPoderina, associandole alla figura di Teoderico e alla sua presenza in situ3 . Nel corsodegli anni sono state mosse ferme critiche alle ricostruzioni di Krischen, criticheche sono sfociate in altrettante ipotesi e interpretazioni4, contraddistinte, tuttavia,nella maggior parte dei casi, dalla mancanza di valide argomentazioni, come è ine-vitabile che accada in absentia di nuovi dati archeologici che consentano di arricchi-re con rinnovata ‘linfa’ una trattazione da tempo sterile.
Le recenti scoperte, che hanno confermato l’effettiva presenza nel sito di una faseedilizia sicuramente posteriore a quella romana5, da inquadrarsi, con tutta probabi-lità, in un periodo compreso fra la metà del V e gli inizi del VI secolo d.C., stra-volgono in gran parte quella che era la chiave di lettura precedente. Appare ormaicerto, dopo due campagne di saggi e tre di scavo estensivo6, che il complesso resi-denziale allora identificato quale “palazzo di Teoderico” sia ben più vasto di quelloricostruito dagli archeologi tedeschi, in virtù del rinvenimento, in un’area moltopiù ampia, di strutture murarie del tutto similari, per tecnica costruttiva e tipolo-gia, a quelle scoperte nel 1942 e riportate parzialmente in luce nel 1998 grazie a
121
* Dipartimento di Archeologia, Università di Bologna.1 Sui risultati degli scavi del 1942 rimando ai seguenti contributi: FUCHS 1942, pp. 259-277;
KRISCHEN 1943, pp. 459-472; JACOPI 1943, pp. 204-212.2 In riferimento all’attività edilizia del re goto, più volte attestata dalle fonti, rimando, in sintesi,
a BALDINI LIPPOLIS 1999, pp. 165-190.3 La presenza di Teoderico a Galeata e nella valle del Bidente è legata alle fonti agiografiche; si
ricorda in particolare il ‘leggendario’ incontro con S. Ellero, celebrato in un brano della VitaHilari. Per una sintesi sul problema si veda BOLZANI 1994, pp. 9-24; più in generale, rimandoalla relazione di Alba Maria Orselli, in questo stesso volume.
4 Fra i numerosi studiosi che hanno trattato del “Palazzo” di Teoderico a Galeata ricordo su tutti:MONNERET DE VILLARD 1952, pp. 26-32; CAGIANO DE AZEVEDO 1966, pp. 663-694;DEICHMANN 1989, pp. 267-262. Per un’antologia critica sull’argomento e per la bibliografia ingenerale rimando a BOLZANI 1994, pp. 117-150.
5 Come appare chiaramente documentato nel settore occidentale dell’area di scavo, dove le strut-ture di età tardoantica si sovrappongono in parte a quelle romane. Sulle fasi romane si veda ilcontributo di G. Lepore contenuto in questa stessa raccolta di Atti.
6 In questo contributo si è deciso di avvalersi, per una maggiore completezza dell’argomento edella documentazione grafica e fotografica, anche dei dati acquisiti nel corso della campagna discavo dell’estate del 2002, svoltasi pochi mesi dopo la Giornata di Studi sul “Palazzo diTeoderico” a Galeata.
due indagini stratigrafiche (Tav. II, saggi 1 e 2 1998) effettuate nell’area del “palaz-zo”7. È evidente, stando agli ultimi dati di scavo, che il principale errore dell’équi-pe tedesca sia stato l’aver scambiato per un complesso integralmente definito nellesue linee essenziali quello che in realtà era solo un settore o una cellula di una gran-de residenza privata, estesa ben oltre i limiti ipotizzati da Krischen e da Fuchs.
In un saggio effettuato a circa sessanta metri a N-E del “palazzo” (Tav. I, saggio6, 1999), è stato portato in luce, infatti, un segmento murario, conservato solo infondazione, pertinente anch’esso, sulla base delle medesime soluzioni costruttive, al“complesso palaziale”. Se questo ritrovamento dimostra come i limiti nord orienta-li della grande residenza privata siano assai più ampi di quelli definiti precedente-mente, la scoperta di una struttura di ancora incerta interpretazione, una ventina dimetri a sud del presunto braccio meridionale del “palazzo” (Tav. I, saggio 3, 1998),e il rinvenimento di un grande “quartiere termale” (Tav. I, area B), a S-E dello stes-so, entrambi della medesima fase edilizia, confermano una notevole estensione versooriente e a meridione del complesso residenziale, aprendo nuovi scenari sull’effetti-va funzionalità dei singoli settori8.
Come si è detto, permangono tuttora dubbi interpretativi sulla natura dell’ac-ciottolato o “vespaio”, composto da un insieme di pietrame e laterizi legati conmalta, venuto in luce nel saggio 3 (Fig. 1). Quest’ultimo, vantando circa due metridi larghezza9, sembra troppo poderoso per identificarsi quale struttura muraria per-tinente ad una cellula abitativa del “palazzo”, specie se rapportato ai parametrimetrici degli altri muri fin qui emersi. L’esigua fondazione, limitata ad una qua-rantina di centimetri, parrebbe escludere, tuttavia, una funzione portante per que-sta struttura, il cui impiego, più probabilmente, doveva essere quello di muro diterrazzamento o di recinzione del complesso10. Un altro dato, di carattere stretta-mente stratigrafico, contribuisce ad alimentare i dubbi circa la natura delle emer-genze archeologiche venute in luce nel saggio, ma, allo stesso tempo, crea uno sce-nario di notevole interesse, se riferito a quelle che potrebbero essere le fasi di costru-zione del grande impianto residenziale. L’acciottolato sopra descritto si imposta,
infatti, con un ‘taglio’ netto, suiresti di una precedente calcara (Fig.2). Di questa struttura è riconosci-bile la larga fossa circolare che fun-geva da camera di combustione,caratterizzata da un diametro com-plessivo di circa 3,30 m. Sullepareti, quasi vetrificate per il calo-re, sono apparse subito evidenti lar-ghe chiazze di calce, residuo dellafase di produzione. Esternamenteuna traccia concentrica di argilla
rubefatta disegna nel suolo la forma anulare della calcara. La tipologia assai sempli-ce, probabilmente a fuoco intermittente, prevedeva una fossa scavata nel terrenoargilloso, costipata da pietre e blocchi destinati alla calcinazione, i più grandi dei
122
7 Per una descrizione più dettagliata delle strutture murarie di età tardoantica venute in luce nelsaggio 1 rimando, anche in questo caso, al contributo di G. Lepore.
8 Strutture murarie, conservate solo in fondazione, pertinenti, con tutta probabilità, al “comples-so palaziale”, sono venute in luce anche nel saggio 4 effettuato nel 1998, una decina di metri adoriente del settore centrale scavato dagli archeologi tedeschi.
9 La lunghezza della struttura, che ha andamento N-E/S-O, non è ancora definibile, a causa dellelimitate dimensioni del saggio.
10 Un’altra ipotesi, priva anche in questo caso di riscontri effettivi, potrebbe essere quella di iden-tificare la struttura con uno stradello o camminamento, da porsi in relazione con un possibileingresso secondario del complesso residenziale.
1. Saggio 3; latoorientale dellastruttura compostada ciottoli e laterizi
Ricerche nell’area della villa di Teoderico a Galeata
quali, poggianti direttamente sul fondo, sostenevano la volta della camera di com-bustione (Fig. 3). Uno strato di calce superficiale aveva la funzione di copertura edi isolante termico. Il fatto che il largo acciottolato si sovrapponga in modo evi-dente alla fornace per calce fa supporre che quest’ultima fosse stata utilizzata nellafase di costruzione del “palazzo”, per poi essere obliterata, una volta assolto il suocompito, dal percorso, probabilmente obbligato, di una delle strutture periferichedella stessa residenza privata. Il proseguimento degli scavi in questo settore con-sentirà di fare chiarezza sulla reale funzione degli apprestamenti suddetti.
La scoperta più importante, comunque, anche al fine della comprensione delcomplesso residenziale nel suo insieme, è quella del settore termale, oggetto di scavoestensivo a partire dalla campagna del 2000 (Fig. 4). I rinvenimenti del 2002 sem-brano confermare i dati preliminari delle campagne precedenti, riconoscendo nellestrutture scavate una serie di vani pertinenti ad un’area termale privata, ben piùvasta delle terme pubbliche della vicina città di Mevaniola11, impostata, probabil-mente, su un percorso assiale centrale, calidarium-tepidarium-frigidarium (vani 9, 3,6), e sicuramente ricavata in un’unica fase, almeno nelle sue linee strutturali essen-
123
11 I vani dell’impianto termale, peraltro messo in luce solo parzialmente, superano i 400 metri qua-dri di estensione.
Il complesso “palaziale”: i nuovi scavi
2. Pianta dellargo acciottolatorinvenuto nel sag-gio 3; la strutturasi imposta sopra iresti di una prece-dente calcara(rilievo R.Villicich, rielabo-razione grafica M.Zaccaria)
3. Ricostruzioneipotetica della cal-cara di Galeata(disegno R.Villicich). 1. Spaccato dell’in-terno della cameradi combustione. 2.blocchi e pietrameda calcinare. 3.imboccatura perl’introduzione delcombustibile. 4.strato di calce coneffetto isolante
Ricerche nell’area della villa di Teoderico a Galeata
12 Per comodità di descrizione, si è fatto uso, nel corso dello scavo, di un nord convenzionale di can-tiere, spostato circa 30° più ad occidente rispetto al nord astronomico. L’andamento reale dellestrutture, infatti, sarebbe all’incirca N-O/S-E.
ziali (Fig. 5). Quest’ultima considerazione appare evidente alla luce della medesimaorientazione N-S/E-O12 di tutte le strutture murarie, canalette comprese, e di un’u-nica tecnica costruttiva comune a tutta l’area in questione. Il “quartiere termale”non si esaurisce nella sequenza dei vani suddetti, che costituiscono essenzialmente ilnucleo centrale dell’impianto, ma appare articolato in più settori, con una propag-gine ad oriente incentrata su un ampio vano ottagonale, solo parzialmente messo inluce, ed una teoria di vani e di vasche ad occidente, in stretta relazione con un’am-pia corte scoperta.
Purtroppo al fine della comprensione di questo interessante impianto termale edei suoi percorsi, ha influito negativamente la perdita pressoché completa degli ele-vati, specialmente nel settore centrale e in quello orientale; si tratta, in questo caso,di un dato che caratterizza tutta l’area di scavo. La maggior parte delle strutturemesse in luce, infatti, appare conservata solo in fondazione, dal momento che lo scar-so interro ha costituito una ben misera protezione, contro l’azione dell’aratro, per ipochi resti di elevato che le massicce spoliazioni di età antica dovevano avere rispar-miato.
La situazione stratigrafica dei due grandi vani riscaldati è pressoché identica. Sitratta, infatti, di due ambienti i cui piani pavimentali, a causa delle arature e dellespoliazioni, risultano completamente asportati. Questi erano sostenuti da pilastri-ni, costituiti da bessali di buona fattura, che poggiavano sul piano dell’hypocaustumin cocciopesto (Fig. 6). Lo statumen del piano in cocciopesto era ricavato diretta-
124
4. Planimetria del settore termaledella villa diTeoderico (rilievoR. Villicich, riela-borazione graficaM. Zaccaria)
mente sullo strato limo-argilloso corrispondente allo spianamento del terreno sopral’ultimo strato di accrescimento naturale precedente all’impianto. I piani dientrambi i vani erano ricoperti da uno spesso accumulo (50-60 cm) di crollo e mace-rie, composto in parte da tubuli fittili a siringa, utilizzati nel sistema a volta deisoffitti, e da altri a sezione rettangolare, che venivano messi in opera lungo le pare-ti delle stanze, con il compito di favorire il passaggio dell’aria calda, come preve-deva il sistema di riscaldamento dell’epoca. Nello stesso strato sono stati rinvenutiresti frammentari di mattoni bipedali, destinati a sostenere la pavimentazione deivani riscaldati, e residui della malta che doveva servire come legante e piano di posa.Tutte le strutture murarie che delimitano gli ambienti appaiono interessate da spo-liazioni successive (di età probabilmente altomedievale o medievale), consistenti in
125
5. Planimetriaschematica del settore termale(rilievo E. Giorgi,G. Milanesi, R.Villicich)
Il complesso “palaziale”: i nuovi scavi
profonde fosse che hanno intaccato imuri del complesso, asportandone icorsi di laterizi, fino alle fondazio-ni13 (Fig. 7).
Nonostante la mancanza di pianipavimentali, non penso vi sianodubbi sulla natura dei due ambientiriscaldati. Il fatto che l’unico prae-furnium (Fig. 8) rinvenuto nell’areadi scavo (vano 15) risulti ubicatoimmediatamente a nord del vano 9conferma come questo fungesse dacaldarium, mentre il vano 3 nonpoteva che essere un tepidarium.Quest’ultima stanza presentava unasorta di appendice, un prosegui-mento verso oriente costituito dauna piccola saletta quadrata14,riscaldata, che congiungeva ilnucleo del “quartiere termale” con ilnotevole padiglione ottagonale(vano 2), solo in parte scavato, di cuisi è accennato in precedenza. Mi
sento di escludere che il piccolo ambiente fosse un alveus, sia perché non vi è trac-cia di un praefurnium ad esso collegato, funzionale al riscaldamento dell’acqua caldadella vasca15, sia perché nei sistemi termali gli alvei rappresentano un annesso pres-soché esclusivo dei caldaria. È probabile invece che la ragione della piccola appen-dice quadrata si possa ricondurre semplicemente ad un espediente architettonico. Lapresenza di questo ambiente, infatti, impediva che la massa strutturale del padi-glione ottagonale incombesse direttamente sul corpo centrale del settore termale,creando zone d’ombra non funzionali all’esposizione verso oriente e meridione degliambienti riscaldati. Grazie a questa soluzione, si venivano così a creare due simme-trici e ampi subsecivi trapezoidali, con la probabile funzione di giardino, che garan-tivano spazialità e favorivano indirettamente la luminosità dei vani suddetti.
Sulla natura della grande aula ottagona e dei due piccoli ambienti ad essa annes-si (vani 4 e 14) sussistono ancora diversi dubbi, dovuti soprattutto alla completaasportazione dei piani d’uso. In questo punto il vomere dell’aratro si è approfondi-to ben al di sotto di quelli che dovevano essere gli strati di preparazione del pavi-mento, cancellando qualsiasi riscontro oggettivo sulla funzionalità delle stanze.Appare probabile, comunque, che il padiglione ottagonale non fosse destinato adessere riscaldato. Qualora la prosecuzione degli scavi dovesse confermare la naturadei due piccoli vani 14 e 4 quali vasche accessorie al vano 216, si avvalorerebbe l’i-potesi che questo avesse funzione di frigidarium; soluzione che, fra l’altro, trovereb-be confronti non dissimili nei settori termali delle grandi ville di Piazza Armerina
126
13 Si segnala anche la presenza di fosse di vite parallele, con direzione E-O, che hanno provocatoulteriori danni ai resti archeologici. I filari di vite appaiono ben riconoscibili in alcune fotogra-fie scattate dagli archeologi tedeschi durante la campagna di scavo del 1942.
14 Il lungo muro che delimitava ad oriente i vani 9, 3 e 6 quasi sicuramente non aveva elevato, limi-tandosi alla sola fondazione, nel tratto che separava il vano 3 dall’absidiola; in questo modo i duevani venivano a formare un unico ambiente.
15 Allo stesso tempo non sono state rilevate tracce di alcuna struttura da porsi in relazione con unapossibile caldaia per l’acqua calda.
16 Il dato potrebbe essere confermato, in questo caso, dal rinvenimento di una terza vasca nell’e-stremo lato orientale dell’ambiente.
6. Gli ipocaustidel caldarium edel tepidarium;in evidenza le seriedi pilastrini for-mati da mattoniquadrati (bessali)
Ricerche nell’area della villa di Teoderico a Galeata
7. Veduta dall’altodi una parte delsettore termale; siosservano le profon-de fosse agricole edi spoliazione
in Sicilia17 (Fig. 9) e di Löffelbachnel Noricum18 (Fig. 10), dove il frigi-darium era costituito da sale ottago-nali, con annesse vaschette di acquafredda.
Si tratta, comunque, di quesitiche sembrano destinati ad avere unarisposta già nel corso della prossimacampagna di scavo.
A sud del tepidarium è statomesso in luce un vano chiuso ameridione da un’abside (Fig.11, vano 6). Anche in questocaso, come si è detto per glialtri ambienti, si conservanosolo le fondazioni delle struttu-re murarie. L’ipotesi più proba-bile è che si tratti di un secon-do frigidarium o, comunque, diun ambiente non riscaldato,che concludeva l’allineamentoassiale N-S degli ambienti cen-trali del settore termale, secon-do una scansione, calidarium-tepidarium-frigidarium, fra lepiù semplici e comuni. Nelvano non sono state rinvenutetracce di pavimentazione se sifa eccezione per i residui di unostrato di preparazione riscon-trato nel suo limite nord. Talepreparazione (del tutto simileai piani degli ipocausti) in coc-ciopesto e ciottoli, limitata,come si è detto, alla zona norddell’ambiente, assume unaforma quasi rettangolare, certamente non casuale. Si tratta molto probabilmente diciò che resta dei gradini dell’ampia scala destinata a colmare il dislivello fra il pianodel tepidarium, sopraelevato con il sistema delle suspensurae, e quello dell’ambienteabsidato, mettendoli in comunicazione. Anche in questo caso il piano pavimentaledi quest’ultimo vano, composto forse da lastre di marmo o di arenaria, sarebbe statocompletamente asportato. È assai probabile che l’abside, con cui si chiudeva a sudil vano, accogliesse al suo interno una vasca semicircolare.
Ad occidente degli ambienti appena descritti, il “quartiere termale” prosegui-va, come si è detto, con un settore connotato da una serie di strutture destinate pre-valentemente ad abluzioni e bagni in acqua fredda.
Di particolare interesse è un lungo vano di forma rettangolare, caratterizzato dauna sorta di vestibolo centrale di forma quadrata (vano 7), attraverso il quale si pote-
127
17 Sul “quartiere termale” della Villa di Piazza Armerina si vedano in sintesi: NIELSEN 1990, p. 56(vol. I), C 65 e fig. 87 (vol. II); SCAGLIARINI CORLAITA 1995, pp. 858-860.
18 Sulla villa di Löffelbach si vedano: SCAGLIARINI CORLAITA 1995, pp. 861-864; HUDECZEK-KAINZ
1994, pp. 265-269; TÒTH 1978-1979, pp. 189-195.
8. Il praefurnium(vano 15) visto danord
Il complesso “palaziale”: i nuovi scavi
9. Planimetriadella villa delCasale a PiazzaArmerina (daMielsch)
Ricerche nell’area della villa di Teoderico a Galeata
128
19 Il pavimento, anche alla luce dello strato di preparazione assolutamente omogeneo in tutto ilpiano e speculare a quello degli altri settori dell’area termale, è stato ricavato evidentemente inun unico momento, anche se la tipologia eterogenea del materiale inizialmente aveva fatto pen-sare a rabberciature successive. La scelta di far coesistere l’arenaria con il marmo andava forseincontro al gusto del proprietario o, più probabilmente, si trattava di un espediente per rispar-miare il marmo, che non è escluso scarseggiasse in quella fase di cantiere.
20 Questo sistema di copertura di vani rettangolari non è raro, si veda, per esempio, GIULIANI 2000,pp. 92-93.
va accedere a due vasche latera-li, simmetriche (vani 8 e 13),ricavate a nord e a sud di que-st’ultimo (Fig. 12). La vascasettentrionale era pavimentatain modo composito con lastredi arenaria, alternate a listelli elastre di marmo irregolari19. Sulpavimento della vasca, a causadella quota inferiore rispetto aipiani pavimentali, è stato possi-bile rinvenire parte del crollodella copertura voltata di que-st’ultimo ambiente. La presenzadi un grande numero di tubulia siringa, alcuni dei quali anco-ra concatenati in serie di cinqueo sei esemplari, fornisce unimportante elemento di riferi-mento sulla tecnica costruttivadelle volte e sul materialeimpiegato (Fig. 13). È probabi-le, dunque, che l’edificio pre-sentasse due volte a botte late-rali, che coprivano entrambe levasche, e un’ampia volta a cro-ciera in corrispondenza delvestibolo centrale, secondo unoschema peraltro non raro, checonsentiva di ricavare finestrelucifere nella volta al centro20.Della pavimentazione dellavasca meridionale (vano 13), acausa dell’approfondimentodelle arature, si è conservatosolo un piccolo lacerto in arena-ria nell’angolo nord-occidenta-le. Non vi sono motivi, comun-que, per dubitare che il pianopavimentale fosse del tuttosimile a quello della gemellasettentrionale. L’acqua delle due
vasche defluiva attraverso fistule plumbee, conservatesi in parte, in un sistema dicanalizzazione a ‘T’, che scorreva sotto il pavimento del vano 7, per poi scaricare inun collettore centrale, localizzato nel vano immediatamente ad occidente (vano 11),da cui l’acqua veniva convogliata verso sud, in direzione del torrente Saetta.
10. Planimetriadella villa diLöffelbach inStiria (da Hudeczek-Kainz 1994)
11. Veduta dal-l’alto dell’ambienteabsidato; a nord è riconoscibile l’hypocaustumdel tepidarium
12. La vasca 8 eil vano 7 visti dal-l’alto. A norddella vasca 8, siriconosce il vano10, pavimentato inlastre di arenaria
Il complesso “palaziale”: i nuovi scavi
129
21 Anche fra vano 7 e vano 6 doveva sussistere la stessa differenza di quota del piano pavimentale(circa un’ottantina di cm.) che c’era fra il vano 3 e quest’ultimo, supplita, in quel caso, grazie aduna rampa di gradini. I vani 7, 11, 10 e quelli con suspensurae, 9 e 3, tranne che per pochi cm.di differenza, presentavano evidentemente la medesima quota di piano di calpestio, mentre nelvano 6 il pavimento era stato messo in opera ad una quota inferiore. A quale quota si cammi-nasse nel vano 2, come si è detto, non si può per ora dare risposta.
22 La corte era evidentemente priva di copertura, sia per la mancanza di basi per colonne o pilastri,da mettersi in relazione con un peristilio o un portico, sia per la presenza, nel lastricato in are-naria, di tombini, disposti ad intervalli regolari, per il deflusso delle acque piovane, evidente-mente funzionali ad un’area scoperta. La pavimentazione in massicce lastre di arenaria è tipica,inoltre, delle ampie aree senza copertura.
23 Allo stato attuale delle ricerche sono stati portati in luce tratti dei muri perimetrali nord, est esud della grande corte; è di consolazione il fatto, che, almeno in questo frangente, le strutturemurarie si presentano in più punti conservate in elevato (per una quarantina di cm circa).
Sul motivo delladuplicazione dellevasche nell’ambitodello stesso edificio,sussiste tuttora piùdi una zona d’ombra.Forse tale distinzionetrova una ragione nelfatto che i due trogo-li, profondi non piùdi 70-80 cm, nonfossero entrambidestinati ad abluzio-ni in acqua fredda,come sembra appa-rentemente, ma uno dei due fosse funzionale a bagni in acqua calda o tiepida.Un’altra spiegazione, se non si vuole ricondurre questa soluzione ad una semplicescelta estetica, è che una delle vasche fosse destinata agli uomini e l’altra alle donne.
Non vi sono invece dubbi, a mio avviso, sul fatto che l’edificio descritto facesseparte di quello chepotremmo definire ilsettore estivo del“quartiere termale”.Se il collegamentodiretto fra il vano 7 equello 6 (forse trami-te una rampa di gra-dini)21 risulta deltutto ipotetico acausa dell’approfon-dimento repentinoverso S-E dell’azionedell’aratro, che haobliterato gli elevatie parte delle fondazioni, è viceversa evidente come al primo si accedesse attraverso ilbraccio orientale di un cortile (vano 11), solo in parte riportato in luce. Si tratta inquesto caso di un’ampia corte scoperta22, di forma quadrangolare, pavimentata conlastre di arenaria, che aveva, come vedremo, la probabile funzione di ‘cerniera’ fra ilquartiere termale e il settore messo in luce nel 1942 (Fig. 14). All’incirca al centrodi uno spazioso deambulatorio, circoscritto da quelli che dovevano essere alti muridi cinta23, è venuta in luce buona parte di una vasca di dimensioni decisamente supe-
13. Il pavimentodella vasca 8coperto dal crollodella volta. In evidenza i tubuli fittili deltipo “a siringa”
14. Il cortile (vano 11) ancoraricoperto da macerie
Ricerche nell’area della villa di Teoderico a Galeata
130
24 Le misure sono approssimative in quanto lo scavo della struttura non è stato ancora completato.25 Per quello che concerne il materiale ceramico rinvenuto nello scavo, rimando al contributo di
Luisa Mazzeo, all’interno di questo stesso volume.
riori alle due succita-te (almeno 11 x 7m)24 (Fig. 15). Lascarsa profondità delgrande invaso, cheanche in questo casonon sembra superaregli ottanta cm, rendeimprobabile, tutta-via, la sua identifica-zione quale natatiovera e propria. È pro-babile, comunque,che questa struttura,di cui si sono conser-
vate integralmente la pavimentazione in arenaria e le imboccature delle fistule plum-bee per il deflusso dell’acqua, fosse destinata a semplici abluzioni refrigeranti, sfrut-tata nel periodo estivo, in alternativa alle due del settore coperto, di cui si è detto inprecedenza (Fig. 16). Lo scavo degli strati di macerie che la colmavano è risultatoricco di dati interessanti. Si è potuto constatare come a partire da un certo periodo
la vasca venisse uti-lizzata quale discari-ca per rifiuti e mace-rie (Fig. 17). Il rin-venimento di cera-mica databile al VII-VIII secolo d.C.25 edi altri resti dibivacchi, fra cui ossadi animali, nellastratificazione supe-riore del riempimen-to della vasca, sem-bra confermare chela stessa avesse perso
da tempo la sua funzione originaria. È apparso evidente , infatti, come al momentodella dispersione della ceramica suddetta si fossero già accumulati sul fondo dellavasca consistenti livelli di macerie (Fig. 18). Si tratta, in questo caso, di un indizioche deporrebbe a favore di una precoce decadenza e di un prematuro abbandono dellagrande residenza privata, destinata a non essere frequentata, nel pieno del suo splen-dore, per più di un centinaio di anni (probabilmente fra la seconda metà del V e lametà del VI secolo d.C.). D’altronde non è un ipotesi improbabile, se si tiene contoche nell’Italia riemersa dalla catastrofe della guerra greco–gotica, conclusasi datempo la grande stagione monumentale di età teodericiana, ben pochi dovevano esse-re i ricchi proprietari e le grandi famiglie in grado di conservare un tenore di vitapari a quello goduto anche solo cinquant’anni prima.
In generale, soffermandoci su alcuni aspetti strettamente stratigrafici relativi aquesto settore di scavo, si è potuta riscontrare l’assenza pressoché totale di struttu-re di età precedente al periodo tardoantico, anche se i reperti mobili testimonianouna presenza umana nell’area già in età protostorica. È assai probabile che nella fase
16. Particolaredell’interno dellavasca 16 in corsodi scavo
15. L’area del cor-tile a scavo ultima-to. In basso, a sini-stra, è visibile unaparte della grandevasca 16
di vita della precedente villaromana, i cui resti, come si èdetto, sono stati localizzati adoccidente del “quartiere terma-le”26, parte della superficie su cuisorse la grande residenza tardo-antica fosse destinata ad uso agri-colo. Sporadici frammenti cerami-ci e un asse repubblicano dellaseconda metà del II secolo a.C.,rinvenuti in livelli intercettatidalle fondazioni delle strutture
tardoantiche, denotano, comunque, una saltuaria frequentazione, in epoca romana,dell’area su cui poi verrà impiantato il settore termale.
Ad una fase forse di poco successiva a quella originaria dell’impianto dell’areatermale sembrano riconducibili, invece, alcune strutture murarie riscontrate nel set-tore nord-ovest della stessa. Si tratta dei due muri che circoscrivono a nord e a sudl’ambiente 12 e di una presunta fontanella localizzata immediatamente a nord diquest’ultimo. È probabile che l’ambiente suddetto e il vano 10 siano stati ricavati,in una seconda fase, con la funzione di locali di servizio del “quartiere termale”,sfruttando parzialmente quella che doveva essere una precedente area a giardino.
Un altro aspetto che si è potuto constatare, relativo alla particolare situazionegeomorfologica del sito al momento della progettazione del “quartiere termale”, ciconferma come quest’ultimo sia stato ricavato in un’area che presentava un eviden-te dislivello, con un costante digradare del terreno verso S-E. Questa considerazio-ne appare molto probabile alla luce degli strati di livellamento artificiale prodottiper rialzare la quota del vano 7 e di alcuni settori esterni (12, 11 e, inizialmente 10),riportandola a quella che doveva essere la stessa quota dei pavimenti sopraelevati delcaldarium e del tepidarium. È strano, infatti, che sia stato scelto di rialzare artificial-mente i piani di almeno quattro grandi vani (di cui, come si è detto, tre esterni), anord ovest dei due vani con suspensurae, invece di ricavare questi ultimi a partiredalla quota di campagna dei vani esterni, sottoscavando ipocausti e prefurnio. Talesoluzione può trovare una spiegazione se si immagina un dislivello da colmare frala zona ad ovest dei vani scoperti e l’area dei vani riscaldati. Si osserva, a confermadi questa ipotesi, come la quota dell’interfaccia superiore dell’unità stratigrafica cherappresenta il livello del piano di campagna al momento dell’impianto delle strut-ture, tenda a rialzarsi, a partire dai vani riscaldati, in direzione ovest, fino a rag-giungere la quota più alta nell’area centrale del podere, da cui con molta probabi-lità il terreno iniziava a digradare, con una pendenza progressiva, in direzione S-E.
131
26 Come si è già sottolineato (si vedano note 5 e 7), parte del settore occidentale del Palazzo tar-doantico, messo in luce nel 1942 dagli archeologi tedeschi, insisteva su strutture romane appar-tenenti alla villa in questione, il cui settore centrale doveva probabilmente ubicarsi ad occiden-te dell’attuale strada del Pantano, nell’attuale podere Alpestri.
Il complesso “palaziale”: i nuovi scavi
17. La vasca 16in corso di scavo.Nello strato piùscuro, visibile alcentro della vasca,sono stati rinvenutiframmenti di cera-mica altomedievalee resti di bivacchi
18. Sezione deglistrati di interroaccumulatisi soprae all’interno dellavasca 16 (limitesud dello scavo)
La scelta dell’orientazione delle strutture murarie e la disposizione dei vani, infi-ne, non sembra essere stata affatto casuale, ma progettata, in realtà, per favorire unacorretta esposizione verso meridione degli ambienti destinati ad essere riscaldati. Lagrande quantità di frammenti di vetri da finestra sembra confermare, come è con-suetudine in complessi di questa tipologia, la presenza di grandi vetrate che dove-vano rendere molto luminosi i vani dell’area termale.
In linea con i dati derivanti dai saggi dei primi due anni di scavo, anche nell’areadel quartiere termale si segnala un modesto rinvenimento di reperti fittili. Questodato vale sia per gli ambienti destinati ad essere riscaldati, dei quali sono stati aspor-tati completamente i piani d’uso, sia per gli ambienti scoperti, in parte pavimenta-ti con lastre di arenaria. Tale mancanza è comunque spiegabile, oltre che per lo statodi conservazione dei resti, ampiamente interessati e distrutti dalle arature e dallefosse agricole, anche per la destinazione stessa dei vani, in cui doveva essere previstoun uso limitato del materiale ceramico. Rari frammenti ceramici, purtroppo scarsa-mente utili per stabilire dei validi indizi cronologici, sono stati rinvenuti negli stra-ti di livellamento artificiale, sotto i piani di alcuni vani. Si tratta perlopiù di cera-mica da cucina, ceramica comune e qualche esiguo segmento di anfora. Gli stessistrati di livellamento hanno restituito, a livello della testa dello strato, direttamen-te sotto i piani in arenaria (in parte lacunosi), alcuni frammenti di marmo reimpie-gati (forse appartenenti alle strutture di età romana di cui si è parlato, rinvenute piùad ovest, nell’area interessata dagli scavi del 1942). Questi reperti sono in prevalen-za residui di lastre di rivestimento, ma si segnala anche la presenza di un esemplareche potrebbe essere pertinente allo stipite di una porta. Frequente, come si è detto,il rinvenimento di elementi fittili quali tubuli da volta e da riscaldamento, alcuniconservati perfettamente integri; non rare anche le crustae marmoree e le tesseremusive pertinenti all’apparato decorativo della residenza. Fra gli oggetti metallicirinvenuti si segnalano chiodi di ferro e grappe utilizzati per gli elementi lignei deisoffitti e per la messa in opera dei tubuli da parete e delle crustae marmoree. Comenel caso dei saggi dei primi due anni, lo scavo estensivo del settore termale ha resti-tuito scarso materiale numismatico (fra cui l’asse repubblicano di cui si è detto), manon privo di importanza per la datazione delle strutture. È il caso, per esempio, diun AE 3 frammentato, rinvenuto nello strato direttamente inferiore al piano pavi-mentale in cocciopesto di uno degli ipocausti. Si tratta di un esemplare, emesso versola fine del IV secolo d.C., che, anche alla luce della ‘tosatura’, deve aver circolato perun lungo lasso di tempo, fino ad essere smarrito, con tutta probabilità, in un perio-do successivo alla metà del V secolo d.C., fungendo così da terminus post quem perl’impianto delle strutture soprastanti del “palazzo”. Fra gli altri esemplari venuti inluce si ricordano due AE 4, databili fra la fine del IV e gli inizi del V d.C., scopertinello strato di riempimento di una delle canalette del complesso27.
In riferimento alla sintassi architettonica del “quartiere termale” del “palazzo”,mi sembra palese che qualsiasi tentativo di rimandare a formule e reiterazioni dischemi, applicabili, per esempio, ai grandi complessi pubblici di uno o due secoliprima, sarebbe perlomeno forviante28. Tra l’altro, se prendiamo in esame esempi diIV secolo d.C. di ambito privato (bagni del Palazzo di Massenzio sul Palatino, bagnidella villa di Piazza Armerina29, bagni della villa di Löffelbach30), si può osservare
132
27 Si segnala, come anticipazione della campagna di scavo del 2003, un rinvenimento numismati-co di particolare interesse; si tratta, nella fattispecie, del ritrovamento di una moneta di bronzoda 20 nummi, emessa da Teoderico a Ravenna, agli inizi del VI secolo d.C. Tale scoperta, ovvia-mente, fornisce un’ulteriore conferma dell’orizzonte cronologico proposto per le fasi di costru-zione e di vita della grande residenza.
28 Basti pensare, per esempio, ai grandi impianti termali di età tardo imperiale, fra cui quello diDiocleziano a Roma, di Massimiano a Milano e di Costantino a Treviri.
29 NIELSEN 1990, p. 56.30 Si veda SCAGLIARINI CORLAITA 1995, pp. 861-864.
Ricerche nell’area della villa di Teoderico a Galeata
come questi rispetto agli impianti pubblici presentino caratteristiche di sperimen-tazione e una maggiore fantasia di soluzioni31, dando vita, in ultima analisi, ad unagamma di esempi finiti molto differenti fra loro, se non per alcuni particolari comu-ni, quali la presenza di grandi padiglioni ottagoni e la progressiva diminuzione,soprattutto in ambito occidentale, degli ambienti riscaldati a vantaggio di quellidestinati ad abluzioni in acqua fredda. Questo fenomeno, riscontrato evidentemen-te anche nel più tardo esemplare di Galeata, dove i vani riscaldati sono solo due,trova giustificazione nell’aumento esponenziale del prezzo della materia prima peril riscaldamento e nella difficoltà a reperirla32. Si tratta, in ogni caso, di una formulache trova puntuale applicazione non solo nei bagni delle residenze private, maanche negli impianti termali pubblici di tardo IV – inizio V secolo d.C., come vienedocumentato dalle terme di via della Foce ad Ostia e dai bagni della mansio diValentia in Puglia33.
In conclusione, come è stato già anticipato, il “quartiere termale” e le altre strut-ture precedentemente descritte, riemerse nel corso di queste ultime campagne discavo, costituiscono un insieme di tessere di un unico mosaico: una grande residen-za privata, di proporzioni molto superiori a quelle ipotizzate dagli archeologi tede-schi, voluta e costruita secondo un gusto che ancora ammicca all’architettura roma-na, ben lungi, quindi, da quelli che dovrebbero essere gli schemi di una presuntaarchitettura gota. L’aspetto sicuramente eccezionale che emerge dalle vestigia diquesto grande complesso è quello della cronologia, inquadrabile, ormai con unacerta sicurezza, fra la seconda metà del V e gli inizi del VI secolo d.C. Siamo di fron-te, quindi, ad uno dei più tardi esempi, almeno in ambito peninsulare, di quella cheè stata la tipologia delle grandi residenze private di età tardoantica; nello stessotempo, siamo in presenza di uno dei meglio conservati e più attendibili esempi diquella che viene comunemente definita “edilizia palaziale di età teodericiana”. Loschema planimetrico del c.d. “palazzo” di Teoderico, tuttora ampiamente incom-pleto, doveva prevedere, con tutta probabilità, una grande corte scoperta, che fun-geva da elemento di raccordo per una serie di settori o corpi, variamente articolati,fra cui quello termale, appena venuto in luce, e quello di rappresentanza, che siauspica possa riemergere nel corso delle prossime campagne di scavo. Nel settoremesso in luce dall’équipe di archeologi tedeschi nel 1942, che sembra congiungersial cortile tramite un lungo corridoio34, penso si debba riconoscere una serie di vanidi servizio o, comunque, un’area secondaria della grande abitazione. È precoce, allostato attuale delle ricerche, dire se si tratti di un complesso ricavato integralmentein un’unica fase o se il suo aspetto finale sia il risultato di trasformazioni e adatta-menti successivi. Se confrontiamo, poi, la planimetria, in progressivo sviluppo,della grande fabbrica galeatese con quella di altri impianti presumibilmente coevi,come la villa di Palazzolo o il c.d. “palazzo” di Teoderico a Ravenna35, appare evi-dente come non siano molti gli elementi in comune. Allo stesso tempo, per adesso,il complesso di Galeata dimostra di dividere poche soluzioni anche con le grandiresidenze a peristilio di età tardoantica. Forse una certa similitudine, se non altroper l’articolazione dei vari settori architettonici, si può riscontrare con la già citatavilla di Löffelbach nel Noricum. L’attuale incompletezza della planimetria del nostro“palazzo”, tuttavia, costringe ad attendere i dati delle prossime campagne di scavoper una definitiva e più realistica analisi d’insieme. Semplicemente per non incor-rere, anche questa volta, negli errori prodotti poco più di una sessantina di anni fa.
133
31 Si veda NIELSEN 1990, p. 56.32 In sintesi, sul problema, si veda: NIELSEN 1990, p. 59. Sui bagni tardoantichi e di età bizantina,
si veda, YEGÜL 1992, pp. 314-323.33 Si veda, in sintesi NIELSEN 1990, pp. 55-57.34 Identificato dagli archeologi tedeschi come stalle o carceri.35 Sulla villa di Palazzolo e sul c.d. “palazzo” di Teoderico a Ravenna rimando, in sintesi e con
bibliografia precedente, ad ORTALLI 1991, pp. 170-177 e a BALDINI LIPPOLIS 1999, pp. 169-176.
Il complesso “palaziale”: i nuovi scavi
BIBlIografIa
BALDINI LIPPOLIS 1999 = I. BALDINI LIPPOLIS, Edilizia palaziale “teodericiana”:considerazioni sulle sedi del potere in Romagna tra tardoantico ed altomedioevo, in«Archeologia dell’Emilia Romagna» II/1, 1988, pp. 165-190.
BOLZANI 1994 = P. BOLZANI, Teodorico e Galeata. Un’antologia critica, Ravenna1994.
CAGIANO DE AZEVEDO 1966 = M. CAGIANO DE AZEVEDO, Ville rustiche tardoan-tiche e installazioni agricole altomedievali, in Agricoltura e mondo rurale in Occidente,Settimana di Studi del Centro Italiano di Studi sull’alto medioevo, XIII, Spoleto1966, pp. 663-694.
DEICHMANN 1989 = F. W. DEICHMANN, Der “Palast” von Galeata, in Geschichte,Topographie, Kunst und Kultur in Ravenna. Hauptstadt des Spätantiken Abendlandes,Band II, Stuttgart 1989, pp. 267-272.
FUCHS 1942 = S. FUCHS, Galeata. Vorläufiger Bericht, in «AA» IV, 1942, pp. 259-277.GIULIANI 2000 = C. F. GIULIANI, L’edilizia nell’antichità, Urbino 2000.HUDECZEK-KAINZ 1994 = E. HUDECZEK-I. KAINZ, Die Villa von Löffelbach in der
Steiermark. Neue Forschungsergebnisse, in «Bálacai Közlemények» III, 1994, pp. 265-269.IACOPI 1943 = G. IACOPI, Galeata (Forlì) - Scavi in località Saetta, in «NSc»
1943, pp. 204-212.KRISCHEN 1943 = F. KRISCHEN, Der Theoderic Palast bei Galeata, in «JdI» LVIII
1943, pp. 459-472.MEILSCH 1990 = H. MIELSCH, La villa romana, Firenze 1990.MONNERET DE VILLARD 1952 = U. MONNERET DE VILLARD, Sul Palazzo di
Theoderico a Galeata, in «Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei» s. VIII, CCCX-LIX, 1952, pp. 26-32.
NIELSEN 1990 = I. NIELSEN, Thermae and Balnea. The Architecture and CulturalHistory of Roman Public Baths, I-II, Aarhus 1990.
ORTALLI 1991 = J. ORTALLI, L’edilizia abitativa, in A. CARILE (a c.), Storia diRavenna. Dall’età bizantina all’età ottoniana, II, Venezia 1991, pp. 167-192.
SCAGLIARINI CORLAITA 1995 = D. SCAGLIARINI CORLAITA, Gli ambienti poligona-li nell’architettura residenziale tardoantica, in «Corso di Cultura sull’Arte Ravennate eBizantina» XLII, 1995, pp. 837-873.
TÒTH 1978-1979 = E. TÒTH, Über einen spätantiken Prunksaaltyp, in «SchildStei»15/16, 1978-1979, pp. 189-195.
YEGÜL 1992 = K. F. YEGÜL, Baths and Bathing in Classical Antiquity, Cambridge1992.
134
Ricerche nell’area della villa di Teoderico a Galeata