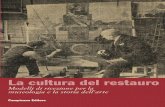Tommaso Garelli nel Rinascimento bolognese in "Nuovi Studi"
Transcript of Tommaso Garelli nel Rinascimento bolognese in "Nuovi Studi"
REDAZIONE
ANDREA BACCHI DANIELE BENATI ANDREA DE MARCHI FRANCESCO FRANGI
GIANCARLO GENTILINI ALESSANDRO MORANDOTTI
Si ringrazia Milvia Bollati per l’aiuto nella redazione di questo volume
COMITATO CONSULTIVO INTERNAZIONALE
KEITH CHRISTIANSEN EVERETT FAHY MICHEL LACLOTTE JENNIFER MONTAGU
MAURO NATALE SERENA ROMANO ERICH SCHLEIER ANNE MARKHAM SCHULZ
TABULA GRATULATORIA
Adolfo Ambrosetti Silvana Bareggi Antonio Barletta Ezio BenappiEdoardo Bosoni Luigi Buttazzoni e Roeland Kollewijn Maurizio Canesso
Carlo Cavalleri Giancarlo e Andrea Ciaroni Ferdinando ColomboGiovanni Cova Minotti Fabio De Michele Gerolamo Etro Gianni e Cristina Fava
Richard Feigen Paola Ferrari Enrico Frascione con Federico e Sasha Gandolfi Vannini Marco Galliani, Profilati spa Luigi Gambaro Matteo Lampertico Silvano Lodi jr.
Mario, Ruggero e Marco Longari Jacopo Lorenzelli Silvio Maraz Sascha Mehringer Alfredo e Fabrizio Moretti Gianna Nunziati Carlo Orsi Walter Padovani
Andreas Pittas Huberto Poletti Luca e Patrizia Pozzi Davide Sada Alvaro Saieh Simonpietro Salini Giovanni Sarti Tiziana Sassoli
Pier Francesco Savelli Mario Scaglia, Sit spa Bruno Scardeoni Rob e Paul Smeets Edoardo Testori Marco Voena
Si ringrazia per il sostegnoIntesa San Paolo
© 2012 TIPOGRAFIA EDITRICE TEMI S.A.S. - Tutti i diritti riservatiDirettore responsabile: Luca Bacchi
Registrazione nr. 912 presso il Tribunale di TrentoPubblicazione annuale. Euro 60,00
Progetto grafico: Paolo Fiumi e Gabriele Weber. Realizzazione a cura della redazioneSelezioni colore e bicromia: Tipolitografia TEMI - Trento
Redazione: 20121 Milano - Via Fatebenefratelli, 5 - Tel. e Fax 02/6599508Distribuzione e abbonamenti: Libro Co. Italia, 50026 San Casciano V.P. (Firenze)
Tel. 055/8228461 Fax 055/8228462 e-mail: [email protected] 978-88-97372-32-5
INDICE
5LAURA CAVAZZINI
Per il Maestro di Pizzighettone
11CLAUDIO BISMARA
Pisanello, Pietro da Sacco, due mappae mundi e una ecclesiola di legno a Verona nel 1430
37LORENZO SBARAGLIO
Una terracotta riscoperta di Donatello: la Madonna della tomba di Giuliano Davanzati
in Santa Trinita
83GIACOMO A. CALOGERO
Tommaso Garelli nel Rinascimento bolognese
101LORENZO PRINCIPI
Il Sant’Egidio di Orte: aperture per Saturnino Gatti scultore
129PAOLO ERVAS
Un’aggiunta a Girolamo da Treviso il vecchio
133DAVID LUCIDI
Zaccaria Zacchi volterrano: una nota sulla formazione e qualche aggiunta
al catalogo dello scultore
167ALESSANDRA GIANNOTTI
Tribolo giovane e le figure ‘meravigliose’ di San Petronio
185PATRIZIA TOSINI
Due affreschi riscoperti dal Palazzo alle Terme di villa Peretti Montalto
e una ricostruzione del Salone sistino
196MARCO FRANZONE
Tanzio da Varallo a Napoli: una nuova testimonianza
199LUCIA SIMONATO
Gaspare Morone, Girolamo Lucenti, Domenico Guidi
e la Tomba di Pietro Martire Neri in Santa Maria del Suffragio a Roma
229ALESSANDRO MORANDOTTI
Pittori della realtà nella Lombardia di Giacomo Ceruti:
quesiti intorno a Pietro Bellotti e a Sebastiano Giuliense, il Sebastianone
243MARCO RICCOMINI Quadri in Caucaso
245ABSTRACTS
GIACOMO A. CALOGERO
TOMMASO GARELLI NEL RINASCIMENTO BOLOGNESE
Tra i molti pittori documentati a Bologna nella seconda metà del Quattrocento spicca, per quantità e rilevanza di attestazioni, la figura di Tommaso di Alberto Garelli. Anche se del tutto sconosciuto alla letteratura antica, numerose sono le tracce documentarie in cui compare il suo nome, disseminate entro un arco di tempo che si protrae dal 1450 al 1495: un lungo periodo in cui Garelli ricoprì svariate cariche istituzionali, ottenne importanti commissioni, operando talora in stretta connessione con eminenti personaggi pubblici, nonché con alcuni dei prota-gonisti dell’incipiente rinascimento artistico felsineo 1. A dispetto di ciò, ancora all’inizio del secolo scorso la personalità del pittore costituiva una sorta di nomen nudum, privo di opere e noto solamente ai frequentatori degli archivi bolognesi. Il presente articolo, che ruota attorno ai fraintendimenti determinati dalla cronologia delle sue opere e dunque al ruolo che va rico-nosciuto alla sua esperienza, deve partire da questa constatazione e non può di conseguenza prescindere da un riesame della vicenda critica che riguarda il pittore.
Il primo tentativo di restituire qualche testimonianza materiale che ridesse corpo alla personalità di Garelli si deve a Francesco Filippini, che nel 1914 tentò di identificarlo con l’autore della pala con il Martirio di San Sebastiano della cappella Vaselli in San Petronio, in virtù del semplice fatto che nel 1489 il pittore figurava tra i testimoni citati nel documento di concessione del patronato della medesima cappella a Donato Vaselli 2. Pochi anni dopo sa-rebbe stato tuttavia lo stesso studioso a far cadere questa sua prima ipotesi, allorché nel 1922 preferì riconoscere quale prova più plausibile della documentata attività del pittore un altro dipinto conservato in San Petronio, ossia il polittico quattrocentesco posto nella cappella di Santa Brigida 3. L’ancona, proveniente dal museo della basilica, era stata collocata all’interno della cappella solo nel 1904, con una significativa attribuzione a Marco Zoppo 4. Filippini proponeva dunque di collegare il dipinto ad alcuni pagamenti in favore di Garelli registrati nell’estate del 1477 e relativi alla realizzazione di una tavola d’altare destinata a un’altra cap-pella petroniana, quella di Santa Barbara, il cui patronato spettava ai Sedici Riformatori dello Stato di Libertà 5, massimo organo istituzionale e decisionale della città. A riprova di tale identificazione, Filippini adduceva la presenza nella predella del polittico dei santi patroni cittadini e degli stemmi del Comune, ben confacenti a una commissione del reggimento bo-lognese. Anche la moderna collocazione del polittico nella cappella di Santa Brigida, dunque pur sempre all’interno della basilica, appariva agli occhi dello studioso un forte indizio per riconoscere quest’ultimo nella “tavola de l’altare de la chapella dei Signori XVI “, per “me-tere in hovera” la quale il 18 agosto del 1477 Garelli aveva ricevuto 250 pezzi d’oro e “oncia 6 d’azuro de lamagna” 6. In ultimo, Filippini aggiungeva che nel polittico “v’è l’immagine di Santa Barbara, perché la tavola doveva andare sopra l’altare della cappella dei Sedici, dedica-ta a Santa Barbara” 7. Bisogna subito precisare che quest’ultima notazione è del tutto errata, poiché nessuna delle figure che compaiono nel dipinto può in alcun modo corrispondere con quella della santa in questione 8. Al di là della svista, appare chiaro come lo stesso Filippini considerasse necessaria la presenza della figura di Santa Barbara ai fini dell’identificazione, giacché in diversi pagamenti registrati nel libro dei conti della Fabbriceria e certamente noti
95.
GIACOMO A. CALOGERO84
anche allo studioso, il dipinto commissionato a Garelli veniva esplicitamente definito come “la tavolla de Santa Barbara” 9.
Ad ogni modo, l’identificazione proposta da Filippini fu accettata senza remore da Guido Zucchini, che riconobbe la medesima mano in altri dipinti, tra i quali la tela della sala delle ri-unioni, o del Corporale, della Compagnia dei Lombardi a Bologna, in cui compare una scritta commemorativa datata 1466 e, soprattutto, il San Vincenzo Ferrer affrescato sulla faccia setten-trionale del quarto pilone orientale di San Petronio, sotto il quale è in effetti ancora leggibile il nome del pittore e una data parzialmente lacunosa che, grazie a una nota ottocentesca redatta da Gaetano Giordani e rintracciata dallo stesso Zucchini, è possibile integrare come 1467 10. Va da sé che il collegamento tra il polittico petroniano e il San Vincenzo Ferrer risulta d’importanza decisiva, poiché proprio la firma apposta ai piedi del santo domenicano certifica l’assegnazione di entrambi i dipinti a Tommaso Garelli, che vi fa ricorso a tipologie assai simili.
Proprio in virtù della vicinanza stilistica con l’affresco firmato, anche Igino Benvenuto Su-pino accettò di fatto l’attribuzione a Garelli del polittico conservato nella cappella di Santa Bri-gida, avvertendo però che esso non andava confuso con quello “commesso nel 1477 al pittore medesimo per la cappella di Santa Barbara o dei Sedici, del quale non si conosce la sorte” 11, ma piuttosto identificato con un altro, originariamente “dipinto per la cappella degli Anziani di Palazzo, passato di lì al Museo Civico” e da qui in San Petronio. Con ogni evidenza, Supino traeva quest’ultima informazione da una delle note apposte all’edizione del 1841 della Felsina pittrice di Carlo Cesare Malvasia, nella quale si legge: “Ho veduto la tavola antica che era nella cappella degli Anziani trasportata in S. Petronio nella cappella di Santa Barbara dipinta del 1457 da un Toma..o, come vi sta scritto sotto” 12. La nota è accompagnata dalla sigla “M.”, con la quale i curatori dell’edizione ottocentesca marcarono le postille riferibili allo stesso canonico bolognese. La nuova proposta di identificazione si sposava d’altronde bene con la presenza nel polittico superstite dei santi patroni di Bologna e degli stemmi civici, senza cozzare però con l’assenza di Santa Barbara, che risulterebbe invece alquanto inconsueta qualora se ne suppo-nesse l’identificazione con la tavola destinata all’altare petroniano dedicato alla santa. A sfavore dell’ipotesi di Supino si potrebbe obiettare che nel polittico oggi noto non è più visibile l’iscri-zione riportata da Malvasia: un dato che però non risulta decisivo, visto che, per citare un caso analogo, lo stesso avviene nel polittico di Sant’Elena di Michele di Matteo (Venezia, Gallerie dell’Accademia), nel quale non si legge più la firma riportata dagli studiosi ottocenteschi 13. Bisognerebbe dunque immaginare che la scritta, riferita in modo lacunoso già da Malvasia, si sia nel frattempo del tutto cancellata; a meno di non pensare, com’è pure plausibile, che fosse tracciata sulla “capsa” originale che conteneva il polittico, oggi sostituita da un rifacimento di primo Novecento 14. Risulta comunque interessante notare che la proposta di Supino venne in seguito accolta dallo stesso Zucchini, che nella sua Guida della Basilica di San Petronio del 1953 rettificava la provenienza del polittico, indicandone l’originaria collocazione all’interno del Palazzo comunale 15. Perfino nel regesto documentario compilato da Filippini e Zucchini si ritrova, tra i fatti documentati della vita di Garelli, la realizzazione nel 1457 di un “polittico (Madonna e Santi) già nella cappella degli Anziani, poi (1685) in quella di S. Barbara in S. Pe-tronio” 16.
Nel 1970 Wanda Bergamini, scrivendo un articolo in cui rendeva note nuove aggiunte al
94.116.
95.
TOMMASO GARELLI 85
catalogo di Garelli suggeritele da Carlo Volpe 17, recuperava tuttavia, nonostante la vistosa retromarcia degli stessi, la primitiva ipotesi di Filippini e Zucchini. Liquidando la nota di Mal-vasia come una sua pura invenzione 18 ed eludendo il problema dell’assenza della figura di Santa Barbara, la Bergamini proponeva dunque di identificare il polittico della cappella di Santa Bri-gida con la commissione ottenuta da Garelli in San Petronio nel 1477. Tale presa di posizione nasceva di fatto dal problema posto dal dipinto della Compagnia dei Lombardi, che imponeva, agli occhi della studiosa, di datare il più moderno polittico petroniano a una data fatalmente successiva al 1466 della tela e quindi non certo al 1457 riportato dal canonico. Il grado ancora aurorale delle conoscenze sul pittore e, nel complesso, sul panorama artistico bolognese di que-gli anni, rendeva in effetti legittima una posizione improntata a una certa prudenza.
La questione relativa al catalogo di Garelli avrebbe però conosciuto di lì a poco una svolta inaspettata. Nel 1978 Luciano Bellosi proponeva infatti di accostare ad alcune tavole con pic-cole figure di Santi conservate nel Museo di Santo Stefano a Bologna, che la Bergamini aveva pubblicato sotto il nome di Garelli, una serie di fogli conservati nel Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi, contenenti, accanto a schizzi di fantasia, precisi appunti dalle porte do-natelliane della Sagrestia vecchia di San Lorenzo e, forse, dal perduto affresco della Sacra di Masaccio al Carmine di Firenze 19. Si tratta di testimonianze grafiche di eccezionale rilievo, che fino a quel momento avevano vissuto una vicenda critica del tutto estranea a quella, ben più limitata e locale, che aveva fin lì coinvolto la figura del pittore bolognese. Dopo che, nelle prime due edizioni dei suoi Drawings of the Florentine Painters, Bernard Berenson aveva menzionato il taccuino indirizzandolo verso la cerchia di Andrea del Castagno 20, nel 1940 Roberto Longhi gli aveva addirittura dedicato un bellissimo saggio, il cui titolo, Genio degli anonimi 21, costitu-iva una non troppo velata provocazione nei confronti del collega, che aveva relegato una testo tanto straordinario nell’oscuro alveo della cerchia castagnesca. La proposta di Longhi in favore di Giovanni di Piamonte, seguace e collaboratore di Piero della Francesca ad Arezzo, avrebbe altresì suscitato la replica del vecchio Berenson, che in un intervento successivo rilancerà a sua volta il nome di Giovanni di Francesco, un artista che egli considerava un tipico seguace del Castagno 22.
La tesi di Bellosi si basava su premesse diverse, nel momento in cui non si limitava a svin-colare i disegni degli Uffizi dal consueto riferimento all’ambito toscano, ma addirittura li avvi-cinava a una personalità poco nota come Garelli. Alla base dell’intuizione si poneva in realtà uno spunto offerto da Eberhard Ruhmer che, nel suo libro altrimenti deludente su Marco Ruggeri, aveva ravvisato nei disegni degli Uffizi “i precorrimenti dell’arte grafica sempre più sfrenata dello Zoppo” 23: una indicazione che certo servì da stimolo a Bellosi per rintracciare un “preciso aggancio ad un’opera pittorica bolognese” della cerchia dello Zoppo, ossia i già citati Santini del Museo di Santo Stefano, attribuiti a Garelli da Carlo Volpe. Risulta d’altronde che quest’ultimo fosse giunto indipendentemente alla stessa conclusione, tanto da poterla rilancia-re, tirando fuori dal cilindro del conoscitore una nuova attribuzione a Garelli, ossia la tavola con San Paolo e San Giovanni battista già in collezione Platt a Englewood e oggi nella collezione Alana di Newark (Delaware) 24. Oltre a fornire nuovi puntuali agganci tra il corpus di Garelli e il taccuino, tale dipinto rende in effetti più plausibile, con la sua tenuta stilistica certo maggiore rispetto a qualunque altro numero del catalogo del pittore, un riferimento all’autore dei fogli
108.112.
101, 103.105, 109.111.
114.
GIACOMO A. CALOGERO86
fiorentini. Sarà inoltre interessante notare come il collegamento fra i disegni e la tavola ex Platt fosse stato già proposto, in tempi non sospetti, dallo stesso Berenson, sotto il nome, appunto, di Giovanni di Francesco 25. Il fatto che tre conoscitori del calibro di Berenson, Volpe e Bellosi abbiano individuato autonomamente gli stretti legami fra i fogli degli Uffizi e alcuni dipinti confluiti nel catalogo di Garelli conferisce in un certo senso una maggiore autorità all’attribu-zione dei disegni al pittore bolognese. Non a caso, essa è stata accolta quasi all’unanimità dagli studiosi che in seguito si sono occupati del problema.
Dopo l’intervento di Bellosi, il dibattito critico è sembrato piuttosto focalizzarsi sulla cro-nologia del taccuino degli Uffizi, in genere collocata entro gli anni cinquanta del Quattro-cento. A riaprire la questione è stato Daniele Benati, che nel 1984 ha proposto di utilizzare in questo senso la data 1467 che compare nella scritta sul margine superiore di uno dei fogli fiorentini 26, da sempre stata nota agli studi ma mai presa in considerazione, visto che già Longhi l’aveva considerata “un’aggiunta più tarda” 27. In effetti, la data 1467 appare in calce a un appunto di natura squisitamente privata, il cui autore annota di dovere del denaro a un certo Geronimo Turco 28 e non costituisce necessariamente un riferimento deci-sivo per la datazione dei disegni. Nel nuovo quadrante cronologico imposto dall’attribuzione del taccuino a Garelli, Benati considerava invece la data 1467 come uno spartiacque tra la fase ancora gotica attestata dalla tela dei Lombardi del 1466 e il rinnovamento in senso rinascimen-tale documentato dal San Vincenzo Ferrer, datato in quello stesso anno, pensando che proprio gli studi condotti su Donatello e su Masaccio in esso contenuti avessero consentito all’artista di cambiare decisamente rotta.
Tale soluzione, per molti versi ragionevole, pone però innegabili problemi. Se appariva in-fatti già difficoltoso il confronto istituito fin dai tempi di Zucchini fra la tela dei Lombardi e il San Vincenzo Ferrer, ancor più arduo è immaginare che un solo anno si frapponga tra la tela e il taccuino degli Uffizi, nel quale compaiono alcuni fogli che in passato hanno retto, per la vigoria espressiva e la forza incisiva del segno, un’attribuzione alla cerchia fiorentina di Donatello 29. In questo senso si spiega forse la recente proposta di Teresa D’Urso, che preferisce dirottare gran parte della serie fiorentina in direzione della bottega modenese degli Erri 30. D’altra parte la tela dei Lombardi, oltre a creare, con la sua data 1466, problemi apparentemente insormon-tabili per la cronologia interna del catalogo di Garelli, sembra stonare anche in relazione al più ampio contesto artistico bolognese del settimo decennio: un panorama non certo univoco e in cui formulazioni di assoluta avanguardia come quelle di Marco Zoppo e Francesco del Cossa potevano anzi convivere con soluzioni certamente più conservatrici, ma entro il quale il suo autore avrebbe finito col giocare un ruolo di irrimediabile retroguardia, paragonabile solo agli stentati esiti del vecchissimo Michele di Matteo, malinconico e decadente alfiere di un mondo ormai tramontato. Ben più aggiornati si dimostrano infatti gli esiti raggiunti da Cristoforo di Be-nedetto, un pittore non certo di prim’ordine ma della stessa generazione di Garelli, nel trittico Zambeccari (Bologna, Pinacoteca nazionale, inv. 237) 31.
Uno studio ravvicinato della tela, reso possibile dalla temporanea rimozione dalla sua con-sueta collocazione entro una teca posta sopra l’alto banco degli Ufficiali, mi ha consentito di dirimere la questione, giacché ho potuto verificare come la scritta che ricorre nella parte supe-riore sia certamente frutto di una stesura successiva. Essa è infatti vergata su una banda di co-
105.
94.116.103.
TOMMASO GARELLI 87
lore scuro, sovrapposta all’originaria cornice dipinta che inquadra la scena e che risulta ancora visibile sugli altri tre lati del dipinto. Nell’angolo superiore a sinistra la fascia sembra addirittura nascondere una scritta sottostante, anche se potrebbe trattarsi più semplicemente della deco-razione dorata che in effetti prosegue lungo gli altri lati della cornice. Persino gli stemmi della Compagnia dipinti negli angoli inferiori, lasciano trasparire, anche ad occhio nudo, la sotto-stante fascia decorata e sembrano dunque frutto di un intervento posteriore 32.
La possibilità di sganciare la tela dal presunto vincolo del 1466 permette di tentarne una nuova collocazione cronologica, più consona ai precipui dati di stile in essa espressi. Il dipinto si legge infatti quale testimonianza diretta della prima formazione del pittore, che quasi cer-tamente dovette svolgersi nel corso del quinto decennio del Quattrocento e dunque nel solco tracciato dai grandi protagonisti del tardogotico locale 33. Un certo ispessimento volumetrico dei panneggi, a suo tempo già decifrato da Benati in termini schiettamente vivariniani 34, sembra altresì spingere la datazione del dipinto oltre la soglia del 1450, anno in cui fu collocato sull’al-tare maggiore della chiesa della Certosa di Bologna il grande polittico eseguito da Antonio e Bartolomeo Vivarini 35. Non è difficile immaginare la reazione suscitata, nell’attardato milieu artistico bolognese, dall’arrivo in città di una macchina d’altare tanto complessa e monumen-tale, il cui prestigio era assicurato dalla dedicazione papale in memoria del cardinale Nicolò Albergati. È perciò da credere che il giovane Garelli, già documentato proprio a partire dal 1450, non restasse insensibile al sottile compromesso proposto dalla bottega muranese fra un sempre vivo gusto esornativo e le novità padovane, che fornivano di fatto un primo appiglio al rinnovamento dell’ormai logora tradizione locale. Nonostante l’uso abbondante degli ori, il rigoglio del prato fiorito, le fisionomie umorali e le pieghe ridondanti dei panneggi, ancora ben confrontabili con quelle dell’ultimo Giovanni da Modena, nella tela dei Lombardi si coglie di fatto una insorgente attenzione plastica e l’esito finale sembra perciò rientrare a buon diritto nel ricco filone del ‘Rinascimento umbratile’ settentrionale.
Se si accetta la nuova cronologia del dipinto dei Lombardi ai primi anni cinquanta, diventa possibile ridiscutere anche l’informazione relativa al polittico della cappella di Santa Brigida contenuta nell’edizione della Felsina pittrice del 1841, che, come detto, ne tramanderebbe una datazione al 1457. Ricerche svolte presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna mi hanno del resto consentito di rintracciare l’appunto autografo di Malvasia dal quale i redat-tori ottocenteschi trassero l’aggiunta in questione. Si tratta di una delle quarantasette schede autografe superstiti che il canonico bolognese aveva redatto in vista di una riedizione aggiorna-ta, ma mai giunta in porto, della sua Felsina pittrice del 1678. Il contenuto integrale della nota stilata da Malvasia è il seguente: “Oggi 18 Luglio 1685 ho veduto la Immagine di M. V. dipinta sul muro detta del Terremoto dipinta a fresco, e a tempera sul muro della scuola del Franza ma non di Francesco certo, ma non di Giacomo più tosto di Giulio detto Chiodarolo o simili segato il muro ho veduto io lavorata e portata nella cappella degli Anziani. Ho veduto la tavola che vi era antica trasportata in S. Petronio nella cappella di S. Barbara, dipinta del 1457 da un Toma..o come vi sta scritto sotto” 36.
In primo luogo, il ritrovamento conferma l’autenticità della fonte utilizzata dai redattori ot-tocenteschi della Felsina. Non sembra poi ragionevole metterne in dubbio l’attendibilità, poiché non si vede per quale ragione, in un appunto privato, Malvasia avrebbe dovuto arbitrariamente
94.
95.
GIACOMO A. CALOGERO88
falsificare una scritta che dice di leggere “sotto” il polittico: lo scrupolo con cui il canonico ri-porta la firma forse ormai stinta del pittore (“dipinta del 1457 da un Toma..o come vi sta scritto sotto”) dimostra che egli si limitò a trascrivere la scritta così come appariva. L’informazione che egli ci fornisce è poi troppo circostanziata per essere messa in discussione: Malvasia non solo segnala il trasporto dell’antico polittico dal Palazzo comunale in San Petronio, ma ne specifica la data esatta e il motivo per cui fu deciso, elementi che sembrano conferire un alto grado di credibilità alla sua testimonianza 37.
Ulteriori ricerche mi hanno inoltre permesso di rintracciare decisivi indizi che consentono di identificare la tavola vista da Malvasia nella cappella degli Anziani in Palazzo comunale con il polittico oggi conservato nella cappella di Santa Brigida. Nella terza edizione delle Pitture di Bologna, curata e pubblicata da Giampietro Zanotti nel 1732, viene infatti citata, all’interno della cappella di Santa Barbara in San Petronio, una “Madonna sotto con Santi a Caselle dorate” 38. Quest’ultima dovette però essere rimossa prima del 1755, poiché nella quarta edizione delle Pitture, non è più menzionata fra le opere conservate all’interno della cappella. Un’indicazione preziosa è in questo caso contenuta nelle Notizie de’ Professori del Disegno di Marcello Oretti, in cui si ritrova un passo dedicato a un “Tomaso Pittore [che] fiorì nel 1457”: Oretti specifica che “di questo artefice vi è una tavola dipinta che era nella Cap-pella di S.a Barbara in San Petronio con il nome sud.o e l’anno 1457” 39. Di seguito, l’erudito segnala che il dipinto si trovava ormai “nella stanza che abita il predicatore di d.a Chiesa in tempo della Quadragesima”, vale a dire in uno dei locali di pertinenza della Fabbriceria di San Petronio 40, e aggiunge che essa è citata “nella aggiunta della Felsina Pittrice Mss. del Malva-sia pag. 41”, riferendosi ovviamente alla nota autografa di Malvasia di cui si è fatto cenno sopra 41. Il fatto che Oretti precisi che la tavola depositata nella stanza del predicatore, ossia nei locali della Fabbriceria, sia la stessa di cui Malvasia aveva segnalato il trasporto dal Palazzo comunale nella cappella di Santa Barbara, costituisce dunque un ulteriore indizio a favore dell’identificazione del-la tavola in questione con il polittico oggi conservato in San Petronio 42. È infatti proprio dai locali della Fabbriceria che il dipinto è pervenuto alla sua attuale collocazione. In quest’ultima sede il polittico fu infatti custodito, e quasi dimenticato, fino al 1881, quando fu appunto riscoperto e richiesto in deposito dalla direzione del Museo civico di Bologna appena inaugurato 43. In quella sede il dipinto fu notato da Corrado Ricci, che lo attribuiva a Marco Zoppo 44 e da Adolfo Venturi, che preferiva riferirlo invece a Michele di Matteo 45. La permanenza presso il Museo civico fu comunque di breve durata, poiché il polittico venne riconsegnato alla Fabbriceria nel 1891 46, per essere esposto nel museo della basilica, inaugurato due anni dopo 47. Nel 1904 il dipinto, ormai considerato opera di Zoppo, fu infine trasferito all’interno della cappella di Santa Brigi-da, da poco riallestita.
Insieme alla destinazione originaria, le fonti fin qui ripercorse consentono dunque di rista-bilire la corretta datazione del polittico di Garelli ora in San Petronio, retrodatandola al 1457. Esistono però altre buone ragioni, di natura prettamente stilistica, che confermano l’ipotesi, recentemente avanzata anche da Miklós Boskovits 48. Numerosi sono ad esempio i rimandi alla lunga stagione del tardogotico bolognese che vi si possono cogliere, ad esempio nello spiccato gusto per le decorazioni preziose: si notino l’elaborata lavorazione delle aureole, il frequente
TOMMASO GARELLI 89
ricorso alle applicazioni metalliche (per la spada di San Paolo, le chiavi di San Pietro, i bordi del manto della Vergine) e le preziose striature dorate che screziano a mo’ di agemina il panneggio del San Pietro. Il motivo floreale della ricca veste damascata della Vergine sembra ricavato da uno specifico modello locale, la Madonna con il Bambino di Michele di Matteo già in collezione Gozzadini 49. Anche la foggia della carpenteria è praticamente identica a quella del polittico fir-mato nel 1462 dallo stesso Michele (Bologna, Pinacoteca nazionale, n. 247) 50, mentre non può in alcun modo essere paragonata alle più evolute elaborazioni prodotte dai maestri intagliatori attivi a Bologna nel corso degli anni settanta. Non meno evidenti appaiono infine i riflessi del grande Giovanni da Modena, tanto a livello tipologico, ad esempio nella Vergine al centro o nel San Pietro al suo fianco, quanto pittorico, se è vero che in talune figure, come quella del Cristo passo, il modellato “si ispessisce entro un contorno che sembra quasi recuperare qualcosa dell’asprezza di Jacopo di Paolo e di Giovanni da Modena” 51. Il permanere di questi forti legami con la tradizione tardogotica locale non sorprende di certo alla data 1457, allorché, morto da poco Giovanni, sono ancora attivi pittori come Michele di Matteo o Pietro di Gio-vanni Lianori 52; ma a favore della data 1457 letta da Malvasia si esprimono anche gli accenti più moderni, che pure vi si colgono. Esistono in effetti significative analogie fra il putto tenuto tra le braccia della Vergine dipinta da Garelli e il Bambino paffuto che occhieggia nella tavola conservata nel Museo Ala Ponzone di Cremona, appartenente al gruppo di Madonne “dal sor-riso eginetico” raccolto da Venturi 53, il cui linguaggio rinvia ancora “a soluzioni tardogotiche sul tipo di quelle adottate da Giovanni da Modena” (Benati), riviste però alla luce della lezione padovana di Donatello, così da costituire un interessante parallelo con gli esiti espressi da Ga-relli. Se il Maestro degli occhi ammiccanti potesse davvero identificarsi con Galasso di Matteo Piva 54, il confronto qui proposto apparirebbe ben più che una semplice suggestione, in virtù del documentato soggiorno del pittore ferrarese a Bologna nel 1455.
Entro un quadrante cronologico che s’incentra sulla data 1457, è possibile poi richiamare la coeva produzione di Giovanni Francesco da Rimini, un artista certo presente a Bologna ben prima del 1459, quando risulta già impegnato insieme a Garelli nella decorazione della cappella di Santa Brigida in San Petronio e firma la Madonna con il Bambino del Museo di San Domenico, scomparto centrale di un importante polittico che doveva trovar luogo su un altare della stessa chiesa 55. L’arrivo a Bologna del pittore romagnolo, reduce dal soggiorno padovano protrattosi lungo il quinto decennio e dalle successive peregrinazioni fra Perugia e Firenze, non avrà mancato di interessare un pittore locale come il nostro, per il sagace compromesso da lui adottato fra un mai rinnegato sostrato tardogotico e i più moderni apporti di matrice tosco-padovana intercettati nel corso della sua carriera. Nel portare a termine il proprio polittico, Garelli sembra di fatto mutuare dal collega romagnolo più di uno spunto, come dimostra l’impostazione della Vergine dello scomparto centrale, che pare quasi ricalcare quella dell’analoga figura dipinta da Giovanni Francesco nel trittico della Galleria nazionale dell’Umbria, databile entro la prima metà degli anni cinquanta e a sua volta desunta dai più moderni prototipi della plastica toscana 56. Anche la solu-zione del basamento marmoreo bicromo che corre alle spalle delle figure del registro principale torna identica nelle opere del riminese databili entro la metà del sesto decennio, come il già citato trittico perugino o il San Vincenzo Ferrer dell’Accademia di Firenze. Si tratta di una soluzione decorativa di chiara ascendenza fiorentina, che Giovanni Francesco riproporrà spesso, in forme
99.
96.
98.
97.
GIACOMO A. CALOGERO90
variate, anche nelle proprie opere bolognesi, come la Madonna con il Bambino ora nella National Gallery di Londra, firmata e datata 1461, o quella più tarda di Lubiana. Gli espliciti riferimenti a quanto elaborato da Giovanni Francesco nel corso degli anni cinquanta sembrerebbero ancorare, una volta di più, il polittico di Garelli alla data 1457.
Le affinità riscontrabili fra il dipinto di Garelli e la coeva produzione del Maestro degli occhi ammiccanti e di Giovanni Francesco da Rimini possono d’altronde essere spiegate in virtù di una comune assimilazione del plasticismo donatelliano, calato però entro un paradigma lingui-stico sostanzialmente tradizionale. Nel caso di Garelli, sono soprattutto i panneggi, solcati da pieghe profonde, quasi vescicose, a denunciare l’adesione al moderno linguaggio di Donatello, attraverso una personale restituzione degli effetti di ‘panno bagnato’ perseguiti dallo scultore fiorentino. Un analogo approccio si riscontra d’altra parte nel già richiamato taccuino di di-segni degli Uffizi, che Bellosi aveva accostato ad un’altra opera pittorica di sicura autografia garelliana, ossia i Santini del Museo di Santo Stefano: di fatto lo stesso “sistema di panneggio assolutamente originale fatto di addentramenti allargati e appiattiti della stoffa, dove le pieghe diventano nervature staccate, quasi cordoni galleggianti” 57, si riscontra anche nel polittico di San Petronio, dove la veste arrovellata del San Giovanni battista può quasi sovrapporsi a quella delle due impressionanti figure ammantate del foglio 331 E. Allo stesso modo, la piega spira-liforme che ruota intorno al ginocchio del San Pietro richiama da vicino il movimento ondu-latorio delle pieghe che fasciano la gamba della figura schizzata sul recto del foglio 14498 F 58. Si tratta di rispondenze assai stringenti, che non solo confermano l’attribuzione a Garelli del taccuino, ma ne suggeriscono una peraltro ovvia funzione di repertorio 59.
La vicinanza fra il polittico di San Petronio (o meglio sarebbe dire a questo punto del Palaz-zo comunale), datato in origine 1457, e il taccuino degli Uffizi impone un ripensamento della cronologia di quest’ultimo, che già Fiora Bellini, certo su suggerimento di Bellosi, datava agli anni cinquanta 60. Assai significativa appare in questo senso la lettura proposta da Angelini, che vi rilevava la presenza di un “bizzarro compromesso tra i retaggi di un goticismo fantasioso ed astratto e adesione alla cultura fiorentina”, ben comprensibile in un pittore di estrazione padana e di esplicita formazione tardogotica, ma aggiornato “sui testi pittorici rinascimentali presenti a Bologna ma anche a Firenze” 61. Pur valorizzando la data 1467 inscritta sul margine di uno dei fogli, lo studioso notava inoltre analogie con i dipinti di pittori fiorentini quali Giovanni di Francesco o Giovanni di Piamonte - i nomi spesi da Berenson e Longhi - spiegandole in base alla comune dipendenza da Donatello. In tal modo, Angelini riscontrava di fatto nei fogli degli Uffizi un riflesso della specifica temperie culturale che caratterizza l’arte fiorentina nel corso del quinto e del sesto decennio del Quattrocento, il che sembrerebbe aggiungere un ulteriore argomento in favore della datazione qui riproposta. Le numerose citazioni letterali di opere del primo rinascimento toscano, da Donatello a Masaccio a Filippo Lippi, spingevano infine Ange-lini a confermare l’ipotesi di Benati circa un viaggio di Garelli a Firenze. Va altresì sottolineato come la repentina accelerazione in senso rinascimentale mostrata nel polittico si situi negli anni che vedono l’arrivo a Bologna non solo di Giovanni Francesco da Rimini ma con tutta probabi-lità anche di Marco Zoppo 62. I chiari riferimenti colti da Bellosi a un “donatellismo di probabile origine padovana” costituiscono un dato di stile che a ben vedere si riscontra anche nel polittico oggi in San Petronio e che potrebbe dunque giustificarsi in relazione alla presenza del centese
107.
104.
108.
103.
95.
105.
100-101.106-107.
TOMMASO GARELLI 91
sulla scena artistica felsinea già intorno al 1456. Certo è che pochi anni più tardi lo Zoppo risul-terà impegnato, insieme allo stesso Garelli, a Giovanni Francesco da Rimini e al cremasco Ago-stino De Marchi, nella decorazione della cappella di Santa Brigida 63. Tale congiuntura, mai del tutto valorizzata, anche a causa della mancata realizzazione dell’impresa 64, è stata giustamente considerata da Giovanni Romano come “un inesplorato punto di incrocio tra squarcionismo e cultura pierfrancescana, nel decennio 1450-1460, sulle strade che uniscono Padova, Ferrara, Modena e Bologna” 65. In questa prospettiva, il polittico in San Petronio e il taccuino fiorentino potrebbero rappresentare dunque i primi riflessi su un artista locale di un insospettato snodo dell’arte bolognese, che fungerebbe da significativa premessa alle successive vicende del Rina-scimento bolognese. Che la presenza di Garelli nella compagine raccolta nel 1459 in vista della decorazione della cappella di Santa Brigida non fosse semplicemente occasionale è d’altronde dimostrato dagli stretti rapporti lavorativi e interpersonali che, proprio nel breve torno d’anni a cavallo tra il sesto e il settimo decennio, sembrano legare Garelli agli altri artisti documentati nell’impresa petroniana. Nel 1461, per esempio, Marco Zoppo risulta essere il padrino di batte-simo di Elena, figlia di Garelli 66: segno di un rapporto ormai consolidato, in virtù del quale nel 1463 il bolognese terrà a sua volta a battesimo Lucrezia, figlia dello Zoppo. Nello stesso anno Garelli dipinge sulla facciata del Palazzo comunale una “immagine de la nostra Madona” entro un tabernacolo ligneo realizzato da Agostino De Marchi 67. Il rapporto lavorativo con Giovanni Francesco da Rimini dovette essere poi ancor più duraturo, se alla morte di questi, avvenuta entro il 1470, Garelli vantava un credito nei suoi confronti di quattro ducati d’oro 68.
È perciò ragionevole pensare che questo nodo documentario testimoni, al di là di un in-contestabile rapporto lavorativo, una marcata affinità di intenti fra il bolognese e i suoi sodali; tanto più se si considera che l’interpretazione dei nuovi fatti culturali di matrice fiorentina e padovana proposti in questi anni a Bologna da Marco Zoppo e da Giovanni Francesco da Ri-mini permetteva di fatto a Garelli un ragionevole compromesso con la sua primitiva formazione tardogotica. Anche in questo senso sembrerebbe più opportuno ricondurre entro i termini marcati da questa precisa congiuntura le prove pittoriche in cui Garelli mostra di adottare, seppur parzialmente, i nuovi stilemi importati a Bologna dal riminese e, con più convinzione, dallo Zoppo. Si è già detto a proposito del taccuino e del polittico conservato nella cappella di Santa Brigida. A una data non troppo distante, probabilmente entro il 1460, potrebbe collo-carsi lo sciupato Battesimo di Cristo della Pinacoteca civica di Budrio, in cui l’insistita ricerca naturalistica di matrice tardogotica si sposa con i più moderni accenti di schietta matrice dona-telliana, evidenziati dalla resa tormentata del panneggio del Battista e dalla risentita anatomia del Cristo. Si tratta con ogni evidenza di una sovrapposizione di linguaggi eterogenei, analoga a quella già riscontrata nel polittico petroniano e ancora decifrabile nei termini del cosiddetto ‘Rinascimento umbratile’.
Un più deciso passo in avanti nel percorso evolutivo di Garelli è rappresentato dalla tavola con San Giovanni battista e San Paolo di recente pervenuta alla collezione Alana di Newark. Non vi sono dubbi sul fatto che la tavola fosse in origine lo scomparto di un polittico di pro-venienza al momento ignota, nei cui pilastri laterali dovevano figurare con ogni probabilità le tavolette conservate nel Museo di Santo Stefano a Bologna 69. Come già segnalava la Ber-gamini 70, i Santini stefaniani vanno intesi come precise citazioni delle analoghe figure dipinte
102.
114.
GIACOMO A. CALOGERO92
da Zoppo nei pilastri del polittico di San Clemente al Collegio di Spagna: in entrambi i casi le minuscole figure di santi alloggiano entro nicchie archiacute e poggiano su piedistalli circolari diversamente scorciati a seconda dell’altezza prevista per le varie tavolette. Al di là del mero rimando letterale, Garelli dimostra di aver acquisito una reale comprensione delle soluzioni prospettiche proposte dallo Zoppo, esperite ormai con consapevole coerenza fin nei più minuti dettagli, come le aureole metalliche scorciate che coronano le teste di alcune figure. A ben vedere, anche la tavola Alana mostra un’innegabile deferenza nei confronti del modello zoppe-sco: i due santi sono colti in una posa dialogante in tutto simile a quella dei laterali del trittico del Collegio di Spagna; inoltre, le due figure non sono più separate da gracili colonnine, come ancora avviene nel polittico petroniano, ma albergano sotto una doppia centina archiacuta 71. Alla più moderna scelta compositiva, di chiara ascendenza padovana, sembra corrispondere un evidente avanzamento stilistico che sembra deporre a favore della posteriorità del dipinto Alana e delle tavolette bolognesi rispetto al polittico ora nella cappella di Santa Brigida. I due Santi Alana s’impongono infatti con un’inedita forza plastico-volumetrica: le pose solenni e la solidità quasi statuaria delle figure, l’impressionante espansione dei volumi, perfettamente scanditi nello spazio, svelano come l’ispirazione di Garelli sia ormai indirizzata verso effetti di vera e propria monumentalità.
La dipendenza del polittico di Garelli, di cui facevano parte i Santini e la tavola Alana, dal polittico di San Clemente, dipinto dallo Zoppo intorno al 1460, sembrerebbe perciò suggerire una datazione entro la metà degli anni sessanta, quando i documentati legami tra i due pittori paiono assumere i caratteri di un vero e proprio sodalizio, oltre che di un’amicizia personale. La decisa progressione in senso rinascimentale esibita da Garelli in questi dipinti andrà dunque spiegata in relazione al decisivo influsso esercitato dallo Zoppo, che ora sembra quasi infiam-mare la già spiccata infatuazione donatelliana del bolognese. Gli spessi panneggi delle figure della tavola Alana sono infatti frammentati da infinite pieghe vischiose, che rivelano lo stesso tormento grafico già visibile nel polittico di San Petronio, esercitato però con ben maggiore co-erenza. Persino le tipologie rimandano al fervido immaginario di Donatello, che certo avrebbe apprezzato queste creature selvatiche, dalla capigliatura medusea: un’umanità caratterizzata da una rustica baldanza, in perfetta sintonia con la più fiera tradizione civica bolognese a cui sembrano uniformarsi le originalissime formulazioni locali del nuovo eloquio rinascimentale. Sorprendente appare poi la libertà con cui il pittore bolognese risolve i drappeggi dei Santini, in cui non a caso Bellosi rintracciava i più evidenti agganci con il taccuino degli Uffizi. Non meno convincenti appaiono però i legami, già segnalati da Benati, fra la tavola Alana e i disegni fiorentini, in particolare fra la figura di San Paolo e il personaggio ammantato che compare sul foglio 329 E.
Un’ulteriore prova della maturità espressiva raggiunta da Garelli nel corso degli anni ses-santa è costituita dal San Vincenzo Ferrer affrescato sul quarto pilastro orientale della navata centrale di San Petronio. Secondo quanto riportato da Gaetano Giordani, il dipinto recava la scritta, oggi parzialmente leggibile, “Thomas pinxit A. D. 1467” 72. La data sembra in effetti pertinente, poiché l’affresco appare assai prossimo al risultato conseguito da Garelli nella ta-vola Alana, collocabile intorno al 1465, ed anzi dà conto di un ulteriore salto di qualità per quanto riguarda la costruzione dello spazio. L’imponente figura, saldamente colonnare, è infatti
108.112.
114.113.
95.
115.
114.
109.110.
116.
TOMMASO GARELLI 93
inquadrata entro una gigantesca nicchia tridimensionale, che rivela un’inedita padronanza del meccanismo prospettico, sulla quale agiscono precisi ricordi toscani: come ha notato Minardi 73, il motivo della volta a conchiglia rimanda di fatto alla soluzione adottata da Paolo Uccello per allogare le figure di santi lungo il sottarco della cappella dell’Assunta nel Duomo di Prato. Avendo così impostato il problema della scatola spaziale destinata a contenere la figura, il pittore può avventurarsi in audaci virtuosismi, come quello del piede destro proteso al di fuori del basamento marmoreo 74. Se l’espressione stirata in una smorfia che connota il volto emaciato del domenicano sottintende una ricerca espressiva di tipo ancora tardogotico, l’energia fascian-te conferita alla vesti e l’ombra portata sul muro testimoniano ormai della decisa evoluzione del pittore in senso rinascimentale.
Il San Vincenzo dovette favorevolmente impressionare i Fabbricieri, tanto da convincerli ad assegnare allo stesso pittore numerosi altri lavori all’interno della basilica nel corso degli anni settanta 75. Nulla ci rimane però di questi ulteriori interventi e deve purtroppo ritenersi perduta la stessa tavola realizzata nel 1477 per la cappella dei Signori XVI, una commissione di grande prestigio che coronava nel migliore dei modi il decennale impegno del pittore al servizio della Fabbrica. Non siamo dunque in grado di dire se e come Garelli reagisse al modernissimo ca-polavoro di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti che dal 1473 rifulgeva all’interno dello stesso edificio sull’altare della cappella Griffoni. V’è da credere però che il “Masaccio” bolo-gnese non riuscisse stavolta ad accodarsi alla poderosa accelerazione impressa all’arte cittadina dai due grandi ferraresi. I tempi d’oro erano ormai lontani e, se il vecchio sodale Giovanni Francesco da Rimini era già morto nel 1470, lo stesso Zoppo, da tempo residente a Venezia, sarebbe scomparso di lì a poco. Privato dei suoi punti di riferimento e avviato verso un inevi-tabile declino, l’attività documentata di Garelli sembra diradarsi drasticamente dopo l’exploit dell’ultima commissione petroniana: un fatto che dovette creargli non pochi problemi di natura economica, spesso risolti grazie ai sussidi e alle elargizioni del Comune ottenuti in quanto “pic-tor pauper et vir bonus integer” 76.
Rispetto alla posizione di attesa circa l’effettivo ruolo svolto da Garelli nel Rinascimento bolognese mantenuta nel fondamentale saggio del 1958, nel cui solco si era sostanzialmente col-locato l’articolo della Bergamini, il giudizio di Volpe cambia radicalmente di segno nelle battute finali dell’intervento dedicato all’affresco di Paolo Uccello inaspettatamente ritrovato in San Martino, dove Garelli diviene un artista “fiorentineggiante”, tra i pochi in grado di rilanciare “temi e idee che Paolo Uccello aveva per tempo consegnato” all’ambiente artistico felsineo 77. Il riconoscimento del taccuino fiorentino e della tavola Alana dovevano aver di fatto convinto lo studioso circa la necessità di assegnare al pittore un ruolo protagonistico, fino ad allora in-sospettato. In modo non diverso, ma ancora più esplicito si sarebbe infine espresso Giovanni Agosti, secondo il quale l’attribuzione del taccuino degli Uffizi a Tommaso Garelli implica il riconoscimento di un suo “nuovo peso nelle vicende della pittura padana del terzo quarto del Quattrocento” 78.
Il percorso evolutivo del pittore, così come si è tentato di tracciare in questa sede, fornisce di fatto una nuova e forse più credibile conferma di tale “nuovo peso”, raggiunto attraverso una crescita sorprendente in cui i determinanti influssi del donatellismo padovano si coniugano con
GIACOMO A. CALOGERO94
spiccate inclinazioni filo-toscane. Il soggiorno a Firenze, determinato dalle curiosità culturali attivate dalla conoscenza di Marco Zoppo e Giovanni Francesco da Rimini e messo a frutto attraverso gli studi da Donatello e da Masaccio di cui è prova il taccuino degli Uffizi, sembra infatti consentire al pittore di superare con decisione gli stentati esordi in chiave tardogotica, testimoniati dalla tela dei Lombardi, per approdare a risultati decisamente più moderni. Rivi-sta sotto questa luce, la figura di Garelli diviene un’importante pietra di paragone dell’ormai avviato processo di aggiornamento della cultura pittorica bolognese, finalmente capace, grazie ai decisivi apporti esterni addensatisi tra sesto e settimo decennio, di scrollarsi di dosso l’in-gombrante peso di un’illustre ma ormai logora tradizione e di contribuire in maniera decisiva e originale allo sviluppo del Rinascimento padano.
* Questo articolo è il frutto delle ricerche svolte in occasione della mia tesi di laurea magistrale, discussa nel marzo del 2010. Devo dunque ringraziare in primo luogo il mio relatore, prof. Daniele Benati, senza la cui gui-da costante e affettuosa non sarei mai giunto ai risultati che qui presento. Di grande giovamento si sono poi rivela-ti i ripetuti confronti con Fabio Massaccesi, Massimo Medica e Mauro Minardi, e ancora gli amici Paolo Cova e Va-lerio Mosso. Sono poi grato all’ing. Piero Bullini e al consiglio della Compagnia dei Lombardi per avermi concesso di studiare da vicino la tela conservata nella sala del Corporale. La visione ravvicinata del dipinto, grazie alla quale ho potuto trarre informazioni decisive, non sarebbe stata così proficua senza i consigli di Pietro Antoni, Marco Pa-squalicchio e Camillo Tarozzi, che mi hanno accompagnato con entusiasmo e competenza durante i vari sopralluo-ghi. Devo ringraziare anche il prof. Giovanni Feo e il dott. Mario Fanti per avermi fornito preziose delucidazioni in merito all’iscrizione commemorativa riportata sulla tela. Non posso esimermi infine dal menzionare, per l’aiuto pa-ziente fornitomi nel corso della mia ricerca, il personale della Biblioteca del Dipartimento di Arti Visive di Bologna, dell’Archiginnasio e della Fondazione Zeri (in particolare Marcella Culatti, Davide Ravaioli, Elisabetta Sambo).
1 Per i documenti relativi a Tommaso Garelli, “dicto el principe” o anche “Masazo”: F. FILIPPINI - G. ZUCCHINI, Miniatori e pittori a Bologna. Documenti del sec. XV, Bologna 1968, pp. 158-165. Oltre il 1495 non si hanno più notizie del pittore, che evidentemente morì di lì a poco, e comunque entro il 1505, anno in cui un atto notarile cita come vedova la moglie Anastasia. Mettendo insieme questi dati è possibile ipotizzare una data di nascita non lontana dal 1430. Garelli ricoprì ripetutamente la carica di massaro delle Quattro Arti a partire dal 1455; nel 1465 assunse la carica di pittore ufficiale del Comune; nel 1882 fu eletto castellano della rocca di Castelfranco dai Sedici Riformatori di Bologna.
2 F. FILIPPINI, Ercole Grandi da Ferrara: pittore ed architetto del ‘400, Bologna 1914, p. 22.3 F. FILIPPINI, La cappella di Santa Brigida di Svezia in San Petronio, in ‘Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia
Patria per le Provincie di Romagna’, s. IV, XII, 1922, pp. 177-207, speciatim 184.4 Il trasferimento del polittico dal museo petroniano alla cappella avvenne in seguito al restauro e al riallestimento
di quest’ultima, operato nei primi anni del secolo scorso (F. CAVAZZA, Finestroni e cappelle in San Petronio di Bologna, in ‘Rassegna d’arte’, V, 11, 1905, pp. 161-166, speciatim 163).
5 Si tratta della decima cappella sul lato orientale, dedicata a Santa Barbara, fondata nel 1448 e concessa nel 1463 alla Magistratura dei Sedici Riformatori dello Stato di Libertà (A. GIACOMELLI, Corporazioni d’arte e famiglie cittadine in relazione con la basilica di San Petronio. Secoli XVI-XVIII, in Una basilica per una città. Sei secoli in San Petronio, a cura di M. Fanti - D. Lenzi, Bologna 1994, pp. 101-135, speciatim 127). Per i pagamenti a Garelli nell’estate del 1477 per la realizzazio-ne della tavola destinata all’altare: A. GATTI, L’ultima parola sul concetto architettonico di San Petronio, Bologna 1914, p. 83, doc. 240; I. B. SUPINO, L’arte nelle chiese di Bologna. Secoli XV e XVI, Bologna 1938, p. 195; FILIPPINI - ZUCCHINI, Miniatori... cit. (nota 1), p. 163. A quelli già segnalati va aggiunto un documento finora inedito in data 18 agosto 1477: “Da magistro Tomaxo de Garelli depintore L. ventissie de quatrini li faziam buoni per dipingere la tavolla de l’altaro de la chapella de Signori XVI a debitto a la fabricha zoè” (ASP, Giornali di Fabbrica, n. 486, 1473-2480, c. 116).
6 SUPINO, L’arte... cit. (nota 5), p. 195.7 FILIPPINI, La cappella... cit. (nota 3), p. 184.8 Poiché lo stesso Filippini nel suo articolo del 1922 elenca correttamente i santi dipinti nel registro principale e
TOMMASO GARELLI 95
nella predella, egli dovette senz’altro scorgere la presenza di Santa Barbara in una delle quattro figure dipinte sulle cuspidi, di cui omette la descrizione. Si tratta però di un evidente fraintendimento, poiché le incisioni entro le aureole permettono di identificarle con i quattro Evangelisti (da sinistra: Marco, Giovanni, Luca e Matteo).
9 Il 16 luglio del 1477 a “Maestro Iohanne da Ravena depintore” sono pagate due lire “per dipingere la cassa dela tavolla del altaro di S. Barbara” (FILIPPINI - ZUCCHINI, Miniatori... cit. [nota 1], p. 83); l’11 aprile dell’anno successivo il maestro lignario Pollo di Mariano ricevette lire 4 e soldi 10 “per una chornixe [che] à fatto a la tavolla de Santa Barbara” (SUPINO, L’arte... cit. [nota 5], p. 195).
10 G. ZUCCHINI, Un affresco del pittore Tommaso Garelli in San Petronio, in ‘L’Archiginnasio’, XXVIII, 3-4, 1933, pp. 227-229). Il testo trascritto nella nota di Gaetano Giordani (“S. VINCENTIUS DE VALENTIA THOMAS PINXIT A. D. 1467”) collima in effetti con quanto ancora si può leggere sulla base del dipinto, ad eccezione della lacuna riguardante l’ultima cifra della data.
11 SUPINO, L’arte... cit. (nota 5), p. 193.12 Felsina pittrice. Vite de’ pittori bolognesi [di] Carlo Cesare Malvasia; con aggiunte, correzioni e note inedite del
medesimo autore di Giampietro Zanotti e di altri scrittori viventi, Bologna 1841, I, p. 38, nota 2.13 F. MASSACCESI, Nuove Riflessioni sul percorso di Michele di Matteo, in ‘Arte cristiana’, 97, 2009, 852, pp. 171-180,
speciatim 177, nota 2.14 CAVAZZA, Finestroni... cit. (nota 4), p. 163.15 G. ZUCCHINI, Guida della Basilica di San Petronio, Bologna 1953, pp. 67-68.16 FILIPPINI - ZUCCHINI, Miniatori... cit. (nota 1), p. 158.17 W. BERGAMINI, Dipinti appartenenti alla Compagnia dei Lombardi, in La Compagnia dei Lombardi in Bologna. 8.
centenario 1170-1970, Bologna 1970, pp. 145-163; ried. in W. BERGAMINI, Scritti d’arte, Bologna 2009, pp. 1-14.18 Ibidem, pp. 10-11, nota 21.19 L. BELLOSI, in I disegni antichi degli Uffizi. I tempi del Ghiberti, catalogo della mostra, Firenze 1978, pp. XXVII,
81-90, cat. 87-100.20 B. BERENSON, The Drawings of the Florentine Painters, London 1903, p. 16; ID., The Drawings of the Florentine
Painters, Chicago 1938, I, p. 16.21 R. LONGHI, “Genio degli Anonimi”: Giovanni di Piamonte?, in ‘La Critica d’arte’, XXIII, 1940, pp. 97-101; ried.
in Edizione delle opere complete di Roberto Longhi, VIII, “Fatti di Masolino e Masaccio” e altri studi sul Quattrocento, 1910-1967, Firenze 1975, pp. 131-137.
22 B. BERENSON, I disegni dei pittori fiorentini, Milano 1961, pp. 46-47. Più in generale, per un’esaustiva panoramica della vicenda critica relativa al taccuino: Disegni del Rinascimento in Val Padana, catalogo della mostra a cura di G. Agosti, Firenze 2001, pp. 84-90, cat. 3.
23 E. RUHMER, Marco Zoppo, Vicenza 1966, p. 38. Il carattere schiettamente padano del taccuino è ribadito da Ruhmer nella recensione a B. DEGENHART - A. SCHMITT, Corpus der italienischen Zeichnungen 1300-1450, Berlin 1968, I, 2, pp. 368-370, dove i fogli sono riferiti alla cerchia di Donatello: E. RUHMER, Das “Corpus” der italienischen Graphik, in ‘Arte veneta’, XXIV, 1970, pp. 268-271, speciatim 271. In quell’occasione lo studioso metteva in connessione i disegni degli Uffizi con gli affreschi eseguiti da Ansuino da Forlì nella cappella Ovetari a Padova.
24 L’attribuzione di Volpe è stata resa nota da D. BENATI, La pittura rinascimentale, in La Basilica di San Petronio in Bologna, II, Milano 1984, pp. 143-194, speciatim 145.
25 BERENSON, I disegni... cit. (nota 22), p. 46.26 BENATI, La pittura... cit. (nota 24), p. 145. La proposta è stata in seguito accettata anche da A. ANGELINI (in Disegni
italiani del tempo di Donatello, catalogo della mostra a cura di A. Angelini, Firenze 1986, p. 57 ) e da AGOSTI (in Disegni del Rinascimento... cit. [nota 22], p. 88).
27 LONGHI, “Genio degli Anonimi”... cit. (nota 21), p. 133. Così anche Luciano Bellosi e Fiora Bellini, i quali ritene-vano che la data 1467 non fosse affatto vincolante ai fini della datazione del taccuino “in quanto può esservi stata apposta in un momento successivo” (I disegni antichi... cit. [nota 19], p. 82).
28 L’iscrizione, vergata sul margine superiore del foglio 11 F, è la seguente: “1467 / ricordo chio ebi da Zironimo turco uno duchato di / quartrini chio non n’ò facto altro richordo credo fusi / a’ X o a’ XI dì di luio salvo el vero”.
29 DEGENHART - SCHMITT, Corpus... cit. (nota 23), pp. 368-370.30 La proposta della D’Urso è riportata, ma non condivisa, da AGOSTI, in Disegni del Rinascimento... cit. (nota 22), p.
89. A dire il vero, già D. BENATI (La bottega degli Erri e il Rinascimento a Modena, Modena 1988, pp. 42-44) aveva accostato le forme arrovellate e guizzanti del taccuino di Firenze agli esiti raggiunti dagli Erri nella pala realizzata per l’Oratorio della
95.
116.
105.
GIACOMO A. CALOGERO96
Morte di Modena (1462-1466), ma giustificando questa innegabile e sorprendente coincidenza di risultati sulla base di una “comune dipendenza da Donatello”, intervenuta in entrambi i casi a vivificare un’ancora desta mentalità tardogotica.
31 D. BENATI, in Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo Generale, 1, Dal Duecento a Francesco Francia, a cura di J. Bentini - G. P. Cammarota - D. Scaglietti Kelescian, Venezia 2004, pp. 251-252, cat. 95.
32 La scritta è riportata per esteso in BERGAMINI, Dipinti appartenenti... cit. (nota 17), p. 9, nota 7. A parere di Mario Fanti, che ringrazio per il competente parere, l’aggiunta, databile appunto al 1466, potrebbe riferirsi a una solenne ricollo-cazione della tela in occasione di lavori promossi dagli ufficiali che vi sono citati. In tal modo la data diviene un ante quem e non un riferimento preciso per l’esecuzione del dipinto, ad evidentiam già esistente. Esso è attualmente inserito entro uno stucco risalente al rifacimento della sala promosso nel 1753-54 da papa Benedetto XIV Lambertini (P. MULAS MARCELLO, Cenni storici sulla casa di residenza della Compagnia dei Lombardi, in La Compagnia dei Lombardi in Bologna. Contribuiti per una storia di otto secoli, Bologna 1992, pp. 49-58, speciatim 52-54). Tra i problemi posti dalla tela va messo in conto anche la singolare assenza, ad eccezione di Pietro e Petronio, dei santi (Ambrogio, Stefano, Paolo, Domenico, Francesco, Martino e Caterina) tradizionalmente venerati dalla Compagnia, quali si desumono dalla matricola del 1334 e dallo statuto del 1488. Per il permesso di esaminare da vicino il dipinto, rimuovendo il vetro che lo protegge, sono grato all’attuale massaro della Compagnia dei Lombardi, ingegner Piero Bullini. Per l’aiuto prestatomi durante l’indagine, ringrazio altresì Pietro Antoni e Camillo Tarozzi.
33 In questo senso: A. VOLPE, in Petronio a Bologna. Il volto di una storia. Arte e culto del santo patrono, catalogo della mostra a cura di B. Buscaroli, Bologna 2001, pp. 263-264, cat. 25. Tra le primizie del pittore dovrebbe trovar posto il San Sebastiano su un pilastro della chiesa bolognese di San Giovanni in Monte, reso parzialmente ingiudicabile dalle estese ridipinture. Vicina alla tela dei Lombardi, quindi già oltre il 1450, dovrebbe invece collocarsi la Madonna col Bambino del cenobio di San Vittore. Per entrambi i dipinti, attribuiti a Garelli da Volpe e pubblicati da BERGAMINI (Dipinti... cit. [nota 17], pp. 5, 11, nota 27) con ben più tarda datazione: BENATI, La pittura... cit. (nota 24), p. 143.
34 D. BENATI, in I dipinti della Pinacoteca civica di Budrio, a cura di D. Benati - C. Bernardini, Bologna, 2005, p. 92, cat. 3.
35 Per una corretta valutazione del polittico della Certosa: G. FOSSALUZZA, in Pinacoteca Nazionale... cit. (nota 31), pp. 224-233, cat. 84, che vi ravvisa, al di là di un aspetto compositivo complessivamente tradizionale, la tendenza “ad una sorta di cristallizzazione della forma che segna un’importante novità e in termini non solo squarcioneschi – con riferimento al polittico De Lazara del 1448 (Padova, Museo Civico) – ma ormai in certa misura anche mantegneschi”. L’esempio dei Vivarini, certo all’avanguardia per il contesto bolognese dell’epoca, può dunque bastare per giustificare i ben più timidi tentativi in senso spaziale e plastico-volumetrici esibiti da Garelli nella tela dei Lombardi.
36 BCABo, ms. B 1729, f. 7. I37 Da quanto riferito da Malvasia, sembra di capire che nel luglio 1685 gli Anziani decisero di collocare nella loro
cappella in palazzo comunale la venerabile immagine della Madonna del terremoto di Francesco Francia e che, per farle posto, fecero trasferire “la tavola che vi era antica” in un altro luogo di loro pertinenza, ossia la cappella di Santa Barbara in San Petronio. I curatori dell’edizione della Felsina pittrice del 1841 conoscevano l’appunto di Malvasia, ma preferirono fra-zionarlo in due parti: la prima, in cui è citata la Madonna del terremoto, fu infatti inserita come postilla alla vita del Francia (Felsina pittrice... cit. [nota 12], 1841, I, p. 50, nota 1); la seconda, relativa al polittico di Tommaso, fu invece scorporata ed utilizzata come nota autonoma posta in calce a p. 38, tra le aggiunte alla prima parte dedicata ai pittori primitivi, rendendo di fatto impossibile il collegamento tra le due informazioni.
38 Le pitture di Bologna [...] Terza edizione con nuova e copiosa aggiunta, Bologna 1732, p. 262.39 M. ORETTI, Notizie de’ professori del disegno, cioè Pittori, Scultori ed Architetti Bolognesi e de’ Forestieri di sua
scuola, BCABo, ms. B. 123, c. 91.40 Come mi suggerisce Mario Fanti, che ringrazio per il prezioso chiarimento, si tratta di uno degli appartamenti
superiori che costituiscono gli attuali locali della Fabbriceria.41 Una scritta a matita vergata sul frammento autografo di Malvasia segnala che esso si trovava tra la pagina 40 e 41
della copia della Felsina pittrice posseduta dallo stesso Malvasia. I 47 fogli del ms. B. 1729 sono infatti accompagnati da un volume contenente il primo tomo della Felsina pittrice nell’edizione originale del 1678; nel verso del foglio di riguardo si legge “A di 17 agosto 1705 questo libro fu donato a me Gio. Pietro Zanotti dal Signor Capitano Moscardini”.
42 La precisazione di Oretti consente di escludere l’ipotesi che il polittico riscoperto alla fine dell’Ottocento nei locali della Fabbriceria di San Petronio, e infine collocato nella cappella di Santa Brigida, possa coincidere con l’antica “tavolla de Santa Barbara” realizzata nel 1477 da Garelli per la cappella petroniana dedicata alla santa. Questa dovette invece essere rimossa dalla cappella agli inizi del XVII secolo, allorché sull’altare fu posta la tela con il Martirio di Santa
94.
TOMMASO GARELLI 97
Barbara di Alessandro Tiarini (D. BENATI, Alessandro Tiarini. L’opera pittorica completa e i disegni, Milano 2001, II, pp. 10-11). Non dovrà poi sorprendere il fatto che, a vent’anni di distanza l’uno dall’altro, Garelli realizzasse ben due polittici per il reggimento cittadino, visto l’importante ruolo da lui rivestito di pittore ufficiale del Comune di Bologna. Non saprei dire se sia possibile collegare la commissione del 1457 con un pagamento ottenuto da Garelli nel 1459, in cui egli risulta pagato “pro pictura per eum facta in dicta Sala”, ossia nella sala grande del palazzo (FILIPPINI - ZUCCHINI, Miniatori... cit. [nota 1], p. 159).
43 Questo ulteriore passaggio è riemerso grazie al ritrovamento presso l’Archivio Storico del Comune di Bologna di un fitto carteggio tra la direzione generale dei Musei civici, il Municipio di Bologna e la Fabbriceria di San Petronio. Il 23 maggio del 1881 il direttore generale dei Musei civici, Giovanni Gozzadini, informava l’allora sindaco della città, Gaetano Tacconi, che “in una camera della Fabbriceria petroniana è situata un’antica tavola dipinta da altare, importante per la sto-ria dell’arte”, lamentando che fosse conservata in un luogo inaccessibile ai visitatori della basilica e notando che “sarebbe perciò molto opportuno e giovevole l’ottenere da essa Fabbriceria il deposito puro e semplice di quella tavola al Museo Civico” (ASCBo, 1881, Carteggio amministrativo, Tit. XIV, 2-3, PG. 4371). Il Municipio si occupò prontamente della que-stione e pochi giorni dopo, il 27 maggio, trasmise alla Fabbriceria di San Petronio la richiesta del direttore Gozzadini. Con una nota del 30 luglio la Fabbriceria comunicava “di concedere il richiesto dipinto in semplice deposito nel Museo civico, riservata sempre a lei la facoltà di riavere presso di se la stessa tavola, ogni qual volta le piaccia” (ASCBo, 1881, Carteggio amministrativo, Tit. XIV, 2-3, PG. 5873).
44 C. RICCI, Guida di Bologna, Bologna 1886, p. 44, che cita, fra le opere conservate nel Museo civico, “una tavola trovata in un magazzino di S. Petronio, distinta a caselle dorate con vari santi che ricordano molto lo stile di Marco Zoppo”.
45 A. VENTURI, La pittura bolognese nel secolo XV, in ‘Archivio storico’, III, 1890, pp. 281-295, speciatim 283.46 In una lettera del 28 novembre 1891 indirizzata al sindaco di Bologna, la Fabbriceria richiedeva la restituzione del
polittico “poiché detta tavola deve essere collocata nel Museo o Tesoro di S. Petronio, che si sta impiantando, contenente gli oggetti più pregevoli della Fabbrica” (ASCBO, 1891, Carteggio amministrativo, Tit. XIV, 2-3, PG. 14692). La richiesta fu accolta, come dimostra una nota stilata nel dicembre del 1891 da un funzionario del Comune, che dichiarava “di aver ritirato dal Direttore della Sez. Med. Cav. D. Luigi Frati, l’antica tavola dipinta da altare, rappresentante nel mezzo mezzo la B.V. seduta col Bambino sulle ginocchia e quattro Santi, due per ciascun lato, di proprietà della Fabbriceria di San Pe-tronio” (ASCBO, 1891, Carteggio amministrativo, Tit. XIV, 2-3, PG. 2535, dove si specifica che la tavola era esposta nella sala XVII del Museo civico). Ringrazio Paolo Cova per avermi segnalato la copia di quest’ultima nota conservata presso l’archivio del Museo civico medievale di Bologna, grazie alla quale è stato possibile rintracciare il resto del carteggio otto-centesco qui pubblicato.
47 In A. GATTI, Catalogo del Museo di S. Petronio, Bologna 1893, p. 17, il dipinto è così descritto: “Ancona del sec. XV che ricorda lo stile di Marco Zoppo bolognese, raffigurante nel compasso centrale la Vergine col Bambino e nell’altre gli Evangelisti, i Protettori di Bologna ed altri Santi”. Gatti accolse dunque il parere di Ricci, rigettando il riferimento a Michele di Matteo proposto da Venturi.
48 Accogliendo il parere dello studioso, A. TURCHI (Il Maestro di San Pier Damiano: profilo di un pittore faentino del primo Quattrocento, in ‘Arte cristiana’, 97, 2009, 850, pp. 7-18, speciatim 14) nota che una datazione del polittico al 1457 renderebbe Garelli un perfetto parallelo bolognese dei più avanzati esponenti del ‘Rinascimento umbratile’ romagnolo di metà secolo, quali Ansuino da Forlì o il Maestro di San Pier Damiano. Il confronto tra Garelli e queste personalità artistiche era stato d’altronde già avanzato da A. TAMBINI (Il Maestro di San Pier Damiano, in ‘Paragone’, XXXI, 1980, 367, pp. 47-60, speciatim 51) e, prima di lei, da C. VOLPE (Tre vetrate ferraresi e il Rinascimento a Bologna, in ‘Arte antica e moderna’, 1, 1958, pp. 23-37, speciatim 36, nota 12; ried. in C. VOLPE, La pittura nell’Emilia e nella Romagna. Raccolta di scritti sul Trecento e sul Quattrocento, a cura di D. Benati - L. Peruzzi, Modena 1993, pp. 152-168, speciatim 166, nota 12).
49 MASSACCESI, Nuove riflessioni... cit. (nota 13), pp. 177, 180 nota 30. 50 Anche M. MINARDI (in The Alana Collection. Italian Paintings and Sculptures from the Fourteenth to Sixteenthth
Century, a cura di M. Boskovits, Firenze 2011, p. 276, cat. 39) ha recentemente sottolineato che nel caso del polittico della cappella di Santa Brigida “the type of altarpiece is still influenced by prototypes of local late-gothic tradition, exemplified by Michele di Matteo’s altarpiece in the Pinacoteca Nazionale di Bologna (1462)”.
51 BENATI, La pittura... cit. (nota 24), p. 149.52 Accogliendo la data 1477, Benati era costretto di fatto a ipotizzare che, rifiutando le novità ormai patenti di Fran-
cesco del Cossa e del giovane Ercole de’ Roberti, Garelli si rifugiasse polemicamente in uno strenuo arcaismo.53 Sulla Madonna con il Bambino di Cremona: D. BENATI, in La Pinacoteca Ala Ponzone. Dal Duecento al Quattro-
cento. Catalogo delle Collezioni, a cura di M. Marubbi, Milano 2004, pp. 188-190, cat. 58, che segnala la scritta “Madonna 98.
GIACOMO A. CALOGERO98
del piombo” leggibile sulla tavola della collezione Ruffo, ipotizzandone una provenienza da Bologna, dove tuttora esiste un oratorio dedicato alla Madonna del Piombo. Ciò renderebbe ancor più pregnante il confronto qui proposto.
54 L’ipotesi, formulata da Benati, è accolta da M. NATALE, in Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’e-tà di Borso d’este, catalogo della mostra a cura di M. Natale, Ferrara 2007, pp. 494-496.
55 Per una possibile ricostruzione del polittico: M. MINARDI, in Angeli. Volti dell’invisibile, catalogo della mostra di Illegio, a cura di S. Castri, Torino 2010, pp. 239-240, cat. 62.
56 A. DE MARCHI, in Gotik in Slowenien, catalogo della mostra a cura di A. Smrekar, Lubiana 1995, p. 317, cat. 183.57 BELLINI, in I disegni antichi... cit. (nota 19), p. 89, cat. 99.58 Anche ANGELINI (in Disegni italiani... cit. [nota 26], p. 58) riconosceva che “la resa dei panneggi è, in sostanza,
l’elemento che accomuna più strettamente i dipinti del Garelli con i disegni di Firenze”, notando, non solo nei Santini stefaniani, ma anche nel polittico di San Petronio, il “coesistere di elementi arcaizzanti, in linea con quelle rigide figurette ‘post-ghibertiane’ e di aspetti assimilati dai grandi maestri del Rinascimento” e, in particolare, nei “panneggi delle figure solcati da pieghe in rilievo e spiraliformi, che si devono ricondurre appunto ad un’origine donatelliana”.
59 Già AGOSTI (in Disegni del Rinascimento... cit. [nota 22], p. 89) sottolineava come la destinazione d’uso del taccu-ino sia dimostrata dalle tracce accidentali d’oro che si scorgono sul recto del foglio 11 F.
60 BELLINI, in I disegni antichi... cit. (nota 19), figg. 119-141.61 ANGELINI, in Disegni italiani... cit. (nota 26), p. 58.62 Il fatto che il 9 ottobre 1455 lo Zoppo sia documentato a Venezia nell’atto di citazione contro Squarcione non
implica di necessità una sua permanenza in laguna lungo tutta la seconda metà del sesto decennio. A parte il disegno con la Resurrezione del Metropolitan Museum di New York, in cui sembra citare la statua lignea di Donatello conservata ai Frari (L. ARMSTRONG, The Paintings and Drawings of Marco Zoppo, New York and London 1976, pp. 72-74, 395), non esistono infatti prove in tal senso, mentre la datazione del polittico del Collegio di Spagna, già in lavorazione nel 1459 (D. BIAGI MAINO, Il retablo del Collegio di Spagna, in Marco Zoppo. Cento 1433-1478 Venezia, a cura di B. Giovannucci Vigi, atti del convegno di Cento, Bologna 1993, pp. 71-70, speciatim 65-68), spinge quella della Croce del Museo di San Giuseppe a Bologna, chiaramente precedente, entro la seconda metà degli anni cinquanta (ARMSTRONG, The Paintings... op. cit., p. 343; D. BIAGI MAINO, Marco Zoppo a Bologna, in La croce dipinta di Marco Zoppo e la cultura pierfrancescana a Bologna, catalogo della mostra a cura di D. Biagi Maino - M. Medica, Bologna 2007, pp. 23-27, speciatim 27). Un ulteriore indizio del precoce ritorno in Emilia dello Zoppo potrebbe essere fornito dal disegno con la Crocifissione degli Uffizi, assai prossimo alla Croce di Bologna, in cui all’ancora fresco ricordo del Donatello padovano si sommano precise citazioni, sia nel recto che nel verso, dell’altare bronzeo realizzato da Nicolò Baroncelli e Domenico di Paris per la cattedrale di Ferrara, già in opera nel 1456 (L. ARMSTRONG, Two Notes on Drawings of Marco Zoppo, in ‘Pantheon’, XXI, 1963, pp. 298-310, speciatim 300, 303; ANGELINI, in Disegni italiani... cit. [nota 26], pp. 64-65; AGOSTI, in Disegni del Rinascimento... cit. [nota 22], p. 92). Ne consegue la possibilità di un ritorno per tempo dello Zoppo anche nella vicina Bologna, in modo da giustificare le improvvise inflessioni donatelliane condotte da Garelli nel polittico datato 1457.
63 Il 31 maggio del 1459 Garelli aveva ottenuto dai fratelli Jacopo e Bartolomeo Maineri, per la cifra di 40 lire, la concessione dell’appalto relativo alla decorazione di una parte della cappella di Santa Brigida (FILIPPINI - ZUCCHINI, Minia-tori... cit. [nota 1], p. 159. Il 14 giugno dello stesso anno, Giovanni Francesco da Rimini riceveva dodici ducati d’oro per dipingere l’altra “mità de la chapella di santa Brigida” (ibidem, p. 90). Tra il 1461 e il 1462 i Fabbricieri pagavano invece lire 30 a “maestro Marcho di Rugiero dipintore per una spaliera e uno banchale a la figura di s. Petronio e arma del Leghato” (ibidem, p. 117). A questi ultimi pagamenti G. ROMANO (Opere di tarsia. Agostino de Marchi e il coro della cappella maggiore, in La Basilica di San Petronio, II, Milano 1984, pp. 269-276, speciatim 269) ha collegato i lavori del coro della cappella di Santa Brigida, per i quali l’8 novembre 1458 era già stato elargito un compenso ad Agostino de Marchi, incaricato di realiz-zare metà del coro ligneo della stessa cappella.
64 Sullo sfortunato esito del cantiere di veda, oltre anche CAVAZZA, Finestroni... cit. (nota 4), pp. 165-166; FILIPPINI - ZUCCHINI, Miniatori... cit. (nota 1), p. 161; ROMANO, Opere di tarsia... op. cit., p. 275, nota 3; O. DELUCCA, Artisti a Rimini fra Gotico e Rinascimento. Rassegna di fonti archivistiche, Rimini 1997, p. 132. Come già sottolineava Romano, l’attuale presenza sulle pareti della cappella di Santa Brigida degli affreschi eseguiti da Luca da Perugia nel 1417, da Francesco Lola nel 1419 e Michele di Matteo del 1430, sembrerebbe confermare il fatto che la commissione del 1459 non fosse alfine andata in porto. Conosciamo però una lettera diretta da Giovanni Francesco da Rimini ai Fabbricieri di San Petronio, in cui il pittore chiede di poter “seguitare la dicta capella”, che egli prometteva di condurre a termine con «honore». In alternativa, il riminese pretendeva una ricompensa per quanto già eseguito: segno forse che almeno una parte della decorazione fosse stata già avviata, probabilmente quella dei pennacchi della volta, poiché, sempre nella lettera si legge: «Item haveti fatto el
100-101.
106-107.
TOMMASO GARELLI 99
principio de la volta de la detta cappella, quello che la merita el poteti vedere» (G. GAYE, Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI, I, Firenze 1839, pp. 244-246; DELUCCA, Artisti a Rimini... op. cit., p. 135).
65 ROMANO, Opere... cit. (nota 63), p. 269.66 FILIPPINI - ZUCCHINI, Miniatori... cit. (nota 1), p. 159.67 C. C. MALVASIA, Le pitture di Bologna [1686], a cura di A. Emiliani, Bologna 1969, p. 107. Lo stesso Agostino de
Marchi terrà a battesimo un figlio di Garelli nel 1468 (FILIPPINI - ZUCCHINI, Miniatori... cit. [nota 1], p. 160).68 CAVAZZA, Finestroni... cit. (nota 4), p. 165.69 Tale ipotesi è stata sostenuta da BENATI (in I dipinti... cit. [nota 34], p. 92) e più recentemente da MINARDI (in The
Alana Collection... cit. [nota 50], p. 272), che ha inoltre ricondotto alla predella dello stesso complesso una piccola tavola con la Presentazione al tempio conservata al Bonnefantemuseum di Maastricht, già riferita a Garelli da Boskovits (ibidem, pp. 272, 278, nota 9).
70 BERGAMINI, Dipinti... cit. (nota 17), p. 4.71 Per la ricostruzione dell’aspetto originario del polittico: MINARDI, in The Alana Collection... cit. [nota 50], pp. 272,
274, fig. 1. In questa sede si pubblica lo stesso grafico, con qualche variazione relativa alla disposizione dei santi nei pilieri e alla posizione dello scomparto di Maastricht nella predella. Si accoglie altresì, con qualche modifica relativa alle dimensioni dei tondi, l’ipotesi che esso rispecchiasse il precedente di Marco Zoppo nel Collegio di Spagna anche per quanto riguarda il coronamento: in proposito va però detto che la sopravvivenza nello stesso Museo di Santo Stefano di un Cristo in pietà di formato triangolare, già ricollegato allo stesso polittico da Benati, porta a non escludere che il polittico di Garelli prevedesse una terminazione simile a quella da lui adottata nel polittico ora in San Petronio.
72 ZUCCHINI, Un affresco... cit. (nota 10), p. 228. 73 MINARDI, in The Alana Collection... cit. (nota 50), p. 276. Il carattere palesemente toscano dell’affresco ha deter-
minato in passato persino una fantasiosa attribuzione a Zanobi del Migliore: G. SIGHINOLFI, Guida di Bologna, Bologna 1926, p. 25.
74 La soluzione è giustamente rilevata, come precoce testimonianza della diffusione a Bologna delle soluzioni pro-spettiche messe in auge da Francesco del Cossa (a Bologna almeno dal 1962), da S. TUMIDEI, Melozzo da Forlì: fortuna, vicende, incontri di un artista prospettico, in Melozzo da Forlì: la sua città e il suo tempo, catalogo della mostra di Forlì, a cura di M. Foschi - L. Prati, Milano 1994, pp. 19-81, speciatim 34; ried. in S. TUMIDEI, Studi sulla pittura in Emilia e Romagna da Melozzo a Federico Zuccari, a cura di A. M. Ambrosini Massari - A. Bacchi - A. Brogi - E. Sambo, Trento 2011, pp. 12-96, speciatim 38.
75 Il 24 luglio del 1472 Garelli viene pagato “quia renovavit figuram beatae Brigide vidue que est super altare sue ca-pelle” (FILIPPINI - ZUCCHINI, Miniatori... cit. [nota 1], p. 161). Tra il gennaio del 1474 e il dicembre del 1475 il riceve diversi pagamenti per la doratura dei capitelli e del parapetto dell’organo e per aver dipinto un’Annunciazione, un San Petronio e tre Angeli sulle portelle dell’organo (ibidem, pp. 162-163).
76 FILIPPINI - ZUCCHINI, Miniatori... cit. (nota 1), p. 163.77 C. VOLPE, Paolo Uccello a Bologna, in ‘Paragone’, 31, 1980, 365, pp. 3-28, speciatim 24; ried. in C. VOLPE, La
pittura nell’Emilia... cit. (nota 48), pp. 102-123, speciatim 119.78 AGOSTI, in Disegni del Rinascimento... cit. (nota 22), p. 89.
115.
116.
ABSTRACTS246
hypothesized that one of these was made in 1461-62 for Santissima Annunziata in Florence, and that this in turn may have been replaced by the marble sculpture now in the Chiostrino dei Voti of that church, here presented as a work of the sixteenth century. Another such sculpture, recently offered at auction, was in the collection of the Comte de Nieuwerkerke during the nineteenth century.
Various elements would indicate that the Santa Trinita Madonna formed a part of the tomb of Giuliano Davanzati, an important Florentine statesman and a trusted colleague of Cosimo de’ Medici. The provenance of the work offers parameters for a date between 1436 and 1447, which would correspond to evidence provided by stylistic analysis.
GIACOMO A. CALOGERO, Tommaso Garelli nel Rinascimento bolognese
The artistic profile of Tommaso Garelli, documented in Bologna between 1450 and 1495, has been elucidated thanks to fundamental studies by Carlo Volpe (1958) and Luciano Bellosi (1978). The latter established his authorship of an album of drawings after Florentine works by Donatello and Masaccio (Florence, Uffizi), formerly attributed to Giovanni di Piamonte (Longhi) and Giovanni di Francesco (Berenson).
The author points out incongruities in the chronology of his works, based on the erroneous identification of the polyptych still housed in San Petronio with a painting for which the artist was paid in 1477. Thanks to a reconstruction of the various movements of this polyptych, it can instead be identified as a work carried out in 1457 for the Palazzo Comunale in Bologna. This leads to a rereading of Garelli’s entire career. Having begun as a practitioner of the Late Gothic style, he was already able by the second half of the 1450s to absorb Renaissance innovations after an early sojourn in Florence – documented by the drawings mentioned above – and through a creative dialogue with Marco Zoppo in Bologna.
Evidence for such evolution is found in a polyptych destined for an unknown location whose sole extant elements are a lateral section (Delaware, Alana Collection) and some minor panels divided between the Museo di Santo Stefano in Bologna and the Bonnefanten Museum in Maastricht. Further information is provided with respect to the dating of the canvas Virgin and Child with Saints (Bologna, Compagnia dei Lombardi), which is here dated to before 1466, the year inscribed on it at a later stage.
PAOLO ERVAS, Un’aggiunta a Girolamo da Treviso il vecchio
The Sheffield Galleries & Museums Trust houses a beautiful fragmentary panel attributed here to Girolamo Strazzaroli da Aviano, better known as Girolamo da Treviso the Elder (1451-1496/97). A formal analysis of the painting reveals fairly close similarities to the two saints in the altarpiece known as the Madonna del Fiore (Treviso, Cathedral), signed and dated 1487.
The painting should thus be dated close to that year, when Girolamo was evolving from the style of his youthful Paduan background to his Venetian manner. This phase shows his interest in Bartolomeo Montagna, to whom the painting in England has been attributed.
That this picture has been compared to Montagna would seem to reflect the transition in Girolamo’s style towards the language of the Vivarini, and especially that of Alvise. The most important manifestation of this late output is the altarpiece with Saint Martin and the Beggar in the parish church at Paese (province of Treviso), datable to circa 1496.
94. TOMMASO GARELLI: Madonna con il Bambino e i Santi Nicola, Pietro, Michele e Petronio. BOLOGNA, Santo Stefano, Compagnia dei Lombardi.
95. TOMMASO GARELLI: Polittico con Madonna e santi. BOLOGNA, Basilica di San Petronio, cappella di Santa Brigida.
96. MICHELE DI MATTEO: Madonna con il Bambino. Già BOLOGNA, collezione Gozzadini.
97. GIOVANNI FRANCESCO DA RIMINI: Madonna con il Bambino. Perugia, Galleria nazionale dell’Umbria.
98. MAESTRO DEGLI OCCHI AMMICCANTI (GALASSO DI MATTEO PIVA?): Madonna con il Bambino. CREMONA, Museo civico Ala-Ponzone.
99. TOMMASO GARELLI: Madonna con il Bambino, particolare del polittico. BOLOGNA, Basilica di San Petronio, cappella di Santa Brigida.
100. DONATELLO: Due santi martiri, particolare della Porta dei Martiri. FIRENZE, San Lorenzo, sagrestia vecchia.
101. TOMMASO GARELLI: Due santi martiri (da Donatello), foglio di taccuino. FIRENZE, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, inv. 14499 F recto.
102. TOMMASO GARELLI: Battesimo di Cristo. BUDRIO, Pina-coteca civica Domenico Inzaghi.
103. TOMMASO GARELLI: Due apostoli, foglio di tac-cuino. FIRENZE, Gabinetto dei Disegni e delle Stam-pe degli Uffizi, inv. 331 E.
104. TOMMASO GARELLI: San Giovanni battista, parti-colare del polittico. BOLOGNA, Basilica di San Petro-nio, cappella di Santa Brigida.
105. TOMMASO GARELLI: Studi di figure, foglio di tac-cuino. FIRENZE, Gabinetto dei Disegni e delle Stam-pe degli Uffizi, inv. 11 F recto.
106. DONATELLO: San Pietro, particolare della Porta degli Apostoli. FIRENZE, San Lo-renzo, sagrestia vecchia.
107. TOMMASO GARELLI: San Pietro (da Donatello), particolare di foglio di taccui-no. FIRENZE, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, inv. 15816 F recto.
108. TOMMASO GARELLI: San Pietro. BOLO-GNA, Museo di Santo Stefano.
109. TOMMASO GARELLI: Studi di figure, foglio di tac-cuino. FIRENZE, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, inv. 329 E.
110. TOMMASO GARELLI: San Paolo, particolare di scomparto. NEWARK (DELAWARE), collezione Alana.
111. TOMMASO GARELLI: Giovane apostolo, foglio di taccuino. FIRENZE, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, inv. 5 F.
112. TOMMASO GARELLI: Giovane apostolo. BOLOGNA, Museo di Santo Stefano.
113. MARCO ZOPPO: San Giovanni battista e San Girolamo, particolare del polittico. BOLOGNA, Collegio di Spagna, San Clemente.