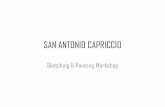La chiesa e il convento di San Domenico a Cagliari nel XVI secolo (resumen tesis doctoral)
La vetrata su cartone di Domenico Ghirlandaio. Personaggi sono San Tommaso d’Aquino e San
Transcript of La vetrata su cartone di Domenico Ghirlandaio. Personaggi sono San Tommaso d’Aquino e San
Lezione 22-03-2014 Santa Maria Novella Il complesso di Santa Maria Novella è un grande complesso conventuale e non è soltanto la chiesa ma è anche il convento, il chiostro, la farmacia e il Cappellone degli Spagnoli. La piazza fu creata quando venne costruita la chiesa odierna perché la chiesa primitiva era orientata in maniera diversa e la piazza antistante è l'attuale Piazza dell'Unità che antecedentemente si chiamava Piazza Vecchia di Santa Maria Novella. Nel '300 quando fu terminata la struttura architettonica della nuova chiesa fu fatta la nuova piazza che fu sistemata a partire dal 500 con i due obelischi e nello stesso periodo si iniziò anche a correre il Palio dei Cocchi.
Dirimpetto alla chiesa c'è l'ospedale dei Convalescenti o ospedale di San Paolo che è un edificio rinascimentale, con i medaglioni realizzati da Andrea della Robbia, dove oggi si trova il museo Alinari e il museo del '900. Un'altra cosa da notare in questa piazza è il grande Hotel Minerva con la sua facciata ottocentesca, facciata sottoposta a vincolo e per questo non modificata, mentre per quanto riguarda la parte interna, intorno al 1950, venne tutta ristrutturata e modernizzata e nell'attico fu creata una piscina. La ristrutturazione fu eseguita da Carlo Scarpa e da Edoardo Detti che sono due architetti importanti del '900, Detti è fiorentino e Scarpa veneziano. Nella storia della chiesa abbiamo i primi documenti che risalgono al X sec., del 983 è il primo documento che ribadisce che questa antica chiesa di Santa Maria fra le Vigne era data in dotazione ai canonici della cattedrale (fra le “vigne” rende ben chiara l'immagine del paesaggio). La chiesa del X sec. occupava l'area del Capitolo cioè del Cappellone degli Spagnoli, naturalmente, all'epoca, eravamo fuori dalle mura di Firenze e oltre il Mugnone (che è stato spostato varie volte) che serviva in passato a formare il fossato attorno alle mura, quindi in aperta campagna come dice il nome S.M. fra le Vigne. La chiesa fu ricostruita avanzando verso la piazza di S.M. Novella Vecchia (Piazza dell'Unità) e la chiesa romanica era collocata nella zona dove oggi si trova la sagrestia e il transetto sinistro.
Nel 1221 l'antica chiesa di S.M. fra le Vigne venne data ai domenicani, che erano arrivati due anni prima a Firenze con il beato Giovanni da Salerno, il quale era stato allievo di San Tommaso a Bologna, mandato a Firenze per iniziare la predicazione dei frati predicatori domenicani. Le fonti ci raccontano che arrivò con dodici frati (non si sa se è leggenda o no). Arrivati nel 1219, si fermarono nell'Oratorio di pian di Ripoli dove crearono il primo convento domenicano femminile a Firenze, successivamente si spostarono più vicino intorno alla chiesa di San Pancrazio, che allora era ancora fuori le mura, chiesa sconsacrata nel 1808 e che oggi ospita il Museo Marino Marini, infine gli fu data la chiesa di Santa Maria fra le Vigne come residenza definitiva che poi diventerà l'attuale Santa Maria Novella. Nel 1272 iniziò la raccolta di fondi per la costruzione della nuova chiesa, che sarà molto più grande delle due precedenti (primitiva e romanica) e cambierà l'orientamento diventando la più grande chiesa domenicana dell'epoca. La chiesa primitiva era poco più grande di un oratorio e quella romanica un po' più grande della precedente. Nel 1279 fu posta la prima pietra (questo è documentato) ed è da far risalire il progetto ai famosi Fra Sisto e Fra Ristoro, che secondo gli studiosi sono nomi più mitici che reali, in quanto la costruzione venne portata avanti nel corso del '300 da un altro frate domenicano, Iacopo Talenti da Nipozzano. Il fatto che questi architetti dell'ordine domenicano, sia quelli rimasti un po' “nebulosi” nel mito della chiesa, sia quelli documentati come Iacopo Talenti e Fra Giovanni da Campi, ci fa intuire che i domenicani erano un ordine di persone (come lo erano stati anche prima i benedettini) professioniste e colte, facendo ancor di più capire come questa chiesa sia stata così importante nella cultura fiorentina, basti pensare che annesso alla Basilica di S.M. Novella c'era lo Studio, che oggi non esiste più, divenuto poi nel 1294 Studio Generale che era l'università più importante e che poteva concedere i titoli accademici agli studenti e importante ricordare che fra gli insegnanti che tennero la cattedra allo Studio fiorentino c'era Fra Remigio de Girolami che probabilmente è stato uno dei docenti di Dante Alighieri. Dante era molto colto e questo derivava dagli studi che aveva fatto, l'impostazione della Divina Commedia è proprio secondo la filosofia tomistica e aristotelica, ovvero segue gli insegnamenti di San Tommaso il quale aveva applicato alla dottrina i principi della filosofia aristotelica in un concetto sistematico. Il sapere dantesco era basato su solide fondamenta di studi che aveva fatto a Santa Croce da ragazzino ma soprattutto allo Studio fiorentino; naturalmente questo ci porta a capire che all'interno del convento di S.M. Novella ci fossero una biblioteca e uno scriptorium (parti andate perdute) come in tutti i conventi che si rispettassero. La chiesa iniziata nel 1279 con la posa della prima pietra venne ultimata nel corso del '300, successivamente venne costruita la piazza ma nel frattempo, dalla fine del '200 ai primi del '300, venne costruita l'ultima cerchia muraria che includeva anche il complesso e la Basilica di S.M. Novella che così entrò a far parte della città. Fra i personaggi importanti che hanno vissuto a S.M. Novella ci sono anche i predicatori e il più importante fra tutti, legato alla storia della chiesa, fu San Pietro Martire o Pietro da Verona, tenace oppositore alle eresie e morto in un'imboscata a Seveso in Lombardia. Alla metà del '200 il problema della chiesa di Roma erano le eresie “pauperistiche” ovvero movimenti di eretici, comprendenti un po' tutti i livelli sociali, che si opponevano allo strapotere della chiesa e dei sovrani (normalmente alleati), di solito la chiesa si schierava con l'imperatore o con il re di Francia. Questa alleanza tra potere spirituale e potere temporale schiacciava la popolazione generando un
sentimento da parte della stessa al ritorno all'origine contro la corruzione, la simonia e il lusso della chiesa. I movimenti principali erano quelli dei catari e dei patari mentre i domenicani si fecero paladini contro l'eresia che minava la chiesa dalla base. Non a caso i domenicani fecero una crociata contro gli albigesi, catari della Provenza e anche della zona del Piemonte e ai dominicani venne dato il ruolo di predicatori contro l'eresia e di inquisitori (il ruolo fu dato dal proprio papa). Nel '200 venne creato l'Istituto dell'Inquisizione e i processi di eresia venivano tenuti in S.M. Novella dai frati domenicani e la pena per gli eretici era il rogo (condanne che non furono molto utilizzate come in altri stati come ad esempio in Francia). San Pietro Martire stette a S.M. Novella soltanto due anni, ma la sua fu una grande figura, per altro fu lui che fece ampliare la piazza di S.M. Novella Vecchia, che fondò delle confraternite e promosse la creazione della Misericordia e anche la Compagnia dei Laudesi, compagnie laicali volte a combattere l'eresia. Più o meno come successe con San Francesco, il papa accolse i francescani in seno alla chiesa perché così poteva conquistare una larghissima fetta di fedeli. La facciata conclude il processo di costruzione della chiesa, è una facciata quattrocentesca, la più bella rinascimentale fiorentina che si inspira alla tradizione fiorentina romanica perché ci sono gli intarsi marmorei che riprendono il Battistero e San Miniato. L'architetto che designò la facciata è stato Leon Battista Alberti ed è datata 1470. Il patrono della facciata è stato Giovanni di Paolo Rucellai. Legati a questa chiesa ci sono i patroni di tantissimi famiglie fiorentine molto importanti: Rucellai, Tornabuoni, Ricci, Strozzi, Minerbetti, Cavalcanti, Acciaiuoli, tutte importanti famiglie fiorentine di mercanti e anche diplomatici come Acciaiuoli e Cavalcanti. L'ultimo intervento importante che conclude la costruzione è proprio la facciata di Leon Battista Alberti, il quale stava lavorando in quegli anni per la famiglia Rucellai. Collegato alla facciata ci sono altre tre commissioni importanti: il Palazzo Rucellai, la Cappella del Santo Sepolcro all'interno della chiesa di San Pancrazio che era la parrocchia alla quale facevano capo i Rucellai e la Loggia Rucellai. Nella facciata il patronato della famiglia Rucellai è reso ben visibile non solo dalla scritta in capitali classiche ma anche dagli emblemi araldici che sono le vele, la cornice marcapiano della facciata è ornata con le vele dei Rucellai che alludano alla mercatura, alle navi che portavano le merci. I Rucellai divennero ricchissimi perché avevano il monopolio di una sostanza che coloravano i panni chiamata: ORICELLUM (un colore sul violetto), la tintoria era l'industria più importante di Firenze. L'opera dell'Alberti è importantissima perché si trattava di uniformare la facciata creando una decorazione architettonica rinascimentale su una chiesa medioevale gotica, quindi vi era la necessita di armonizzare questa fronte caratterizzata dalla scansione delle tre navate, con la centrale più alta e le due laterali più basse e dal rosone trecentesco preesistente disegnato da Andrea Bonaiuti, lo stesso pittore che aveva fatto il Cappellone degli Spagnoli che non poteva essere rimosso. Leon Battista Alberti ha dovuto eseguire un restauro architettonico ridisegnando la facciata e per riuscire ad armonizzare la parte bassa trecentesca, già esistente, dove si trovano gli avelli (le tombe) e gli archetti di ispirazione romana (archi a tutto sesto) aggiunse quattro semi colonne in marmo verde che disegnano e limitano la facciata a destra, a sinistra e le due centrali che inquadrano il nuovo portale con San Domenico dell'Alberti, poi aggiunse le decorazioni sui pilastri laterali zebrati bianco e verde a destra e sinistra dove si trova di nuovo la vela dei Rucellai, e infine realizza la cornice. La parte superiore è tutta albertiana, ci sono le tarsie marmoree che sono molto simili a quelle che lui aveva realizzato due tre anni prima nel tempietto Rucellai di San Pancrazio. Le due volute con i motivi a raggiera servono a nascondere le sporgenze delle due navate laterali così da ridisegnare la struttura della facciata.
Il portale venne pagato non da Giovanni di Paolo Rucellai ma da Bernardo Rucellai. Gli avelli sono sepolture (è anche per questo che la via se chiama Via degli Avelli); queste sepolture erano di famiglie e sono state restaurate, rimaneggiate nei corsi dei secoli però hanno mantenuto il loro aspetto gotico, in tutti ci sono le armi delle famiglie e al centro la croce del popolo; all'interno c'è un cimitero e l'ingresso originale della chiesa primitiva era dal cimitero e dalla porta che da sul cimitero. L'ingresso al museo di S.M. Novella è di recente fondazione con la struttura attuale in quanto prima il museo aveva l'ingresso dalla piazza S.M. Novella ed era una cosa a sé e quindi se qualcuno voleva andare alla chiesa doveva fare un'altra fila e un altro biglietto. Da due anni, invece, è stata fatta una convenzione tra l'opera di S.M. Novella, che gestisce la chiesa, e i Musei Civici, (questo è comunale) che gestisce il museo, ricomponendo così il grande complesso come era realmente in passato; rimane fuori dal circuito museale una parte che è la Scuola dei Sottufficiale dei Carabinieri dove c'è anche la Cappella Papale.
In passato era un complesso ancora più grande e nella zona della entrata di piazza S. M. Novella (della stazione centrale) c'erano altri edifici tra cui la biblioteca e lo scriptorium e c'erano tutte le vigne e gli orti di proprietà del convento. Intorno al complesso si formarono vari ambienti come il chiostro dei morti dove ancora sono presenti molte lapidi ottocentesche (cosa invece che non esiste più nel chiostro di Santa Croce dove sono state smantellate e depositate negli scantinati). La parte architettonica trecentesca è gotica e le lapidi ottocentesche. Le cappelle sono tutte affrescate ed erano appartenenti alle famiglie che avevano il patronato, qui vi seppellivano i membri delle loro famiglie e la più importante è la Cappella Strozzi il cui l'affresco è attribuito ad Andrea Orcagna. L'affresco rappresenta una Crocifissione, una Natività e le armi degli Strozzi con le lune crescenti (le tre mezzelune). Il Chiostro Verde è molto importante per la storia dell'arte, si chiama Chiostro Verde perché gli affreschi che vennero dipinti lungo i muri avevano una base di terra verde, il colore via via distaccandosi, e sbiadendosi lascia apparire un colore verdaccio che era la base utilizzata nella preparazione degli affreschi. Il chiostro era tutto affrescato, probabilmente la maggior parte degli affreschi sono della fine del '300 e inizio '400 e rappresentano le storie dei padri della chiesa e degli eremiti. Vi erano inoltre le storie della Genesi di Paolo Uccello ma questi affreschi furono staccati a causa dell'alluvione e furono messi su un supporto piuttosto pesante e collocati nella zona del refettorio che è diventato il vero e proprio museo della chiesa; gli affreschi furono divisi in due parti,
la parte bassa in forma rettangolare e la parte alta in forma di lunetta e collocati su dei carrelli. Oggi sono in restauro nel laboratorio della Fortezza dove deve essere sostituito il pesante supporto con un supporto di vetro resina molto più leggero al fine di renderli maneggevoli ed elastici. Alessandro Parronchi (grande studioso fiorentino di storia dell'arte) dopo un'accurata analisi della composizione e dello stile data questi due affreschi in due periodi diversi, il primo pannello con la “Creazione - Genesi” sarebbe anteriore al viaggio di Paolo Uccello a Venezia perché ancora molto legato al tardo gotico e pur essendo presente un impianto quattrocentesco la disposizione delle figure corrisponde al suo periodo giovanile, mentre l'altro affresco con “l'Arca di Noè e il diluvio universale” dove l'impianto è molto più prospettico è da far risalire al suo ritorno a Firenze da Venezia (era partito nel 1430 e vi rimase diversi anni). Gli altri affreschi non si sa di chi siano però per quelli di Paolo Uccello ci sono documenti di Vasari e Ghiberti che lo confermano. Il Chiostro Grande fa parte della Scuola dei Sottufficiali dei Carabinieri e questa parte è chiusa al pubblico però in passato faceva parte del complesso conventuale. La primitiva chiesa della quale vi è un documento del X sec era ubicata in questo punto, fu poi ampliata e si entrava dal transetto sinistro; oggi c'è il transetto sinistro, la Cappella Strozzi e la sagrestia e tutto il transetto era il luogo della seconda chiesa romanica e infine la terza ricostruzione è quella che cambia l'orientamento della chiesa. La parte dedicata al refettorio venne costruita con volte trecentesche dalla famiglia degli Embriachi o degli Ubriachi, una famiglia di mercanti fiorentini, oggi è il luogo del museo che raccoglie gli affreschi staccati di Paolo Uccello anche parati e reliquari, un museo di arte sacra, e tra l'altro in questa parte sono stati collocati affreschi staccati che sono quadrilobi con all'interno dei santi e patriarchi che sono stati recuperati durante i restauri dalla Cappella Maggiore dove ora ci sono gli affreschi del Ghirlandaio perché prima degli affreschi del Ghirlandaio c'erano gli affreschi di Andrea Orcagna e il soggetto era sempre dedicato alla Vita di Maria. La parte più grande degli affreschi è stato distrutto perché Ghirlandaio ha dovuto rifare gli intonaci per ridipingere l'affresco quattrocentesco ma in certe parte secondarie dove c'erano queste serie di medaglioni quadrilobati non avevano tolto intonaco e quindi è stato possibile recuperare queste decorazioni di Andrea Orcagna che dopo furono staccate e collocate qui. I reliquiari, belli e preziosi, sono dal tardo gotico al quattrocento e qualcosa anche di periodo più tardo e ci danno un'idea della ricchezza degli arredi del convento e della chiesa; i documenti parlano di una chiesa ricca, la sagrestia era stracolma di parati, reliquiari, di oggetti liturgici e ogni cappella aveva le sue dotazioni. Anche la biblioteca era molto ricca, nel 1489 erano attestati (un documento lo prova) quasi mille codici miniati ma purtroppo la biblioteca fu distrutta quando fu costruita piazza Stazione nel 1800. Il convento di S.M. Novella subì la stessa sorte di tutti gli altri conventi a causa delle soppressioni. La prima soppressione avvenne con Pietro Leopoldo che fece chiudere altri conventi (però non S.M.N) anche perché i religiosi erano calati di numero e riutilizzò molti edifici religiosi per altre scopi come nel caso dell'Accademia delle Belle Arti, scuole e ospedali. La soppressione più problematica fu quella del 1808 nell'epoca napoleonica perché non solo furono chiusi i conventi ma furono soppressi gli ordini religiosi causando la chiusura e la spoliazione dei conventi e delle chiese. La seconda grave soppressione è dovuta al regno d'Italia nel 1866 con i Savoia. In queste due occasioni furono razziati i libri della biblioteca domenicana e anche molti arredi liturgici. Fortunatamente a Firenze a differenza di altri luoghi, il forte legame dei fiorentini con la propria città limitò il problema della spoliazione evitando così che tutto questo patrimonio potesse andare disperso. Nell'interno del convento si trova l'appartamento papale costruito nel '400 e al quale lavorò anche Donatello. Fu costruito per ospitare il Papa a Firenze perché nel medioevo il Papa, prima della
costruzione di tale appartamento, veniva ospitato dalle famiglie private (ad esempio la famiglia dei Mozzi) che avevano un palazzo adeguato a ospitare una persona così importante. Fu scelto questo convento perché era il più grande, il più ricco e perché il legame con il papa era molto forte, non a caso era stato il Papa stesso che conferì il ruolo di inquisitori ai domenicani. In questo appartamento nel '400 vi soggiornarono due Papi, prima Martino V, che nel 1420 consacrò la basilica, e poi anche Niccolò V nell'epoca del Concilio di Firenze che si tenne nel 1439 S.M. Novella. La parte architettonica di questi ambienti è tipicamente trecentesca ed è del frate domenicano Iacopo Talenti da Nipozzano, l'architetto più importante che portò a termine tutti gli ambienti della chiesa, del convento e progettò anche il Cappellone degli Spagnoli mentre Leon Battista Alberti fu l'architetto che disegnò la facciata. La parete del refettorio è ornata con un affresco un po' strano perché vi è una parte trecentesca e una cinquecentesca; questo è dovuto al fatto, che in origine vi era l'affresco di Taddeo Gaddi con la “Madonna in Trono con i Santi”, affresco che fu poi coperto nel '500 per un'opera di rimodernamento con una tela raffigurante “l'Ultima Cena” intorno alla quale Allori aveva fatto una specie di incorniciatura e successivamente allo spostamento della tela venne scoperto l'affresco sottostante di Gaddi. Questa è una cosa molto interessante perché mostra, come nel passato, quando non era necessario non si distruggeva un affresco ma si copriva. Qui c'è un “Polittico” di Bernardo Daddi (La Madonna con bambino in trono e Santi) che si trovava nella Cappella del Capitolo, Cappella che poi venne ricostruita nella metà del '300 molto più ampia. Il Polittico è datato 1344 più antico del Cappellone degli Spagnoli che era il Capitolo del convento iniziato nel 1350. Il Polittico fu tolto e ricollocato. La chiesa di Santa Maria Novella è in stile gotico e di ispirazione cistercense perché la pianta è a forma di T come la chiesa di Santa Croce. Tra questi ordini di frati e in particolar modo i domenicani c'erano dei legami molto stretti con la Francia perché da sempre è stata la Paladina della chiesa cattolica di Roma, fino all'inversione di rotta di Napoleone. Ad eccezione di Carlo V che si oppose alla chiesa cattolica di Roma i re francesi furono sempre considerati paladini della chiesa ed anche da questo si evince l'influenza francese nell'architettura come ad esempio la struttura della pianta della chiesa a tao (T). Il Cappellone degli Spagnoli è la Cappella del Capitolo. Il Capitolo era una sala che serviva alla comunità dei frati per i loro incontri, per le loro confessioni pubbliche chiedendo perdono reciprocamente e anche il luogo dove venivano prese le decisioni relative a tutte le attività del convento. Venne costruito da Iacopo Talenti probabilmente nel 1350 – 1355 con un lascito fatto da Buonamico dei Guidalotti, mercante, che aveva perso sua moglie nella grande peste del 1348. Buonamico aveva lasciato in testamento una ingente somma per la costruzione della Cappella del Capitolo che poteva usare anche come cappella privata potendovi seppellire i membri della propria famiglia. Tutti gli ambienti delle chiese e conventi erano all'epoca di patronato cioè erano in usufrutto alle famiglie che potevano seppellirci i loro cari. Buonamico aveva lasciato i soldi per costruire la cappella del Capitolo in memoria della moglie morta nella peste e pochi anni dopo mori anche lui; lasciò inoltre i soldi anche per la decorazione della cappella che venne affrescata nel 1365. Oggi sono stati ritrovati i documenti nei quali si attesta che gli affreschi furono fatti da Andrea Buonaiuti (detto Andrea da Firenze) ma precedentemente a tale scoperta avvenuta alla fine del '800, furono attribuiti a pittori senesi e addirittura fu stato fatto il nome di Simone Martini perché lo stile è un tardo gotico ed è quindi molto più vicino allo stile di Siena che a quello fiorentino.
Andrea Buonaiuti era un pittore nato a Firenze, per questo il nome Andrea da Firenze, era matricolato nell'arte dei Medici e degli Speziali però di cultura senese e per questo è un altro elemento che attesta la vicinanza fra l'ordine domenicano e Siena che era molto legata alla Francia. Il nome Cappellone degli Spagnoli arriva nel '500 quando la duchessa Eleonora di Toledo, che era spagnola, concesse al suo seguito di spagnoli questa cappella per celebrare la messa. A quel tempo la cappella fu intitolata a San Iacopo di Compostela, protettore della Spagna, e il nome è più tardo ed è legato ad una tradizione cinquecentesca. Gli affreschi sono molto ben conservati, sono molto famosi e danno tanti spunti di lettura e sono la glorificazione e il trionfo dell'ordine domenicano e del ruolo che avevano come frati predicatori contro l'eresia. Sono stati dipinti nel 1365, anno in cui il Papa non risiedeva a Roma ma ad Avignone. Il '300 sono gli anni di Dante, di Boccaccio, di Petrarca e della cattività avignonese che dura quasi tutto il secolo perché il papa Onorio V, che era francese andò ad Avignone nel 1307 fino al 1377, e furono anni di lotte furibonde fra il Papa e il Re di Francia ed anche con l'Imperatore. Il protagonista laico fu il Re di Francia, nel 1314 era Filippo il Bello, fece eleggere un Papa francese per poterlo portare in Francia, provocò il famoso schiaffo di Anagni contro Urbano VIII, ottenne da Onorio V (papa di sua creazione) non solo il trasferimento della sede papale ad Avignone, ma anche l'abrogazione dell'ordine dei cavalieri templari in modo da poter incorporare i beni materiali (si dicevano che erano inestimabili) nelle tasse della Francia, coinvolta in tante guerre e lotte e così bisognosa di soldi. Filippo il Bello fu avversario della chiesa ma anche un abile politico che sfruttò la chiesa e riuscì a sottomettere il potere religioso del Papa. Gli affreschi sono del 1365, Filippo il Bello muore nel 1314, ciò nonostante vi era ancora una grande influenza della Francia sulla chiesa e i domenicani erano i predicatore e i milites (soldati) che dovevano proteggere la chiesa cattolica dall'eresie. Negli affreschi sono rappresentati il trionfo di San Tommaso e il trionfo della chiesa dei domenicani nella chiesa militante. Un personaggio molto importante per il ritorno del papa a Roma fu Santa Caterina da Siena che scrisse una lettera al papa e lo convinse a ritornare; Siena in questi anni del '300 fu una città molto importante mentre Roma era in un periodo di decadenza, tanto che quando il papa ritornò dovettero ricostruire tutto perché molte cose (il laterano) erano state distrutte o incendiate dalle insurrezioni popolari. Le città di Siena e Firenze erano molto ricche in virtù del commercio ma che poi erano al contempo profondamente legate a questi intrighi politici di livello internazionale. Simone Martini aveva lavorato alla corte dei papi ad Avignone dove aveva conosciuto Petrarca, con il quale aveva rapporti molto stretti, per lo stesso aveva miniato la copertina del codice Virgiliano, e pur quanto tali rapporti a noi possano apparire come opere d'arte celano in sottofondo dei veri e propri rapporti politici. Il Cappellone degli Spagnoli è un ambiente molto grande con un'aula rettangolare, quasi quadrata con i costoloni, è quasi tutta affrescata e sono ben conservati ed è documentato che l'architetto è Iacopo Talenti da Nipozzano. È stata ricavata una scarsella nella prima metà del '600 dove era stato collocato il Polittico di Bernardo Daddi che manca dal museo e che era collocato qua fino a due anni fa. Gli affreschi sono del Pozzetti e dell'Allori. L'arco, non è certo, forse è stato un po' ampliato e per far questo sembra che sia stato tagliato un piccolo pezzo dell'affresco superiore, si tratterebbe solo una piccola parte perché si voleva mantenere l'affresco e la sua leggibilità. Sulla parete di fronte all'ingresso abbiamo l'affresco della Crocifissione, a sinistra la Salita al
Calvario e a destra la Discesa di Cristo al limbo quindi. In ordine logico si inizia con la Salita al Calvario, poi la Crocifissione e infine la Discesa di Cristo al limbo. Dopo la resurrezione, secondo i vangeli apocrifi, Cristo scese al limbo e portò in Paradiso tutti i patriarchi, San Giovanni Battista e tutti quei personaggi dell'antico Testamento e anche inizio del Nuovo che erano stati messi nel limbo. Di questo, ci da testimonianza anche Dante nella Divina Commedia, i giusti non avevano conosciuto la rivelazione di Cristo, la chiesa e la fede cristiana perché vissuti prima della Sua nascita quindi per tale ragione non erano stati collocati nell'inferno ma nel limbo che una sorta di pre-paradiso. Nel '300 erano molto usati i vangeli apocrifi per gli affreschi anche a Santa Croce.
(Andrea di Bonaiuto, Salita al Calvario, Crocefissione e Discesa di Cristo al Limbo, 1365-68, affresco )
Dall'altra parte c'è “Il trionfo di San Tommaso d'Aquino” seduto in cattedra proprio come un professore allo studio, ai lati ci sono i patriarchi, nel cielo rossastro (perché sono andati persi i lapislazzuli) ci sono le virtù teologali e le virtù cardinali (fede, speranza, carità, giustizia, fortezza, prudenza e temperanza), ci sono i profeti santi e patriarchi, che hanno segnato il camino ed i dogmi per la chiesa. Sotto San Tommaso, accovacciati, ci sono i grandi eretici sconfitti: Ario, Averroè e Sabellio. Ario fu il fondatore dell'arianesimo, dottrina che asseriva che la natura di Cristo non era divina ma sì umana e quindi di stirpe reale e non divina. In passato molti popoli barbarici erano stati convertiti al cristianesimo secondo la dottrina di Ario e furono poi riconvertiti nuovamente secondo il cattolicesimo, sviluppo più tardo fu quello dei popoli germanici che hanno seguito l'ideologia nazista (la pura razza). Averroè era un dotto spagnolo che diceva che i sacramenti non avevano valore intrinseco ma che erano simbolici. Accanto a lui si trovano, da sinistra a destra, Giobbe, Davide, Paolo, Marco evangelista, Giovanni evangelista, Matteo evangelista, Luca evangelista, Mosè, Isaia e Salomone. Nel registro inferiore si trovano quattordici stalli decorati in stile gotico nei quali siedono le personificazioni muliebri delle sacre scienze (i sette a destra) e delle arti liberali (i sette a sinistra), ai piedi di ciascuna delle quali si trova un illustre rappresentante. Ciascuna di esse è protetta da un pianeta, secondo una tradizione pitagorica ripresa nel medioevo da Michele Scoto, san Tommaso d'Aquino e Dante.
Si allineano così da sinistra: 1. La Legge civile e Giustiniano 2. La Legge canonica e Clemente V 3. La Filosofia e Aristotele 4. La Sacra Scrittura e san Girolamo 5. La Teologia e san Giovanni Damasceno 6. La Contemplazione e san Dionigi Aeropagita 7. La Predicazione e sant'Agostino 8. L'Aritmetica e Pitagora 9. La Geometria e Euclide 10. L'Astronomia e Tolomeo (l'astronomo confuso, come al solito, col sovrano, infatti ha la corona) 11. La Musica e Tubalcain 12. La Dialettica e Pietro Ispano (in alto nel timpano Mercurio nelle vesti del dio babilonese Nabu, inventore della scrittura e protettore dei mestieri ad essa collegati 13. La Retorica, col cartiglio, e Cicerone in abiti romani 14. La Grammatica, accompagnata da giovani scolari, e Prisciano di Cesarea
(Andrea di Bonaiuto, Trionfo di San Tommaso d'Aquino, 1365-68, affresco)
Nell'altra parete si può ammirare il “Trionfo dell'ordine domenicano” con un'ambientazione straordinaria perché, non è solo il trionfo dell'ordine domenicano, ma soprattutto della chiesa dei militanti (la chiesa cattolica romana). La chiesa viene rappresenta da un edificio, il Duomo di Firenze, in questo caso come un edificio universale della chiesa e importante notare come questa rappresentazione ci testimonia uno dei vari concorsi per la costruzione della chiesa e della cupola. Siamo nel 1365 e Brunelleschi ancora non era nato ma già dalla epoca di Arnolfo c'era il progetto di completare la costruzione della cattedrale con la cupola e questa è la versione di Andrea Bonaiuto, che come architetto presentò un progetto per la cupola che era irrealizzabile. All'esterno della chiesa in muratura c'è la chiesa fatta delle persone; al centro il papa (alcuni dicono di essere papa Onorio altri di essere un papa successivo), alla destra un cardinale con il cappello rosso, alla sua sinistra c'è l'imperatore con la spada; sono seduti quasi allo stesso livello del Papa, in ordine Papa, Imperatore e Vescovo a secondo del grado di d'importanza. Il Papa, più in alto, rappresenta il potere spirituale che deve essere superiore a tutto. Accanto all'imperatore ci sono altre due personaggi regali, uno ha il globo in mano, simbolo del potere temporale, e l'altro con la spada, dovrebbe essere il re di Francia (perché deve difendere il papa e la chiesa), sulla sinistra ci sono un vescovo e tutti gli ordini dei frati e dei monaci
(francescani, domenicani, benedettini) tutto il popolo dei fedeli religiosi. Sulla destra, invece, ci sono i popoli dei fedeli non religiosi, donne, uomini, mendicanti, poveri, ricchi (vestiti con la pelliccia), e uno che porge il libro che dovrebbe essere Dante Alighieri (vestito di rosso), proprio a rappresentare l'universalità della chiesa (secondo anche altre interpretazioni dovrebbero esserci anche Petrarca e Boccaccio). Ci sono degli agnelli, la figura dell'agnello allude al sacrificio di Cristo e a Firenze è anche il simbolo dell'arte della lana, ci sono dei cani bianchi e neri, quelli ai piedi del Papa sono tranquilli e gli altri che si avventano sui lupi sono I DOMINI CANIS (il cane di Dio) che contrastano e vanno a caccia dell'eresia iconografata nei lupi rappresentando quindi la missione data dalla chiesa ai domenicani. Viene rappresentato San Domenico che contando sulle dita (famoso sillogismo - quando una persona spiega enumerando le ragioni) spiega le ragioni della chiesa ad un gruppo di eretici riportandoli sulla retta via e gli eretici strappano i fogli dei libri eretici. Nella parte in alto è visibile una rappresentazione ambientata in un giardino con le varie attività della popolazione come fanciulle che danzano, suonatori e persone che raccolgono frutti dagli alberi. In questo caso sono rappresentati i piaceri della vita ma anche il dover render conto delle azioni umane infatti al centro c'è un frate domenicano che confessa un fedele e un altro frate che fa da tramite tra il mondo dei vivi e il mondo ultraterreno, dietro questo frate c'è San Pietro insieme agli angeli alla Porta del Paradiso mettendo le corone ai fedeli buoni (che si sono confessati e pentiti degli errori) che entrano in paradiso e questo mostra la via della salvezza attraverso la chiesa e attraverso i frati domenicani.
(Andrea di Bonaiuto, Esaltazione dell'ordine domenicano (La Chiesa militante e trionfante), 1365-68, affresco)
Nel soffitto ci sono: la resurrezione, la navicella, la pentecoste e l'ascensione.
Sulla parete di fronte abbiamo la Crocifissione seguita dalla Resurrezione, nell'altra parte la chiesa militante e l'affresco rappresenta la Navicella, dipinto da Giotto nell'antica San Pietro a Roma. La navicella è tratta dal vangelo ed era una nave in pericolo a causa della tempesta, Gesù camminando sulle acque salvò la navicella e San Pietro. La nave rappresenta la chiesa, Gesù il Salvatore e San Pietro il suo successore, questo è il simbolo della missione che Gesù da a San Pietro come capo della chiesa. Sull'altra parete c'è il trionfo di San Tommaso e nella volta la pentecoste – la discesa dello Spirito Santo – che è la sapienza divina che scende sui cristiani, la sapienza divina è quella che permette a San Tommaso di insegnare il cammino. Nell'altra volta abbiamo l'ascensione quando Cristo sale definitivamente al cielo e lascia la Madonna e i dodici apostoli e in corrispondenza sulla parete c'è l'affresco, mutilato, con tante figure di domenicani e il protagonista a predicare dal pulpito è San Pietro Martire (martirizzato dopo il 1244). Ci sono anche il suo martirio e i miracoli fatti da lui tra cui anche una resurrezione di una fanciulla. San Pietro era conosciuto per il potere taumaturgico di sanare le malattie e resuscitare, è diventato il santo patrono della farmacia di S. M. Novella e dopo si aggiunse a lui Santa Rosa da Lima, la prima santa del nuovo mondo (è una santa del Perù nel '600). Salita di Cristo al Calvario Gesù è rappresentato con la tunica rossa che era il colore regale, portando la croce con un'espressione molto triste, e guardando indietro dove ci sono Maria la Madonna, vestita di azzurro,
Maria Maddalena, vestita di rosso e due bambini (che sono presenti anche alla base della crocifissione), che secondo alcuni studiosi sono i figli di Gesù con Maria Maddalena ma c'è anche chi dice che secondo la tradizione la Maddalena aveva abbandonato la Palestina con i figli e era andata in Francia, era arrivata a Marsiglia ed è stata sepolta a “Saintes-Maries-de-la-Mer” dove esiste il santuario dedicato a lei. Secondo altri ancora questi non sono i veri figli sono soltanto una simbologia dei poteri spirituale e temporale che si uniscono in Cristo ma che dopo si dividono, teorie fatte dopo l'epoca di Dante dove il papa aveva il potere spirituale e il re o l'imperatore aveva il potere temporale quindi erano figli della chiesa e di Cristo, così la chiesa era sempre al di sopra di tutto. Questa rappresentazione quasi non si trova, c'è in un altro polittico fatto da Simone Martini precedente a questi affreschi, nella seconda metà del '300 fatto per Napoleone Orsini che era cardinale d'Avignone.
Questa parte dalla chiesa non era aperta al pubblico ma solo frati, che erano molto colti e preparati erano capaci di capire queste raffigurazioni; ed in chiesa ci sono altri tipi di rappresentazioni destinate proprio ai fedeli, di più facile comprensione. Nel Capellone degli Spagnoli dove c’è la raffigurazione della Cattedrale di Santa Maria Novella. Sulla sinistra c’è un pezzettino di campanile di Giotto che è un inserto del 1700 dipinto dal restauratore. Consiglio pratico: quando è aperto l’ingresso dove ora ci sono i lavori, si entra dal cimitero. Normalmente si fa la visita della chiesa e poi si entra nel chiostro e si esce dalla sinistra. Ora abbiamo fatto il contrario. L’attuale chiesa di Santa Maria Novella è una chiesa gotica. La prima pietra fu benedetta nel 1279. Nel corso del 1300 la chiesa fu completata e la chiesa pronta fu consacrata nel 1420. È una chiesa molto grande a forma di T con tre navate con volte a crociera con costoloni di impianto cistercense, perché l’abside non è semicircolare ma è quadrata. La caratteristica di questa chiesa è che la distanza fra i pilastri delle campate è variabile. Lo schema è BAABCCAB. L’A è la più grande è sono la seconda e la terza campata. Le prime sono un pochino più piccole. Poi ci sono due molto più piccole e le altre due riprendono lo schema delle prime due comprendendo anche l’abside. Questo schema è fatto a posta. Quando entri dalla porta da dove normalmente si entra, crea un effetto di fuga prospettica verso l’abside. Sembra più lunga di quello che è. è un effetto ottico fatto falle campate di lunghezza diversa. Le ultime che corrispondono all'alzamento del pavimento sono molto più strette delle altre.
In origine la chiesa conventuale aveva il tramezzo dove ora ci sono i due gradini come tutte le chiese. A San Miniato esiste ancora, era talmente bello che non fu distrutto, anche perché era decentrata. Nel 1500 subirono questo cambiamento, spesso fatto da Giorgio Vasari come anche qui. Il tramezzo divideva l’aula riservato ai fedeli dallo spazio riservato ai religiosi, ai frati in questo caso. Il tramezzo era abbastanza alto e on si vedeva l’abside come si vede oggi. La croce di Giotto che ora vediamo qui, per tanti anni è stata nella controfacciata, poi in sagrestia, ed emblematicamente (non è sicuro) era collocata nel tramezzo. Davanti agli affreschi di Assisi c’è un crocifisso appeso uguale. Nelle navate laterali c’erano degli antichi altari che furono rinnovati da Giorgio Vasari. Gli altari vasariano furono sostituiti nel 1800 da questi odierni altari che nell’idea dell’epoca dovevano essere neogotici. Con questo cambiamento si voleva restituire alla chiesa l’aspetto originale. All’interno degli altari ci sono comunque le tele della scuola vasariana, di tutti i pittori che ci lavorarono nella seconda metà del 1500. Nella chiesa originale si entrava dall’ingresso laterale. La Trinità di Masaccio si trova di fronte all’ingresso laterale. Lì c’era naturalmente un altro altare vasariano con la Madonna del Rosario che ora si trova in un'altra cappella. Le vetrate delle navate non sono antiche, sono dei primi del 1900, perché in parte sono andate distrutte. Quelle del rosone e delle cappelle della parte del transetto del coro sono antiche.
Quello del rosone è molto bella ed è stata realizzata su disegno di Andrea di Buonaiuti. Di questo abbiamo documenti per Taddeino dei Ricci. La famiglia dei Ricci di mercanti molto importanti. Taddeino aveva lasciato per testamento nel 1362 dei denari per realizzare l’occhio della facciata. Al centro del rosone c’è l’incoronazione della Vergine. Nelle storie laterali ci sono i cori degli angeli. Nella fetta in basso a sinistra ci sono tre fette (ogni quarto è diviso in tre parti). Nel quarto superiore nella cornice sono rappresentati quattro ricci nel tondino > lo stemma parlante della famiglia Ricci. Nella stessa fetta sono rappresentati gli angeli in piedi, ma c’è una figura inginocchiata (vestito di azzurro) e tagliata dal taglio tra due pezzi delle vetrata > Taddeino dei Ricci. Al trecento risalgono anche l’Annunciazione di Pietro di Miniato e la lunetta della porta interna c’è un presepe che era attribuito alla scuola di Filippo Lippi ma molti lo attribuiscono a Botticelli giovane. Ci sono vari altari cinquecenteschi, Naldini e Macchietti soprattutto. A metà dell’aula riservata ai fedeli c'è il pulpito di Andrea Cavalcanti detto il Buggiano, figlio adottivo di Filippo Brunelleschi. Gli studiosi sostengono che l’esecuzione sia stata di Buggiano ma che il progetto di rilievi con degli fondati prospettici sia di Brunelleschi stesso. Sono dei rilievi curvi perché il pulpito è circolare, di marmo con dorature e rappresentano i fatti della vita di Maria. La chiesa è dedicata alla Madonna e ci sono molto temi mariani.
La Trinità di Masaccio
È stata una riconquista molto importante. Le fonti ne hanno sempre parlato e Vasari stesso la descrive perché l’aveva vista. Si pensava perduta ma nel 1800 durante i restauri per togliere gli altari vasariani sotto l'altare del Rosario fu trovata il dipinto ancora molto ben conservato. Era stato staccato, restaurato e appoggiato nella controfacciata per un periodo. Poi fu ritrovata anche la Morte, cioè la parte in basso con lo scheletro che allude proprio alla sepoltura. Nell’ultimo restauro hanno collocato l’affresco nel posto originale. Tutti gli altari vasariani sono rimasti tranne qui. È un’opera di Masaccio, probabilmente del 1425-27. È uno dei primi esempi dell’architettura prospettica dove Masaccio segue i dettami di Brunelleschi. Secondo Brunelleschi la costruzione dello spazio doveva essere fatta secondo la geometria euclidea con il punto di fuga al centro dove coincidono tutte le linee laterali. Le proporzioni delle figure vengono collocate dentro questo spazio e degradano dalla dimensione più grande frontale alla dimensione più piccola via via verso il punto di fuga. Brunelleschi probabilmente aveva studiato i libri degli antichi, Euclide soprattutto. Lui anche commenta i libri degli antichi. A parte il valore artistico, matematico, geometrico, compositivo c'era anche secondo B una valenza morale nella prospettiva perché è una visione retta, non diverge ma va al punto centrale > sentimento di rettitudine morale. B era un grande lettore e commentatore di sacre scritture, lo chiamavano nuovo San Paolo. Frequentava gli ambienti umanistici, come di Ambrogio Traversari, del primo 1400. Nella prima fase dell’elaborazione della prospettiva c’è anche una forte valenza morale, di rettitudine orale. Masaccio condivideva probabilmente gli stessi argomenti. Lui dipinge una vera e propria cappella dei due donatori, che prima erano considerati di famiglia Lenzi, ora ci sono altre ipotesi, che si trovano all’esterno della cappella. Le loro figure sono grandi ma siccome sono inginocchiate, si dimezzano in proporzioni. In piedi sarebbero state più grandi della Madonna , di San Giovanni e di Gesù > nonostante le proporzioni geometriche e prospettiche si salvaguardia la gerarchia rappresentando queste figure inginocchiate. La cappella è di stile brunelleschiano, sembra di pietra serena e cotto (decorazioni in rosso > marmo rosa o cotto). Soffitto cassettonato a botte che sfonda la parete. La Madonna e San Giovanni Evangelista con la
Trinità (Padre, Figlio, Spirito Santo). Lo Spirito Santo è la colomba bianca che sembra il colletto del Santo Padre. L’origine di rappresentare lo Spirito Santo attraverso la colomba bianca è curiosa. Nel vangelo forse di Matteo si dice che lo Spirito Santo scende su Cristo volando come una colomba. Da lì c’è stata un’interpretazione sbagliata del vangelo > colomba che vola. In realtà non si dice “volando come una colomba”. La colomba è anche il simbolo della pace. La Trinità è un’opera importantissima di pro rinascimento, siamo alle origini fondamenti del rinascimento fiorentino e della prospettiva brunelleschiana. Il crocifisso di Giotto
Anche questa è un’opera giovanile del pittore. Non abbiamo delle date sicure, ma abbiamo un documento > lascito fatto da un signor, di soldi lasciati per mantenere sempre accesa una lanternina sotto il crocifisso dato il 1312. Dallo stile si capisce che è un'opera giovanile, allora si data intorno ai 1290-95. Vicino all’esecuzione degli affreschi di Assisi. è un'opera molto bella, restaurata da poco > sono apparsi dei particolari molto interessanti > il colore della croce, blu cobalto > meglio leggibili nell’aureola di Cristo gli inserti di smalti, di vetri che riflettono la luce. Alla base rappresentato Monte Calvario rappresentato con il teschio di Adamo > la croce di Cristo è simbolo della salvezza, il sacrificio di Cristo porta alla salvezza degli uomini. Secondo la leggenda di Jacopo da Varazze, la leggenda aurea > Croce di Cristo realizzata usando il legno dell'albero che era cresciuto sopra la tomba di Adamo > simbolo di riscatto > Adamo è il primo peccatore > il peccato originale > il suo peccato viene cancellato dal sacrificio di Cristo > la sua croce (simbolo di sacrificio) salva l’umanità. Spesso nell’iconografia medievale ma anche rinascimentale (si trova addirittura a Signorelli) a base della croce c’è il Calvario. Durante il restauro la croce fu ricollocata all'attuale posizione che idealmente riporta la sua collocazione originale sul tramezzo che oggi non c’è più. I due monumenti funebri sono di Stefano Ricci, scultore neoclassico, professore di scultura all’Accademia di Firenze, un seguace di Antonio Canova, il più grande scultore del neoclassicismo. La figura a destra, che sarebbe forse la fede coniugale/legame del matrimonio, assomiglia alla statua Italia di Canova sul monumento funebre di Vittorio Alfieri a Santa Croce. A Ricci si deve anche il monumento di Dante a Santa Croce che forse è il lavoro più brutto che lui abbia fatto. Senatore Ginori e la moglie. Monumento funebre di Signora Villana de’ Botti, poi beatificata > Beata Villana.
A corollario dell’ordine domenicano erano state fondate nel corso degli anni delle cosiddette confraternite o compagnie dei laici. Una molto importante fondata fin dall’inizio era quella delle terziarie domenicane > donne che entravano nell’ordine ma non era consacrate (non erano suore) ma promettevano di seguire una vita religiosa, moralmente retta. Terziarie = persone che non si consacrava ma che seguivano le regole dell'ordine. Nel 1300 tra le terziarie c'è questa signora. Da giovanissima forse avrebbe voluto entrare nell’ordine delle suore ma il suo padre, ricco mercanto, l'aveva fatta sposare con un altro mercante. Faceva una bella vita, ricevimenti ecc. Una volta specchiandosi dallo specchio vide un mostro > lei pensò essere il diavolo. Era un avvertimento di tornare alla vita retta, abbandonare i lussi e di cominciare a fare una vita virtuosa. Lei iniziò a fare penitenza, a fare carità ai poveri, a frequentare le terziarie domenicane e morì in quasi santità. Più tardi venne dichiarata beata. Venne sepolta qui nel 1300 nel monumento funebre di Bernardo Rossellino della metà del 1400. Un monumento un po’ arcaizzante con gli angeli che tengono le tende e questa figura abbastanza rigida > voluto perché Rossellini ha rappresentato un personaggio del 1300 > interessante. Monumento funebre di Beato Giovanni da Salerno che venne da Bologna con i 12 frati e che fondò il convento di SMN (all’epoca Santa Maria fra le Vigne). Il monumento è di Vincenzo Danti, lo scultore della fine 1400, primo 1500 che fede la Decollazione del Battista in bronzo in una delle porte del Battistero. Artista molto avanzato ma anche qui il monumento, anche se molto tardo, ha un aspetto molto arcaizzante perché qui si ritorna addirittura nel 1200. Cappella della Pura, molto bella, rinascimentale, sempre chiusa, aperta per il culto. Tutta restaurata nel 1800 dall’architetto Baccani in stile quattrocentesco. Baccani di solito interviene sempre o in stile neogotico e in stile neorinascimentale. Orientamento della chiesa primitiva > hanno chiesto all’ultimo esame! Si entrava dalla piazza vecchia di Santa Maria Novella. La seconda chiesa documentata, quella romanica, occupava la zona dove oggi c’è la cappella Strozzi e la sagrestia. Oggi la chiesa è una basilica a croce e il transetto è occupato da due grandi cappelle: Cappella Rucellai e Cappella Strozzi. Ci sono più di una cappelle Strozzi ma quella è quella originaria (anche nel chiostro ce n’è una, dove c’è l’affresco dell’Orcagna e dove si trovavano le sepolture). Cappella Rucellai Ancora gli affreschi e Madonna di Nino Pisano. Prima ospitava la famosa Pala di Rucellai di Duccio di Buoninsegna, oggi negli Uffizi. Non è proprietà degli Uffizi ma è solo concessa là.
C’è un bellissimo sarcofago strigilato quattrocentesco > sepolcro di Paolo Rucellai, padre di Giovanni di Paolo Rucellai che ha fatto fare la facciata. Una statua marmorea di Madonna trecentesca di Nino Pisano. La lastra tombale in bronzo (di Ghiberti) in origine stava nella cappella Rucellai ed è della sepoltura di Leonardo Dadi, bibliotecario, studioso dello Scriptorium, dello Studiorium di Santa Maria Novella. Riprende la tipologia delle tombe terragne trecentesche anche se lui muore ai primi dei 1400. La tomba del patriarca di Costantinopoli che morì durante il consiglio di Firenze. Era arrivato a Firenze nel 1439 e morì nel 1440 nel convento durante i lavori e fu sepolto qua. L’affresco con il patriarca rappresentato è attribuito a Beato Angelico, non sappiamo di sicuro. Sembra un’icona bizantina > tipologia di arte orientale > doti bizantini. Un busto di Sant'Antonino Pierozzi, vescovo dell'ordine domenicano. Cappella dove sono sati ritrovati degli affreschi trecenteschi a lungo attribuiti a un maestro bolognese o emiliano Dalmasio degli Scannabecchi > legami stretti anche con Bologna > Beato Giovanni da Salerno venne da Bologna e a Bologna c’era anche università. Archivio: libri che facevano parte della biblioteca sono andati dispersi durante le due soppressioni ma i documenti di archivio di SMN son conservati e sono oggi all’archivio di stato > molto importante perché per esempio l'archivio di Santa Croce ha sempre subito gravissimi danni dalle alluvioni, anche da quella del 1966. Quelli di SMN sono ancora consultabili > fonte inesauribile di documentazioni per attribuzioni e datazioni e per la storia della chiesa. La pala d’altare, Madonna del Rosario, di Giorgio Vasari era stata dipinta per l’altare che copriva la Trinità di Masaccio. Una volta tolta l’altare e lasciato l’affresco in vista, la pala è stata trasportata dove sta oggi. Cappella di Filippo Strozzi (Cappella Strozzi è quell’altra) Voluta da Filippo Strozzi il Vecchio. Il padre era stato esiliato in conseguenza del ritorno di Cosimo il Vecchio a Firenze. Cosimo era stato bandito nel 1433 dai suoi avversari, Albizi e Strozzi. Quando torna a Firenze dopo la revoca del bando e si vendica e fa bandire i suoi avversari politici > Albizi e Strozzi. Palla Strozzi morirà in esilio, il padre Simo pure quando Filippo era bambino. Filippo cresce fuori Firenze perché l’esilio colpiva tutti i maschi, le mogli potevano restare a Firenze. Anche gli Alberti erano in esilio ma poi tornano a Firenze. Strozzi erano una famiglia molto ricca e lui si appoggia ai parenti a Napoli e in Spagna (regno di Napoli era collegato alla Spagna). I cugini che lo proteggono erano banchieri e lui impara il lavoro di banchiere. Dopo la revoca del bando torna a Firenze e ritorna ad essere ricchissimo. Vuole riscattare l’onore della famiglia e acquista questa cappella come nuova cappella di famiglia. Gli Strozzi erano sempre stati sepolti in SMN. Lui acquista una nuova cappella per sé, la moglie e i figli (lui si sposa due volte, prima volta rimane
vedovo). Poco dopo fa un contratto con Filippino Lippi per la decorazione. Filippino Lippi come pittore e Benedetto Damaiano come scultore. La sepoltura di Filippo Strozzi con arcosolio rinascimentale. Medaglione con la Madonna e gli angeli. Il sarcofago di porfido scuro e c’era anche il busto di Filippo Strozzi che venne conversato in Palazzo Strozzi fino alla fine del 1800. Fu venduto dagli Strozzi a Louvre dove si trova oggi. L’attuale direttrice del Bargello, Beatrice Bartolozzi Strozzi è discendente da questa famiglia. La sua nonna era una Strozzi, aveva sposato un Bartolozzi > la famiglia ha conservato il nome Bartolozzi Strozzi. Filippo Strozzi finanziò anche la costruzione del palazzo principesco. Il suo figlio che si chiamava Giovan Battista (1489-1538) ma veniva chiamato Filippo (a lui è dedicato il viale intorno la fortezza da Basso) era un avversario dei Medici che dopo la battaglia di Montemurlo venne incarcerato in carcere della fortezza e si suicidò > per quello a lui è dedicato il viale. Nel contratto da Filippo Strozzi e Filippino Lippi venne stabilito che la cappella viene affrescata con storie di San Giovanni Evangelista e San Filippo > il patrono del proprietario. Lippi era libero di raffigurare le scene ma venne richiesto 1-2 scene di resurrezione > simbolico > cappella funebre. La cappella è abbastanza piccola sicché Lippi può decorare la volta con i patriarchi e due pareti perché la parete di fondo è occupata dalla vetrata, anche disegnata da Filippino di Lippi nel 1502. Il contratto era stato stipulato già alla fine degli anni 80 del 1400 ma allora Lippi era impegnato a Roma con la Cappella di Carafa. I lavori inizia nel 1494. A sinistra la storia di San Giovanni Battista Evangelista. In alto il martirio > la sua martirizzazione > praticamente bollito nel calderone. Ambientazione molto alla romantica, classicità > lo stendardo SPQR, trionfi delle armi appese, il Cesare che comanda la pena. Sotto la Resurrezione di Drusiana. Ambientazione molto bella con tempietto rotondo. Ci sono gli armi degli Strozzi. A destra il martirio di San Filippo e uno dei suoi miracoli > la resurrezione del figlio del re di Ierapoli che era stato ucciso da puzzo del drago che viene fuori dal sotto il tempio. Drago = demonio che esce da un tempio pagano e il suo fetore uccide. E la fede errata uccide il giovane che viene resuscitato da San Filippo. Giorgio Vasari racconta che Filippino Lippi era andato via dicendo al Garzone di finire i lavori. Lui si è messo a fare la merenda. Improvvisamente il maestro rientra e lui per non farsi vedere cerca di nascondere la merenda nel buco del dipinto che sembrava vero. Cappella del coro era di patronato dei Ricci ma nella seconda meta del 1400 loro, quando avevano già fatto la vetrata, erano decaduti e non potevano restaurare la cappella. Giovanni Tornabuoni la comprano. Lui era lo zio di Lorenzo il Magnifico perché la sua sorella Lucrezia Tornabuoni era la sposa di Piero il Gottoso. Giovanni fece nel 1485 un contratto, rimasto, con i Domenico e Davide Ghirlandai per i nuovi affreschi. La cosa più importante era di usare tanto azzurro e oro > ricco. Predispose una somme altissima per oro e lapislazzuli. Soggetto: la vita della Madonna alla quale erano stati dedicati anche gli affreschi precedenti & storie di San Giovanni Battista. I lavori finirono nel 1490. Lavorarono sodo e in tanti, fra i garzoni anche Michelangelo giovanetto. Ce lo dicono Vasari e le fonti. Ha iniziato imparato ad usare i pennelli nella bottega di Ghirlandaio. All'epoca aveva 12-13 anni e è difficile dire dove avesse intervenuto. Qualcuno dice che lui abbia fatto le figure che si sporgono dal muretto, altri invece pensano che possa essere intervenuto nelle figure del battesimo di Cristo > la figura nuda. È da ricordare che Michelangelo inizia come pittore proprio nella cappella del coro di SMN. Gli affreschi sono molto belli, hanno una sfarzosa ambientazione che non storica ma riportata dal committente. I personaggio sono maggiormente ritratti dei personaggi dell'epoca > autoritratto di Ghirlandaio, del suo fratello, cugino ecc. Poi ci sono ambientazioni esterni come la presentazione al tempio di San Gioacchino > sullo sfondo sembra o la loggia di San Paolo che abbiamo di fronte alla chiesa, assomiglia ai loggiati quattrocenteschi fiorentini. O ambientazioni interni con fregi, bassorilievi, decorazioni in legno ecc. La glorificazione di questa grande famiglia strettamente apparentata con dei Medici. I Tornabuoni si riconoscono molto bene. L’Annuncio a Zaccaria: L’angelo, quattro personaggi schierati, l’ultimo a sinistra in rosso (colore dei nobili) è Giovanni Tornabuoni, il fratello di
Lucrezia Tornabuoni che è la signora l'ultima a sinistra. Tutti i due hanno lo stesso naso. Lei si trova nella Visita a Sant'Anna > la terza signora a destra con velo in testa, con il naso un po’ in su e gli occhi un po' miopi che aveva ereditato a Lorenzo che assomigliava alla madre. Le storie iniziano dal basso e vanno verso l'alto. Le storie della Madonna La presentazione di San Giacchino (padre della madonna) al tempio. Lui viene cacciato perché lui e la moglie erano una coppia sterili. Per la mentalità ebraica, la sterilità era una colpa. Devono aver fatto qualcosa di male perché non è stata data la benedizione dei figli. Da San Giaachino e dalla Sant’Anna nasce la Vergine, la Madonna > la nascita della Madonna. Bellissima la bimba. La
presentazione di Maria al tempio. Viene dal vangelo perché nella tradizione ebraica le donne non erano mai presentate al tempio. Lo sposalizio di Maria con San Giuseppe. Sopra la Natività in parte sciupata. Sulla destra la strage degli innocenti. In alto la morte della Madonna e l’assunzione al cielo. In questo caso bisogna dire assunzione perché Maria è portata in cielo dagli angeli con corpo incorrotto > non ha lasciato il suo corpo in terra ma è salita in cielo. Dall’altro lato più o meno gli stessi episodi della vita di San Giovanni Battista L’Annuncio a Zaccaria, il padre di San Giovanni che era il sacerdote del tempio. Gli viene annunciato dall’angelo che avrà un figlio ma lui non crede. Era molto anziano, anche loro con la moglie Elisabetta erano sterile. Per punizione diventa muto fino a quando non deve fare il nome al figlio. Tutto intorno ci sono dei personaggi del Firenze del 1400. A parte i Tornabuoni, ci sono i Medici, Marsilio Ficino, tutte le famiglia importanti ecc. La visitazione, incontro di Elisabetta con la Madonna. La Nascita di San Giovanni Battista, Elisabetta sul letto, vedete come erano le camere da letto dei signori ricchi fiorentini. Bellissima natura morta sui vasi. Le donne che assistono sono tutti ritratti della famiglia Medici e Tornabuoni. L’Imposizione del nome in cui il padre riacquista la parola. In alto predica del Battista e il Battesimo di Gesù. In alto il banchetto di Salomé e la Decollazione. Altre scene con i due donatori: Giovanni Tornabuoni con la moglie. La partenza di
San Giovanni per il deserto. In alto l’uccisione di San Pietro martire. Sopra ci sono i domenicani: la dottrina di San Tommaso. L’Incoronazione della Vergine conclude tutta la cappella della facciata dell'abside. Poi ci sono quattro evangelisti nelle volte. La vetrata su cartone di Domenico Ghirlandaio. Personaggi sono San Tommaso d’Aquino e San Domenico. Poi ci sono San Lorenzo e San Giovanni > due santi legati a questi due famiglie. Giovanni > Giovanni Tornabuoni & la città di Firenze. Lorenzo > Lorenzo il Magnifico. San Pietro e San Paolo > difensori della cristianità. Nella parte centrale sono episodi della vita di Maria: al centro la presentazione di Gesù al tempio, sopra la Vergine che lascia la cintola a San Tommaso, sotto miracolo della Madonna nella neve, il miracolo legato all’iconografia mariana. La cintola = cintura: secondo la tradizione Madonna lasciò la sua cintura a San Tommaso quando fu portata in cielo. La cintola è conservata nel Duomo di Prato. Sono reliquie finte ma hanno avuto così tanta importanza nel corso dei secoli che sono venerate come se fossero vere. Cosa manca in questa cappella? La pala d’altare che era di Ghirlandaio. Secondo Vasari la lasciò incompiuta per la morte. Le date di Ghirlandaio si ricordano bene: 1449-1494. Aveva completato gli affreschi e stava lavorando alla pala finita poi dalla sua bottega. Viene smontata in epoca napoleonica quando il convento venne chiuso per ordine di Napoleone. Nel 1816 venne acquistata dall'Alte Pinakothek di Monaco e anche dal Kaiser Friedrich Museum di Berlino. I tedeschi comprano pezzi della pala d’altare che era grandissima, doppia con due parti centrali con la Madonna in Gloria (seduta sulle nuvole e non in trono) davanti e la Resurrezione di Gesù dietro. Tutta la parte della predella è andata quasi completamente perduta. Quattro santi laterali perlato. Aveva una bellissima cornice in legno dorato di Baccio d’Angolo che è andata persa ma è documentata. Purtroppo due tavolette laterali sono andate distrutte quando il museo Kaiser Friedrich Museum fu bombardato. L’altare del Ghirlandaio viene smontato e dal 1816 venduto in Germania (c’è la documentazione). Nel 1804-5 era già stato sostituito da un altro altare marmoreo di Giuseppe del Rosso (lavorava molto per i granduchi lorenesi) che viene smantellato e sostituito da quello attuale nel 1861 fatto da Enrico Romoli. Molti hanno criticato questo altare.
Vasari descrive Ghirlandaio con molta ammirazione dicendo che fu creato per essere pittore. Della cappella dice che Ghirlandaio condusse a tempere la tavola isolata tutta e che le figure sembrano così vere che gli manca solo la parola. Molto belli sono i sedili intarsiati quattrocenteschi. Cappella Gondi Parati marmori di Giuliano di Sangallo. Il crocifisso è di Brunelleschi, importantissimo > l'unica scultura in legno (in bronzo è rimasta la formella) rimasta di Brunelleschi. Le fonti ricordano anche altre opere in legno, come una Maddalena in legno dipinta che si trovava nell’antica chiesa di Santo Spirito che era bruciata. La sfida tra Brunelleschi e Donatello: c’è chi riconosce il crocifisso di Donatello in quello di Santa Croce nella cappella di Niccolini. Ma ci sono alcuni studiosi che pensano che in realtà il crocifisso a cui Brunelleschi oppose questo qua non è quello di Bosco ai Frati che stava a Santa Croce ma fu successivamente portata a Borso ai Frati, un convento francescano fatto su committenza dei Medici. Sarebbe quel crocifisso, esposto in tante mostre. È molto sofferente come pathos, Cristo nel momento in cui spira, sta morendo. Le misure sono stesse identiche di questo crocifisso di Brunelleschi > questi elementi hanno convinto i studiosi. Brunelleschi critica che Donatello ha messo in croce un contadino. Donatello sfida Brunelleschi a provare a farlo lui stesso. Il Cristo di Brunelleschi è molto composto, mette in evidenza più la sua natura divina che la natura umana. È sulla croce e sta morendo ma il corpo non è corrotto dalla sofferenza e anche il viso è composto in un'espressione molto ideale che umana > deriva dal neoplatonismo di Brunelleschi. Neoplatonismo = il platonismo antico applicato alla religione cristiana. La natura divina di Cristo è molto importante per Brunelleschi mentre Donatello sceglie sempre l'aspetto più umano nelle figure, come nei pulpiti di San Lorenzo > nella resurrezione Gesù ha la faccia distrutta dall'esperienza della morte. Donatello fu sospettato di essere epicureo, cioè di non credere nella resurrezione della carne. I due amici a un certo punto prenderanno due strade diverse, litigano alla Sagrestia Vecchia e iniziano a lavorare separatamente. Probabilmente non era questione di piccole cose > due personaggi con convinzioni completamente diverse legate alla religione. Anche il crocifisso di Santa Croce, che altri studiosi ritengono sia quello della sfida, è molto più realistico rispetto a questo qua. Il crocifisso era stato tutto ridipinto, ora è stato restaurato recentemente ed è stata trovata la cromia originale. Un carnato di color avorio molto delicato con una ferita al costato aperta dalla quale esce il sangue. La datazione è problematica a mancanza di documenti. Qualcuno dice 1410, gli anni i cui Brunelleschi idea la prospettiva. Qualcuno dice 1425, coevo al crocifisso di Trinità di Masaccio. Tutte e due valide. Nella volta della cappella ci sono degli affreschi molto sciupati che sono attribuiti ai maestri greci perché da alcune fonti antiche dicono che uno dei primi interventi della chiesa sono questi affreschi della prima metà del 1300. Non sarebbe una sorpresa perché SMN era una realtà importantissima internazionale: studio, convento, arrivi e partenze di grandi intellettuali domenicani. La sagrestia Le volte sono gotiche ma l’aspetto è proprio barocco. C'è un bel lavabo di Giovanni della Robbia, quattrocentesco. La vetrata tutta trecentesca probabilmente su disegno di Niccolò Gerini tranne il presepe che vedete nascosto dall’angelo dell’armadio. La parte centrale del presepe è fatta nei primi del 1900 dalla vetreria dei Polloni, ancora esistono, molte commissioni di restauri di vetrate. Facevano anche delle vetrate Liberty. L’unica cosa trecentesca rimasta nella sagrestia che originalmente era trecentesca. I quadri sono di scuola vasariana. La vasca è di marmo, altre parti di maiolica. Occupa l’aria dell’antica chiesa, edificata nella metà del 1300 da Talenti per testamento di Mainardo Cavalcanti, siniscalco della regina di Napoli e della Sicilia, la Regina Giovanna. La moglie Andreola era una Acciaiuoli, famiglia importante, padroni della cappella della Spezieria. Cavalcanti fece edificare la sagrestia come cappella mortuaria della propria famiglia. Solo a Firenze anche le
sacrestie sono di patronato di famiglie. Normalmente servono solo per conservare gli oggetti liturgici per la messa e gli abiti dei preti. Era allora costruita sia come sagrestia sia come cappella. Cavalcanti nel suo testamento c’è il lascito sia per la costruzione sia per la decorazione, non con affreschi ma con la vetrata e una pala d'altare che ora si trova ad Accademia di Giovanni del Biondo. La vetrata è ancora qui. Poi c'era il monumento funebre di Mainardo Cavalcanti, andato disperso. Fu spostato per far posto agli armadi, disegnati da Buontalenti nel 1500, per le reliquie. Via via spostando è rimasto disperso. Gli arredi sono rimasti. Nel 1700 furono fatti anche altri armadi in stile rococò in legno di noce con dorature. Il bancone è rimasto ma gli armadi originali quattrocenteschi non ci sono più. Erano armadi intarsiati, con le tipiche tarsie a trompe-l'oeil. Tutti gli arredi liturgici in gran parte sono conservati, altri li avete visti nel museo. Una bellissima porta barocca, tardo manierista disegnata da Fabrizio Boschi. Doveva essere la cornice di un monumento funebre di un altro Cavalcanti che doveva stare all’interno. Aveva commissionato l’opera per essere stato messo dento ma fu riutilizzato come porta d’ingresso per la sagrestia. Cappella Strozzi La prima cappella della famiglia Strozzi trecentesca, ben conservata con gli affreschi della bottega dell’Orcagna, ci lavorò soprattutto il suo fratello Nardo di Cione. Sono ispirati alla Divina Commedia, c’è l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso e il Giudizio Universale. L’iconografia molto particolare perché al centro c’è il Cristo, il redentore. Di solito c’è la Madonna con il Bambino. Ai lati santi domenicani. Gli affreschi avevano subito molti danni perché le pareti sono all'esterno (siamo al transetto) > umidità. In più durante l’alluvione l’acqua non è arrivata là ma l’umidità era alta. Furono staccati, restaurati e ricollocati. Nel 1972 c’è stata una mostra Firenze restaura, la prima dopo l’alluvione, dove c’erano tutte le opere restaurate, anche questo affresco enorme. In confronto di questi affreschi e di quelli che abbiamo visto nel Cappellone degli Spagnoli, questi sono un pochino precedenti. Quelli del Cappellone degli Spagnoli sono del 1365, la distanza di 20 anni. Due botteghe che lavorano più o meno contemporaneamente. Quella di Cione è giottesca > impostazione delle figure molto solida, autoritaria. Lo si vede negli affreschi che sono più mossi perché naturalmente raccontano le storie, ma hanno questa compostezza, questa struttura architettura proprio dei corpi che è molto diversa da quella che abbiamo visto negli affreschi di Andrea Buonaiuti che sono tardo gotici > attenzione ai dettagli, alle pettinature, ai vestiti che qui non c’è. Qui conta più la sostanza che la forma. La pala d’altare è più antica > completa, originale, anche la cornice, documentata da Andrea Orcagna. Tutti i santi più importanti a difesa della chiesa: San Michele con la spada, Santa Caterina d’Alessandria, la Madonna incoronata che presenta San Domenico al Gesù, San Pietro e San Paolo in primo piano a destra, San Pietro inginocchiato con le chiavi, in piedi San Paolo con la spada. Sullo sfondo i santi fiorentini (legati alla città di Firenze): San Lorenzo, San Giovanni Battista. Le storie: la messa di San Domenico da sinistra, la navicella, la morte dell'imperatore Federico che viene salvato (sulla sinistra un angelo con la spada, con la bilancia in mano per misurare l'anima) e che si pende e evita l’inferno. Nella cornice c’è lo stemma degli Strozzi. Questo crocifisso è molto strano. È formato di due parti di due epoche diverse. Una croce è quattrocentesca ma la figura del Cristo probabilmente più tarda, applicata sopra su una croce che era solo una croce. La croce senza il Cristo è di manifattura inglese. Una rarità, difficile trovare delle opere di arte inglese a Firenze. Probabilmente era un dono portato dai fratelli che arrivavano dall'Inghilterra. Sopra la croce inglese è stato applicato il Cristo che è una raffigurazione particolare > porta i segni del flagello ma ci sono le pustole della peste. Tipico a del periodo delle peste che anche Cristo portava i segni della peste. Chiostro verde Le storie della Bibbia, in colore verdastro perché prevaleva questa colorazione. Il rosso dei cieli è caduto. Non ci sono documenti che dicano chi li abbia realizzati. Qualcuno dice che siano di Odelli,
fine Trecento, primi Quattrocento. Anche questi sono stati tutti staccati, restaurati e riattaccati dopo l’alluvione. Sfera armillare e meridiana, 1570 ca. Di Ignazio Danti, astronomo nella corte di Cosimo I. Frate domenicano. Sulla facciata della chiesa ci sono questi strumenti scientifici per la misura del tempo che fanno capire che si trattava di un centro di grande cultura, anche di scienza, e non solo teologia. Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella Il famoso pot-pourri di foglie secche dei fiori delle colline fiorentine > profumo di SMN. Il complessa di SMN a parte alcune parti è ben conservato, anche le opere maggiormente. Non c’è più lo Studiorium, la parte della scuola, lo Sciptorium. Fortunatamente è rimasta la farmacia perché molte volte alla chiusura del convento vengono chiuse tutte le parti accessorie. La farmacia risale alla formazione del convento. Il convento era molto grande, alcuni frati ci abitavano fissi, alcuni venivano e andavano. C'era un’infermeria, un tipo di ospedale per i frati malati, da queste parti, verso via della Scala. C’erano anche tutti gli orti dei frati e il giardino dei semplici dove coltivano le piante medicinali. C’era una vigna di uva luglina, precoce che maturava a luglio invece di settembre o ottobre. Questa uva pare che avesse proprietà miracolosi e curò Niccolò Accaiuoli. Una volta guarito attribuiva la guarigione a questo succo dell’uva dei frati di SMN e destinò un ingente somma per la costruzione di una cappella per i malati di infermeria che non avevano una cappella ma andavano nelle celebrazioni nella chiesa. L’attuale sala di vendita della farmacia era in origine una cappella dell’infermeria della chiesa, dedicata a San Pietro martire e successivamente a Santa Rosa da Lima. L'architetto fu Iacopo Talenti. C’erano gli affreschi di Spinello Aretino. Lo dice Vasari che però già nel 1500 scrisse che erano quasi tutti guasti. Alla cappella di San Nicola fu annessa una piccola sagrestia, che ancora c’è con gli affreschi attribuiti a Mariotto di Nardo, seguace di Spinello Aretino. La grande cappella aveva due campate è stata nel 1800 trasformata in sala di vendita ma la sagrestia è rimasta e gli affreschi sono ancora visibili. Storie di Cristo e della Passione: la lavanda dei piedi, l'ultima cena ecc. Storie della Maddalena. La storia della farmacia è molto lunga. Un’erboristeria esisteva già nel Medioevo perché era predisposto al lato dell’infermeria. Si curava con le erbe e le materie naturali. Una notizia certa risale al 1389 e riguarda la produzione di pseudofarmaci > una ricetta di acqua di rose > uno dei primi prodotti. Dal 1457 sono testimoniate le attività di distillazione. Le acque venivano prodotte mettendo a macerare i fiori o le foglie nell’acqua e nell’alcol e poi venivano distillate. Lo stesso metodo si usa per fare i profumi. C’erano gli apparati di distillazione. Il primo libro di contabilità risale al 1542. Questi documenti attestano che c’era un'attività di farmacia ormai ben stabilita. L’attività non riguardava solo i ricoverati nell'infermeria ma anche gli esterni. Persone come appunto gli Acciaiuoli venivano ad acquistare farmaci, medicamenti o profumi. Nel 1600 fu aperto questo corridoio di accesso dalla via della Scala perché i frati non volevano che la gente entrasse dal chiostro. La farmacia ormai era diventata grande e vendeva al pubblico e fu aperto questo ingresso laterale, tutto ristrutturato nel 1800. Tutti i direttori della farmacia sono frati domenicani. Per esempio uno dei più importanti è stato Fra Angelo di Marchissi che iniziò nel 1592. Altri Gian Domenico Cavalieri, Angelo Paladini. Nel 1716-88 Cosimo Buccelli, inventore dell'Alkermes, liquore famosissimo inventato qui, miscela di tante erbe, con colorante rosso, uno dei liquori di base della zuppa inglese. Fra Tommaso Valori che nel 1813 acquistò la farmacia. Cosa succede? La soppressione da parte di Napoleone riguardava tutto il complesso. Ma la farmacia era così importante, rinomata e utile che si decide di non chiuderla. Per renderlo possibile fra Tommaso Valori l’acquista e dopo l'epoca napoleonica la dona di nuovo al convento nel 1817. Fra Damiano Beni, l’ultimo frate direttore della farmacia. I tempi cambiano, c’è la soppressione
sabauda ma la farmacia viene salvata. Nel 1847 la cappella è trasformata in sala di vendita. Il nipote di Fra Damiano Beni diventa il primo direttore laico della farmacia, si chiama Cesare Augusto Stefani. Ci sono profumi che prendono il nome da lui perché lui era anche un alchimista. La farmacia rimane la proprietà della famiglia Stefani, oggi forse è una società. Fino a pochi anni fa i direttori erano i discendenti di Stefani. Hanno mantenuto un’attività di tutta la farmacia con le antiche ricette di Santa Maria Novella, tutto a base naturale: erbe, fiori, estratti vegetali. Si dice che la ricetta di alcuni profumi fosse stata carpita durante le torture delle inquisizioni. Era una farmacia famosissima dove si producevano dei profumi di cui uno per esempio fu inventato Caterina dei Medici, c’è ancora. Qui ci sono solo prodotti di Santa Maria Novella, niente altro. Qui non c’è più l’orto o il giardino dei semplici, vengono prodotti in altri luoghi, ma sempre secondo le ricette di SMN. Alcune attrice comprano le loro creme qui, sono dei prodotti ottimi. Quelli caratteristici, storici sono l’Alkermes, alcuni profumi, l’acqua di rose, l’acqua antisterica che serviva per le signore che svenivano per far le rivenire. Gli affreschi sul soffitto risalgono all’intorno al 1847 e sono di Paulino Sarti, pittore del 1800 non molto rinomato ma piuttosto bravo. Rappresentano i quattro continenti: Europa, Africa, Asia, America. Gli armadi sono tutti in stile neogotico, in legno, realizzati nel 1800, come anche tutte le decorazioni in stucco. Ci sono tutti i ritratti dei direttori della farmacia. C’è una bellissima collezione di vasi antichi prodotti a Montelupo. Le manifatture ceramiche di Montelupo fornivano tutto il vasellame per SMN. Lo stemma della chiesa: ovale nero con il triangolino bianco. Questi vasi, i piccoli orci, sono caratteristici perché rispecchiano la tipologia inventata nel 1500 con le candelabre rafaellesche > le decorazioni festoni, uccellini ecc. > raffaellesche perché nelle grottesche di Raffaello c’erano gli stessi motivi. Anche nella ceramica di Urbino si può trovare questo tipo di decorazione. Un'altra caratteristica sono i manici a forma di delfino. L'altro tipo di vaso più cilindrico si chiama l'albarello > per conservare le essenze o liquide o solide.