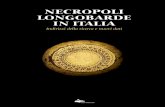Evoluzione del danneggiamento nelle ghise sferoidali durante la propagazione di cricche di fatica
La ceramica nel castello di Rontana. Evoluzione e trasformazione della cultura materiale tra...
Transcript of La ceramica nel castello di Rontana. Evoluzione e trasformazione della cultura materiale tra...
Introduzione
Le indagini archeologiche all’interno del-l’area del castello di Rontana hanno avutoinizio nell’autunno del 20071, concentrandosiinizialmente nella zona sommitale del sitocon lo scopo di individuare le tracce più an-tiche dell’insediamento (fig.1). L’esistenza delcastrum è testimoniata dalle fonti scritte, in par-ticolare da un contratto agrario che lo cita nel960 in relazione alla Pieve di Santa Maria,compresa al suo interno2. La storia del ca-stello di Rontana ci racconta di vicende sto-riche intricate, che lo vedono appartenere inorigine ad Ugone di Rontana, per entrare trai possedimenti della Chiesa di Ravenna, delComune di Faenza, della famiglia Manfredi edella repubblica veneziana, fino alla sua di-struzione nel 1591 per ordinanza di Grego-rio XIV3.
Il sito si trova sulla sommità di uno dei piùimportanti rilievi della riva settentrionale delLamone4, il monte Rontana, in una posizionedi controllo dell’asse viario che collegava Ra-venna con Firenze e Lucca e che intersecavala via Emilia, passando per Faenza.
Il Castello di Rontana è stato sinora og-getto di quattro campagne di scavo e la mag-gior parte dei reperti rinvenuti è riferibile allefasi di abbandono del sito.
Questo progetto offre una buona possibi-lità per verificare le dinamiche dell’incastella-mento in Romagna, soprattutto attraversol’analisi della cultura materiale, in particolarmodo la ceramica5. L’indagine del settore
1000, corrispondente all’area sommitale delsito, ha portato ad uno dei ritrovamenti più in-teressanti nella storia degli scavi del castello.Durante l’autunno del 2008 si è proceduto alleoperazioni di recupero dei materiali conser-vati all’interno del pozzo, situato nell’area cor-tilizia6. Si tratta di un pozzo “alla veneziana”
1 Le indagini archeologiche sono condotte dal prof.
Andrea Augenti e dal dott. Enrico Cirelli del Dipartimento
di Archeologia di Bologna, sede di Ravenna. Le ricerche
sono state possibili grazie al sostegno del Comune di Bri-
sighella, del Parco Regionale della Vena del Gesso Roma-
gnola e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.
2 BENERICETTI 2002, pp. 38-42.
3 BERARDI et al. 1970.
4 BERARDI et al. 1970.
5 AUGENTI et al. 2009a; AUGENTI et ali 2009b; CI-
RELLI 2010
6 Le operazioni di scavo sono state possibili grazie
all’aiuto di un gruppo di speleologi e volontari della
zona guidati da Ivano Fabbri
77
La ceramica nel castello di Rontana. Evoluzione e trasformazione della cultura materiale tra medioevo e rinascimento
ELVIRA LO MELE
Fig. 1 - Planimetria dello scavo.
(fig. 2), un sistema di raccolta e depurazionedelle acque che si afferma in Romagna neltardo Medioevo, ma che è già diffuso in areaalto adriatica a partire dalla fine del X secolo7.Tale struttura era articolata in due cisterne co-perte da volte in mattoni separate da tre pozziverticali di forma troncoconica che raggiun-gono una profondità di 7-8 metri. All’internodelle due cisterne, l’acqua piovana veniva de-purata da un deposito di sabbia fluviale e poiraccolta nel pozzo centrale.8
L’esame del materiale proveniente dal ca-stello di Rontana diventa un importante puntodi partenza per lo studio del vasellame pre-sente nei siti fortificati della regione, per iquali non si hanno ancora purtroppo deglistudi quantitativi puntuali. Tuttavia in questocontributo faremo riferimento alle diverse in-formazioni pubblicate in varie edizioni di la-vori di restauro e o di scavo di emergenzacondotti in questo territorio per poterne deli-neare un quadro delle trasformazioni chehanno interessato tali produzioni tra Me-dioevo e Rinascimento nella regione, coinvol-gendo la cultura materiale del sito di Rontana,
che diventa così caso e modello di studio.Analisi del materialeUno dei primi elementi che emerge ad
una prima analisi è sicuramente la scarsaquantità di vasellame fine da mensa, anchenelle cosiddette aree a carattere privilegiato,nella metà del X secolo. Ad esempio a diffe-renza delle zone costiere dove sono molto dif-fuse, non sono presenti ceramiche del tipo“Sant’Alberto”. Questo vasellame difatti risultadistribuito solo in contesti urbani e contesti ru-rali che si trovano su grandi vie di comunica-zione, sia fluviali che terrestri9.
La cultura materiale del castello di Ron-tana, soprattutto nelle sue prime fasi di vita ècaratterizzata da vasellame da cucina: sono at-testate pentole con prese forate rialzate ri-spetto all’orlo e testi da pane con anse laterali.A tale materiale sono spesso associati esem-plari in pietra ollare (fig. 3), e trova confrontoin alcuni esemplari rinvenuti negli scavi di SanSevero (Classe Ravenna)10. Sempre da San Se-vero, e dall’area portuale di Classe proven-gono inoltre alcuni esemplari di brocchetrilobate in acroma depurata, che trovano
ELVIRA LO MELE
7 MONTEVECCHI, MORICO, 1992, p 170.
8 AUGENTI et al. 2009.
9 GELICHI, SBARRA, 2003, p. 124.
10 CIRELLI LOMELE c.s
78
Fig.2 - Sezione pozzo alla veneziana, elabora-zione grafica NU.M.A.3d.
Fig.3 - Frammenti in pietra ollare
larga diffusione nelle zone costiere tra Riminie l’area alto adriatica, si tratterebbe di unaclasse di ceramiche semi-fine, secondo la de-finizione di Wickham11. Appartengono a que-sto repertorio brocche con versatoio tubolare(fig. 4) realizzate con argilla depurata e deco-rate con motivi incisi ad andamento ondulatolungo le spalle. Tuttavia il materiale sinoraanalizzato riferibile a queste fasi è piuttostoscarso12. Sembra quindi che il materiale riferi-bile a queste prime fasi di vita dell’insedia-mento risponda quasi esclusivamente adesigenze domestiche essenziali, inoltre nonsono state notate differenziazioni del materialein rapporto alle distinte aree che caratteriz-zano il castello.
Per quanto riguarda le ceramiche fini damensa le prime attestazioni risalgono alla finedel XIII secolo. Si tratta di alcuni frammenti diMaiolica Arcaica, la cui diffusione in ambitorurale è scarsamente testimoniata per questoperiodo. Maioliche databili al terzo quarto delXIII secolo sono infatti state rinvenute inpochi centri urbani della Romagna: Imola, Fa-enza, Forlì, Rimini e Ravenna (fig. 5). L’unico
centro in cui sembra accertata la sua produ-zione è Ravenna dove sono presenti anche al-cuni esemplari del secondo quarto del XIIIsecolo, di probabile importazione. In questoperiodo il castello di Rontana viene ampia-mente fortificato e la qualità della cultura ma-teriale aumenta considerevolmente. Sonoattestate forme che appartengono ai repertoriromagnoli, di probabile produzione faentina,ma sono anche stati rinvenuti esemplari cheprovengono dalla Toscana. Anche in questocaso ceramiche fini sono diffuse sia nell’areasommitale che nel resto dell’insediamento, adimostrazione di una scarsa gerarchizzazionemateriale degli spazi occupati nel castello traXIII e XIV secolo. È possibile che in questocaso le ceramiche non siano un elemento di-stintivo per l’identificazione sociale degli spaziabitativi e che si debba ricorrere ad altri indi-catori archeologici, come è stato tentato inaltri insediamenti con successo.
All’interno dei diversi ambienti che carat-terizzano il sito sono stati rinvenuti numerosiframmenti appartenenti a forme aperte, riferi-bili alle produzioni di Graffita Arcaica Padana(Tav I), i cui principali centri di produzione inquesto periodo sono Imola e Forlì. Ad un pe-riodo ancora successivo appartengono leforme di ceramica dipinta e ingobbiata sottovetrina con decorazione in giallo e verde, pro-dotto di minor costo appartenente alle fasi piùrecenti di vita del sito.
In quantità minori sono state rinvenuteproduzioni come le smaltate e dipinte “blu sublu” di probabile produzione faentina, i cuiframmenti riconducono prevalentemente aforme aperte,su imitazione della più nota pro-duzione veneziana e alcuni frammenti di zaf-fera a rilievo appartenenti a boccali. Sempretra le produzioni di epoca Rinascimentalesono stati riconosciuti diversi frammenti diproduzione smaltata conventuale tutti ricon-ducibili a forme aperte e di piccole dimen-sioni.
Il materiale di maggior rilievo proviene in-vece dal’indagine effettuata all’interno del
XLIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA - SAVONA, 28-29 MAGGIO 2010
11 WICKHAM 2005.
12 Complessivamente ne sono stati identificati 25
esemplari ( 3 pentole, 8 testi da pane, 10 pentole in pie-
tra ollare, 4 brocche in acroma depurata)
79
Fig.4 - Versatoio tubolare in acroma depurata.
XLIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA - SAVONA, 28-29 MAGGIO 2010
81
pozzo alla Veneziana. Le operazioni svolte alsuo interno hanno consentito di riportare allaluce un cospicuo numero di ceramiche. Sitratta di un gruppo di ceramiche composto da20 boccali smaltati e 18 privi di rivestimento,una ciotola emisferica smaltata (fig.6), alcuniframmenti di ceramiche Graffite Padane ri-conducibili a forme aperte e alcune ciotolinedi produzione conventuale. Associati a questeceramiche sono stati rinvenuti diversi oggettiappartenenti alla vita quotidiana come ele-menti di calzatura e borselli in cuoio, dadi dagioco in osso, ditali per cucito, un richiamo
per uccelli, una fibbia in lega di rame, ed altrielementi in osso e legno. La maggior parte deimateriali rinvenuti all’interno del pozzo pre-senta tracce di combustione e segni di frattureappartenenti ad un periodo precedente aquello di deposizione all’interno della strut-tura stessa. Anche se le dinamiche del sep-pellimento non sono chiare appare evidentecome il butto all’interno del pozzo ne abbiacausato la sua dismissione e pertanto risultadifficile pensare che ciò si avvenuto prima deldefinitivo abbandono del castello.
Diversi boccali presentano uno stato di
Fig.5 - Carta di distribuzione della Maiolica Arcaica, elaborazione Enrico Cirelli.
conservazione ottimo, permettendo così unalettura completa anche dei motivi decorativiche li caratterizzano. In generale gli esem-plari sono attribuibili a produzioni faentine.Per quanto riguarda gli esemplari con rive-stimento stannifero in generale si presen-tano dalla forma panciuta, versatoiotrilobato, ansa a nastro e piede basso epiatto. Il repertorio decorativo, invece, sipresenta piuttosto eterogeneo, tipico co-munque delle produzioni locali. Si passacosì da motivi strettamente legati a momentidella vita quotidiana, come quello dei “settedenari” (Tav. II, fig.1a-1b) molto diffuso inRomagna a quello della dexterarum iunctio (fig.7) ai motivi tipici dello stile severo, sempremolto diffusi in Romagna, a cui sono riferi-bili diversi boccali decorati con foglie goti-che accartocciate (fig. 8) e un boccale conmotivo a “palmette persiane” (Tav. II, fig 2a-2b) ed uno con occhio di penna di pavone(Tav. III fig. 4a-4b). Diversi inoltre gli esem-plari recanti al centro il motivo del cosid-detto “trigramma bernardiniano” (Tav. III,fig 3a-3b) delimitato da una fascia circolaree contornato da fiammelle radiali alternate agruppi di pennellate degradanti e legato allatradizione religiosa. Presenti anche esem-plari decorati con figure antropomorfe
XLIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA - SAVONA, 28-29 MAGGIO 2010
83
Fig.6 - Ciotolina emisferica in maiolica rinasci-mentale.
Fig.7 - Boccale in maiolica rinascimentale, conmotivo “dexterarum iunctio”.
Fig.8 - Boccale in maiolica rinascimentale, conmotivo “foglie gotiche accartocciate”.
XLIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA - SAVONA, 28-29 MAGGIO 2010
85
(fig.9), definiti dalla letteratura in stile “belledonne”.
Oltre agli esemplari smaltati presso il ca-stello dei Rontana e nello specifico nel con-testo del pozzo, sono presenti diversiesemplari privi di rivestimento, vere e pro-prie produzioni di uso domestico alternativealla più pregiate maioliche faentine, rappre-sentate sia da boccali con versatoio tubolare(fig. 10) che trilobato. Da una analisi preli-minare, la morfologia dei recipienti privi dirivestimento si presenta più slanciata ri-spetto ai boccali della fine del quattrocentoe gli esemplari si presentano generalmentepiù alti rispetto a quelli con rivestimentostannifero. Sono inoltre caratterizzati da unimpasto con matrice prevalentemente fer-rosa. È possibile si tratti di una manifatturalocale, forse da identificare all’interno delsito o di altri insediamenti vicini, situatilungo la vallata del Lamone, come ad esem-pio Brisighella.
Fig.8 - Boccale in maiolica rinascimentale, conmotivo “foglie gotiche accartocciate”.
Fig.9 - Boccale in maiolica rinascimentale, conmotivo “belle donne”.
Fig.10 - Boccale privo di rivestimento con ver-satoio tubolare.
Bibliografia
AUGENTI A., 2006, Archeologia dei castelli dellaRomagna: linee programmatiche di unaindagine in corso, in Castelli medievali eneomedievali in Emilia Romagna, Attidella giornata di studio, Bologna, 17marzo 2005, pp. 75-95.
AUGENTI A., CIRELLI E., FIORINI A., RAVA-IOLI E., 2009, l’incastellamento in Roma-gna: indagini 2006-2008, in G. VOLPE, P.FAVIA (ed.) , V congresso Nazionale di Ar-cheologia Medievale (Foggia - Manfredo-nia, 2009), Firenze, pp. 341-348.
AUGENTI A. , CIRELLI E., GUARNIERI C. (eds),2009, Dalla fattoria al castello. Archeolo-gia nel Parco della Vena del Gesso Roma-gnola, Brisighella 2009 (Catalogo dellaMostra), Ravenna 2009.
ARGNANI F., 1903, Le ceramiche e maioliche ar-caiche faentine dalla loro origine fino alprincipio del XVI secolo, Faenza.
BALLARDINI G., 1938, La maiolica italiana dalleorigini alla fine del Cinquecento, Firenze.
BENERICETTI R., 2002, Le carte ravennati deldecimo secolo. Archivio Arcivescovile, II,(aa. 957-976), Faenza.
BERARDI D., CASSI RAMELLI A., MONTEVECCHI F.,RAVALDINI G., SCHIETTINI F., 1970, Rocche ecastelli di Romagna , Imola vol. I, pp. 324-326.
BERTI G. CAPPELLI L., 1994, Dalle ceramicheislamiche alle “Maioliche Arcaiche” secc.XI- XV, in FRANCOVICH R., VON HESSEN O. (acura di) Ricerche di archeologia Altome-dievale e Medievale, n. 19-20, Firenze.
BERTI G., GELICHI S., 1995, Ceramiche cerami-sti e trasmissioni tecnologiche tra XII e XIIIsecolo nell’Italia centro-settentrionale, inMiscellanea in memoria di Giuliano Cre-monesi, Pisa, pp. 409-445.
BERTI G., GELICHI S., MANNONI T., 1997, Tra-sformazioni tecnologiche nelle prime pro-duzioni italiane con rivestimenti vetrificati(secc. XII-XIII), in La céramique médiévaleen Méditerranée Occidentale. Actes di 6econgrès, Aix-en-Provence, pp. 383-403.
BERTI G., CAPPELLI C., MANNONI T., 2002, Tra-smissione di tecnologie nel medioevo: ten-denze e linee di ricerche attuali, in Atti delXXXII Convegno internazionale della ce-ramica. Albisola 1999, Firenze 2001, pp.23-42
BLAKE H., 1903, I bacini di San Nicolò di Ra-venna e la ceramica graffita medievalenell’Emilia Romagna, estr. da Faenza an-nata 70, n. 5-6, Faenza pp.354-368.
CAPPELLI C., MANNONI T. 1996, I problemi dei ri-vestimenti nelle ceramiche italiane del XIIIsecolo, «Albisola», XXIX, pp. 229-234.
Conclusioni
Il contesto si presenta quindi piuttostovariegato nella presenza delle classi cerami-che, con una certa prevalenza delle produ-zioni locali, seppure non mancano repertiche testimoniano la vitalità del sito in rela-zione ad altri contesti produttivi più lontani,come ad esempio quello toscano. Un’ analisitipologica puntuale dei reperti provenienti
dallo scavo potrebbe consentire di delineareun quadro più dettagliato delle produzionipresenti e delle loro evoluzioni morfologi-che, analisi che associata alle determina-zioni chimico-mineralogiche effettuate suireperti fornirebbe un ottimo modello di con-fronto per lo studio della cultura materialedegli insediamenti fortificati in Emilia Ro-magna.
ELVIRA LO MELE
86
XLIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA - SAVONA, 28-29 MAGGIO 2010
87
cali, in “Rivista di Archeologia”, 23, pp.120-140.
GELICHI S., 2008, Un ritorno alle origini: il di-battito sulla “maiolica arcaica” e sulla“proto maiolica “ trent’anni dopo, in Me-todologia, insediamenti urbani e produ-zioni. Il contributo di Gabriella Maetzke ele attuali prospettive delle ricerche, Atti delConvegno Internazionale di studi sull’ar-cheologia medievale in memoria di Ga-briella Maetzke, Daidalos, 9, pp. 255-286.
GUARNIERI C., 2009, Il bello dei butti. Rifiuti ericerca archeologica a Faenza tra Me-dioevo ed Età Moderna, Firenze 2009.
LIBRENTI M., 1992, La ceramica ingobbiata egraffita. Ceramica e centri di produzionenell’Italia Settentrionale tra XVI e XVII se-colo, Firenze, pp. 27-67.
MANNONI T., 1974, Alcuni problemi di classifi-cazione della ceramica medievale in ar-cheologia, «Albisola», VI, pp. 11-22.
MAZZUCCATO O., 1990, Problematiche nell’ori-gine della cosiddetta maiolica, «Albisola»,XXIII, pp. 41-47.
MILANESE M., 1994, Archeologia e ceramica po-stmedievale, «Albisola», XXVII, pp. 7-10.
NEPOTI S., 1975, La transizione medioevo-ri-nascimento nella ceramica dell’Emilia Ro-magna: problemi aperti e primeinformazioni dallo scavo bolognese di SanGiorgio, «Albisola», VIII, pp.75-96.
NEPOTI S., 1983, Manufatti di uso domestico,«Archeologia Medievale», X, pp.199-212.
TROVABENE G., 1999, Viaggio fra le rocche e icastelli della provincia di Ravenna, Ra-venna, p. 136.
WICKHAM C., 2005, Framing the Early MiddleAges, Europe and the Mediterranean 400-800, Oxford.
CIRELLI E., 2009, Il castello di Rontana, «Ar-cheologia Medievale», XXXVI, p. 160.
CIRELLI E., LO MELE E., 2010, La cultura mate-riale di San Severo alla luce delle nuovescoperte archeologiche, in P. RACAGNI (ed.),San Severo, Ravenna, cs.
COSTANTINI R., 1994, Le ceramiche medievali ri-vestite: le produzioni smaltate e la cera-mica graffita, in Ad mensam-manufattid’uso da contesti archeologici fra tardaAntichità e Medioevo, pp. 264-318.
FRANCOVICH R., 1982, La ceramica medievale aSiena (secc. XIV-XV). Materiali per una ti-pologia, Firenze.
FRANCOVICH R, GELICHI S., 1983, La ceramicamedievale nelle raccolte del Museo Medie-vale e moderno di Arezzo, in FRANCOVICH
R., VON HESSEN O. (a cura di) Raccolte diarcheologia Altomedievale e Medievale, n.8, Firenze.
GELICHI S., 1988, La maiolica italiana dellaprima metà del XV secolo. La produzionein Emilia Romagna e i problemi della cro-nologia «AM», XV, pp. 65-104.
GELICHI S., 1991, La maiolica a Bologna nel XVsecolo, nuovi dati archeologici,«Albisola»,XXIV, pp. 19-48.
GELICHI S., 1992, La ceramica a Faenza nelTrecento: il contesto della cassa rurale edartigiana, Faenza.
GELICHI S., 1995, Fornaci per ceramica in Emi-lia Romagna in epoca moderna, «Albisola»,XXVIII, pp. 37-40.
GELICHI S., LIBRENTI M., 1997, Ceramiche po-stmedievali in Emilia Romagna, in “Arch.Post Med.”, 1, pp. 185-229.
GELICHI S., SBARRA F., 2003, La tavola di SanGerardo. Ceramica tra X e XI secolo nelnord Italia: importazioni e produzioni lo-