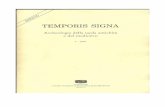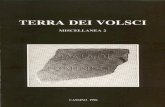Paesaggi in trasformazione: insediamento longobardo, ambiente e oscillazioni climatiche nel Trentino...
Transcript of Paesaggi in trasformazione: insediamento longobardo, ambiente e oscillazioni climatiche nel Trentino...
NECROPOLILONGOBARDE
IN ITALIAIndirizzi della ricerca e nuovi dati
Atti del Convegno Internazionale26 - 28 settembre 2011
Castello del Buonconsiglio, Trento
a cura di
Elisa Possenti
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIOMONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI
2014
Ugo RossiPresidente della Provincia autonoma di Trento
Tiziano MellariniAssessore alla CulturaProvincia autonoma di Trento
Sergio BettottiDirigente generale Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport
Claudio MartinelliDirigente Servizio Attività Culturali
Atti del Convegno Internazionale Necropoli loNgobarde iN italiaIndirizzi della ricerca e nuovi datiTrento, Castello del Buonconsiglio 26-28 settembre 2011
a cura diElisa Possenti
Curatela redazionale, coordinamento e rapporti istituzionaliCarmen CaloviMichele Dalba
Organizzazione del convegnoUniversità degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e FilosofiaCastello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
con il sostegno diProgetto Apsat “Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini”RFA - Associazione Culturale RicercheFortificazioni AltomedievaliCassa Centrale Bancacredito cooperativo del nord est
Responsabile scientifico del convegnoUniversità degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e FilosofiaElisa Possenti
Segreteria organizzativaUniversità degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia Antonella NeriCastello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provincialiAnnamaria Azzolini
Convegno Internazionale realizzato nell’ambito del PROGETTO APSAT“Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini”Provincia autonoma di Trentobando “Grandi progetti 2006” delibera G.P. 2790/2006
Provincia autonoma di Trento
Cassa Centrale Bancacredito cooperativo del nord estProgetto APSAT
con il sostegno di:
Franco MarzaticoDirettore Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
Fulvio FerrariUniversità degli Studi di TrentoDirettore Dipartimento di Lettere e Filosofia
Elisa PossentiUniversità degli Studi di Trento Dipartimento di Lettere e Filosofia
© 2014 Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provincialiTutti i diritti riservati
ISBN 978-88-940135-0-4
Associazione Culturale Ricerche Fortificazioni Altomedievali
15
IntroduzIone ............................................................................................................................................................................................................................................................. p. 31 Elisa Possenti
necropolI longobarde In ItalIa: lo stato della rIcerca ....................................................... » 35Elisa Possenti
la rIcerca e le ultIme scoperte longobarde In pannonIa: una sIntesI .............................................................................................................................................................................................................. » 55Tivadar Vida
la rIcerca sull’età merovIngIa In germanIa sud-occIdentale dopo la seconda guerra mondIale ............................................................................ » 73Dieter Quast
muerte y enterramIentos de los reyes hIspanovIsIgodos ................................................................................................................................................................................................................................................. » 86Raquel Alonso Álvarez
due nuove grandI necropolI In pIemonte........................................................................................................................... » 96Egle Micheletto, Francesca Garanzini, Sofia Uggé, Caterina Giostra
cassano d’adda (mI) e montIchIarI (bs): sepolture con manufattI selezIonatI, sIgnIfIcato socIale e cIrcolazIone dI prodottI ....................................................................................................... » 118Paola Marina De Marchi, Laura Simone Zopfi
recentI rItrovamentI longobardI In terrItorIo bergamasco ............................................................................................................................................................................................................................................... » 137Maria Fortunati (a cura di), Riccardo Caproni, Emiliano Garatti, Angelo Ghiroldi, Monica Resmini, Annalisa Rizzotto, Mariagrazia Vitali
langobard lords In central emIlIa: the cemetery of spIlamberto (modena - northern Italy) ............................................. » 163Paolo de Vingo
I longobardI nel parmense: revIsIone dI vecchI datI e nuove acquIsIzIonI ............................................................................................................ » 188Manuela Catarsi, Cristina Anghinetti, Pietro Baraldi, Danilo Bersani, Luana Cenci, Anna Losi, Patrizia Raggio, Giulia Rebonato, Emma Salvioli Mariani, Licia Usai, Greta Zancan, Paolo Zannini
Indice
16
testimoNiaNze fuNerarie d’età loNgobarda Nel piaceNtiNo e studio prelimiNare della Necropoli di saNt’aNdrea di travo (pc) ................................................................................................................................................................................... p. 228Roberta Conversi, Cristina Mezzadri
la Necropoli di povegliaNo veroNese, loc. ortaia ................................................................................ » 259Caterina Giostra
Nuovi dati dal belluNese iN età loNgobarda: Notizie prelimiNari........................................................................................................................................................................................................................................ » 275Giovanna Gangemi (a cura di), Davide Pacitti, Sara Emanuele, Simone Masier, Paolo Michelini, Paolo Paganotto
la Necropoli di romaNs d’isoNzo. coNsiderazioNi alla luce delle Nuove acquisizioNi e degli studi receNti ................................................................................................................................................................................................................................. » 293Serena Vitri, Donata Degrassi, Davide Gherdevich, Sara Gonizzi, Paola Ventura, Fabio Cavalli, Valentina Degrassi, Annalisa Giovannini, Franca Maselli Scotti
la Necropoli di saN mauro iN rapporto alle altre aree sepolcrali loNgobarde cividalesi ......................................................................................... » 319Isabel Ahumada Silva
la collaNa moNetale della tomba 5 della Necropoli altomedievale di offaNeNgo (cr) e la moNeta iN tomba iN età loNgobarda .............................................................................................................................................................................................. » 339Ermanno Arslan
il sepolcreto altomedievale di poNtedera, località la scafa. primi dati della campagNa 2011 ...................................................................................................................................................................... » 351Sara Alberigi, Giulio Ciampoltrini
Necropoli loNgobarde e d’età loNgobarda Nel maNtovaNo. elemeNti per la coNosceNza Negli scavi dagli aNNi ’90 ad oggi ....................................................................................................................................................................................................................... » 366Elena Maria Menotti
preseNze loNgobarde iN emilia romagNa orieNtale: il puNto sulla questioNe ............................................................................................................................................................................................................. » 380Cinzia Cavallari
i loNgobardi del ducato di spoleto: uN problema di visibilità archeologica Nella ricerca coNtemporaNea .......................................................... » 402Vasco La Salvia
due casi a coNfroNto: borgovercelli e beNeveNto ................................................................................ » 417Marcello Rotili
tradizioNi fuNerarie Nel ducato di beNeveNto: l’apporto delle popolazioNi alloctoNe .......................................................................................................................................... » 445Carlo Ebanista
17
ritrovameNti fuNerari altomedievali iN treNtiNo. uN aggiorNameNto alla luce dei receNti scavi di vervò ...................................................... p. 472Lorenza Endrizzi
ritrovameNti fuNerari altomedievali iN treNtiNo. uN aggiorNameNto alla luce dei receNti scavi di beseNello............................................................................................................................................................................................................................................. » 479Nicoletta Pisu
sepolture, costumi e oratori fuNerari. uN rappreseNtativo caso alpiNo di vi-vii secolo .................................................................................... » 483Enrico Cavada, Francesca Dagostin, Anny Mattucci, Cristina Ravedoni
paesaggi iN trasformazioNe: iNsediameNto loNgobardo, ambieNte e oscillazioNi climatiche Nel treNtiNo orieNtale tra v e vii secolo ......................................................................................................................................... » 504Paolo Forlin
legNi, tessuti, cuoi ed altri materiali orgaNici coNservati Nelle tombe loNgobarde dell’italia setteNtrioNale: lo stato delle ricerche .................................................................................. » 516Mauro Rottoli, Elisabetta Castiglioni
loNgobardi iN piemoNte: gli aspetti paleobiologici ............................................................................ » 532Elena Bedini, Emmanuele Petiti
aspetti aNtropologici, paleopatologici e musealizzabili dei loNgobardi iN lombardia ................................................................................................... » 542Alessandra Mazzucchi, Daniel Gaudio, Emanuela Sguazza, Davide Porta, Cristina Cattaneo
sepolture aNimali iN Necropoli loNgobarde: gli esempi del piemoNte ................................................................................................................................................................................................................ » 550Emmanuele Petiti, Elena Bedini
504
paesaggi in tRasfoRmazione: insediamento longoBaRdo, amBiente e oscillazioni climatiche nel tRentino oRientale tRa v e vii secolo
1. intRoduzione
Il dibattito sulla trasformazione dei paesaggi antropici durante l’età di transizione (V-VII secolo) re-gistra negli ultimi anni una crescente attenzione nei confronti delle oscillazioni climatiche e l’evoluzione ambientale che hanno contraddistinto questa fase cronologica.
Nonostante vadano segnalati alcuni contributi che hanno richiamato la complessità del tema e sot-tolineato lo scarso dettaglio storico dei dati paleoclimatici soprattutto in rapporto a determinati eventi metereologici1, alcune ricerche condotte nell’ambito di diverse regioni europee iniziano ad interrogarsi in modo sistematico sugli effetti che il clima produsse, tra V e VII secolo, sull’ambiente, sulla rete insediativa e sulle modalità di sfruttamento delle risorse agrosilvopastorali2. È indubbio infatti come si cominci ad avvertire la necessità di predisporre nuove e più sistematiche ricerche sul rapporto tra il cambiamento climatico, le modificazioni paleoambientali e le trasformazioni socio-economiche anche per il periodo che segnò la fine dell’antichità3: un nuovo modo di osservare le dinamiche di evoluzione dei paesaggi antropici durante l’epoca delle migrazioni su cui peraltro, come ha osservato Andrew Reynolds, molto resta da fare per conseguire una sostanziale e generale visione4.
Sulla scia di questi studi, il presente contributo cercherà di contestualizzare il tema dell’insediamento delle élites longobarde all’interno del Trentino orientale alla luce delle recenti ricerche paleoclimati-che e paleobotaniche promosse dal Museo delle Scienze di Trento nell’ambito dei progetti Acquapast e Oloambient5, con l’obiettivo di individuare nuovi elementi di discussione in rapporto alle strategie di insediamento e di sfruttamento economico che emergono dalle informazioni archeologiche nell’area dell’alta Valsugana e degli altopiani di Lavarone e Folgaria.
2. i longoBaRdi nel tRentino oRientale
Gli indicatori archeologici di cultura longobarda noti per la porzione medio-occidentale della Val-sugana sono quasi esclusivamente costituiti degli oggetti di corredo provenienti dai nuclei sepolcrali di Civezzano, Bosentino e Telve di Sopra, rinvenuti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo (fig. 1).
Uno dei due sepolcreti localizzati nell’ambito del territorio di Civezzano emerse all’interno dei cortili di Castel Telvana, una domus murata di origine basso medievale6 che sorge ad ovest del centro cittadino7. Tra 1886 e 1905, furono portate alla luce alcune sepolture maschili con corredi di armato e una deposi-zione femminile accompagnata da un ricchissimo corredo costituito da una croce in lamina d’oro, orec-chini a cestello, fibbia per cintura e fibiette per calzari, bacile in bronzo, bracciale in argento, spillone per capelli in argento e un pettine in osso (fig. 2). Poco distante, in località Al Foss, già a partire dal 1875 era stata rinvenuta una seconda area cimiteriale presso cui si concentravano alcune tombe, apparentemente solo maschili, accompagnate da corredo in armi ed elementi di broccato d’oro. Da una delle inumazioni si recuperarono alcune guarnizioni in ferro con raffigurazioni zoomorfe e una croce a braccia patenti che costituivano le decorazioni metalliche della cassa lignea del defunto8. Fatta eccezione per una sepoltura
1 Ad esempio, squatriti 2010 a proposito della cosiddetta ‘Rotta della Cucca’.2 Per l’ampia bibliografia, si vedano Cheyette 2008 e lewit 2009.3 hodGes 2010, pp. 71, 80.4 reynolds 2005, p. 98.5 Frisia 2007.6 Forlin 2013a, pp. 29-32.7 Campi 1885, pp. 121-138; amante simoni 1984, pp. 29-30; Ciurletti 1997, pp. 520-521; terzer 2005, pp. 297-300; pazienza
2009, pp. 90-97.8 Campi 1885, pp. 121-138; amante simoni 1984, pp. 27-28; terzer 2005.
PAOLO FORLIN
505
proveniente da Castel Telvana contenente una fibbia con ardiglione a scudetto che si data all’ultimo tren-tennio del VI secolo (informazione Elisa Possenti), la cronologia dei corredi rimanda omogeneamente ad una datazione di inizio - prima metà del VII secolo.
A Bosentino, sull’altopiano della Vigolana, presso la località Ai Nogaredi9 emersero tra il 1907 e il 1925 sette inumazioni con corredo tra cui si segnalava una sepoltura di armato, accompagnata da un corredo databile al VII secolo costituito da spatha, impugnatura e umbone di scudo, punta di lancia a foglia di alloro e coltellino. Un tremisse d’oro longobardo a nome di Maurizio Tiberio (582-602) fu rinvenuto, con modalità incerte, nello stesso territorio10.
Il terzo ed ultimo contesto funerario con materiale di cultura longobarda fu individuato a Telve di Sopra, nei pressi di Borgo Valsugana11: probabilmente riferibili ad un’unica tomba maschile, si conser-vano una spatha, un frammento di umbone da parata, una borchia di bronzo dorato che si inquadrano cronologicamente, anche in questo caso, alla prima metà del VII secolo. Dall’area sommitale del colle di San Pietro, di cui Telve di Sopra occupa un pianoro lungo il fianco sud-est, sono note inoltre due cuspidi di lancia che trovano parziali confronti in età altomedievale12.
Vanno aggiunte a queste evidenze alcune informazioni rappresentate unicamente da oggetti decon-testualizzati, rinvenuti fortuitamente o attraverso una semplice raccolta di superficie, che provengono da tre contesti d’altura del Perginese e che, in un caso (quello di Doss del Guardian), si associano a materiale di IV-V secolo (fig. 3). Rientrano in questo gruppo una crocetta aurea rinvenuta sul Doss Tambos13 e una placca di cintura recuperata sul Doss del Guardian14, ovvero da altrettante posizioni di sommità limitrofe al castello di Pergine, sito probabilmente interessato da una precoce fase di incastellamento come lasce-rebbe pensare il rinvenimento di esemplari numismatici di fine V e VI secolo15.
La posizione di questi siti si colloca omogeneamente su aree di altura e di versante rilevate rispetto al sottostante fondovalle, inserendosi in alcuni casi (come Civezzano, Bosentino, Doss del Guardian) all’interno di settori già interessati dalla presenza di indicatori insediativi di epoca romana e tardoantica, in altri (Telve di Sopra, Doss Tambos, Madrano) presso superfici apparentemente non coinvolte da una frequentazione anteriore al VI secolo. Purtroppo molto limitato si presenta il livello informativo dei dati a disposizione,
9 roBerti 1925, pp. 210-223; amante simoni 1984, pp. 37-38; pisu 2010.10 amante simoni 1984, p. 38.11 Eadem 1984, p. 31.12 Forlin 2013b.13 Cavada 1991, p. 75.14 pasquali, toldo 2008, pp. 42-43.15 Forlin 2013c; rizzolli 2005.
Fig. 1. Siti altomedievali citati nel testo.
506
considerato come questi dati provengano esclusivamente da rinvenimenti oc-casionali o da semplici ricerche di superficie. In questo settore del Trentino, infatti, solo il contesto altomedievale di Santa Maria Assunta di Civezzano è stato indagato attraverso un’apposita indagine stratigrafica, in grado di verifi-care la presenza di due diversi edifici di culto anteriori all’attuale complesso, di origine cinquecentesca. Datati rispettivamente al V-VI e all’VIII-IX secolo, le due chiese più antiche sorsero direttamente in rapporto alle strutture di un edifcio rustico di epoca tardoantica16.
3. i dati paleoclimatici e paleoamBientali tRa v e vii secolo: dati euRopei e tRentini a confRonto
In apertura del paragrafo, abbiamo sottolineato come la disamina dei cambiamenti climatici e delle loro ripercussioni sull’ambiente si presti ad essere utilizzata come chiave di lettura per l’analisi delle strategie di utilizzo del suolo e delle dinamiche insediative che coinvolsero la Valsugana trentina
durante l’età longobarda. A questo proposito, il tema della modificazione del quadro economico tra la tarda antichità e l’alto
medioevo può fornire un inquadramento preliminare alla questione, focalizzando la nostra attenzione su uno tra gli aspetti più cruciali dell’età di transizione.
È infatti noto, dai dati archeologici e dalle fonti scritte, come il periodo dello stanziamento e del radica-mento delle élites longobarde all’interno della penisola italiana sia coinciso con una fase di netta cesura rispet-to alle modalità di produzione agricola del mondo romano e del corrispettivo modello insediativo incentrato sulle villae, rimasti, seppur con alcune importanti variabili regionali, parzialmente vitali fino all’età gota17.
Un dato, quest’ultimo, assolutamente in linea con il trend generale dell’economia europea tra V e VII secolo, contraddistinta in modo omogeneo da una diffusa contrazione della produzione cerealicola spe-cializzata e dell’allevamento bovino18. Attività legate al modello economico di produzione, distribuzione e consumo sostenuto dall’apparato statale romano, in questa fase progressivamente sostituito da un sistema
16 possenti 2013; Ciurletti, rizzi 2003, pp. 371-375; Ciurletti, porta 2007, p. 568. 17 BroGiolo 1996; BroGiolo, possenti 2008.18 lewit 2009.
Fig. 2. Il corredo della tomba femminile di Civezzano, Castel Telvana (da CiurLetti 1997, p. 521).
Fig. 3a. La crocetta aurea rinvenuta sul doss Tambos (da CAVAdA 1991, p. 73)Fig. 3b. La controplacca di cintura multipla dal doss Guardian (da PASquALi, toLdo 2008, p. 43).
507
agrosilvopastorale basato sulla coltivazione di cereali minori e sullo sfruttamento del bosco per l’allevamento brado di capi di piccola ta-glia, soprattuttuto maiali19.
Archeologicamente, l’incremento dell’inci-denza del pascolo brado sull’allevamento bo-vino è documentata nei primi secoli altome-dievali presso alcuni siti dell’East Anglia20, della Scozia meridionale21, della Francia meridiona-le22 e dell’Italia centro-settentrionale solo per citare alcuni esempi23. Dati sulla riforestazione di alcune aree di bonifica – forse avviatesi in un contesto di promozione del pascolo brado – sono stati osservati in Italia settentrionale24, nel Glouce-stershire25 e nella Francia sudorientale così come nel nord-ovest della Spagna, in Svizzera e nei bacini del Reno e della Mosa26. In alcuni contesti i processi di riforestazione non significarono tout-court un abbandono delle antiche superfici agricole, ma piuttosto l’adattamento di alcuni settori del paesaggio alle necessità di disporre di un supporto al pascolo brado dei maiali e dei capriovini: sarebbe questo il caso, ad esempio, suggerito dai dati paleobotanici di Sorano nella Lunigiana, dove la diffusione del nocciolo è stata messa in relazione con l’allevamento di suini27.
Come ampiamente sottolineato da un recente contributo di Tamara Lewit, queste informazioni con-corrono a ricostruire un quadro di profonda trasformazione economica basata essenzialmente su tre fattori: la diversificazione agricola, l’abbandono o la riconversione a bosco di alcune aree di coltivo, la diminuzione della specializzazione produttiva28. In particolare, la diminuzione nella specializzazione agricola si tradusse nell’adozione di una più articolata base cerealicola e soprattutto nella promozione della segale, un cereale maggiormente adattabile ai climi freddi e ai suoli umidi29.
Condizioni climatiche, dunque, che avrebbero determinato precise e sostanzialmente inedite strategie colturali.
Ma quale fu la reale portata del cambiamento climatico durante i secoli della transizione e quanto intenso il suo effetto sui modelli economici e sulle dinamiche insediative più in generale?
La fase climatica che accompagnò la transizione dall’antichità all’altomedioevo – il cosiddetto Dark Age Cold Period – fu contraddistinta dall’aumento della piovosità e da una sensibile flessione delle tem-perature medie. Determinata dalla NAO (North Atlantic Oscillation), la diminuzione delle temperature è ampiamente documentata da studi condotti su speleotemi della penisola iberica30 e della Germania31, da alcune analisi sulle diatomee32 e sulla paleovegetazione dell’Islanda33, nonché dalla lettura di una serie dendrocronologica della Svezia settentrionale34. In Spagna, l’abbassamento delle temperature per questo periodo è noto anche grazie all’analisi dei valori di ∂13C di alcune stalagmiti35 e allo studio di alcuni campioni palinologici36.
19 montanari 1979 e montanari 1984 per l’Italia centro-settentrionale; per il Trentino orientale, Forlin 2011-2012.20 CraBtree 2010.21 dark 2000.22 trèment 2001.23 Baker 1991; Baker 1996; salvadori 2007.24 Christie 2006, pp. 484-487.25 Fowler 2002, p. 77.26 lewit 2009, p. 81, con bibliografia di dettaglio.27 Christie 2006, pp. 485-6 con bibliografia. Per la diffusione del nocciolo in Italia settentrionale si veda la recente mo-
nografia di Paolo Squatriti (2013).28 lewit 2009, p. 91.29 Cheyette 2008, p. 163; montanari 1984.30 desprat et al. 2003.31 niGGemann et al. 2003.32 jianG et al. 2002.33 olaFsdottir et al. 2001.34 Grudd et al. 2002.35 martín-Chivelet et al. 2011.36 Gil-GarCìa et al. 2007.
Fig. 4. Indici di umidità ricavati dai dati paleobotanici della torbiera di Bolton Fell Moss, Inghilterra settentrionale. La freccia rossa indica l’aumento delle condizioni di umidità nel periodo altomedievale (modificato da BeLL, WALker 1996, p. 33).
508
Per quanto concerne l’oscillazione delle precipitazioni, l’aumento della piovosità è documentato, per richiamare alcuni esempi, da numerosi indicatori che dimostrano l’incremento delle condizioni di umidi-tà, tra V e VII secolo, nelle Highlands scozzesi37, in Germania e in Danimarca38. Nel nord dell’Inghilterra39, la curva dell’umidità dedotta dall’analisi dei macroresti contenuti all’interno delle torbiere evidenzia un aumento delle precipitazioni tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo (fig. 4).
Informazioni relative all’instabilità idrogeologica indotta dall’aumento delle piovosità e all’abbas-samento delle temperature sono ampiamente note per l’Italia centrale, dove l’incidenza degli episodi alluvionali dell’Arno40 e dei fiumi degli Appennini settentrionali41 tra VI e VII secolo è stata associata alla progradazione dei ghiacciai appenninici e alpini42. Dati, questi ultimi, che si inseriscono in un panorama generale di instabilità, documentata peraltro in modo sistematico grazie ai lavori condotti durante la costruzione della TGV all’interno del bacino del Rodano43.
Secondo Bjorn E. Berglund44, i dati paleoclimatici e paleoambientali del Dark Age Cold Period rivelano una correlazione positiva tra il peggioramento climatico da una parte e l’impatto antropico e le strategie di utilizzo del suolo dall’altra, come dimostrerebbero a questo proposito la contrazione dell’agricoltura e la riforestazione di ampie aree dell’Europa centrale e della Scandinavia. Frederic L. Cheyette45, in aggiunta, ha sottolineato le implicazioni prodotte da questi fenomeni sul piano delle strategie insediative altome-dievali, contraddistinte dalla risalita degli abitati sulle alture o su aree più rilevate rispetto al fondovalle46. Un caso emblematico, tra i molti, può essere ravvisato nel sito di Claydon Pyke, nel Gloucestershire, presso cui il sistema insediativo sviluppatosi all’interno di un terrazzo alluvionale drenato durante tutta l’epoca romana, fu abbandonato nel V secolo a favore di quello superiore, più asciutto e riparato rispetto agli episodi esondativi del fiume Severn47.
In modo del tutto analogo, le evidenze paleobotaniche, paleoambientali e paleoclimatiche a disposi-zione per il Trentino di epoca altomedievale (fig. 5) si inseriscono coerentemente all’interno del quadro generale descritto da queste informazioni.
37 Blundell, BarBer 2005, p. 1270.38 BarBer, ChamBers, maddy 2004.39 Bell, walker 1996, p. 33.40 Benvenuti et al. 2006.41 Giraudi 2005.42 holzhauser et al. 2005; joerin et al. 2006.43 Cheyette 2008, pp. 158-160 con bibliografia.44 BerGlund 2003.45 Cheyette 2008, pp. 162-163.46 FranCoviCh, hodGes 2003; BroGiolo, possenti 2008.47 Fowler 2002, p. 77.
Fig. 5. Siti trentini da cui provengono i dati paleobotanici citati nel testo. 1: Lago Nero di Cornisello, 2: Cogola Grande di Gaizzera, 3: Lago di Lavarone; 4 Grotta di Ernesto.
509
Fig. 6. Instabilità dei conoidi della valle dell’Adige. Le porzioni in rosso indicano fenomeni di riattivazioni geomorfologica avviatesi nel VI secolo (modificato, da CoLtorti, dAL ri 1985, p. 127).
Il deterioramento delle condizioni climatiche tra V-VI e VII secolo è stato ad esempio osservato dai proxy data ricavati dai sedimenti lacustri dal Lago Nero di Cornisello48 (Parco Naturale Adamello-Brenta) e da una stalagmite della Grotta di Ernesto in bassa Valsugana49, dati che in entrambi i casi docu-mentano un abbassamento delle temperature medie e un aumento della piovosità rispetto al periodo precedente.
Da un punto di vista archeologico, gli effetti del peggioramento climatico si riconoscono in quei contesti – urbani e rurali – in cui l’abbandono dei livelli di frequentazione tardo antica fu determinato dalla comparsa di potenti strati alluvionali. Per quanto concerne la valle dell’Adige, numerose sono le informazioni riferibili ad episodi alluvionali e all’instabilità dei versanti databili tra V e VII secolo: solo per ricordarne alcuni, è nota l’insorgenza di questi processi a San Floriano, Aica di Fiè, Velturno, Vola-no-San Rocco, Mezzocorona - Drei Canè e a Mezzocorona - Giontec50 (fig. 6). A Trento, l’abbandono del-le superfici tardo antiche in associazione con eventi alluvionali è stato documentato in via Calepina51, in via Rosmini52, a San Lorenzo53 e nell’area dell’anfiteatro54, località poste immediatamente all’esterno del circuito murario del municipium (fig. 8).
Ancora all’esterno dell’area urbana, lo scavo dell’area di Palazzo Roccabruna ha permesso di individuare almeno due importanti episodi alluvionali che sigillano le superifici tardoromane55. La violenza di questi fenomeni è chiaramente osservabile nei contesti di via Calepina e di via Rosmini, dove la forza d’urto dell’onda di piena produsse addirittura la dislocazione di alcune strutture mu-rarie (fig. 7).
Processi del tutto simili sono emersi anche dalle indagini condotte nell’area del Sommolago e in particolare all’interno dell’abitato di Riva del Garda56. Lungo gli assi di viale Dante e viale Roma, là dove gli interventi archeologici hanno consentito di individuare un articolato complesso edilizio realizzato a partire del I secolo d.C., si registra la comparsa di un potente strato alluvionale responsabile di una netta cesura nella destinazione funzionale di quegli spazi, sfruttati da quel momento esclusivamente per la deposizione di inumazioni dotate di elementi di corredo (numerosi pettini in osso ed una fibula ad “S”) che rimandano ad una cronologia di VI secolo57. Allo stesso modo, le necropoli di località Baltera, in uso fino al II secolo avanzato, e di San Cassiano, con frequentazione protrattasi fino al IV58, furono entrambe sigillate da episodi alluvionali messi in relazione all’instabilità dei conoidi di versante, la cui riattivazione si data alla tarda antichità59.
Analogamente ai numerosi contesti europei sopra ricordati, anche in ambito trentino tali dinamiche
48 Filippi et al. 2007.49 Frisia 2003; Borsato et al. 2007; Frisia et al. 2007.50 Coltorti, dal ri 1985; Bassetti 2004.51 Bassi 2004; Bassetti 2004.52 Bassi, endrizzi 1996.53 Bassetti 2004; Ciurletti, pisu 2005.54 Bassi 2006.55 peterlini 2009-2010, p. 287.56 Bassetti et al. 2013, pp. 11-52.57 Bassi 2010a, p. 39. I dati sono emersi grazie allo scavo della necropoli di piazzale Pilati.58 Bassi 2010b, p. 48.59 CariBoni 2010.
510
ambientali si ripercossero sulla modalità di gestione del territorio, determinando l’abbandono di ampie zone pianeggianti fino ad allora destinate allo sfruttamento agrario. Emblematici, a questo proposito, appaiono i dati pollinici raccolti nei livelli di interramento della cloaca romana scavata tra piazza Belle-sini e via Rosmini che attestano, a partire dal V secolo, l’interruzione nell’utilizzo degli spazi agrari a sud della città di Trento a seguito di un’alluvione del torrente Fersina: un bosco spontaneo associato ad aree palustri permanenti occupò un’area presso la quale, fino a qualche decennio prima, venivano coltivati cereali e vite60.
Ciononostante, a fronte dei processi di destrutturazione del paesaggio agrario nelle aree di fondovalle e di versante più instabile, emergono, per l’epoca altomedievale, evidenze di grande interesse che consen-tono di cogliere la comparsa di nuove strategie di utilizzo del territorio, inaugurate attraverso l’aumento dell’impatto antropico su aree fino ad allora poco o per nulla interessate dallo sfruttamento economico. I dati – forse non a caso – provengono da due aree laterali alla valle dell’Adige: la val Terragnolo e l’al-
topiano di Lavarone, che della Valsugana può essere considerato – soprattutto per ragioni storiche – l’appendice sud-occi-dentale.
L’analisi tessiturale e isotopica di una stalagmite dalla Cogola Grande di Giazzera, in val Terragnolo, e dei reperti pollinici contenuti nei sedimenti lacustri del Lago di Lavarone documentano in-fatti un’importante riduzione delle aree boschive a vantaggio del pascolo nel corso di una fase cronologica che si col-loca tra la fine del VI secolo e tutto il VII secolo.
Nel dettaglio, i dati desunti dalla cam-pionatura di una stalagmite dalla Cogola Grande di Giazzera (1025 m slm), pres-so le pendici sud-occidentali del Monte Pasubio, hanno messo in evidenza una ripresa del concrezionamento dello spe-leotema che potrebbe essere il “prodotto del passaggio da una foresta di conifere ad una foresta decidua o pascolo” in un
60 marvelli et al. 2002, pp. 382-383.
Fig. 7. Il crollo indotto dall’onda di piena di due strutture murarie di epoca romana in via Rosmini (fig. a; da BASSi 2004, p. 418) e in via Calepina (fig. b; da BASSi 2004, p. 419). Fig. 8. Trento romana. Siti citati nel testo. 1 San Lorenzo; 2 Piazza Bellesini; 3 Via Rosmini; 4 Anfiteatro; 5 via Calepina; 6 Palazzo Roccabruna (a sud di via Calepina); modificato, da CiurLetti 2000, p. 295.
511
Fig. 9. Modelllo 3D dell’area di Lavarone. Si distingue il piccolo bacino lacustre, posto ad una quota di 1114 m slm.
periodo databile tra il 590 e il 71561. Allo stesso modo, presso il lago di Lavarone (fig. 9), i dati paleoambientali permettono di osservare un im-portante episodio di deforestazione praticato, se-condo i dati cronometrici disponibili, tra il 570 e il 655, in piena epoca longobarda: i taxa arborei del faggio, della quercia e delle conifere che caratte-rizzavano l’area durante tutta l’epoca romana, su-birono infatti una significativa diminuzione per-centuale a vantaggio dei pollini erbacei, indicatori della realizzazione dei nuovi pascoli62.
Anche nell’area nord-occidentale della provincia di Trento, cominciano ad emergere dati omologhi: una recente indagine condotta nell’ambito del progetto Alpes ha datato la fre-quentazione di un recinto d’alta quota in Val di Sole ad un periodo compreso tra il VII e l’inizio dell’VIII secolo63.
La cronologia di questi fenomeni, che sottendono allo sviluppo di un nuovo modello economico sensibilmente più orientato allo sfruttamento delle risorse silvopastorali esattamente durante l’epoca longobarda, pone dunque anche il problema del rapporto tra queste inedite tendenze all’uso delle aree marginali e l’evoluzione ambientale intervenuta all’interno delle aree di fondovalle di numerosi settori trentini con la presenza dei Longobardi in tale settore geografico. Un radicamento che, peraltro, è do-cumentato archeologicamente – come dimostra il caso di Bosentino – anche in posizioni-chiave lungo i percorsi di collegamento tra queste aree di alta quota e i bacini fluviali dell’Adige e del Brenta.
4. il Radicamento delle aRistocRazie longoBaRde sul teRRitoRio: tRasfoRmazione o continuità dei paesaggi antRopici?
Alcuni contributi dedicati allo stanziamento longobardo nella Valsugana, pur riconoscendo nelle mo-dalità di insediamento la necessità di privilegiare alcuni nodi militarmente strategici64 hanno sostanzial-mente privilegiato una prospettiva di continuità rispetto alle strutture socio-economiche e insediative di tradizione romana e tardo-antica65. Questa lettura è stata avanzata a partire dalla presenza di indicatori archeologici relativi a soggetti di rango, come il sarcofago di Levico (II-III secolo)66 o l’iscrizione funeraria della prima metà del VI secolo proveniente dall’area di San Valentino di Tenna, dati che consentirebbero di identificare il radicamento sul territorio di quei possessores che le fonti scritte ed epigrafiche attestano diffusamente dalla prima età imperiale all’epoca gota67. La comparsa di individui di cultura longobarda sarebbe quindi maturata in un contesto di fluida continuità, in cui la sostituzione di una classe dirigente all’altra68 non avrebbe intaccato i precedenti assetti patrimoniali né le strategie di utilizzo del territorio. Strategie di utilizzo che, secondo questa lettura, sarebbero state fortemente imperniate sullo sfruttamento agricolo del fondovalle, come suggerito dalla cospicua presenza antropica di epoca romana nell’area di Caldonazzo e Levico.
Tuttavia, i dati richiamati nel paragrafo precedente, dalle informazioni paleobotaniche agli indicatori insediativi di epoca longobarda, tendono semmai a suggerire una decisa differenziazione del quadro economico e della trama dell’habitat durante il VI-VII secolo.
Appare piuttosto evidente, sulla base dei dati finora acquisiti, come lo stanziamento longobardo non andò ad inserirsi in modo aderente con le gerarchie insediative di epoca romana (fig. 10). Proprio presso le aree di Caldonazzo e di Levico infatti, dove i numerosi indicatori funerari e i resti di qualche edificio
61 Frisia et al. 2007, p. 219.62 arpenti, Filippi 2007.63 anGeluCCi et al. 2013.64 BierBrauer 2005; Cavada 1991, p. 75.65 Cavada 2004, pp. 204-205; parzialmente seguito, con alcune riserve da pisu 2010, p. 20.66 Cavada 1999, pp. 299-300.67 paCi 1993, pp.153-158; Buonopane 1994, pp. 159-160.68 I ‘signori della terra’ in Cavada 2004, p. 206.
512
Fig. 10. Il popolamento di epoca romana in rapporto con la distribuzione dei siti altomedievali. La freccia rossa indica l’area di Levico-Caldonazzo, zona privilegiata dall’habitat di epoca romana.
rustico autorizzano ad ipotizzare la concentrazione di un sistema di incolati in rapporto alla sfruttamento agrario del fondovalle alluvionale, la presenza dei Longobardi non è finora stata documentata.
Viceversa, i nuclei longobardi finora noti disegnano una chiara tendenza a privilegiare le aree rilevate rispetto al fondovalle, come l’altopiano di Bosentino, il terrazzo fluviale di Civezzano e la dorsale di Telve di Sopra, senza dimenticare i siti d’altura che gravitano sul Perginese. Quello della risalita degli insedia-menti è un processo ampiamente noto69 che sembra accelerarsi in corrispondenza con l’epoca longobarda, come sottolineano recenti indagini in Italia centro-settentrionale70.
Che questo fenomeno sia stato condizionato anche da fattori ambientali e da precise scelte di natura socioeconomica – nonché da un generale clima di insicurezza – è un dato considerato ormai ampiamente accettato.
Sul versante delle strategie di gestione della terra, gli insediamenti di altura si presentavano mag-giormente integrati all’interno della nuova economia silvopastorale, posizionandosi ai margini di quelle aree di alta quota che, come sembrano suggerire i dati provenienti dal lago di Lavarone, cominciarono ad essere interessati da una crescente pressione in corrispondenza con l’età longobarda.
Motivo per il quale non appare dunque del tutto aleatoria l’ipotesi che la nascita di un nuovo modello di sfruttamento del territorio, in rapporto anche con l’affermazione di nuovi regimi alimentari71, possa essere stato favorito dalla presenza delle aristocrazie longobarde72.
In conclusione, la nuova gerarchia del popolamento e le inedite strategie di utilizzo delle risorse ambientali che sembrano maturare durante l’età longobarda disegnano un quadro di rimodulazione insediativa, economica e sociale che denota una forte rielaborazione degli assetti demografici e delle at-tività economiche di epoca romana. Invece che presentarsi contraddistinti da una sostanziale continuità, i paesaggi antropici del Trentino orientale denotano al contrario una decisa trasformazione durante l’età longobarda. E nel bilancio complessivo di queste trasformazioni, l’evoluzione ambientale indotta dal cambiamento climatico non sembra avere svolto un ruolo marginale.
69 FranCoviCh, hodGes 2003.70 BroGiolo, possenti 2008.71 montanari 1979; montanari 1990.72 BroGiolo 2005, p. 13; moreno 2001.
513
BIBLIOGRAFIAAmAnte Simoni C. 1984, Schede di archeologia longobarda in Italia. Trentino, “Studi medievali”, XXV, pp. 901-955.
AnGeLuCCi d.e., CArrer F., CAVuLLi F., deLPero A., ForAdori G., mediCi t., Pedrotti A., PiSoni d., rottoLi m. 2013, Primi dati archeologici da una struttura pastorale d’alta quota in Val di Sole: il sito MZ005S (Mezzana, Trento), in AnGeLuCCi d.e., CASAGrAnde L., CoLeCChiA A., rottoLi m. (a cura di), APSAT 2. Paesaggi d‘altura del Trentino: evoluzione naturale e aspetti cul-turali, Mantova, pp. 141-162.
ArPenti E., FiLiPPi M.L. 2007, Evoluzione della vegetazione nei pressi del Lago di Lavarone (TN) negli ultimi 2200 anni, “Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Geologica”, 82 (2005), pp. 317-32.
BAker P. 1991, Fauna, in BroGioLo G.P., CASteLLetti L. (a cura di), Archeologia a Monte Barro. Il grande edificio e le torri, Lecco, pp. 153-168.
BAker P. 1996, Socio-economic aspects of food supply in Early Medieval Brescia: the zooarchaeological remains from Longobard S.Giulia, in BroGioLo G.P. (a cura di), Early medieval towns in the western mediterranean. Ravello, 22-24 september 1994, Documenti di Archeologia, 10, Mantova, pp. 89-96.
BArBer K.E., ChAmBerS F.M., mAddy D. 2004, Late Holocene climatic history of northern Germany and Denmark: peat macrofossil investigations at Dosenmoor, Schleswig-Holstein, and Svanemose, Jutland, “Boreas”, 33, pp. 132-144.
BASSetti M. 2004, Approccio geoarcheologico al territorio della Valle dell’Adige: appunti sui dati paleoambientali, in de VoS M. (a cura di) 2004, pp. 263-301.
BASSetti M, CAPPeLLozzA N., CAriBoni M., deGASPeri N 2013, Modificazioni geomorfologiche e aspetti geoarcheologici del territorio del Sommolago. Elementi per una ricostruzione del paesaggio, in BroGioLo G.P. (a cura di), APSAT 3. Paesaggi Storici del Som-molago, Mantova, pp. 11-52.
BASSi C. 2004, L’acqua e la città romana. Il caso Tridentum: il fiume, i fossati, i pozzi, le condutture, in M. de VoS (a cura di) 2004, pp. 405-428.
BASSi C. 2006, L’anfiteatro di Tridentum, in La forma della città e del territorio, 3. Atlante tematico di topografia antica, Acta, 15, Roma, pp. 7-18.
BASSi C. 2010a, Il territorio di Riva del Garda in epoca roma-na, in BASSi C., GrAnAtA A., oBeroSLer R. (a cura di) 2010, pp. 31-42.
BASSi C. 2010b, Le necropoli e la loro frequentazione in epoca romana, in BASSi C., GrAnAtA A., oBeroSLer R. (a cura di) 2010, pp. 43-132.
BASSi C., endrizzi L., 1996, Trento, Via Rosmini: vecchi e nuovi rinvenimenti, in GuidoBALdi F., GuGLiA GuidoBALdi A. (a cura di), Atti del III colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, Bordighera, 6-10 dicembre 1995, Bordighera (IM), pp. 181-188.
BASSi C., GrAnAtA A., oBeroSLer R. (a cura di) 2010, La via delle Anime. Sepolture di epoca romana a Riva del Garda, Catalogo della Mostra, Riva del Garda, 9 luglio - 1 novembre 2010, Riva del Garda (TN).
BeLL m., WALker m.J.C. 1992, Late Quaternary Environmental Change. Phisical and Human Perspectives, New York.
BenVenuti m., mAriotti-LiPPi M., PALLeCChi P., SAGri M. 2006, Late-Holocene catastrophic floods in the terminal Arno River (Pisa, Central Italy) from the story of a Roman riverine harbour, “The Holocene”, September 2006, vol. 16, 6, pp. 863-876.
BerGLund B.E. 2003, Human impact and climate changes-syn-chronous events and a causal link?, “Quaternary International”, 105 (2003), pp. 7-12.
BierBrAuer V. 2005, Romani e Germani fra V e VIII seco-lo dal punto di vista della ricerca archeologica, in Romani e Germani nel cuore delle Alpi tra V e VIII secolo, Saggi, Bolzano, pp. 213-239.
BLundeLL A., BArBer K. 2005, A 2800-year palaeoclimatic record from Tore Hill Moss, Strathspey,Scotland: the need for a multi-proxy approach to peat-based climate Reconstructions, “Quaternary Science Reviews”, 24 (2005), pp. 1261-1277.
BorSAto A., FriSiA F., miorAndi R., VAn der BorG K., SPotL C., CorrAdini F. 2007, Ricostruzioni climatico-ambientali per l’Olocene da tufo calcareo e latte di monte in grotte del Trentino, “Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Geologica”, 82 (2005), Trento, pp. 239-259.
BridA L. 2000, Caldonazzo. Contributi storici, Pergine Valsugana (TN).
BroGioLo G.P. (a cura di) 1996, La fine delle ville romane: trasformazioni nelle campagne tra tarda antichità e alto medioevo, I Convegno Archeologico del Garda, Gardone Riviera, 14 ottobre 1995, Mantova.
BroGioLo G.P. 2005, Risultati e prospettive della ricerca archeologica sulle campagne altomedievali italiane, in BroGioLo G.P., ChAVArriA ArnAu A., VALenti M. (a cura di), Dopo la fine delle ville: le campa-gne dal VI al IX secolo, 11° Seminario sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo, Gavi, 8-10 maggio 2004, Mantova, pp. 7-16.
BroGioLo G.P., PoSSenti E. 2008, Aktuelle Forschungen und Ansätze der langobardischen Archäologie in Italien, in BemmAnn J., SChmAuder M. (Hrsg.), Kulturwandel in Mitteleuropa Lango-barden - Awaren - Slawen, Akten der Internationalen Tagung, Bonn, 25-28 febbraio 2008, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, 11, Bonn, 2008, pp. 449-466.
BuonoPAne A. 1994, Regio X-Venetia et Histria. Ausugum, in Supplementa Italica, n.s., XII, Roma, pp. 151-168.
CAmPi L. 1885, Le tombe barbariche di Civezzano e alcuni rinve-nimenti medioevali nel Trentino, “Archivio Trentino”, 5 (1886), pp. 3-32.
CAriBoni M. 2010, Geomorfologia del territorio nelle località S. Cassiano e Baltera, in BASSi C., GrAnAtA A., oBeroSLer R. (a cura di) 2010, pp. 13-18.
CAVAdA E. 1991, Dai possessores feltrini ai signori delle torri, in BerLAndA G. (a cura di), Il castello di Pergine, Trento, pp. 59-78.
CAVAdA E. 1999, Archeologia e territorio. Esame delle informazione dell’Alta Valle del Brenta e del Trentino Orientale, Atti “Accademia Roveretana degli Agiati”, Volume 249, pp.281-312.
CAVAdA E. 2004, Città e territorio nell’alto medioevo alla luce delle fonti archeologiche, in CAStAGnetti A., VArAnini G. M. (a cura di) 2004, pp. 195-223.
Cheyette F.L. 2008, The disappearance of the ancient landscape and the climate anomaly of the early Middle Ages: a question to be pursued, “Early medieval Europe”, 16 (2), Oxford, pp. 127-165
ChriStie N. 2006, From Constantine to Charlemagne: An Archaeo-logy of Italy, AD 300-800, Aldershot.
CiurLetti G. 1997, Corredo tombale da Civezzano (loc. Castel Tel-vana), in endrizzi L., mArzAtiCo F. (a cura di), Ori delle Alpi, Catalogo della Mostra, Trento, 20 giugno - 9 novembre 1997, Trento, pp. 520-521.
514
CiurLetti G., PiSu N. 2005, S. Lorenzo, Trento, l’Adige. Topografia e storia, in GroSSeLLi A. (a cura di), La badia di S. Lorenzo a Trento, Rovereto (TN), pp. 157-181.
CiurLetti G., PortA P. 2007, La chiesa trentina delle origini, in BonACASA CArrA R.M., VitALe E. (a cura di), La cristianizzazio-ne in Italia tra tardoantico ed altomedioevo, Atti del IX congresso nazionale di archeologia cristiana, Agrigento, 20-25 no-vembre 2004, Palermo, pp. 567-604.
CiurLetti G., rizzi G. 2003, Civezzano, S. Maria, in SennAhAuSer H.R. (a cura di), Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet, Von der Spätantike bis in ottonische Zeit, München, pp. 371-375.
CoLtorti M., dAL ri L., 1985, The Human impact on the landscape: some examples from the Adige Valley, in mALone C., StoddArt S. (eds.), Papers in Italian Archaeology. IV/I. The human landscape, BAR International Series, 243, Oxford, pp. 105-134.
CrABtree P.J. 2010, Agricultural innovation and socio- economic change in early medieval Europe: evidence from Britain and France, “World Archaeology”, 42:1, pp. 122-136.
dArk P. 2000, The Environment of Britain in the First Millennium A.D., London.
de VoS M. (a cura di) 2004, Archeologia del territorio. Metodi Materiali prospettive: Medjerda e Adige: due territori a confronto, Trento.
deSPrAt S., Goñi M.F.S., Loutre M.-F. 2003, Revealing climatic variability of the last three millennia in northwestern Ibera using pollen influx data, “Earth and Planetary Science Letters”, 213, pp. 63-78.
FiLiPPi m.L., heiri o., ArPenti e., AnGeLi n., BortoLotti m., Lotter F., VAn der BorG k. 2007, Studio paleolimnologico del Lago Nero di Cornisello (Parco Naturale Adamello-Brenta,Trentino), “Studi Trentini di Scienze Naturali”, Acta Geologica, 82, Trento, pp. 261-278.
ForLin P. 2011-2012, Remote Sensing Analysis e Archeologia dei paesaggi nel Trentino orientale. La Valsugana, la Val di Cembra e l’Altopiano di Pinè tra l’età tardoantica e il medioevo, Tesi di dot-torato, Università degli Studi di Trento, Scuola di dottora-to in Discipline Umanistiche, XXIV Ciclo.
ForLin P. 2013a, Castel Telvana di Civezzano, in PoSSenti E., GentiLini G., LAndi W., CunACCiA M. (a cura di), Apsat 4. Castra, castelli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo. Schede 1, Mantova, pp. 88-92.
ForLin P. 2013b, Castello di San Pietro, in PoSSenti E., GentiLini G., LAndi W., CunACCiA M. (a cura di), Apsat 4. Castra, castelli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo. Schede 1, Mantova, pp. 65-68.
ForLin P. 2013c, Castello di Pergine, in PoSSenti E., GentiLini G., LAndi W., CunACCiA M. (a cura di), Apsat 4. Castra, castelli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo. Schede 1, Mantova, pp. 112-118.
FoWLer P. 2002, Farming in the First Millennium AD: British Agriculture Between Julius Caesar and William the Conqueror, Cambridge.
FrAnCoViCh R., hodGeS R. 2003, Villa to village: the transfor-mation of the Roman countryside in Italy, c. 400-1000, Bristol.
FriSiA S. 2003, Towards an understanding of the relationship between environmental changes and human societies: analytical techniques and examples from the Alps, “Preistoria Alpina”, 39 (2003), Trento, pp. 39-47.
FriSiA S. 2007, I progetti AQUAPAST e OLOAMBIENT del Museo Tridentino di Scienze Naturali: un tuffo nel passato per conoscere il clima del futuro, “Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Geologica”, 82 (2005), pp. 1-4.
FriSiA S., BorSAto A., riChArdS A. D., miorAndi R., dAVAnzo S. 2007, Variazioni climatiche ed eventi sismici negli ultimi 4500 anni nel Trentino meridionale da una stalagmite della Cogola Gran-de di Giazzera, “Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Geo-logica”, 82 (2005), pp. 205-223.
GiL-GArCíA M.J., ruiz-zAPAtA M.B., SAntiSteBAn J.I., mediAViLLA R., LóPez-PAmo E., dABrio C.J. 2007, Late Holocene environments in Las Tablas de Daimiel (south central Iberian Peninsula, Spain), “Vegetation History and Archaeobotany”, 16 (4), pp. 241-250.
GirAudi C. 2005, Late Holocene Alluvial Events in the central Appennines, Italy, “The Holocene”, 15 (2005), pp. 768-773.
Grudd H., BriFFA K.R., kArLen W., BArthoLin T.S., JoneS P.D., kromer B. 2002, A 7400-year tree-ring chronology in northern Swedish Lapland: natural climatic variability expressed on annual to millennial timescales, “The Holocene”, 12 (6), pp. 657-665.
hodGeS R. 2010, AD 536: The year Merlin (supposedly) died, in mAinWArinG A.B., GieGenGACk R., VitA-Finzi C. (eds), Climate Crisis in Human History, Philadelphia, pp. 71-82.
hodGeS R. 2012, Dark Age Economics. A new Audit, Bristol.
hoLzhAuSer H., mAGny M., zumBÜhL H.J. 2005, Glacier and lake-level variations in west-central Europe over the last 3500 years, “The Holocene”, 15 (6), pp. 789-801.
JiAnG H., SeidenkrAntz M-S., knudSen K.L., eirikSSon J. 2002, Late-Holocene summer sea-surface temperatures based on a diatom record from the north Icelandic shelf, “The Holocene”, 12 (6), pp. 137-147.
Joerin U.E., StoCker T.F., SChLÜChter C. 2006, Multicentury glacier fluctuations in the Swiss Alps during the Holocene, “The Holocene”, 16 (5), pp. 697-704.
Lenzi K. 2009, E ‘sotto’ i castelli? Un tentativo di lettura delle preesi-stenze dei siti fortificati di età medievale della Valsugana trentina, in oSti G. (a cura di), Prima dei castelli medievali: materiali e luoghi nella regione atesina, Atti della Tavola Rotonda, Rovereto, 27 novembre 2009, Accademia Roveretana degli Agiati, Ro-vereto (TN), 259, pp. 25-46.
LeWit T. 2009, Pigs, presses and pastoralism: farming in the fifth to sixth centuries AD, “Early medieval Europe”, 17 (1), pp. 77-91.
mArtín-ChiVeLet J., muñoz-GArCíA M. B., edWArdS R. L., turrero M. J., orteGA A. I. 2011, Land surface temperature changes in Northern Iberia since 4000 yr BP, based on δ 13C of speleothems, “Global and Planetary Change”, 77 (2011), 1-2, pp. 1-12.
mArVeLLi S., mArCheSini M., torri P., ForLAni L. 2002, Indagini archeopalinologiche a Trento (III-XIV secolo d.C.). Pri-mi risultati, “Archeoalp - Archeologia delle Alpi”, vol. 6, Trento, pp. 365-396.
montAnAri M. 1979, L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo, Napoli.
montAnAri M. 1984, Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari, Torino.
montAnAri M. 1990, Vegetazione e alimentazione, in L’ambiente vegetale nell’Alto Medioevo, Settimane di Studio del CISAM, 30 marzo - 5 aprile 1989, I, Spoleto, pp. 281-322.
515
moreno D. 2001, Uscire dal paesaggio: il contributo dell’ecologia storica e della storia locale, in de mArChi M., SCudeLLAri M., zAVAGLiA A. (a cura di), Lo spessore storico in urbanistica, Giorna-ta di studio, Milano, 1 ottobre 1999, Documenti di Archeo-logia, 23, Mantova, pp. 85-87.
niGGemAnn S., mAnGini A., riChter D.K., Wurth G. 2003, A paleoclimate record of the last 17,600 years in stalagmites from the B7 cave, Sauerland, Germany, “Quaternary Science Reviews”, 22 (2003), 5-7, pp. 555-567.
oLAFSdottir R., SChLyter P., hArALdSSon H.V. 2001, Simulat-ing Icelandic vegetation cover during the Holocene: Implications for long-term land degradation, “Geografiska Annaler”, 83 (4), pp. 203-215.
PACi G. 1993, Spigolature epigrafiche trentine, “Archeoalp. Archeologia delle Alpi”, 2, pp. 129-158.
PASquALi T., toLdo A. 2008, I rinvenimenti del dosso del Guardian o Puster, in BeBer L., StuLzer M., zAmPedri M. (a cura di), Vignola Falesina: due piccole, forti comunità nel tempo, Vignola Falesina (TN).
PAzienzA A. 2009, I Longobardi trentini nell’Ottocento: storia e interpretazione della necropoli di Civezzano, in GASPArri S. (a cura di), Archeologia e storia dei Longobardi in Trentino (secoli VI-VIII), Atti del convegno nazionale di studio, Mezzolombardo, 25 ottobre 2008, Mezzolombardo (TN), pp. 77-102.
PeterLini M. 2009-2010, Indagini archeologiche a Palazzo Roccabruna (Trento), scavi 2007/2008. Interazione tra fattori natu-rali e culturali nella genesi di una stratificazione tardo-olocenica, Tesi di Laurea, Relatore Angelucci D., Università degli Studi di Trento.
PiSu N. 2010, Le tracce del popolamento altomedievale, in Corni G., FrAnCeSChini I. (a cura di), Nel tempo e tra la gente di Bosenti-no e Migazzone: territorio, società e istituzione, Trento, pp. 19-24.
PoSSenti E. 2013, 1.2.1 Civezzano, Santa Maria Assunta, in Bro-GioLo G.P., CAVAdA E., iBSen M., PiSu N., rAPAnà M. (a cura di), Apsat 10. Chiese trentine dalle origini al 1250, I, Mantova, pp. 159-162.
reynoLdS A. 2005, Review Article: On Farmers, Traders and Kings: Archaeological Reflections of Social Complexity in Early Medieval North-Western Europe, “Early Medieval Europe”, 13 (1), pp. 97-118.
rizzoLLi H. 2005, L’economia monetaria in epoca barbarica nella regione trentino-tirolese, in Romani e Germani nel cuore delle Alpi tra V e VIII secolo, Saggi, Bolzano, pp. 283-295.
roBerti G. 1925, Il sepolcreto barbarico di Bosentino e gli altri rinvenimenti della Valsorda, “Archivio Veneto-Trentino”, VII, pp. 210-223.
SALVAdori F. 2007, Resti osteologici animali: elementi di continuità e discontinuità tra tardoantico ed altomedioevo, in FrAnCoViCh R., VALenti M. (a cura di), IV Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, 2006, pp. 520-524.
SquAtriti P. 2010, The Floods of 589 and Climate Change at the Beginning of the Middle Ages: an Italian Microhistory, “Specu-lum”, 85 (4), pp. 799-826.
terzer C. 2005, Le tombe longobarde di Civezzano. Sull’interpretazione di reperti provenienti da antichi scavi, in Roma-ni e Germani nel cuore delle Alpi tra V e VIII secolo, Saggi, Bolzano, pp. 297-313.
trément F. 2001, Habitat et peuplement en Provence à la fin de l’Antiquité, in ouzouLiAS P., PeLLeCuer C., rAynAud C., VAn oSSeL P., GArmy P. (eds), Les campagnes de la Gaule à la fin de l’Antiquité, Actes du colloque, Montpellier, 11-14 marzo 1998, Antibes, 275-301.