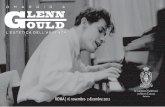Delli Zotti 2007 Are you experienced…? Trasformazione di variabili e creazione di indici con Spss
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate (Processes of urban transformation...
Transcript of I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate (Processes of urban transformation...
WORKING
PAPERS
#9/2015
Valentina Gingardi, GSSI
I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE URBANA A MILANO:
il caso di Lambrate
GSSI CITIES
CITIES RESEARCH UNIT
G S
S I
GRAN SASSO
SCIENCE INSTITUTE
CENTER FOR ADVANCED STUDIES
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE URBANA A MILANO:
il caso di Lambrate
Copyright © Valentina Gingardi 2015
Email: [email protected]
Gran Sasso Science Institute
CITIES Research Unit
Via Francesco Crispi 7, 67100 L’Aquila (IT)
Website: www.gssi.infn.it
Blog: www.studiurbani.it
3
VALENTINA GINGARDI, GSSI
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate.
Il paper indaga i processi di trasformazione urbana nel settore est di Milano, il sistema normativo che li regola ed i conseguenti equilibri e squilibri che si producono, con l’obiettivo di identificarne l’esito aggregato sulla qualità urbana ed il benessere degli abitanti. Presentando il caso studio di Lambrate il paper mette a sistema le azioni e le posizioni di svariati portatori d’interesse, pubblici e privati. Ritenendo che una valutazione complessiva degli effetti finali sul benessere di Lambrate potrà esprimersi solamente quando l’intero quartiere sarà reso operativo, la ricerca sottolinea l’importanza di approcciare il tema della trasformazione considerandone simultaneamente le implicazioni spaziali e quelle temporali. Le conclusioni del testo propongono di allargare lo sguardo alla scala sovra-comunale, avviando un ragionamento coordinato tra i quartieri periferici della città e i comuni di cintura, nel tentativo di delineare una traiettoria coerente e strategicamente sostenibile di sviluppo del territorio. Parole Chiave: Milano, trasformazione urbana, rigenerazione urbana, qualità urbana
_____ [Processes of urban transformation in Milan: the case of Lambrate] This paper investigates the processes of urban
transformation within the east area of Milan, the
prescriptive system which regulates them and
the resulting imbalances that are produced. The
aim is to identify the expected results on urban
quality and well-being. Through the case study of Lambrate the paper outlines the actions and
positions of both public and private
stakeholders. Assessing that the overall
evaluation of the final results on Lambrate’s well
being may be stated only when the whole
settlement will be complete, the research
emphasizes the importance of approaching the
topic of urban transformation considering both
spatial and temporal implications. A proposal to
view this transformation at the metropolitan
scale is recommended, as is stressing the importance of a common debate among
suburban districts and external municipalities,
trying to outline a coherent and sustainable
development trajectory of the territory.
Keywords: Milan, urban transformation, urban
regeneration, urban quality
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate
4
1. INTRODUZIONE
Nell’interrogarsi sulle traiettorie di sviluppo delle città non si può evitare di affrontare i temi della trasformazione urbana e della rigenerazione del territorio. In particolare, la riqualificazione della periferia ha assunto una rilevanza crescente e da diversi anni è al centro delle politiche promosse dall’Unione Europea. Le città italiane rappresentano un caso studio rilevante per la consistenza spaziale, economica e sociale delle periferie urbane, spesso caratterizzate da un disegno ed un assetto funzionale incompleto (Pinto, 2007). Sebbene molti studiosi abbiano indagato i processi di trasformazione e di sviluppo urbano nell’area milanese (Bolocan Goldstein & Bonfantini, 2007; Bovone & Ruggerone, 2009; Curti & Gibelli, 1998; Montedoro, 2011; Zajczyk, Borlini, Memo, & Mugnano, 2005) e le problematiche di natura sociale ed abitativa delle zone periferiche (Bricocoli & Savoldi, 2010; Centro Studi PIM, 2003; Tosi, 2008), appare utile approfondire il ragionamento in merito all’analisi delle trasformazioni urbane alla scala del quartiere e dei conseguenti impatti sul territorio. Considerando parallelamente l’evoluzione spaziale e quella temporale dei processi in corso, il presente lavoro indaga il sistema di equilibri e squilibri che regolano i processi di rigenerazione nel settore est di Milano. L’unità di analisi della ricerca è la realtà di Lambrate, che occupa una posizione strategica all’interno dell’area metropolitana milanese (cfr. fig. 1) e rappresenta un nodo infrastrutturale. Il quartiere è stato interessato negli ultimi anni (2000-2014) da profondi processi di riqualificazione promossi da differenti attori pubblici e privati e attuati con diversi strumenti normativi. Il presente lavoro si propone di analizzare i progetti di trasformazione urbana a Lambrate – conclusi ed in corso – nel tentativo di individuare il loro esito aggregato sulla qualità urbana e il benessere degli abitanti. Una lettura sistemica del processo di trasformazione rappresenta, infatti, il presupposto fondamentale per comprendere e valutare gli effetti emergenti dalle diverse azioni, al fine di calibrare l’intervento pubblico. L’osservazione del processo di trasformazione in corso e dell’interazione tra gli attori consente di avanzare alcune ipotesi di lavoro. In primo luogo è possibile riscontrare un’incerta e mutevole concettualizzazione dei progetti da realizzare. La liberalizzazione delle destinazioni funzionali (Comune di Milano, 2009d; Regione Lombardia, 2005) e le progressive modifiche apportate ai progetti durante l’iter di approvazione rappresentano importanti fattori da considerare per la valutazione del processo e per il raggiungimento concreto degli obiettivi. In secondo luogo – e conseguentemente alla prima proposizione – la ricerca rileva una sostanziale viscosità ed uno slittamento temporale rispetto alle previsioni iniziali, sia nella definizione che nella realizzazione dei progetti, con frequenti revisioni degli stati di avanzamento e del cronoprogramma complessivo. Il paper si articola in 4 sezioni principali. Dopo un paragrafo introduttivo nel quale sono descritti i caratteri morfologici di Lambrate, il profilo della popolazione e delle attività imprenditoriali (§2), vengono analizzati gli episodi di trasformazione urbana più significativi che stanno interessando il territorio (§3 e seguenti). Sono poi indagati gli effetti attesi sul quartiere in relazione al processo di trasformazione in corso (§4). La sezione conclusiva (§5) è dedicata ad alcune riflessioni alla scala sovra-comunale e rileva l’importanza di individuare una traiettoria coerente e strategicamente sostenibile di sviluppo del territorio, al fine di preservare il “carattere dei luoghi” ed allo stesso tempo implementare le politiche pubbliche.
GSSI Cities | Working Papers 9/2015 | Valentina Gingardi, GSSI
5
Fig. 1: Cantieri e progetti nel nucleo centrale milanese. Fonte: rielaborazione dell’autore su dati Camera di Commercio di Milano e Politecnico di Milano (2012)
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate
6
2. LAMBRATE: UN INQUADRAMENTO DEL QUARTIERE
Lo strumento di pianificazione urbanistica della città di Milano è rappresentato dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 1 approvato nel 2012. Il comune è suddiviso in 9 circoscrizioni e Lambrate fa parte della zona di decentramento 3, Città Studi-Lambrate-Venezia 2 e rappresenta un Nucleo di Identità Locale (N.I.L.), ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti centralità di quartiere 3. Antico borgo a carattere agricolo, inglobato nel comune di Milano nel 1923, il quartiere deve il proprio nome alla presenza del fiume Lambro che lo attraversa 4. Il territorio è cintato da insediamenti residenziali consolidati, in particolare quelli di Feltre a nord, Ortica a sud e Città Studi ad ovest. La morfologia urbana di Lambrate è caratterizzata dalla presenza della direttrice del ferro e della tangenziale, che rappresentano due sistemi lineari definiti (cfr. fig. 2). Tra queste due infrastrutture si è consolidato il baricentro storico del quartiere a carattere residenziale ed industriale, interessato da successivi investimenti nel settore delle nuove tecnologie d’informazione e design. La fermata della metropolitana che serve questa zona si trova nella parte occidentale di Lambrate, in stretta connessione con il quartiere di Città Studi. Il nucleo storico, compreso tra l’asse di via Rombon a nord, la tangenziale ad est e la ferrovia a sud ed ovest, è tuttavia collocato dalla parte opposta del tracciato ferroviario; per poter raggiungere quest’area è necessario attraversare il fascio dei binari (cfr. fig. 2). La zona di decentramento 3 è tra le meno popolate, con un totale di circa 165.000 residenti. Solo le zone 1 (Centro Storico) e 5 (Porta Ticinese-Porta Lodovica-Vigentino-Chiaravalle-Gratosoglio) presentano valori inferiori (Comune di Milano Settore Statistica, 2014). Il trend della popolazione di quest’ambito ha tuttavia registrato un incremento importante negli ultimi anni, in relazione ai fenomeni di immigrazione che riguardano l’intero territorio nazionale. Il N.I.L. di Lambrate ha circa 12.700 residenti al 31 dicembre 2013 (Comune di Milano Settore Statistica, 2014), di cui il 17% è rappresentato da stranieri (2.189 unità). La popolazione italiana registra una variazione di +3,2% rispetto al 2011, mentre quella straniera si assesta al +8%. 5 Il quartiere vede una prevalenza di anziani nel nucleo storico e un incremento delle famiglie del ceto medio, plausibilmente in relazione al nuovo potenziale abitativo connesso agli interventi di rigenerazione urbana. La fascia di residenti italiani più corposa in zona 3 è quella compresa tra i 40 ed i 59 anni, mentre per i residenti stranieri è quella tra i 20 ed i 39 anni (cfr. tab.1-2). In
1 Il P.G.T. è stato redatto nel 2009 sotto la giunta Moratti e ha ricevuto l’approvazione definitiva nel novembre 2 Fino al 1999 le zone di decentramento erano 20, poi ridotte al numero attuale mediante accorpamenti. Recentemente è stato avviato un dibattito per incrementarne nuovamente il frazionamento.
3 Lambrate rappresenta il N.I.L. n. 23. I N.I.L. “corrispondono ad ambienti dai confini variabili, in grado di modificarsi, sovrapporsi, sconfinare l’uno nell’altro” (Comune di Milano, 2009b, p. 73). 4 Nel corso del ‘700 gli sparsi insediamenti rurali iniziano a consolidarsi attorno a due nuclei principali: Lambrate superiore ed inferiore (Archivio di Stato di Milano, 1722). Nel 1846 viene costruito il tracciato ferroviario che connette Milano a Venezia ed i terreni agricoli di questa zona divengono i più quotati di Milano, grazie al potenziamento infrastrutturale e alla prossimità con il centro città. Il 1865 vede l’unificazione dei percorsi ferroviari e Lambrate viene divisa in due parti dalla ferrovia e separata dal nucleo milanese (Archivio di Stato di Milano, 1887). Durante il secondo decennio del ‘900 numerose industrie meccaniche e metalmeccaniche si innestano nel territorio (Leone, 2005), richiamate dalla presenza della ferrovia. Gli anni ’60 e ’70 sono caratterizzati da un forte sviluppo residenziale. 5 Il N.I.L. 23 rappresenta circa lo 0,8% dell’intera popolazione della città di Milano e il 7,7% della zona 3. Le nazionalità straniere prevalenti a Lambrate sono: filippina (3.321), peruviana (1.746), egiziana (1.252), cinese (1.050), srilankese (971), romena (924), ecuadoriana (864) e ucraina (669), sulla base delle rilevazioni al 31 dicembre 2012 (Bonomi, Gatti, & Montrasio, 2012).
GSSI Cities | Working Papers 9/2015 | Valentina Gingardi, GSSI
7
entrambe le casistiche si registra una riduzione della popolazione nella fascia d’età 15-19 anni (Comune di Milano Settore Statistica, 2013). Il nucleo della vitalità commerciale e sociale è rappresentato dall’asse storico di via Conte Rosso, che sin dai primi del ‘900 ha costituito la “strada-mercato” del quartiere. La zona di Lambrate superiore conserva ancora la memoria di un’imprenditoria di scala locale che intesse rapporti di fiducia e frequentazione quotidiana con i residenti. E’ possibile a tutt’oggi riscontrare la presenza di un’officina, un laboratorio artistico, bar e ristoranti che si sono insediati nel dopoguerra, nei decenni del forte boom economico. 6 A partire dagli anni ’30 Lambrate ha visto cambiare repentinamente la propria traiettoria di sviluppo: da zona essenzialmente agricola e suburbana ad importante polo industriale. L’evoluzione urbana del quartiere è la diretta conseguenza di questo slancio produttivo. Le grandi fabbriche che si sono insediate a partire dagli anni ’30 hanno occupato la zona di Lambrate inferiore, conferendo a questi spazi la connotazione di enclave industriale che perdura ancor oggi. Si tratta di aggregazioni di imprese e di altri attori appartenenti ad una stessa filiera produttiva o a filiere strettamente correlate, caratterizzate dall’essere localizzate all’interno della stessa area. L’esistenza di più enclave all’interno del medesimo ambito urbano diventa perciò un fattore che rende possibile lo scambio e la combinazione di conoscenze diverse (Caroli, 2004).
6 Testimonianze dirette sono contenute nelle interviste agli abitanti dei quartieri Feltre, Ortica, Lambrate (Auser Forlanini, 2011).
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate
8
Fig. 2: Lambrate: contesto, morfologia e accessibilità. Fonte: elaborazione grafica dell’autore
GSSI Cities | Working Papers 9/2015 | Valentina Gingardi, GSSI
9
1. 2.
Tab. 1: Popolazione italiana residente in zona 3 al 31 dicembre 2012 per classi di età.
Tab. 2: Popolazione straniera residente in zona 3 al 31 dicembre 2012 per classi di età. Fonte: Comune di Milano, Settore Statistica, 2013
3. UN TERRITORIO IN TRASFORMAZIONE
Nel territorio compreso tra la ferrovia e la tangenziale est, da Lambrate a San Donato Milanese (cfr. fig.1), si osserva una tensione tra situazioni insediative consolidate e nuovi insediamenti, a motivo degli interventi di trasformazione urbana in corso. (Ricci in Bolocan Goldstein & Bonfantini, 2007). A Lambrate, durante i primi anni 2000, sono entrati in funzione due differenti progetti che hanno aperto la stagione di rinnovamento del quartiere ed il “riposizionamento” dello stesso all’interno della città di Milano. Il primo intervento è rappresentato dal recupero dei capannoni industriali di via Ventura, riconvertiti a spazi per il design, l’arte e la ricerca, campi nei quali oggi Lambrate ha un ruolo di primo piano nel panorama internazionale (cfr. par. 3.1). Nel 2004 è poi entrata in funzione la prima tranche del polo residenziale e commerciale di Rubattino all’interno delle ex aree industriali Maserati-Innocenti, in cui risiedono all’oggi più di 3000 persone 7 e che è tuttora in corso d’implementazione. Le principali sfide che riguardano il quartiere sono rappresentate dal recupero della caserma Rubattino e dalla trasformazione dell’ex scalo merci di Lambrate. La riqualificazione di queste aree dismesse potrebbe rivelarsi centrale nel delineare il futuro assetto urbanistico del settore orientale milanese, in virtù della natura pubblica e semi-pubblica della proprietà (cfr. par. 3.2). Il quartiere è inoltre interessato da consistenti processi di de-industrializzazione governati dall’attore privato, in particolar modo nella parte centro-meridionale di Lambrate. Un quadro complessivo dell’entità delle trasformazioni urbane in corso e del loro assetto funzionale è presentato nella tabella 3, mentre la figura 3 colloca territorialmente gli interventi analizzati. Viene inoltre elaborata una proiezione del numero degli abitanti insediabili ex post e della quantità di alloggi da realizzare, giacché le trasformazioni urbane, per quanto differenti e non coordinate tra loro, presentano nella maggioranza dei casi una quota rilevante di insediamenti residenziali.
7 Informazione derivante da intervista ad un membro del Comitato P.R.U. Rubattino. Le interviste sono state realizzate dall’autore nel marzo 2014.
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate
10
Tab. 3: Interventi di trasformazione urbana a Lambrate. Fonte: elaborazione dell’autore su dati comunali (*) informazione derivante da intervista (Comitato P.R.U. Rubattino e policy makers)
(P.R.U. Rubattino: l’interlocutore stima 3500 abitanti attuali e 5000 a fine intervento) (**) stima 2,5 ab/alloggio, su parametri comunali; s.l.p.= superficie lorda di pavimento
Fig. 3: Trasformazioni urbane nel quartiere di Lambrate (2000-2014) Fonte: elaborazione grafica
dell’autore
GSSI Cities | Working Papers 9/2015 | Valentina Gingardi, GSSI
11
3.1. Progetti realizzati ed in fase d’implementazione
Nel 2000 la rigenerazione postindustriale del quartiere è stata innescata dal recupero dei capannoni di via Ventura, ex sede dell’azienda Faema, produttrice storica di macchine per il caffè (cfr. foto 1). Si tratta di una riqualificazione tematica che ha portato all’insediamento di attività imprenditoriali creative quali studi di architettura, design, arti e moda (Giuliani, A.A. 2009-2010). Il progetto è nato dall’iniziativa privata di due architetti – Mariano Pichler e Gianluigi Mutti – nella quale il soggetto pubblico ha avuto un ruolo “marginale”, limitato all’approvazione delle proposte. Il quartiere si anima in alcuni periodi dell’anno, in particolare nel mese di aprile in concomitanza al Salone del Mobile, evento di profilo internazionale 8 capace di attrarre alla Fiera di Milano 357.212 visitatori in soli 6 giorni durante l’edizione 2014 (+13% rispetto al 2013) 9. Il polo “Lambrate-Ventura” è una delle sedi del Fuori Salone 10, ed ha ospitato nel 2013 un totale di 80.000 visitatori in meno di una settimana, con presenze più che raddoppiate rispetto al 2010 (dati Cosmit, 2013). Le persone che partecipano a questo evento provengono da tutto il mondo; designers, artisti, galleristi, imprenditori e studenti sono interessati al contenuto di questi spazi e alle potenziali relazioni che un evento come questo può attivare. All’interno del quartiere di Lambrate il distretto del design costituisce un’enclave d’eccellenza stretta tra aree residenziali e commerciali ad ovest e vasti ambiti dismessi ad est (cfr. fig.3, area 2). A partire dal 2004 un nuovo insediamento urbano ha iniziato a prendere forma nell’area dall’importante passato industriale collocata sul lato nord di via Rubattino,11 arteria di collegamento tra il quartiere di Lambrate ed il comune di Segrate (cfr. foto 2). Lo strumento urbanistico adottato per la trasformazione è il Programma di Riqualificazione Urbana (P.R.U.), veicolo per la contrattazione tra attore pubblico e privato, istituito nel 1994 da un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 12. Il P.R.U. n.8.1 Rubattino-Maserati interessa una superficie di 611.207 mq e rappresenta il maggiore intervento tra quelli approvati dalla Giunta comunale nel 1997 (cfr. tab.4). Nel complesso il nuovo insediamento registra una netta prevalenza della funzione residenziale13 (cfr. tab.3) in parte rappresentata da edilizia convenzionata e sovvenzionata e dunque accessibile per segmenti della popolazione a reddito medio-basso (Camera di Commercio di Milano, 2013). Nel gennaio 1997 sono stati avviati i cantieri e nel 2004 i primi alloggi sono stati consegnati, in assenza dei servizi di base per i residenti, ultimati negli anni successivi. L’intero potenziale abitativo (165.000 mq) e commerciale (12.000 mq) trova posto nel settore ovest dell’area, non oltre la tangenziale (cfr. fig.3, area 3a). Gli abitanti
8 Il giro d’affari del Salone del Mobile per l’anno 2014 si attesta a 206 milioni di euro. La promozione, gli allestimenti ed i servizi connessi all’evento generano altri 120 milioni di euro di indotto (stime della Camera di Commercio di Monza e Brianza in Finizio, 6 aprile 2014, Il Sole 24 Ore). 9 (Cavestri, 13 aprile 2014, Il Sole 24 Ore) 10 Il Fuori Salone o design week è ad oggi l'evento più importante al mondo legato al tema del design. Il termine è usato per definire l'insieme di eventi ed esposizioni che animano l'intera città di Milano durante il Salone del Mobile, che ha luogo nel polo fieristico di Rho. Le principali sedi del Fuorisalone sono Lambrate-Ventura, Zona Tortona ed il Brera Design District. 11 Nel 1933 l’azienda metalmeccanica Innocenti si insediò in queste aree, avviando nel 1947 la produzione della storica Lambretta, il cui nome deriva dal canale presente all’interno dell’area industriale. Nel secondo dopoguerra l’azienda ampliò i propri stabilimenti che, nel 1967, arrivarono a coprire 1,5 milioni di mq occupando circa 8000 dipendenti. Nel 1992 l’Innocenti-Maserati è stata chiusa, producendo significative ripercussioni anche sull’indotto di imprese fornitrici (Leone, 2005). 12 D.M. LL.PP. 1/12/94 e successiva legge regionale (art. 94 L.R. 12/05 Regione Lombardia, 2005). 13 La L.R. 12/05 ha recepito le istanze di flessibilità introdotte dal D.M. LL.PP. 1/12/94, in merito alla liberalizzazione delle destinazioni funzionali.
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate
12
sono per lo più famiglie del ceto medio, anziani e studenti, dal momento che uno dei blocchi realizzati è sede di una residenza universitaria. Nel luglio del 2005 è stata inaugurata la prima parte del parco di quartiere sotto la tangenziale, elemento naturale di collegamento tra il nucleo residenziale ad ovest e l’area ex Maserati ad est, ancora da recuperare (cfr. fig.3, aree 3b-3c).
Tabella 4. P.R.U. approvati dalla Giunta comunale al 31 dicembre 1997, rielaborazione dell’autore.
Fonte: (Centro Studi PIM, 2003) conv.= alloggi a canone convenzionato
Foto 1. Interno via Ventura, ex fabbrica Faema
Foto 2. P.R.U. Rubattino, vista dal parco pubblico
3.2. La lunga marcia dei progetti pubblici Due sono gli ambiti pubblici da recuperare a Lambrate e riguardano un’area militare ed un’infrastruttura, entrambe dismesse. Il P.G.T. di Milano ha fatto ricorso allo strumento dell’Ambito di Trasformazione Urbana (A.T.U.)14 per recuperare caserme, ex aree industriali e scali ferroviari, con l’obiettivo di conferire a questi spazi la connotazione di servizi per il quartiere, aree verdi attrezzate e collegamenti con altri settori della città. Un grande spazio inutilizzato è rappresentato dalla Caserma Mercanti-Rubattino, la cui superficie territoriale supera gli 81.800 mq e la superficie massima insediabile è pari a 100.000 mq (cfr. foto 3). Il P.G.T. di Milano sottolinea che l’Ambito di Trasformazione Urbana Caserma Rubattino dovrà essere caratterizzato da spazi pubblici di elevata qualità che consentano una nuova permeabilità urbana con orientamento est-ovest in modo tale da garantire continuità rispetto ai temi ambientali legati al sistema del fiume Lambro. La trasformazione dell’area
14 In P.G.T. allegato 3, schede di indirizzo per l’assetto del territorio (Comune di Milano, 2009b).
GSSI Cities | Working Papers 9/2015 | Valentina Gingardi, GSSI
13
risulterà fortemente caratterizzata dalla presenza di nuovi spazi pubblici e di verde attrezzato, a servizio dell’intero quadrante orientale della città (Comune di Milano, 2009b). L’altro importante ambito è rappresentato dall’ex scalo merci di Lambrate (cfr. foto 4), che interessa un’area di 70.716 mq non ancora bonificata, per la quale il P.G.T. prevede una superficie lorda di pavimento realizzabile pari a 34.000 mq e la costruzione di circa 320 appartamenti (cfr. tab. 3). Questa trasformazione urbana è inserita all’interno del programma di recupero degli scali ferroviari milanesi che prevede la dismissione di circa 1,2 milioni di mq di territorio, in passato occupato da infrastrutture pubbliche. 15 L’Accordo di Programma (A.d.P.) in discussione dal 2005 e siglato nel 2009 coinvolge il proponente privato (rappresentato dalla Società Rubattino 87), il Comune di Milano, la Regione Lombardia e le Ferrovie dello Stato. Nel caso di Lambrate la trasformazione dello scalo dovrebbe tenere in considerazione il complessivo e potenziale carico urbanistico gravante sul territorio, alla luce dei differenti progetti di rigenerazione in corso, al termine dei quali il quartiere potrebbe arrivare ad ospitare fino a 8.000 nuovi abitanti 16. A tal riguardo è importante rilevare che, a differenza degli altri progetti che interessano il quartiere, la trasformazione dello scalo vede un ruolo preminente dell’attore pubblico poiché la Società Ferrovie dello Stato è controllata tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per quanto concerne le destinazioni d’uso il Piano indica che “è prevista la realizzazione di nuove aree a verde e il completamento edilizio con funzioni d’interesse generale, orientate all’accoglienza sociale e alla residenza temporanea e universitaria, che costituiscono obiettivi specifici dell’area. La presenza di realtà d’eccellenza come l’Università nell’adiacente quartiere di Città Studi e all’interno dell’ambito di Lambrate, ha orientato la scelta di insediare funzioni connesse alle necessità dell’utenza, come la residenza universitaria” (Comune di Milano, 2009a). La nuova Giunta Comunale ha assegnato agli Ambiti di Trasformazione Urbana un indice massimo di 1 mq/mq (per Lambrate il coefficiente si attestava a 1,76 mq/mq). È stato poi inserito l’obbligo di destinare il 20% della superficie fondiaria delle medesime aree alla realizzazione di edilizia a carattere speciale, in particolare edilizia popolare (E.R.P.) ed edilizia convenzionata agevolata.17
15 Le sette stazioni interessate sono: Lambrate, Farini-Lugano, Greco-Breda, Porta Romana, Rogoredo, Porta Genova, San Cristoforo. 16 Intervista a policy maker Consiglio di Zona 3. 17 Gli alloggi E.R.P. sono destinati a cittadini con grave disagio economico, familiare e abitativo; il canone è commisurato al valore locativo e alla condizione economica del nucleo e può avere un’incidenza variabile tra il 14% ed il 24% del reddito (R.R. 1/04, Regione Lombardia, 2004). L’edilizia convenzionata agevolata, disciplinata dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/01 (Presidenza della Repubblica Italiana, 2001), si caratterizza per un prezzo di cessione calmierato dell’alloggio, nonché la previsione obbligatoria dei requisiti soggettivi degli assegnatari/acquirenti per l’accesso a tale tipologia abitativa.
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate
14
Foto 3. Aree di pertinenza della Caserma Mercanti-Rubattino Foto 4. Area ferroviaria dismessa, ex scalo merci di Lambrate
3.3. Una costellazione d’interventi d’iniziativa privata Gli strumenti e le norme oggi utilizzati nel campo della pianificazione attuativa suggeriscono un modello decisionale elastico, affidato all’interlocuzione tra pubblico e privato, secondo la logica del “caso per caso” (Montedoro, 2011). I Piani Integrati di Intervento (P.I.I.) rappresentano un parte consistente degli strumenti di contrattazione tra gli attori 18 per la riqualificazione di importanti ambiti del tessuto urbano che coinvolgono un'ampia casistica di zone presenti sul territorio, con particolare riferimento a centri storici, periferie ed aree industriali dismesse. Nel quartiere di Lambrate troviamo cinque esempi dell’applicazione di questo strumento e differenti stati di avanzamento dei processi (cfr. tab.3 e fig.3). L’intervento denominato Giardini di Lambrate (cfr. foto 5) è stato convenzionato e prevede il recupero architettonico e paesaggistico dell'area industriale ex Laminati Colombo, ma il lotto è ancora in demolizione, nonostante il progetto fosse stato calendarizzato per il triennio 2005-2008 e la fine dei lavori fosse poi slittata al 2016. Le funzioni originarie del P.I.I. prevedevano una destinazione terziaria e produttiva con parziale recupero di alcuni capannoni dell’ex complesso. Tuttavia la maggior parte della superficie, pari al 62% del totale, sarà destinata ad ospitare residenze private e a carattere sociale 19. Un altro programma che ha ottenuto la convenzione nel 2008 è il P.I.I. di via Pitteri 106, che prevede la riqualificazione ambientale di una piccola area dismessa a carattere industriale. Il 91% della superficie edificabile sarà destinato a residenza, la restante metratura a funzioni compatibili a quella abitativa, modificando completamente la destinazione d’uso originaria (cfr. foto 6). 18 Altri esempi di contrattazione pubblico-privato sono rappresentati dai P.R.U. (Programmi di Recupero Urbano) e dai P.R.U.S.S.T. (Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio). 19 Il cambio delle destinazioni d’uso è avvenuto in sede di Consiglio di Zona, delibera n.126 del 16.12.2013.
GSSI Cities | Working Papers 9/2015 | Valentina Gingardi, GSSI
15
Foto 5. Area del progetto Giardini di Lambrate
Foto 6. Progetto di recupero residenziale, via Pitteri 106
Il P.I.I. di via Dardanoni 9, che interessa un’ex area industriale di 3.100 mq nella parte settentrionale del quartiere, è stato realizzato nel 2010 (cfr. foto 7). La destinazione d’uso attuale è di tipo residenziale per l’80% e terziario-direzionale per il 20%, a fronte di una s.l.p. totale realizzata di 3.500 mq. Il recupero dell'area a funzione residenziale consente la monetizzazione delle aree a standard pari a 2.940 mq, per la realizzazione di un parcheggio pubblico di 555 mq in prossimità della stazione di Lambrate, posta nelle immediate vicinanze (cfr. fig.3). Il Programma di Intervento di via San Faustino ha ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio Comunale nel 2013. La destinazione d’uso dell’area era industriale ed artigianale e la pregressa attività consisteva nella produzione di profilati speciali in acciaio (cfr. foto 8). Il progetto di trasformazione prevede la realizzazione di 150 unità abitative per un totale di circa 280 residenti (cfr. tab.3), mentre una parte dell’area sarà destinata a parco e a parcheggi pubblici.
Foto 7. Render del progetto di recupero residenziale, via Dardanoni
Foto 8. Area dismessa di via San Faustino
In continuità a quest’ambito, nella parte nord di via San Faustino, era in corso l’operazione di trasformazione delle industrie De Nora S.p.A. (cfr. foto 9-10), prima che il P.I.I. venisse bloccato a motivo di una revisione della destinazione d’uso dei piani terra in funzione di una possibile
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate
16
percorrenza ciclabile (intervista a policy maker). L’intervento prevede la realizzazione di edilizia residenziale convenzionata e libera, integrata ad esercizi commerciali.
Foto 9 e 10. Area dismessa, ex industrie De Nora S.p.A.
Importanti progetti di recupero urbano sono gestiti tramite lo strumento del Piano Integrato d’Intervento (art. 87 e seguenti L.R. 12/05, Regione Lombardia, 2005), che attribuisce all’attore privato un ruolo preminente. Nel caso di Lambrate le aree interessate differiscono per superficie e per stato di avanzamento dei processi, ma presentano sostanziali caratteristiche comuni. In primo luogo nella maggioranza dei casi l’assetto funzionale dell’area, completamente modificato, incoraggia la destinazione residenziale, apparentemente più spendibile. Questa linea d’intervento sottende un doppio rischio: da un lato l’incremento della “bolla immobiliare” – connessa alla crisi del 2008 - senza tuttavia dare risposta all’emergenza abitativa, dall’altro, quello di premiare la rendita fondiaria e scoraggiare le attività d’impresa (Montedoro, 2011). In secondo luogo, per la maggior parte delle aree non è possibile definire un assetto temporale certo nel processo di trasformazione 20, che consenta di mettere in relazione i tempi della rigenerazione con il benessere atteso per i cittadini ed il territorio. L’articolazione temporale dei progetti è illustrata nella figura 4.
20 L’articolo 46 della L.R. 12/05 stabilisce per i P.I.I. un tempo massimo di realizzazione degli interventi non superiore a 10 anni.
GSSI Cities | Working Papers 9/2015 | Valentina Gingardi, GSSI
17
Fig. 4: Linea del tempo dei cantieri della trasformazione urbana a Lambrate. Fonte: elaborazione
dell’autore. E’ possibile osservare che 3 sono i progetti realizzati negli ultimi 15 anni, 2 sono le aree cantierizzate/in demolizione, i restanti interventi non hanno ancora trovato attuazione.
4. GLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE URBANA
Il Piano di Governo del Territorio individua alcuni indicatori attraverso i quali mappare i diversi quartieri cittadini ed uno dei parametri di riferimento riguarda la quantità di aree in trasformazione. Il territorio di Lambrate, con un’estensione totale di 309,7 ettari, è interessato da processi di riqualificazione urbana per il 53,1% della propria superficie, pari a 164,5 ettari (Comune di Milano, 2009c, p. 223 e seguenti). Nel complesso 42 Piani Attuativi (P.A.) potranno generare nell’intero capoluogo milanese circa 5 milioni di metri quadri di superficie lorda di pavimento – ai quali si devono aggiungere gli A.T.U. e gli A.T.I.P.G. 21 – e nei comuni di cintura le quantità delle trasformazioni, piani attuativi in corso ed in progettazione, si attestano a 4,8 milioni di mq di s.l.p., per un totale di 23 interventi (Bolocan Goldstein M & Gaeta, 2012). A titolo esemplificativo nel Comune di Segrate, collocato nella prima periferia est in continuità al quartiere di Lambrate, le aree in trasformazione interessano complessivamente più di un milione di mq. Gli effetti della trasformazione urbana attesi sul lungo periodo nel quartiere di Lambrate sono individuabili nel miglioramento della qualità dell’area, nel potenziamento di servizi pubblici, verde urbano, trasporti e mobilità e nell’incremento dell’offerta abitativa (cfr. tab.5 e Comune di 21 I 42 P.A. in questione sono per la maggior parte P.I.I., A.d.P., P.R.U., P.P. (Piani Particolareggiati), P.Z. (Piani di Zona) e P.L. (Piani di Lottizzazione). In merito agli A.T.U. e A.T.I.P.G. si veda par. 3.2.
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate
18
Milano, 2009b). In virtù degli obiettivi di lungo periodo individuati e della quantità di aree coinvolte in tale processo, appare urgente approcciare al tema della trasformazione urbana affiancando alla valutazione dell’entità spaziale dei progetti quella dell’articolazione temporale dei processi. La pianificazione dell’orizzonte temporale dei processi in corso è uno degli elementi chiave sui quali lavorare, allo scopo di definire gli effetti attesi sul quartiere in termini di benessere collettivo. Poiché la qualità urbana complessiva di Lambrate potrà manifestarsi solamente quando i diversi interventi di trasformazione urbana saranno resi operativi, è opportuno che la pianificazione si proponga di governare simultaneamente il fattore spaziale e quello temporale. In riferimento ai processi di trasformazione urbana che sono stati presentati nelle sezioni precedenti è difficile individuare le potenziali ricadute in termini di benessere collettivo poiché l’orizzonte temporale del loro completamento è incerto e mutevole e di conseguenza il livello di qualità complessivo dei progetti non può essere valutato. Lo strumento di pianificazione traccia uno scenario che prevede un incremento di popolazione di migliaia di abitanti all’interno del territorio milanese. Nel caso di Lambrate i diversi interventi di trasformazione urbana potranno richiamare sul territorio fino ad 8.000 nuovi residenti 22, ma non è possibile definire univocamente quando questi processi verranno completati. L’Accordo di Programma rileva a tal proposito la necessità di avviare un coordinamento per raggiungere l’obiettivo di dotare in maniera adeguata un tessuto, come quello di Lambrate – attualmente povero di disegno urbano – di aree a verde, di collegamenti ciclopedonali e viabilistici, in considerazione del fatto che l’attuale viabilità può raggiungere livelli di criticità in relazione ai nuovi carichi urbanistici che si andranno a insediare (Comune di Milano, 2009a). Tra i progetti presentati, due sono stati realizzati – via Ventura e P.R.U. Rubattino, entrambi promossi da operatori privati – ed il secondo è tuttora in fase di implementazione. Tra i P.I.I. solamente uno è stato concluso ed un altro è in costruzione, mentre i restanti piani di iniziativa privata e gli A.T.U. di natura pubblica non sono ancora stati temporalmente definiti, come illustrato nella figura 4. La valutazione degli impatti e la loro rilevanza in termini d’incremento della qualità urbana e del benessere collettivo potranno tuttavia essere discussi solamente quando ad ogni intervento verrà associato un orizzonte temporale chiaro e la qualità degli spazi trasformati potrà essere oggettivamente misurata. L’altro elemento chiave da considerare è rappresentato dalla dimensione spaziale dei processi in corso all’interno del quartiere e nei territori limitrofi. Il territorio analizzato rappresenta una realtà di confine: ultimo quartiere della periferia est di Milano, Lambrate gioca un ruolo importante nell’assetto infrastrutturale di questo quadrante, come rappresentato nella figura 5. L’arteria viabilistica principale è rappresentata dalla tangenziale est, asse fondamentale per la mobilità milanese. La circolazione a scorrimento veloce su gomma è centrale anche nel collegamento con il vicino aeroporto di Linate, che serve l’intera Milano. Nell’estate del 2014 è entrata in funzione la BreBeMi, nuova autostrada che connette Brescia, Bergamo e Milano ed intercetta la Strada Provinciale Cassanese, che collega il Comune di Segrate al quartiere di Lambrate. Nel corso del periodo 2014-2015 sarà operativo anche l’arco T.E.E.M. (Tangenziale Est Esterna Milano). La necessità di avviare un’analisi in merito al sistema della mobilità ed i suoi sviluppi futuri è solamente un aspetto, per quanto cruciale, che rende evidente l’importanza di ripensare il territorio in termini di progetto metropolitano.
22 Intervista a policy maker, Consiglio di Zona 3.
GSSI Cities | Working Papers 9/2015 | Valentina Gingardi, GSSI
19
La distribuzione della popolazione all’interno dell’area metropolitana è altresì un fattore rilevante, com’è possibile osservare nella figura 6 mediante una comparazione del trend demografico di Milano con quello di Segrate. Le trasformazioni urbane in corso all’interno del comune di Segrate 23, per citare un esempio, dovrebbero tener conto del carico di mobilità che incide su Milano est, così come nella gestione delle fasce verdi sarebbe auspicabile avviare un ragionamento coordinato tra i quartieri periferici della città e i comuni della cintura 24 . E’ quindi necessario adottare un approccio metodologico aperto e multifattoriale, al fine di individuare la traiettoria di sviluppo del territorio e poter quindi utilizzare la conoscenza acquisita per preservare il “carattere dei luoghi” ed allo stesso tempo implementare le politiche pubbliche. A partire dalla comprensione delle diverse unità locali, della loro evoluzione spaziale e temporale, è infine possibile interrogarsi sulle modalità attraverso le quali queste interagiscano tra loro, come cambino nel tempo ed influenzino l’agenda urbana.
CATEGORIE OBIETTIVI
Sostenibilità ambientale Miglioramento delle condizioni ecosistemiche, inserimento del quartiere all’interno del sistema ambientale dei Ponti Verdi, mobilità ciclo-pedonale
Infrastrutture e trasporti
Nuova linea di trasporto pubblico verso sud ed est, miglioramento e potenziamento della rete di trasporto pubblico esistente (collegamento con P.R.U. Rubattino), connessioni est-ovest, mobilità ciclo-pedonale, realizzazione del sottopassaggio ferroviario Lambrate-Città Studi
Riqualificazione urbanistica
Ridisegno del margine urbano e degli spazi aperti
Capitale pubblico Interventi edilizi destinati ad ospitare funzioni d’interesse generale orientate all’accoglienza sociale e alla residenza universitaria
Tabella 5. Obiettivi di lungo periodo nel processo di trasformazione urbana a Lambrate
Fonte: rielaborazione dell’autore su dati comunali (P.G.T. allegato 3, Comune di Milano, 2009b)
23 Nel febbraio 2012 la Giunta comunale di Segrate approva il P.G.T. e definisce, nel Documento di Piano, l’entità delle aree da trasformare e gli strumenti urbanistici da utilizzare: vi sono Piani Esecutivi in corso di realizzazione, Piani Integrati d’Intervento, Piani Attuativi, nuove aree di trasformazione private e pubbliche (Comune di Segrate, 2012). 24 Nel settore est di Milano l’area naturale del Parco Lambro è ancora presente, sebbene nella zona del Rubattino la fascia verde sia piuttosto contenuta; anche per quanto riguarda Segrate buona parte del territorio è in corso di trasformazione, ad esempio la zona del Laghetto di Redecesio.
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate
20
Fig. 5: Trasformazioni urbane e nodi infrastrutturali nell’area metropolitana
Fonte: rielaborazione dell’autore, su dati provenienti da Camera di Commercio e Politecnico di Milano (2012)
GSSI Cities | Working Papers 9/2015 | Valentina Gingardi, GSSI
21
Fig. 6: Profili della popolazione a confronto. Milano, Segrate, Lambrate * (1961-2013) Fonte: elaborazione dell’autore su dati Istat e S.I.Ce
* Il grafico del quartiere di Lambrate ha valori mancanti (periodo 1960-2005) a motivo della riforma dei decentramenti amministrativi, avviata nel 1999 nel Comune di Milano (cfr. nota 2). I dati precedenti agli anni 2000 non sono quindi omogenei rispetto alle rilevazioni attuali, a causa della revisione delle sezioni
censuarie.
5. CONCLUSIONI
Il paper ha proposto il caso studio di Lambrate, quartiere della cintura milanese oggetto di diversi processi di trasformazione urbana non governati nelle sinergie sul piano temporale e spaziale. Il Piano di Governo del Territorio indica che il 53,1% del quartiere di Lambrate è interessato da processi di rigenerazione. Policy makers impegnati sul territorio stimano un incremento di popolazione di migliaia di abitanti, sino ad un massimo di 8.000 persone al termine della trasformazione, a fronte di un valore attuale della popolazione di 12.700 unità. La presente ricerca ha fornito una stima della quantità dei nuovi alloggi in corso di realizzazione, per un totale di circa 2.900 abitazioni.
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate
22
Il paper ha presentato i differenti progetti di trasformazione urbana che interessano Lambrate, distinguendo quelli realizzati ed in fase d’implementazione da quelli ancora sulla carta, che costituiscono la maggioranza dei casi analizzati. Si è poi riflettuto sulla natura dei processi in questione, osservando come i progetti di recupero all’oggi operativi siano stati promossi e gestiti dall’attore privato, mentre i grandi Ambiti pubblici di Trasformazione Urbana siano caratterizzati da un orizzonte temporale incerto, con evidenti difficoltà persino nell’individuazione delle destinazioni d’uso e delle esatte quantità da insediare. In primo luogo si è osservato come il nuovo assetto funzionale delle aree presenti una netta prevalenza di residenziale, aspetto che può premiare la rendita fondiaria e scoraggiare le attività d’impresa, riducendo il gradiente di complessità urbana del territorio. In secondo luogo è stato rilevato come per la maggior parte delle zone non sia possibile definire un assetto temporale certo che consenta di mettere in relazione i tempi della rigenerazione urbana con il benessere atteso per i cittadini ed il territorio. Tenuto conto della scarsa complessità spaziale di tali ambiti e della fallimentare gestione di differenti processi di trasformazione urbana, sembrano esserci scarse probabilità che le aree considerate possano rientrare in un fruttuoso ciclo di valorizzazione immobiliare nel breve periodo. La sezione conclusiva del paper argomenta l’urgenza di approcciare al tema della trasformazione urbana considerandone simultaneamente le implicazioni spaziali e quelle temporali. La pianificazione dell’orizzonte temporale dei processi in corso è uno degli elementi chiave sui quali lavorare, allo scopo di definire gli effetti attesi sul quartiere in termini di benessere collettivo, dal momento che una valutazione complessiva degli effetti finali sul benessere di Lambrate potrà esprimersi solamente quando l’intero quartiere sarà reso operativo. Per quanto concerne la dimensione spaziale dei processi in corso, si propone di allargare lo sguardo alla scala sovra-comunale, poiché Lambrate rappresenta l’ultimo quartiere della periferia est di Milano e gioca un ruolo importante nell’assetto infrastrutturale di questo quadrante. La necessità di ripensare il territorio in termini di progetto metropolitano è argomentata facendo riferimento al sistema della mobilità e alle consistenti trasformazioni urbane in corso nel contiguo comune di Segrate. Viene quindi sostenuta l’opportunità di adottare un approccio metodologico aperto e multifattoriale, nel tentativo di individuare la traiettoria di sviluppo del territorio e poter quindi utilizzare la conoscenza acquisita per preservare il “carattere dei luoghi” ed allo stesso tempo implementare le politiche pubbliche.
GSSI Cities | Working Papers 9/2015 | Valentina Gingardi, GSSI
23
BIBLIOGRAFIA
Archivio di Stato di Milano. (1722) Catasto Teresiano [online], Milano. Disponibile all’indirizzo: http://archiviomilano.cineca.it.
Archivio di Stato di Milano. (1887) Catasto Lombardo-Veneto [online], Milano. Disponibile all’indirizzo: http://archiviomilano.cineca.it.
Auser Forlanini. (2011) FOLQ: Feltre,Ortica,Lambrate. Il Quartiere visto dai suoi abitanti. Catalogo e interviste. Milano: Auser.
Bolocan Goldstein M. & Gaeta L. (2012) Mercato urbano e trasformazioni dell’ambiente costruito. Geografie di Milano verso Expo 2015. Milano: Camera di Commercio di Milano
Bolocan Goldstein M. & Bonfantini B. (2007) Milano incompiuta. Interpretazioni urbanistiche del mutamento, Milano: Quaderni del Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Franco Angeli.
Bonomi P., Gatti A.C. & Montrasio S. (2012) Focus on stranieri. Milano: Comune di Milano, Settore Statistica, DC Politiche Sociali e Cultura della Salute.
Bovone L. & Ruggerone L. (2009) Quartieri in bilico. Periferie milanesi a confronto, Milano: Mondadori.
Bricocoli M. & Savoldi P. (2010) Milano downtown: azione pubblica e luoghi dell'abitare, Milano: Et al.
Camera di Commercio di Milano. (2013) Milano produttiva, XXIII rapporto. Milano: Servizio studi e supporto strategico, Camera di Commercio di Milano.
Caroli M. (2004) I cluster urbani. Modelli internazionali, dinamiche economiche, politiche di sviluppo, Roma: Il Sole 24 ore Collana Studi.
Cavestri L. (13 aprile 2014) Il Salone di Milano chiude con numeri record: visitatori in aumento del 13% [online] Disponibile all’indirizzo:: http://www.ilsole24ore.it.
Centro Studi PIM. (2003) Abitare nell'area metropolitana milanese. Le politiche di intervento di fronte alla nuova domanda e alla crisi del modello tradizionale, Argomenti e contributi, n.5. Milano.
Comune di Milano. (2009a) Accordo di programma con contenuto di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in comune di Milano, Relazione illustrativa. In: Direzione centrale sviluppo del territorio e Settore Progetti Strategici. Milano.
Comune di Milano. (2009b) P.G.T. Piano di Governo del Territorio, Documento di Piano. Milano.
Comune di Milano. (2009c) P.G.T. Piano di Governo del Territorio, Piano dei Servizi. Milano.
Comune di Milano. (2009d) P.G.T. Piano di Governo del Territorio, Piano delle Regole. Milano.
Comune di Milano Settore Statistica. (2013) Popolazione residente al 31 dicembre 2012 per classi di età [online]. Disponibile all’indirizzo: http://www.comunedimilano.it.
Comune di Milano Settore Statistica. (2014) Popolazione residente anno 2013 [online]. Disponibile all’indirizzo: http://www.comunedimilano.it.
Comune di Segrate. (2012) P.G.T., Piano di Governo del Territorio, Documento di Piano.
I processi di trasformazione urbana a Milano: il caso di Lambrate
24
Curti F. & Gibelli M.C. (1998) Pianificazione strategica e gestione dello sviluppo urbano, Firenze: Alinea.
Finizio M. (6 aprile 2014) Il Salone del mobile porta a Milano 206 milioni di euro: ecco il giro d'affari della design week [online] Disponibile all’indirizzo: http://www.ilsole24ore.it.
Giuliani I. (A.A. 2009-2010) Dismissione industriale e città creativa. Due processi di trasformazione urbana tra riqualificazione fisica e strategie di promozione del territorio: i casi di Zona Tortona e Ventura Lambrate a Milano. Facoltà di Architettura e Società Corso di laurea specialistica in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali. Politecnico di Milano: tesi di laurea, relatrice Maria Antonella Bruzzese.
Leone U. (2005) Aree dismesse e verde urbano Bologna: Patron Editore.
Montedoro L. (2011) Una scelta per Milano. Scali ferroviari e trasformazioni della città, Milano: Quodlibet.
Pinto F. (2007) Riqualificazione delle periferie e governo del territorio: politiche e strumenti nell’area metropolitana milanese. National conference: Territorial areas and cities in Southern Italy. How many suburbs? What policies for territorial government. Napoli, 22-23 marzo 2007: Politecnico di Milano.
Presidenza della Repubblica Italiana. (2001) D.P.R. 380/01, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Roma.
Regione Lombardia. (2004) R.R. 01/04, Regolamento per l'assegnazione degli alloggi a canone sociale e moderato. Milano.
Regione Lombardia. (2005) L.R. 12/05, Legge per il governo del territorio. Milano.
Tosi A. (2008) Questione sociale, questione urbana: dentro e fuori dai quartieri in crisi. Territorio 46: 99-103.
Zajczyk F. et al. (2005) Milano: quartieri periferici tra incertezza e trasformazione, Milano: Mondadori.
_______
Si ringraziano Antonio Calafati, Francesco Chiodelli e Francesco Trombetta per il prezioso e paziente lavoro di revisione di questo paper e per il supporto alla mia attività di ricerca. La responsabilità di eventuali inesattezze in questo saggio è da imputare unicamente all’autore. Desidero ringraziare vivamente anche Federico Zanfi per i consigli ricevuti.