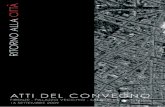Aspetti e fasi del processo formativo delle città in Etruria meridionale costiera, in M. Rendeli (a...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Aspetti e fasi del processo formativo delle città in Etruria meridionale costiera, in M. Rendeli (a...
Comitato ScientificoGilda BartoloniFrancesca BoitaniLarissa BonfanteDominique BriquelFederica CordanoMichel GrasNota KourouDirce MarzoliAnnette RathjeMarco RendeliNancy A. Winter
Comitato di redazioneFolco BiagiMatteo MillettiSara NeriFederica PitzalisJacopo Tabolli
ISBN 9788860491329
© Copyright 2015by Officina Edizioni, Romavia Virginia Agnelli, 58http://www.officinaedizioni.ithttp://www.officinaetruscologia.it
officina edizioni
ARCHEOLOGIA DEI PROCESSI DI FORMAZIONE URBANA
LE CITTÀ VISIBILI
a cura di Marco Rendeli
Atti del Seminario Internazionale in onore di Gilda Bartoloni e Alberto Moravetti
(Alghero, Complesso di S. Chiara, 31 Gennaio - 1 Febbraio 2014)
I. Penisola Italiana e Sardegna
Indice
6 Chi festeggia Gilda e Alberto?
Marco Rendeli 7 lE città visibili…pEr gilda bartOlOni E albErtO MOravEtti
Stefano Santocchini Gerg13 fElsina villanOviana: “città visibilE”. stratEgiE insEdiativE tra brOnzO finalE E priMO fErrO
Discussione su Bologna
Matteo Milletti59 la nascita di pOpulOnia: dati E ipOtEsi sullO sviluppO dElla città Etrusca all’alba dEl priMO MillEnniO a.c.
Discussione su Populonia
Teresa Marino97 aspEtti E fasi dEl prOcEssO fOrMativO dEllE città in Etruria MEridiOnalE cOstiEra
Discussione sull’Etruria Meridionale
Valeria Acconcia143 l’abruzzO: sEdi E pErcOrsi dEgli uOMini in arMi
Discussione sull’Abruzzo
Alessandra Gobbi181 fOrMaziOni prOtOurbanE in caMpania. cOnsidEraziOni tra pOntEcagnanO E capua
Discussione sulla Campania
Mauro Mariani225 sant’iMbEnia E i prOcEssi di fOrMaziOnE urbana nEl nOrdOvEst dElla sardEgna durantE l’Età dEl fErrO
Discussione sulla Sardegna nord occidentale
259 Discussione finale
Chi festeggia Gilda e Alberto?
Le persone che hanno partecipato alla festa per Gilda Bartoloni e Alberto Moravetti sono:
Valeria AcconciaElisabetta AlbaPietro AlfonsoMaria Giulia AmadasiDaniela AngottiAngela AntonaGiovanni AzzenaEmanuela BaldinuPaolo BernardiniMaria BoffaClaudio BullaRoberto BusoneraMichela BussuLuigi CampagnaFranco G. CampusGabriele CarentiArnaldo Bibo CecchiniLuca CerchiaiFederica ChiesaErcole ContuRoberto DeaddisAna DelgadoMaria Antonietta DemurtasAnna DepalmasBeatrice De RosaVincenzo d’ErcoleFrancesco di GennaroRubens D’OrianoLuca DoroNoemi FaddaLucia FaeddaSimona FaeddaAnna FalconiLavinia FoddaiPeppinetta FoisMarcella FrangipaneGiovanna FundoniElisabetta GarauDominique GarciaAlessandra GobbiElisabetta GoviAlessandro GuidiMichele GuirguisMaria IacovouNota KourouAlessandra La FragolaMauro Mariani
Teresa MarinoAttilio MastinoMattia MaturoMauro MenichettiMatteo MillettiMaurizio MinchilliMarco Edoardo MinojaGreta MontiDemis MurgiaGiorgio MurruFederico NurraMassimo OsannaGiuseppe PaduaMarta PaisBarbara PanicoSandra ParlatoAntonella PautassoCarmine PellegrinoCaterina PetrettoEnrico PetruzziGiovanni PireddaFederica PitzalisElisa PompianuAnnette RathjieVeronica ReMarco RendeliSalvatore RizzaDaniela RovinaGiuseppina RuggiuCinzia SabaLuca SannaStefano Santocchini GergEnrico SartiniGiuseppe SassatelliMaria Margherita SattaSalvatore SebisEmanuela SiasAlessandro SodduMargherita SolciGiuseppa TandaLoredana TedeschiCarlo TronchettiAntonella UnaliAlessandro UsaiEmerenziana (Emina) UsaiRaquel Vilaça
Aspetti e fasi del processo formativo delle città in Etruria meridionale costiera
Teresa Marino*
Aspects and Phases of the Process of Urban Formation in Coastal Southern Etruria
This paper focuses on the coastal Southern Etruria in order to examine the beginnings of the formation processes of the Etruscan cities of Veio, Cerveteri, Tarquinia and Vulci. The radical changes that occur in settlement organisation in this area and, probably, in the socio-political and economic structure of the communities between the Final Bronze Age (FBA1-2 and FBA3) and the Early Iron Age (EIA1 and EIA2) (ca. 12th – third quarter of the 8th century BC) are part of a broader phenomenon, which characterises the entire Etruria. The results of the excavations and of the surveys carried out in coastal Southern Etruria have provided an important contribution to the theoretical reflection on the reasons, the ways and the stages of the so-called “proto-urban revolution” in Etruria. The first part of the paper is dedicated to a general description of the settlement dynamics observed all over Etruria during the considered time span: the analysis of the archaeological evidence reveals the transition from a dispersed settlement pattern to a nucleated one and the concentration of population in the sites of the future Etruscan cities. This new territorial arrangement shows some recurring elements regarding the choices of settlement location and their in-ternal organisation. This part also provides a reconstruction of the main tendencies and theoretical-methodological cruxes of the debate on the Etruscan poleogenesis. The second part offers a detailed analysis of the FBA-EIA settlement dynamics leading to the formation of the four “proto-urban centres” of the coastal Southern Etruria. Starting from the data acquired with the most recent studies and field research, the attempt is to clarify the limits of a “rigid” and “static” interpretive model and to highlight the complexity and the dynamism of the examined processes: even within a widespread phenomenon, there is a significant local variability, which is visible in the various forms of settlement organisation and in the phases of development. Several archaeological indicators prove that the settlement structure changes considerably both in a synchronic (from context to context) and in a diachronic sense (through the different chronological phases of the considered period); in addition, some markers suggest that the progressive consolidation of the settlement structures coin-cides with the growing complexity in the sociopolitical and economical organisation. This process has a strong acceleration towards the end of the Early Iron Age (especially from the mid-8th century BC) and even more with the transition to the Orientalising period, when the centres are on the point of acquiring an urban structure.
Il presente contributo si concentra sul territorio dell’Etruria meridionale costie-ra, dedicando una particolare attenzione alle prime fasi del processo di forma-zione degli insediamenti da cui si svilupperanno le grandi città etrusche di Veio, Cerveteri, Tarquinia e Vulci (Fig. 1)1.
* Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio [email protected]
1 Le riflessioni presentate in questa sede prendono spunto dalla ricerca di dottorato condotta negli anni 2011-2013 presso l’Università degli Studi di Salerno (tutor: prof. L.
98 Teresa Marino
Tra l’età del bronzo finale (BF1-2 e BF3) e la prima età del ferro (PF1 e PF2) (XII – terzo quarto dell’VIII sec. a.C. ca.)2 si registrano importanti cambiamenti negli assetti insediativi di quest’area; essi s’inquadrano in un fenomeno di più ampia portata che interessa i vari comparti dell’Etruria propria e che presenta alcuni aspetti comuni a quanto avviene contemporaneamente in Etruria campa-na e padana. Tale fenomeno appare almeno in parte confrontabile con i processi di strutturazione urbana che, seppure con caratteristiche proprie, coinvolgono altri contesti dell’Italia e del Mediterraneo antico tra la fine del II e l’inizio del I millennio a.C.
1. L’Etruria propria tra l’età del bronzo finale e la prima età del ferro
1.1. Caratteri generali del popolamento
Gli studi condotti negli ultimi decenni hanno permesso di giungere ad una ricostruzione piuttosto consolidata e condivisa delle linee di tendenza generali che caratterizzano lo sviluppo dei modi di occupazione del territorio dell’Etru-ria protostorica e di individuare nelle fasi di transizione tra il Bronzo Finale e il Primo Ferro un decisivo salto di qualità nell’organizzazione del popolamento dell’intera regione.
L’evidenza archeologica mostra, a questo livello cronologico, un radicale mu-tamento nella distribuzione, nel numero e nelle dimensioni degli insediamenti che rappresenta il risultato di una serie di fenomeni interconnessi, quali l’abban-dono di moltissimi siti occupati nelle fasi precedenti, lo svuotamento di ampie porzioni di territorio e il confluire dei gruppi umani verso le sedi storiche delle cit-tà etrusche. Questi fenomeni determinano il superamento del sistema di popola-mento per “insediamenti sparsi” (dispersed settlement pattern) e la formazione di un nuovo sistema per “insediamenti concentrati” (nucleated settlement pattern).
Cerchiai) e conclusasi con la discussione finale della tesi il 24 giugno 2014. La ricerca è incentrata sull’analisi delle dinamiche di sviluppo degli insediamenti dell’Etruria propria tra l’età del bronzo finale e la prima età del ferro e, attraverso il riesame critico dei dati disponibili per specifici casi di studio, mira a: fornire una base documentaria organizzata secondo criteri di sistematicità e aggiornata alle più recenti acquisizioni; definire in maniera più puntuale le forme di strutturazione dei singoli insediamenti e le fasi del loro sviluppo nel corso del Bronzo Finale e del Primo Ferro; approfondire la dialettica tra le dinamiche insediative locali e i processi di portata generale che interessano l’intero arco cronologico e l’insieme del territorio preso in esame, valorizzando le articolazioni dei fenomeni (MarinO 2011-2013). Sono molto riconoscente al prof. L. Cerchiai, per aver accompagnato con de-dizione il mio percorso universitario e dottorale, e al prof. M. Rendeli, per aver seguito con interesse la mia ricerca e per avermi dato l’opportunità di partecipare a questo seminario. Ringrazio, inoltre, il prof. A. Guidi, il dott. F. di Gennaro e la prof.ssa G. Bartoloni per i numerosi spunti di riflessione fornitimi nel corso del dibattito.
2 Nel testo si fa sempre riferimento al sistema di cronologie assolute tradizionali ela-borato per l’Italia peninsulare.
99Aspetti e fasi del processo formativo
In particolare, si assiste alla dissoluzione dell’assetto tipico dell’età del bron-zo, costituito da una rete di insediamenti di ridotta estensione (appartenenti a ordini dimensionali diversi, generalmente compresi tra meno di 1 e 15 ha ca.), distribuiti capillarmente sul territorio e situati per lo più in aree naturalmente difese, quali piccoli rilievi isolati o propaggini ben delimitate di ampi pianori. Benché l’abbandono generalizzato di tali insediamenti avvenga in modo piut-tosto repentino nelle fasi di passaggio tra il Bronzo Finale e il Primo Ferro, il fenomeno rappresenta l’esito finale di un processo di trasformazione di lunga durata sviluppatosi nei secoli precedenti: la tendenza alla progressiva concentra-zione insediativa si manifesta a partire dal Bronzo Medio, quando si registrano i primi segni di un cambiamento nelle scelte locazionali e di una selezione stra-tegica dei siti che porta nel corso del tempo a privilegiare gli abitati sorti in aree più difendibili, a scapito di quelli in aree non difese, e a favorire la formazione di insediamenti sempre più grandi; nel Bronzo Finale e ancor più nel momento avanzato del periodo il processo diviene così rapido e diffuso da determinare il definitivo superamento della forma di organizzazione insediativa tipica delle fasi precedenti.
Contemporaneamente, si struttura un nuovo sistema di popolamento, costi-tuito da insediamenti numericamente limitati, ma molto più grandi (con esten-sione variabile tra i 50 e i 200 ha ca.), distanziati tra loro e ubicati nei luoghi che saranno interessati senza soluzione di continuità dallo sviluppo delle principali città etrusche3.
Tali insediamenti presentano alcuni caratteri ricorrenti che suggeriscono un avanzato livello di progettualità sia nell’ubicazione, nella conformazione geomor-fologica e nelle dimensioni dell’area occupata sia nell’organizzazione topografica interna. Essi sorgono in corrispondenza di unità orografiche di grandi dimen-sioni, ben difese naturalmente e dominanti rispetto al territorio circostante, e occupano posizioni territoriali favorevoli, a seconda dei casi, per la vicinanza di corsi d’acqua o del mare, per l’ampia disponibilità di risorse agricole o minerarie e per la facilità di collegamento con altre aree. Ciascun agglomerato insediativo sembra, inoltre, dotato di un’organizzazione interna di tipo “multifocale”: l’inte-ra superficie difesa è generalmente riservata fin dall’inizio all’abitato, risultando occupata in maniera diffusa da nuclei di capanne intervallati da spazi liberi (vero-
3 Ampia è la bibliografia sulle trasformazioni degli assetti territoriali che si manifestano in Etruria tra l’età del bronzo finale e la prima età del ferro. Tra i principali e più recenti studi di sintesi sull’argomento vd.: per l’intera Etruria, quelli di R. Peroni (1989; 1996; 2000; 2003), M. Pacciarelli (1994a; 2001; 2010a), A.M. Bietti Sestieri (2008), A. Mandolesi (2012), A. Zanini (2012) e i vari contributi negli Atti Valentano 2010; per l’Etruria meridionale costiera e interna, gli studi di F. di Gennaro, A. Guidi (di gEnnarO 1979; 1982; 1983; 1986; 1988; 1990; 1999a; 1999b; 2000; 2006; di gEnnarO, guidi 2010), M. Rendeli (1991; 1993), B. Barbaro (2010), A. Schiappelli (2008), A.M. Bietti Sestieri (2012) e i vari contributi negli Atti Roma 2005b; per l’Etruria settentrionale costiera e interna, gli studi di A. Zanini (1994; 1997), A. Maggiani (2010), G. Bartoloni (2011), V. Acconcia (2012), andrEOtti et al. 1998, biEtti sEstiEri et al. 2001 e i vari contributi negli Atti Colle di Val d’Elsa 2002.
100 Teresa Marino
similmente destinati ad attività di sussistenza); due o più sepolcreti si dispongono solitamente all’esterno dell’area destinata all’abitato, per lo più a poca distanza da essa e lungo i principali percorsi di accesso all’abitato e di collegamento con il territorio circostante4.
La generale ristrutturazione dell’assetto territoriale è stata collegata da una consolidata tradizione di studi a profondi cambiamenti nell’organizzazione so-cio-politica ed economica delle comunità. L’intero fenomeno è stato interpretato nei termini di una vera e propria “svolta protourbana e protostatale”, vale a dire come un momento decisivo del processo di lunga durata che determina il gra-duale superamento dell’assetto protostorico “per villaggi” a favore di un’organiz-zazione incentrata sulle “città”5.
1.2. Orientamenti teorico-metodologici e nodi problematici del dibattito
Strettamente connessa alla ricostruzione delle dinamiche insediative è la ri-flessione sulle origini del processo poleogenetico in ambito etrusco e, in partico-lare, sulle ragioni, sui modi e sui tempi del suo manifestarsi. Il dibattito sull’ar-gomento, iniziato intorno alla metà del XX sec. e tuttora molto complesso, si è sviluppato nel corso del tempo di pari passo con il progredire della ricerca sul campo, degli strumenti di analisi, degli approcci di studio e dei modelli inter-pretativi. Si ritiene opportuno richiamarne brevemente alcuni aspetti cruciali, che risultano di notevole interesse in relazione al tema specifico del seminario.
La discussione si è concentrata, in primo luogo, sul rapporto problematico tra modelli insediativi e processi socio-politici. Proprio l’Etruria meridionale costiera ha rappresentato il terreno privilegiato per osservare e ricostruire la struttura degli insediamenti della prima età del ferro, grazie alla conoscenza non solo del tessuto funerario ma anche di alcuni contesti d’abitato e alla pos-sibilità di integrare, in misura sempre crescente, i dati di scavo con i risultati delle ricognizioni di superficie sistematiche, condotte sui pianori delle future città etrusche e nelle aree circostanti. Il dibattito è sorto tra gli anni ‘50 e ‘60 del XX sec. in rapporto alle indagini condotte a Veio e ha visto nel corso del tempo la formulazione di due principali ipotesi interpretative, che sono state successivamente applicate anche agli altri insediamenti “villanoviani” dell’E-truria propria, campana e padana.
4 I caratteri ricorrenti di tali insediamenti sono stati precisati soprattutto da M. Pacciarelli (1994a, pp. 229-238, 251-252; 1994b, pp. 181-193; 2001, pp. 128-136, 165-170; 2010a).
5 Per il concetto di “centro protourbano” si rimanda agli studi di H. Müller-Karpe (1962), R. Peroni (1969; 1979; 1989, pp. 426-531; 1996, pp. 409-507; 2000; 2003), A. Guidi e F. di Gennaro (guidi 2006; 2008; di gEnnarO, guidi 2010; guidi 2010), M. Pacciarelli (1994a; 1994b; 2001; 2010a), C. Renfrew (1975), G. Colonna (1976), B. d’Agostino (1995; 2005), M. Bonghi Jovino (bOnghi jOvinO, chiaraMOntE trEré 1997, pp. 217-220) e G. Bartoloni (2006).
101Aspetti e fasi del processo formativo
Inizialmente, fu proposto un modello “policentrico” che riferiva le evidenze d’abitato (resti di capanne e concentrazioni di materiali in superficie), che allora apparivano distribuite soprattutto lungo i bordi del pianoro veiente e piutto-sto distanziate tra loro, e i nuclei sepolcrali esterni ad una pluralità di piccoli “villaggi” coesistenti, distinti e autonomi sia a livello insediativo che “politico”; secondo tale ricostruzione, i villaggi del Primo Ferro erano riconducibili ad una forma insediativa “preurbana” e solo attraverso un processo lento e graduale si sarebbero ingranditi fino a fondersi e a formare nel corso del VII sec. a.C. un’u-nica entità topografica e politica riconoscibile come “centro urbano”6.
Il prosieguo delle indagini ha, tuttavia, dimostrato una distribuzione “a macchie di leopardo” del materiale abitativo su tutto il pianoro ed è prevalso un modello “monocentrico”, secondo cui l’intera superficie difesa era occu-pata già nel Primo Ferro da un “centro protourbano”, vale a dire da una co-munità “politicamente” unitaria che formava un unico grande insediamento, caratterizzato da un’organizzazione “multifocale” delle aree abitative e al quale erano pertinenti i vari nuclei sepolcrali dislocati intorno al pianoro; secondo tale prospettiva, la strutturazione insediativa rappresenta l’esito di una “scelta progettuale”, la cui validità sarebbe confermata dalla continuità di occupazione dell’area anche da parte della città etrusca e che attesterebbe, già al passaggio tra il Bronzo Finale e il Primo Ferro, un considerevole cambiamento nell’or-ganizzazione insediativa e socio-politica da connettere con l’avvio del processo di formazione urbana7. Con l’intensificarsi delle ricerche e delle scoperte, l’in-terpretazione in chiave protourbana ha acquisito un credito progressivamente maggiore e, seppur con diverse formulazioni e sfumature, appare ormai quasi unanimemente condivisa dagli specialisti.
Ancora molto discusse sono le ragioni che hanno innescato il “salto di quali-tà” legato all’emergere delle prime entità urbane in Etruria (e, più in generale, in area medio-tirrenica) e diversificate le opinioni espresse in merito dagli studiosi.
La chiave di lettura che sembra attualmente più condivisibile spiega il feno-meno come l’esito di processi locali di lunga durata, intervenuti sia a livello di organizzazione insediativa che di strutturazione socio-politica ed economica, che affondano le radici nell’età del bronzo e che s’innescano in maniera più
6 A partire da un modello elaborato all’inizio del secolo per le origini dell’insediamento di Roma (pinza 1905), l’ipotesi “policentrica” è stata proposta nel 1961 da J.B. Ward-Perkins, integrando i dati già noti dagli scavi delle necropoli e di alcune strutture abitative della prima età del ferro con i risultati delle ricognizioni sistematiche condotte sul pianoro di Veio dalla British School at Rome nell’ambito della South Etruria Survey (Ward-pErKins 1961, pp. 20-25).
7 L’ipotesi “monocentrica” o “protourbana” è stata formulata nel 1962 e nel 1969 da H. Müller-Karpe e da R. Peroni in seguito ad alcuni sopralluoghi effettuati sul pianoro veiente (MüllEr-KarpE 1962; pErOni 1969) e successivamente avvalorata dai risultati di ulteriori ricognizioni sistematiche condotte alla fine degli anni ‘70 da M. Guaitoli con l’Istituto di Topografia Antica dell’Università di Roma (guaitOli 1981); alla definizione della configu-razione interna degli insediamenti protourbani hanno, poi, contribuito in maniera decisiva le osservazioni elaborate da M. Pacciarelli a partire dagli anni ‘90 (pacciarElli 1994a, pp. 251-252; 1994b, pp. 190-193; 2001, pp. 165-170; 2010a).
102 Teresa Marino
evidente tra la fine dell’età del bronzo e la prima età del ferro con la formazio-ne dei cosiddetti “centri protourbani” ad un livello cronologico precedente l’inizio della colonizzazione in Occidente8; ad essa si contrappone un diverso filone interpretativo che spiega il fenomeno come il risultato di uno stimolo esterno, enfatizzando il ruolo svolto dalla colonizzazione greca e fenicia nella trasmissione del modello insediativo in Occidente e facendo risalire l’avvio dei processi di formazione urbana in area medio-tirrenica al momento di transizio-ne tra la prima età del ferro e il periodo orientalizzante9.
Rispetto a tale polarizzazione in anni recenti è divenuta sempre più avvertita la necessità di approfondire, seppur con percorsi ed esiti teorici e interpretativi differenziati, la complessità del rapporto tra i processi di trasformazione locale e quelli di interazione con altre comunità. Se appare sempre più chiaro che le entità urbane etrusche di età storica rappresentino lo stadio finale dei processi di sviluppo locali “preurbani” e “protourbani” delle fasi precedenti, è anche innegabile l’intensità dei contatti esistenti tra le varie sponde del Mediterraneo molto prima della fase coloniale; resta, pertanto, da precisare meglio il peso del-le componenti allogene e indigene in tali processi di sviluppo locali e le modalità in cui si articolavano i loro rapporti10.
Oggetto di dibattito è anche il valore da attribuire alla cultura materiale (fa-cies) villanoviana della prima età del ferro: la questione ha un ruolo particolar-mente importante per la definizione di un eventuale nesso tra la poleogenesi e l’etnogenesi nell’Etruria protostorica, vale a dire per la definizione della loro
8 Si tratta del cosiddetto approccio “autoctonista” o “occidentalista”: pErOni 1969; di gEnnarO 1986; di gEnnarO, pErOni 1986; pErOni 1989; stOddart, spivEy 1990, pp. 40-61; pErOni 1996; barKEr, rasMussEn 1998, p. 84; di gEnnarO 2000; pErOni 2000; pacciarElli 2001; bOnghi jOvinO 2005; d’agOstinO 2005; guidi 2008; Roma 2008; bruni 2010; di gEnnarO, guidi 2010; pacciarElli 2010a.
9 Si tratta del cosiddetto approccio “diffusionista” o “orientalista”: chaMpiOn et al. 1984, p. 259; pallOttinO 1984, pp. 213, 307; harris 1989; ridgWay 1992, pp. 129-144; shErratt 1993, p. 93; daMgaard andErsEn et al. 1997.
10 Tra le recenti proposte in tal senso si segnalano: le teorie basate sui concetti di re-ciprocità, ibridità, connettività e network, elaborate per l’analisi dei processi di formazione urbana in Italia e nel Mediterraneo (fulMinantE, stOddart 2010, pp. 17-18, con bibl. prec.); l’approccio adottato da M. Pacciarelli nel suo studio sulla nascita delle comunità urbane dell’Italia tirrenica, “volto a discriminare i processi di trasformazione interna delle società, che possono condurre all’emergere di determinate strutture socio-economiche richiedenti la formazione di centri di tipo urbano, e i processi di interazione [...] tra comunità diverse e politicamente indipendenti, che in una certa misura influiscono sulle strutture stesse, ma perlopiù sulle forme culturali con cui il fenomeno urbano si manifesta” (pacciarElli 2001, p. 11); l’ipotesi formulata da A.M. Bietti Sestieri, secondo cui l’avvio dei processi di formazione protourbana nell’Etruria villanoviana sarebbe l’esito di un processo complesso e articolato che vede fin dal Bronzo Recente-Finale l’instaurarsi di un rapporto tra le comunità indigene e una componente esterna di matrice fenicio-cipriota o più genericamente levantina, capace di inserirsi nel contesto sociale locale, di assumere la gestione delle principali attività econo-miche e il controllo politico-organizzativo e di modificare dall’interno il sistema trasformando l’assetto insediativo delle comunità (biEtti sEstiEri 2012).
103Aspetti e fasi del processo formativo
contemporaneità o della priorità cronologica dell’una sull’altra. Discusso è il rapporto intercorrente tra la facies villanoviana d’Etruria e le sue manifestazioni in area campana, padana e medio-adriatica, nonché il rapporto tra la facies villa-noviana e quelle protovillanoviane d’Etruria11. Il principale nodo problematico riguarda, però, l’interpretazione complessiva del fenomeno “villanoviano”, che è stato inteso come manifestazione etno-culturale legata alla formazione della civiltà etrusca12 oppure come epifenomeno socio-politico privo di connotazione etno-culturale13; alle precedenti si è recentemente aggiunta un’altra prospettiva interpretativa, che considera “l’insieme degli aspetti villanoviani come una ma-nifestazione di specificità culturale che può essere legittimamente collegata con gli sviluppi della civiltà etrusca” e che attribuisce l’omogeneità e la contempo-raneità di diffusione del “villanoviano” su scala interregionale ad un progetto politicamente unitario e pianificato, in cui avrebbe avuto un ruolo determinante la componente orientale14.
Altro aspetto cruciale è la proposta di revisione della cronologia assoluta dell’età del bronzo finale e della prima età del ferro italiana, che s’inserisce in un ampio dibattito relativo alla revisione delle sequenze cronologiche dell’Europa protostorica: la questione riguarda l’opportunità di sostituire il sistema di cro-nologia assoluta “tradizionale”, fondato sulle cronologie storiche mediterranee, con un nuovo sistema ottenuto grazie ad analisi dendrocronologiche, radiocar-boniche e crossing-dates, che implicherebbe un rialzamento generale delle da-tazioni di alcuni decenni. Il dibattito, tuttora aperto, risulta trasversale al tema del presente contributo, giacché la ridefinizione dei limiti cronologici assoluti dell’età del bronzo finale e della prima età del ferro italiana si riflette sulla data-zione dei processi insediativi esaminati in questa sede15.
11 Per il “villanoviano” in Etruria campana: pacciarElli 1994a, pp. 248-249; pErOni 1994; pacciarElli 2001, pp. 116, 120; d’agOstinO 2011. Per il “villanoviano” in Etruria padana: sassatElli 2000. Per il “villanoviano” a Fermo: pErOni 1992. Per il rapporto tra la facies villa-noviana e quelle protovillanoviane d’Etruria: biEtti sEstiEri 2008, pp. 12-17; 2012.
12 In quest’ottica, B. d’Agostino (2011) ha valorizzato l’unitarietà del fenomeno, l’omo-geneità della cultura materiale – pur con alcune specificità locali – e la sua contemporanea diffusione nelle aree che saranno poi interessate dalla presenza etrusca (con l’eccezione dell’enclave di Fermo); secondo tale prospettiva, la poleogenesi sarebbe contemporanea all’etnogenesi.
13 R. Peroni ha, in tal senso, negato l’esistenza del “villanoviano” come fenomeno unitario – evidenziando soprattutto le differenze locali – e ha sostenuto che esso costitui-rebbe solo la documentazione materiale di una serie di comunità, appartenenti a diverse componenti etniche e portatrici di diverse facies archeologiche, che trasversalmente vanno verso l’adozione di un assetto protourbano; secondo questa prospettiva, la poleogenesi anticiperebbe l’etnogenesi (pErOni 1992, p. 33; 1994; 1996, pp. 434-436).
14 Tale prospettiva è stata presentata da A.M. Bietti Sestieri come parte di una più ampia e articolata proposta interpretativa sull’emergere del “fenomeno villanoviano” (biEtti sEstiEri 2008, pp. 12-17; 2012).
15 Per il dibattito sull’argomento si rimanda al Convegno di Roma del 2003 (Atti Roma 2005a, con bibl. prec.) e ad alcuni contributi più recenti (vErgEr 2007; biEtti sEstiEri 2008; dElpinO 2008a; nijbOEr, van dEr plicht 2008).
104 Teresa Marino
2. L’Etruria meridionale costiera: specificità locali dei processi insediativi tra l’età del bronzo finale e la prima età del ferro. La formazione e l’assetto topografico dei “centri protourbani” di Veio, Cerveteri, Tarquinia e Vulci
Gli attuali orientamenti del dibattito sulle fasi formative delle città etrusche in-vitano a superare l’eccessiva “staticità” e “rigidità” di certi modelli interpretativi e ad esaminare in una prospettiva più articolata il processo di generale riassetto insediativo che investe tra il Bronzo Finale e il Primo Ferro l’area compresa tra i bacini fluviali del Tevere e dell’Arno. In effetti, un’approfondita analisi sincronica e diacronica dei dati disponibili permette di osservare la complessità e il dinamismo dei suddetti fenomeni e dimostra come, al di là di alcune linee di tendenza comuni ai vari comparti territoriali dell’Etruria propria e all’intero periodo considerato, vi sia una significativa variabilità locale, che si manifesta nei modi e nelle forme diversificate di strutturazione degli insediamenti e nei tempi e nelle fasi del loro sviluppo.
L’Etruria meridionale costiera rappresenta, allo stato attuale delle conoscen-ze, il comparto per il quale si dispone di una più solida base documentaria. In quest’area si percepisce molto chiaramente la portata dei cambiamenti che pre-ludono alla formazione delle grandi entità urbane di Veio, Cerveteri, Tarquinia e Vulci e si colgono altresì alcune specificità dei processi nei singoli casi16. Al fine di chiarire tali aspetti, si intende soffermare l’attenzione su alcuni elementi par-ticolarmente significativi che emergono dalle indagini e dagli studi più recenti.
2.1. Forme insediative: ubicazione, morfologia, dimensioni, rapporto tra abitato e sepolcreti
Per quanto riguarda le scelte locazionali, i quattro centri protourbani dell’E-truria meridionale costiera si sviluppano in corrispondenza di vasti pianori tu-facei nettamente distinti rispetto al paesaggio circostante: nel caso di Cerveteri il pianoro ha una conformazione unitaria, mentre negli altri casi di Veio, Tar-quinia e Vulci si tratta di un sistema di più pianori uniti da selle o strozzature (per Veio: i pianori contigui della “Città di Veio” e di “Piazza d’Armi”; per Tar-quinia: il pianoro de “La Civita” – che comprende il “Pian di Civita”, il “Pian della Regina”, la “Castellina della Civita” e il “Poggio Cretoncini” – e, separato da esso, il colle dei “Monterozzi”; per Vulci: i pianori contigui de “La Città” e di “Pozzatella”) (Fig. 2). Tutti sono caratterizzati da una superficie sommitale
16 La vastità di dati disponibili per l’Etruria meridionale costiera deriva dalla possibilità di indagare sia i sepolcreti che gli abitati protostorici per lo più in condizioni di mancata continuità insediativa contemporanea. È stato, inoltre, ipotizzato che i cambiamenti in atto tra l’età del bronzo finale e la prima età del ferro appaiano qui più accentuati e radicali che nel resto d’Etruria e che, pertanto, quest’area possa aver rappresentato l’epicentro della “svolta protourbana” e aver avuto un ruolo propulsivo per la diffusione del nuovo modello di organizzazione insediativa (pacciarElli 2001, pp. 128-136).
105Aspetti e fasi del processo formativo
spianata o lievemente ondulata, delimitati quasi sull’intero perimetro da ver-santi scoscesi o strapiombanti e lambiti da corsi d’acqua a carattere per lo più torrentizio che rientrano nel sistema idrografico di fiumi più grandi, utilizzati come vie di collegamento tra l’entroterra e la costa (rispettivamente il Tevere per Veio, il Vaccina per Cerveteri, il Marta per Tarquinia e il Fiora per Vulci). Notevole è l’estensione della superficie difesa di tali pianori che si aggira intorno ai 150 ha, con lievi oscillazioni da un caso all’altro (185 ha per Veio, 150-160 ha per Cerveteri, 150 ha del pianoro de La Civita e 150 ha del colle dei Monterozzi per Tarquinia, 126 ha per Vulci). Gli insediamenti si sviluppano, inoltre, in aree che garantiscono la possibilità di sfruttamento di ampi territori agricoli. Nei casi di Cerveteri, Tarquinia e Vulci, le sedi prescelte sono situate a pochi chilometri dal mare e immediatamente alle spalle della fascia pianeggiante costiera, che do-minano visivamente; fa eccezione Veio, ubicata nell’entroterra, ma ugualmente ben collegata alla costa attraverso il fiume Tevere.
Quanto alla configurazione interna, tali insediamenti mostrano un rapporto topografico ricorrente e una chiara separazione funzionale tra lo “spazio dei vivi” e lo “spazio dei morti”: la distribuzione degli affioramenti ceramici e delle strutture capannicole suggerisce che di solito l’abitato occupi in maniera diffusa la superficie del pianoro, definita e difesa da limiti naturali; la distribuzione delle evidenze funerarie rivela l’uso contemporaneo di vari sepolcreti, ubicati a poca distanza dall’abitato (per lo più sulla sommità e sui versanti dei rilievi ad esso circostanti, ma anche nel fondovalle dei corsi d’acqua che lo lambiscono o in aree poste alla base del pianoro da esso occupato) e disposti a creare una sorta di “cintura” intorno ad esso (Figg. 3-9,11).
2.2. Cronologia della svolta insediativa “protourbana” e rapporto con le preesi-stenze
Uno dei temi di maggior interesse, nonché uno dei più discussi, è quello della definizione cronologica della svolta insediativa detta “protourbana” e del rapporto con eventuali preesistenze.
Il salto di qualità che segna l’avvio della nuova fase di sviluppo è stato da tempo individuato, a livello insediativo, nel confluire della popolazione verso le sedi delle future città etrusche e nella formazione di un abitato esteso sull’in-tera unità orografica o su gran parte di essa: in una prima fase delle ricerche si riteneva, sulla base della documentazione allora disponibile, che il fenomeno si fosse manifestato a partire dall’inizio del Primo Ferro17; le successive scoperte hanno indotto a rivedere tale ricostruzione e hanno suggerito che il fenomeno si sia sviluppato a seconda dei contesti in momenti diversi, inquadrabili nelle fasi terminali del Bronzo Finale (BF3) o in quelle iniziali del Primo Ferro (PF1)18.
17 pErOni 1969; rittatOrE vOnWillEr et al. 1977; di gEnnarO 1982.18 pErOni 1996; pacciarElli 2001; guidi 2008; di gEnnarO, guidi 2010; pacciarElli
2010a; di gEnnarO 2012.
106 Teresa Marino
È ormai accertato, inoltre, che le aree in cui si formano gli insediamenti protourbani in alcuni casi ospitino già nelle precedenti fasi dell’età del bronzo piccoli insediamenti canonici del popolamento del periodo. Preesistenze di tal genere sono state identificate in corrispondenza di propaggini ben difendibili del futuro pianoro urbano oppure in aree fisicamente distinte ma poste a poca distanza da esso e possono rappresentare un elemento di continuità o di discon-tinuità rispetto agli sviluppi insediativi successivi, a seconda che siano inglobate o escluse dall’area dell’abitato protourbano.
In base ai dati attualmente disponibili, a Vulci e a Tarquinia il momento di cambiamento decisivo in senso protourbano si inquadra abbastanza chiaramen-te nel corso del BF3.
Nel caso di Vulci (Fig. 11)19, il processo sembra iniziare già nel BF3A (pri-ma metà del X sec. a.C. ca.) con l’occupazione abitativa dell’intera area difesa formata dai rilievi interconnessi de La Città e di Pozzatella e con l’installazione di piccoli nuclei sepolcrali intorno ad essa; benché nessun elemento attesti sul pianoro forme di stanziamento precedenti al BF3A, non è stata esclusa, sulla base di alcune osservazioni topografiche, l’ipotesi della preesistenza di un “abi-tato d’altura” tipico dell’età del Bronzo sulla propaggine nord-orientale – la cosiddetta “Acropoli”, estesa almeno 5 ha (Fig. 2d, area C) –, da cui si sarebbe eventualmente sviluppata l’occupazione estensiva del pianoro20.
Nel caso di Tarquinia (Figg. 7-8, 9a)21, la propaggine nord-orientale del pia-noro de La Civita – la cosiddetta “Castellina della Civita”, estesa 3,5 ha ca. (Fig. 2c, area C) – sembra essere occupata in maniera stabile e continuativa a partire dalla fase avanzata del Bronzo Antico e per tutte le successive fasi protostoriche e storiche. Da essa prende avvio il processo di graduale ampliamento insediativo che conduce, già nel BF3B (seconda metà del X sec. a.C. ca.), all’occupazione estensiva dell’area del futuro abitato urbano – rilievi della Castellina, del Pian della Regina e del Pian di Civita – circondata dai relativi sepolcreti e alla prima frequentazione rituale e cultuale dell’area sacra del Pian di Civita.
A Cerveteri e a Veio, il salto di qualità che determina l’occupazione esten-siva dei futuri pianori urbani e l’ampia strutturazione dei sepolcreti circostanti sembra compiutamente avvenuto solo nel PF1 (IX sec. a.C. ca.), anche se non mancano nelle due aree tracce di preesistenze insediative dell’età del bronzo, talora di problematica lettura.
Nel caso di Cerveteri (Figg. 5-6)22, le indagini condotte sul pianoro della città etrusca non hanno restituito attestazioni anteriori al Primo Ferro, ma le tracce individuate negli immediati dintorni forniscono qualche indizio per ricostruire il quadro insediativo del periodo precedente: nelle valli fluviali che lambiscono il pianoro di Cerveteri e in posizione “aperta” lungo i bordi dei pianori ad esso
19 pacciarElli 2001, pp. 136-158.20 di gEnnarO, guidi 2010, pp. 433-434.21 MandOlEsi 1999.22 nardi 1986; EnEi 2001; cErasuOlO 2008.
107Aspetti e fasi del processo formativo
prospicienti sono stati riconosciuti piccoli insediamenti pertinenti alle diverse fasi del Bronzo Finale (ma talora interessati anche da una frequentazione più antica), che subiscono un abbandono generalizzato al massimo entro il mo-mento di passaggio al Primo Ferro; inoltre, sulla base di considerazioni di ca-rattere topografico e del rinvenimento di due sepolture del BF3A2 alle pendici sud-occidentali e occidentali del pianoro di Cerveteri (rispettivamente nelle aree del Sorbo – Fondo Chiani e di Poggio dell’Asino – Fondo Rossi, utilizzate a scopo funerario anche nella prima età del ferro e in epoca etrusca) è stata ipotizzata l’esistenza di un “abitato d’altura” del BF3 sull’estrema propaggine occidentale del rilievo (la cosiddetta “Rocca”, estesa 4 ha ca.) (Fig. 2b, area A); a differenza dei suddetti nuclei insediativi esterni al pianoro, quest’ultimo potrebbe essere sopravvissuto alla fine dell’età del bronzo finale e aver rap-presentato il punto di partenza dello sviluppo dell’insediamento protourbano della prima età del ferro23.
Nel caso di Veio (Figg. 3-4)24, alla luce di recentissime scoperte è possibi-le precisare meglio alcune tappe del processo che conduce alla formazione del centro protourbano: tra il BF1-2 e il BF3A, forse con dei precedenti nel Bronzo Recente, s’inquadra la vita dell’abitato di Isola Farnese (su un’area difesa di 5 ha ca.) (Fig. 2a) e del sepolcreto di Pozzuolo ad esso riferibile, posti immediatamente a SO del pianoro di Veio (ma da questo fisicamente separati attraverso il Fosso del Piordo) e riconducibili ad un insediamento “su altura isolata” che risulta definitivamente abbandonato dopo il BF3A e non incluso nell’area dell’abitato villanoviano ed etrusco di Veio; nel BF3B si registra la prima occupazione del pianoro veiente nella forma di un abita-to probabilmente circoscritto alla sola estremità nord-occidentale del rilievo (loc. Campetti – area tra le Porte Nord-Ovest e Caere), difeso da una fortifi-cazione a terrapieno (che continua significativamente ad essere utilizzata con successivi rifacimenti fino all’età arcaica) e a cui potrebbero corrispondere alcune attestazioni funerarie individuate sulle colline prospicienti al versante settentrionale del pianoro (in loc. Casale del Fosso e, forse, Quattro Fonta-nili); solo con l’inizio del PF1 sembra, però, avvenire la diffusa occupazione a scopo abitativo dell’intera superficie difesa del pianoro di Veio e della sua propaggine meridionale di Piazza d’Armi e l’impianto di diversi nuclei sepol-crali tutt’intorno ad essi.
A prescindere dalla datazione della “svolta protourbana” al BF3 o al PF1, è significativo che, in tutti i casi esaminati, la strutturazione dell’insediamento sul pianoro prosegua nelle fasi successive con una serie di trasformazioni, ma con un’ininterrotta continuità di occupazione del sito fino all’epoca romana.
23 barbarO 2010, p. 140; di gEnnarO, guidi 2010, p. 434.24 di gEnnarO et al. 2004; babbi 2005; cascinO et al. 2012; di gEnnarO 2012; Pozzuolo
2013a-b; bartOlOni et al. 2014.
108 Teresa Marino
2.3. Segni di strutturazione degli insediamenti e delle comunità
L’esame della documentazione disponibile per l’Etruria meridionale costiera consente di enucleare una serie di indicatori archeologici che dimostrano come la configurazione degli insediamenti protourbani e le modalità di organizzazio-ne e gestione dello spazio cambino sensibilmente sia in senso sincronico, da un contesto all’altro, sia in senso diacronico, tra le varie fasi cronologiche esamina-te; alcuni indizi suggeriscono, inoltre, il progressivo consolidarsi della struttura insediativa e socio-politica che, verso la fine della prima età del ferro (soprattut-to dalla metà dell’VIII sec. a.C.), e ancor più con il passaggio all’Orientalizzante, si avvia ad acquisire una fisionomia urbana.
2.3.1. Aree a connotazione sacra e “politica”Per alcuni degli insediamenti in esame è attestata o è stata comunque ipotizza-
ta l’esistenza di aree e di strutture sacre all’interno dell’abitato: il fatto che si tratti di spazi destinati per lo più ad attività di culto anche in epoca etrusca suggerisce un possibile legame tra la prima forma di frequentazione sacra e il processo di strutturazione della comunità locale e dell’insediamento in senso protourbano.
Di particolare interesse è il contesto della cosiddetta “area sacra/complesso sacro-istituzionale” messo in luce nell’abitato del pianoro de La Civita di Tar-quinia (n. 59 delle Figg. 7b, 8a-b, 9a): un insieme di evidenze a forte connotazio-ne rituale e cultuale documenta che la frequentazione sacra del sito sia iniziata fin dal BF3B (seconda metà del X sec. a.C.) e sia proseguita senza soluzione di continuità per molti secoli, facendone un luogo di identificazione della comuni-tà25. L’area sacra potrebbe aver rivestito un ruolo importante nella formazione del centro protourbano e nella costruzione di un’identità collettiva, giacché la sua strutturazione comincia proprio nel periodo in cui avviene il passaggio dal piccolo abitato sull’altura della Castellina all’abitato esteso sull’intero pianoro de La Civita (BF3B) e continua nel PF1 e nel PF2 con vari interventi di risi-stemazione e di progressiva monumentalizzazione e con l’elaborazione di un sistema sempre più complesso di riti che talora sembrano assumere una conno-tazione non solo sacra, ma anche politico-istituzionale; elemento indicativo di questo processo è che il più antico fulcro sacro dell’area – una cavità naturale della roccia – continua ad essere rispettato e che alcune attività rituali restano invariate nel tempo.
Un probabile carattere sacro è stato attribuito anche ad altre evidenze della prima età del ferro individuate negli abitati di Veio e di Cerveteri; si tratta, in tali casi, di interpretazioni da considerare con maggior prudenza, essendo state formulate sulla base di inizi meno forti e talora controversi.
Nel caso di Veio, l’ipotesi che una o più delle strutture capannicole del Pri-mo Ferro individuate nel santuario etrusco di Portonaccio (su un piccolo terraz-
25 bOnghi jOvinO, chiaraMOntE trEré 1997, pp. 145-167, 217-220; Tarquinia 2001, pp. 21-44.
109Aspetti e fasi del processo formativo
zo immediatamente sottostante al margine occidentale del pianoro) (n. 15 delle Figg. 4a-b) rivestissero già un carattere sacrale è stata suggerita dall’ubicazione in un’area che almeno dalla prima metà del VII sec. a.C. è destinata al culto26. In modo non dissimile, per il nucleo capannicolo del Primo Ferro messo in luce nell’area della villa romana di Campetti (poco a N del precedente, su una piccola propaggine del pianoro) (n. 3 delle Figg. 4a-b) è stata ipotizzata la desti-nazione sacra di una capanna ellittica e, nella stessa ottica, è stato interpretato il rinvenimento fuori contesto di un elmo crestato fittile27; la destinazione d’uso del contesto resta, tuttavia, incerta sia per la prima età del ferro (solo area abi-tativa o anche presenza di una struttura di culto?) sia per il periodo etrusco (quando ad alcune strutture in blocchi di tufo di dubbia funzione si affiancano dei depositi votivi).
Problematica è anche la lettura delle tracce del Primo Ferro messe in luce nel santuario arcaico di Sant’Antonio – Vigna Calabresi, al margine sud-orienta-le del pianoro di Cerveteri (n. 29 delle Figg. 6a-b). All’ipotesi che la sequenza di alcune sepolture femminili del PF1 e di alcune capanne del PF2 indichi un cam-biamento di destinazione d’uso dell’area da funeraria ad abitativa28 si affianca quella che almeno una parte di tali evidenze possa riferirsi a un complesso sacro: in particolare, l’individuazione di una capanna ovale del PF2 nel luogo in cui è edificato in età arcaica il “tempio II” (o “tempio B”), la sovrapposizione degli ingressi della capanna e del tempio e la presenza di un ripostiglio di aes rude in associazione stratigrafica con la capanna hanno suggerito la possibile funzione rituale-cultuale della capanna (una sorta di “pre-tempio”)29; secondo una diver-sa ipotesi, il carattere sacro del complesso non sarebbe documentato solo dalle evidenze del PF2, ma potrebbe risalire già al PF1 per la presenza di sepolture con caratteri particolari30 che sono risparmiate dagli interventi edilizi di epoca successiva e che potrebbero appartenere ad addette al culto o sacerdotesse31.
Le ipotesi relative alla destinazione funzionale di questi tre contesti veienti e ceretani si basano, come si è visto, soprattutto sulla sovrapposizione tra ap-prestamenti di culto di età storica e strutture capannicole della prima età del ferro. Sebbene non si possa sempre provare con certezza che tali capanne siano connesse al culto, è comunque interessante sottolineare che esiste almeno una continuità nella valorizzazione di alcuni spazi di cui si avverte la criticità e che in età storica sono marcati da funzioni di culto specifiche: a Veio, ad esempio, nel caso di Portonaccio le evidenze si localizzano su un piccolo terrazzo naturale posto poco più in basso della superficie difesa del pianoro e immediatamente
26 cOlOnna 2002, pp. 146-147; van KaMpEn 2003, p. 27.27 cErasuOlO et al. 2004; bartOlOni 2009a, p. 105.28 cristOfani 1996; Maggiani, rizzO 2001; 2005.29 izzEt 2000. La capanna ovale è affiancata da un tratto di canaletta quasi rettilinea,
verosimilmente riferibile a un’altra capanna a pianta rettangolare edificata in un momento immediatamente posteriore all’uso di quella ovale (Ibid., pp. 323-324).
30 Vd. infra (par. 2.3.2).31 guidi 2009, p. 721.
110 Teresa Marino
all’esterno della cinta muraria etrusca e della Porta di Portonaccio, mentre nel caso di Campetti – villa romana si tratta di una piccola propaggine del pianoro situata in posizione dominante rispetto al terrazzo di Portonaccio e subito all’in-terno della suddetta porta urbica; a Cerveteri, l’area di Sant’Antonio – Vigna Calabresi è ubicata presso la Porta di S. Antonio della città etrusca e in antico rivestiva un’importanza strategica per il controllo del percorso che, scendendo lungo il costone tufaceo, conduceva in direzione NE verso Veio.
Non del tutto chiara è, infine, la funzione di una serie di cavità artificiali del Primo Ferro messe in luce in loc. Vigna Parrocchiale, al centro del pianoro di Cerveteri e nel cuore monumentale della futura città etrusca (n. 30 delle Figg. 6a-b): l’ipotesi che si tratti di pozzetti incineratori, formulata a più riprese dagli scavatori32, è, in verità, alquanto discutibile, perché scaturisce dalla sola osser-vazione della struttura delle buche e dal rinvenimento di scarsissimi materiali frammentari, non necessariamente riferibili a contesti funerari; considerando la disposizione planimetrica, è più verosimile l’ipotesi che le buche siano pertinen-ti ad una grande capanna ovale edificata esattamente al di sotto dell’”edificio ellittico” (in uso dall’arcaismo all’età romano-imperiale per riunioni di carattere pubblico), che, a sua volta, potrebbe rappresentare una monumentalizzazione della struttura del Primo Ferro33. Per le eccezionali dimensioni34, la posizione centrale sul pianoro e la probabile relazione con il più tardo “edificio ellittico” non è da escludere che la capanna possa aver rivestito una funzione particolare (come luogo di identificazione politica?) per la comunità della prima età del ferro.
2.3.2. “Sepolti tra i vivi”: deposizioni umane in contesti d’abitatoLa presenza all’interno delle aree abitate dei pianori di Tarquinia-Civita,
Veio e Cerveteri di alcune sepolture o deposizioni umane riferibili a diversi mo-menti della prima età del ferro attenua l’idea di una netta separazione funzio-nale tra “spazio dei vivi” e “spazio dei morti”, ribadendo la complessità della realtà archeologica rispetto a schemi interpretativi troppo rigidi. Il dibattito si concentra attualmente sul tentativo di comprendere se tali sepolture possano testimoniare che non sia ancora compiuta una chiara distinzione nell’uso degli spazi o se, piuttosto, esse assumano significati particolari in relazione all’identità e al ruolo che il defunto rivestiva nella comunità35.
32 cristOfani 1986, pp. 12-13; cristOfani et al. 1992; et al. 2003, p. 250.33 cristOfani et al. 1988, pp. 88-90; cErasuOlO 2002 (con un aggiornamento planime-
trico della capanna, di forma ovale, a tre navate e verosimilmente munita di portico esterno).34 Stando alla ricostruzione proposta in cErasuOlO 2002, la capanna ovale a tre navate
misurerebbe 27 x 13 m, equivalenti a 275 m2 ca., ma, aggiungendo il portico esterno, si arriverebbe a 34,4 x 18,8 m, pari a 508 m2 ca. di superficie totale.
35 In una prospettiva più ampia, estesa all’intero bacino del Mediterraneo dalla preistoria all’età romana, il tema è stato affrontato nel Convegno internazionale di Roma del 2006 dal titolo Sepolti tra i vivi. Buried among the living. Evidenza e interpretazione di contesti funerari in abitato (Atti Roma 2009); per l’Etruria protostorica, si rimanda anche a dElpinO 2008b.
111Aspetti e fasi del processo formativo
Nel panorama dell’Etruria protostorica, il fenomeno del seppellimento di individui in abitato appare circoscritto a un numero limitato di casi, individuati solo nei suddetti insediamenti dell’Etruria meridionale costiera e generalmente caratterizzati da peculiarità relative al rituale funerario e al contesto di deposi-zione, che farebbero pensare a sepolture di individui considerati “eccezionali” più che ad una pratica funeraria ordinaria.
Dall’analisi dei contesti noti emerge che, al di là di alcuni elementi comuni – quali il seppellimento sul pianoro dell’abitato e al di fuori delle coeve aree sepolcrali, l’assenza pressoché totale del corredo, l’uso dell’inumazione anche in periodi di prevalente o esclusiva diffusione dell’incinerazione –, le singole evidenze sono verosimilmente riconducibili a fenomeni almeno in parte non omologabili, che permettono di cogliere alcuni aspetti dell’ideologia e del pro-cesso di strutturazione delle comunità nel corso del Primo Ferro.
L’area sacra del Pian di Civita di Tarquinia ha restituito deposizioni umane inquadrabili tra la prima età del ferro e l’età arcaica, distribuite in diversi punti del complesso, caratterizzate dall’uso dell’inumazione nella nuda terra e dall’as-senza quasi totale di corredo e riferibili secondo i risultati delle analisi antropo-logiche a individui di sesso ed età differenti, morti in circostanze diversificate: data l’esiguità di attestazioni distribuite su un ampio arco temporale, le più re-centi proposte interpretative attribuiscono tali deposizioni a una pratica limita-ta a circostanze straordinarie e a fenomeni che variano dalla sacralizzazione di defunti particolari, nei casi di morte naturale, alla pratica del sacrificio umano, nei casi di morte violenta. Tra quelle del Primo Ferro (n. 59 delle Figg. 8a, 9a), la più antica, risalente al PF IB (fine del IX sec. a.C.) e rinvenuta nella cosiddet-ta “area alpha”, appartiene a un bambino albino ed encefalopatico/epilettico defunto per cause naturali, forse un individuo considerato prodigioso, la cui sepoltura è a lungo rispettata e onorata con rituali; diversamente, le deposizioni del PF IIB (terzo quarto dell’VIII sec. a.C.) appartengono a individui defunti di morte violenta e sono state riferite a sacrifici regolamentati dalla comunità e svolti nell’ambito di pratiche rituali e cultuali probabilmente con finalità pro-piziatorie – nel caso dei tre neonati inumati nell’area alpha in prossimità della deposizione più antica – ed espiatorie – nel caso dell’adulto deposto al margine settentrionale dell’area sacra, forse di origine straniera e ucciso con un colpo alla testa a seguito di uno scontro fisico e di un periodo di prigionia36.
Connotazioni alquanto differenti sembrano avere le sepolture del Primo Ferro rinvenute in contesti d’abitato a Veio. Al centro del piccolo pianoro di Piazza d’Armi sono state individuate due sepolture (n. 14 delle Figg. 4a-b) da-tabili rispettivamente al PF IA (prima metà del IX sec. a.C.) e al momento di passaggio tra la prima età del ferro e l’Orientalizzante (seconda metà dell’VIII sec. a.C.) che, per l’ubicazione e l’adozione di un rituale funerario atipico – inumazione senza corredo in fossa absidata con copertura monumentale non attestata nelle coeve necropoli veienti –, sono state riferite a personaggi oggetto
36 bOnghi jOvinO 2009 (con bibl. prec.); MallEgni, lippi 2009.
112 Teresa Marino
di una particolare venerazione funeraria; le similitudini nel rituale funerario, il medesimo orientamento, la vicinanza spaziale e la distanza cronologica tra le due sepolture hanno, inoltre, suggerito l’ipotesi di un rapporto di parentela tra i defunti. L’apprestamento funerario più antico (la cosiddetta “cappella funeraria”), riferibile ad un uomo adulto e frequentato con ripetute attività ri-tuali nei secoli successivi, è stato collegato alla sacralizzazione e al ricordo du-raturo di un individuo che potrebbe aver avuto un ruolo di prestigio connesso all’inizio del processo di urbanizzazione (“capostipite”/“fondatore”); in fase con la ristrutturazione di tale complesso si pone la realizzazione del secon-do apprestamento funerario, pertinente ad un adolescente di sesso maschile, identificato come un possibile discendente morto prematuramente37. Anoma-la è anche la deposizione risalente al PF IC della sequenza veiente (fine del IX sec. a.C.), individuata in prossimità del margine nord-occidentale del pianoro principale, tra le Porte Nord-Ovest e Caere della cinta muraria etrusca (n. 2 della Fig. 4a): si tratta di donna adulta inumata senza corredo in una stretta fossa scavata nel vano più interno di una grande capanna ovale che, nelle fasi immediatamente precedenti, era stata utilizzata come abitazione o struttura accessoria in relazione ad un impianto produttivo per la ceramica; l’appresta-mento, che ricade nello spazio dell’abitato, si pone anche in prossimità della fortificazione che fin dal BF3B protegge questo versante del rilievo. L’ubica-zione della deposizione e il suo rispetto nei secoli successivi hanno suggerito l’ipotesi che la defunta fosse stata sepolta in modo atipico e al di fuori delle necropoli per il ruolo rivestito da viva in relazione alle attività artigianali svolte nell’area, probabilmente come domina che soprintendeva alla produzione in quanto padrona dell’oikos e alla quale sarebbe stata riservata una particolare memoria funeraria38.
Meno definita è l’interpretazione delle testimonianze note dal pianoro di Cerveteri. Ormai sostanzialmente accantonata, come si è detto, è l’ipotesi di una funzione funeraria delle buche rinvenute al centro del pianoro, in loc. Vi-gna Parrocchiale (n. 30 delle Figg. 6a-b) 39. Sicura è, invece, la presenza di un gruppo di inumazioni in fossa del PF1, appartenenti a donne adulte e presso-ché prive di corredo, nell’area del già citato santuario arcaico di Sant’Antonio (n. 29 della Fig. 6a): la loro ubicazione ha alimentato l’ipotesi che a quel livello cronologico l’insediamento ceretano non fosse ancora ben strutturato come gli altri coevi e che sul pianoro coesistessero piccoli nuclei abitativi e sepolcra-li40; d’altro canto, considerando le specificità del rituale funerario, la presenza esclusiva di sepolture femminili, il loro rispetto nel tempo e la possibile lettura
37 bartOlOni 2009b; 2012; et al. 2014, pp. 139-140 (tutti con bibl. prec.). La deposi-zione più antica è stata altrove interpretata come un precedente protostorico della pratica del bidental o fulgur conditum (tOrElli 2009, pp. 809-810).
38 bOitani 2008, pp. 142-143; et al. 2009.39 Vd. supra (par. 2.3.1).40 cristOfani 1996; izzEt 2000; Maggiani, rizzO 2001; 2005.
113Aspetti e fasi del processo formativo
in chiave cultuale di almeno una capanna del PF2, è stato anche ipotizzato che l’area avesse un carattere sacro fin dal PF1 e che si trattasse di tombe di addet-te al culto o di sacerdotesse con il privilegio del seppellimento in area urbana (secondo una pratica nota per le Vestali di Roma e di Albalonga)41.
2.3.3. “La città murata”: fortificazioni e processo di definizione dei limiti dell’abitatoIl processo di definizione dello spazio insediativo si manifesta, in alcuni
contesti dell’Etruria meridionale costiera, con la realizzazione dei più antichi sistemi difensivi. I risultati delle indagini condotte negli ultimi anni hanno deter-minato il progressivo ampliamento della base documentaria e, parallelamente, lo sviluppo della riflessione teorica sulle fortificazioni del periodo e del territorio in esame42.
Nei casi attualmente noti di Veio e di Vulci si tratta non di strutture difensive destinate a racchiudere l’intera area abitata in una cinta perimetrale, bensì di sistemi di fortificazione a terrapieno funzionali a completare la delimitazione dell’abitato solo nei punti più deboli, laddove essa non è assicurata da limiti naturali, quali pareti scoscese o corsi d’acqua. La realizzazione di tali opere è indicativa del raggiungimento di un notevole livello di sviluppo da parte della comunità locale: in effetti, la validità delle scelte compiute in questo periodo si riflette nel fatto che gli stessi apprestamenti difensivi continuano ad essere uti-lizzati, con una serie di successive risistemazioni, anche dopo la fine della prima età del ferro e che le cinte murarie di epoca etrusca s’impostano in corrispon-denza delle fortificazioni protostoriche. Occorre al tempo stesso sottolineare come, stando ai dati più aggiornati, l’impianto dei sistemi difensivi di Veio e di Vulci sembri risalire a momenti alquanto distanti e non sia, pertanto, riconduci-bile ad un fenomeno unitario di sviluppo.
Nel caso di Veio, il più antico apprestamento difensivo è realizzato nel BF3B (seconda metà del X sec. a.C.) presso il ciglio nord-occidentale del pianoro, nell’area compresa tra le Porte Nord-Ovest e Caere in loc. Campetti, a pro-tezione dell’unico limite del rilievo non munito naturalmente (n. 2 delle Figg. 3b, 4a-b). Il primo intervento consiste nella realizzazione di un grande fossato parallelo al ciglio del pianoro, intenzionalmente obliterato in un momento im-mediatamente successivo per l’impianto di un terrapieno difensivo connesso ad una struttura portante in scapoli di tufo sbozzati di grandi dimensioni; l’ap-prestamento subisce reiterati rifacimenti nel corso del PF1 anche a causa delle intense attività artigianali svolte nella zona limitrofa, è ulteriormente consolida-to all’inizio del PF2 (prima metà dell’VIII sec. a.C.) con la realizzazione di un
41 guidi 2009, p. 721.42 Il tema delle fortificazioni in Etruria è stato affrontato nel Convegno di Studi Etruschi
e Italici tenutosi a Chianciano Terme-Sarteano-Chiusi nel 2005 e intitolato La città murata in Etruria (Atti Chianciano Terme 2008) e, più di recente, anche nell’ambito del Convegno internazionale di Roma del 2012 intitolato Mura di legno, mura di terra, mura di pietra: fortificazioni nel Mediterraneo antico (Atti Roma 2014).
114 Teresa Marino
più aggiornato sistema difensivo costituito da un muro a terrapieno e continua ad essere utilizzato con vari restauri fino all’edificazione della cinta muraria in opera quadrata di età arcaica43. La costruzione della fortificazione protostorica potrebbe essere l’“esito di un’iniziativa pianificata, il cui atto trova traccia ar-cheologica nella realizzazione del fossato, cui non sfuggirebbe forse un valore di “fondazione””44; l’intervento potrebbe, dunque, indicare una progettualità che segna l’inizio della formazione dell’insediamento protourbano e suggerire la continuità e l’unitarietà del processo che vede la prima forma di occupazione del rilievo nel BF3B e il decisivo ampliamento dell’abitato all’intera superficie difesa nel PF1.
Nel caso di Vulci, il più antico apprestamento difensivo, costituito da fossato e terrapieno e ipoteticamente completato da una palizzata, è realizzato in un momento molto avanzato o finale del PF2 (seconda metà dell’VIII sec. a.C.) presso la Porta Ovest della futura cinta muraria etrusca, nella stretta sella che congiunge i due pianori de La Città e di Pozzatella (n. 79 della Fig. 11c). A differenza di quanto registrato per Veio, l’intervento s’inserisce in un contesto insediativo già strutturato, che aveva assunto una fisionomia protourbana fin dal BF3; esso segna, inoltre, una cesura rispetto alle fasi precedenti, obliterando una serie di strutture abitative in uso tra il BF3 e l’inizio del PF2, e determina un riassetto insediativo, ponendosi nel punto più debole dell’abitato protostorico e l’unico non munito naturalmente. La realizzazione della fortificazione potrebbe essere stata finalizzata a ridefinire i limiti dell’abitato sul versante occidentale, escludendo il pianoro di Pozzatella dall’area dell’“abitato urbano” e relegando-lo al ruolo di un “sobborgo periferico”45.
A Vulci, la presenza di strutture difensive con fossato e terrapieno anche in altri punti del pianoro de La Città è stata ipotizzata sulla base di tracce lineari individuate nelle fotografie aeree; seppur di ignota datazione, esse potrebbero indicare l’esistenza di altri aggeres protostorici volti a isolare le due propaggini dell’“Acropoli” (a NE) e della “Piccola Acropoli” (a SE) protese sul fiume Fio-ra46 (Fig. 2d, aree C e D).
Per completezza si segnala che anche per l’abitato de La Civita di Tarquinia è stata ipotizzata l’esistenza di una fortificazione precedente alla cinta muraria in opera quadrata di età arcaica nell’area di Porta Romanelli, vale a dire sul ciglio settentrionale del pianoro in corrispondenza della sella che unisce il Pian di Civita e il Pian della Regina, ma al momento tale ipotesi non è supportata dall’evidenza archeologica. L’unico possibile accenno ad un apprestamento di-fensivo più antico è stato riconosciuto nel diario del 1938 relativo agli scavi di P. Romanelli, dove si legge dell’esistenza di una fossa e di un vallo fuori città lungo
43 bOitani 2008; et al. 2009; bartOlOni et al. 2014, pp. 137-139.44 bartOlOni et al. 2014, p. 138.45 MOrEtti sgubini 2006, pp. 326-342; 2008.46 pOcObElli 2004, pp. 133 e 136, figg. 3a, 5.9, 5.26, 15.3 e 17.6; MOrEtti sgubini
2005, p. 461; 2008, p. 178.
115Aspetti e fasi del processo formativo
le mura e a sinistra della porta. Inoltre, considerando che le attività produttive erano spesso dislocate ai margini dell’abitato, la recente individuazione di im-pianti artigianali a 70 m ca. a E di Porta Romanelli, in uso tra la metà del VII e la prima metà del VI sec. a.C. ca., ha indotto a ritenere che già a quell’epoca il limite urbano potesse correre non lontano dalla futura porta47.
2.3.4. Graduale trasformazione della struttura dell’insediamento: il sistema Civi-ta-Monterozzi-Saline di Tarquinia tra l’età del bronzo finale e la prima età del ferro
Come già anticipato, la struttura di tali insediamenti non è “cristallizzata” nel tempo. In genere, al momento della “svolta protourbana” l’insediamento ac-quisisce, conservandola fino alla fine della prima età del ferro, una configurazio-ne più o meno stabile per quel che riguarda, a livello macroscopico, il rapporto topografico e orografico tra l’area abitata e i sepolcreti. Alcuni cambiamenti diacronici si colgono, invece, nell’organizzazione interna: nonostante la disomo-geneità dei dati disponibili per i vari contesti, si registra una comune tendenza al progressivo infittirsi del tessuto abitativo – con la riduzione delle aree “vuote” – e funerario – con l’incremento del numero dei sepolcreti e delle sepolture –, che potrebbe indicare una progressiva crescita della densità demografica e un’ulte-riore concentrazione della popolazione da altre parti del territorio circostante.
Nel comparto dell’Etruria meridionale costiera, il caso di Tarquinia spicca per la complessità e il dinamismo dei processi di formazione urbana in atto tra il Bronzo Finale e il Primo Ferro, dal momento che il sistema insediativo appa-re più articolato degli altri, attraversa varie fasi di riorganizzazione del proprio assetto e di ridefinizione dei propri limiti e raggiunge solo alla fine della prima età del ferro una fisionomia assimilabile a quella della città etrusca (Figg. 7-9). I due pianori coinvolti nel sistema insediativo tarquiniese delle fasi protostoriche sono quello de La Civita (Pian di Civita, Pian della Regina, Castellina e Poggio Cretoncini) e quello dei Monterozzi, rispettivamente sedi dell’abitato e della principale necropoli urbana di epoca etrusca.
Nel BF1-2 (XII-XI sec. a.C. ca.) (Fig. 7a) due propaggini ben difese del pia-noro de La Civita – l’area della Castellina – e del colle dei Monterozzi – l’area del Castello di Corneto – risultano già occupate da abitati tipici dell’età del bronzo. È verosimile che da esse sia partita l’occupazione estensiva dei due pia-nori, rispettivamente nel BF3 per La Civita e nel PF1 per i Monterozzi; tuttavia, mentre l’occupazione della Castellina inizia nel Bronzo Antico e prosegue senza soluzione di continuità in tutte le successive fasi protostoriche e storiche, quella del Castello di Corneto appare circoscritta alla sola età del bronzo finale.
Nel corso del BF3 (X sec. a.C. ca.) (Fig. 7b) si coglie il graduale ampliamento dell’area abitata sul pianoro de La Civita, dapprima verso le zone circostanti alla Castellina e poi anche verso quelle più lontane; il salto di qualità in senso protourbano appare chiaro nel BF3B (seconda metà del X sec. a.C.), quando
47 baratti et al. 2008, p. 165; baratti, MOrdEglia 2009, p. 90; cataldi et al. 2010-2011, pp. 26-27.
116 Teresa Marino
inizia la frequentazione dell’area sacra de La Civita e le tracce abitative si distri-buiscono in modo rado su gran parte del rilievo (Castellina, Pian della Regina e Pian di Civita), tranne sul Poggio Cretoncini, che ospita alcuni nuclei sepolcrali in aggiunta a quelli distribuiti tutt’intorno al pianoro. Nessun cambiamento si registra, invece, sul colle dei Monterozzi.
L’organizzazione del popolamento nell’area tarquiniese diviene molto più complessa nel periodo compreso tra il PF1 e il momento iniziale del PF2 (PF IIA) (IX-prima metà dell’VIII sec. a.C. ca.) (Figg. 8a-b). L’insediamento de La Civita mostra il progressivo intensificarsi del tessuto abitativo e funerario, l’estensione della superficie abitata anche al Poggio Cretoncini, l’impianto di nuovi sepolcreti e il potenziamento dell’area sacra con nuove strutture e con-notazioni rituali-cultuali. Contemporaneamente, sul colle dei Monterozzi si re-gistra l’abbandono del piccolo abitato della propaggine del Castello di Corneto e l’occupazione estesa del rilievo con una serie di nuclei capannicoli distribuiti in vari punti della sua superficie e alcuni sepolcreti impiantati ai margini dell’a-rea verosimilmente riservata all’abitato, sia nel settore orientale del rilievo che alle sue pendici meridionali e sud-occidentali. Con l’inizio della prima età del ferro avviene, inoltre, l’occupazione della fascia costiera, segnalata da estesi af-fioramenti ceramici distribuiti su una superficie di 60 ha ca. nell’area delle ex-Saline di Stato di Tarquinia (Fig. 9b) e riferiti ad un’installazione funzionale allo sfruttamento delle risorse marine48 o, secondo un’altra interpretazione, ad un insediamento organizzato in modo non molto diverso da quello de La Civita, sebbene manchi traccia di sepolture49. La relativa vicinanza tra il pianoro de La Civita, il colle dei Monterozzi e l’area costiera delle Saline (Figg. 10a-b), il rap-porto di intervisibilità che lega le tre aree e le dinamiche insediative che si regi-strano nel corso del Primo Ferro hanno suggerito l’ipotesi che esse si riferissero ad un unico sistema insediativo, caratterizzato da una probabile “centralità” dell’area de La Civita (dove si svilupperà la città etrusca) e da un’occupazione “periferica” delle aree dei Monterozzi e delle Saline, finalizzata a una prima forma di controllo del territorio circostante e del litorale.
Una netta discontinuità si coglie con il passaggio al momento avanzato del PF2 (PF IIB) (terzo quarto dell’VIII sec. a.C. ca.) (Fig. 9a), quando una serie di cambiamenti verosimilmente interconnessi determinano l’ulteriore riassetto del sistema insediativo, la ridefinizione dei suoi limiti, la riorganizzazione fun-zionale degli spazi e il raggiungimento di una configurazione del tutto simile a quella della città etrusca. La superficie dell’abitato sul pianoro de La Civita si contrae (Castellina, Pian della Regina e Pian di Civita), escludendo definitiva-mente il Poggio Cretoncini, nuovamente destinato ad un uso funerario, mentre i sepolcreti circostanti al pianoro continuano ad essere utilizzati fino alla fine della prima età del ferro per essere poi gradualmente abbandonati. Allo stesso tempo, l’assetto del colle dei Monterozzi subisce una radicale trasformazione:
48 pacciarElli 2001, pp. 131, 170-176.49 MandOlEsi 1999, pp. 200-202.
117Aspetti e fasi del processo formativo
tutti i nuclei abitativi e funerari sono abbandonati, il rilievo si spopola e all’inizio dell’Orientalizzante diviene la sede della principale necropoli relativa all’abitato urbano de La Civita; è probabile che lo sviluppo della grande necropoli etrusca sia partito dal sepolcreto delle Arcatelle, l’unico a restare in uso dopo il PF IIA. Il processo di riorganizzazione del popolamento avvenuto al passaggio tra il PF IIA e il PF IIB determina la selezione definitiva del pianoro de La Civita come unica sede dell’abitato, la contrazione dei limiti dell’abitato entro i soli settori del pianoro occupati dalla futura città (Pian di Civita, Pian della Regina e Ca-stellina) e l’infittirsi del suo tessuto abitativo per il confluire dei gruppi umani dalle aree abbandonate del colle dei Monterozzi e del Poggio Cretoncini.
Alla fine della prima età del ferro è, poi, abbandonata anche l’area costiera delle Saline, mentre nelle aree circostanti a La Civita inizia a formarsi una rete di piccoli insediamenti, verosimilmente interpretabili come una proiezione della comunità di Tarquinia verso il territorio finalizzata allo sfruttamento sempre più intenso delle sue risorse50.
2.3.5. Ritualità e ideologia funerariaDall’analisi condotta per l’Etruria meridionale costiera emerge come i dati
acquisiti con le indagini degli ultimi anni non solo contribuiscano a chiarire sempre meglio la portata della trasformazione insediamentale “protourbana” in atto tra la fine dell’età del bronzo e la prima età del ferro, ma permettano anche di cogliere le forme concrete e diversificate di organizzazione dei singoli insediamenti e di precisare ulteriormente le tappe del processo che li conduce verso la forma urbana di epoca successiva.
Sempre più numerosi sono, inoltre, i segni che consentono di verificare come la progressiva definizione delle strutture insediative suggerisca indirettamente il coevo sviluppo delle strutture socio-politiche ed economiche delle rispettive co-munità durante il periodo esaminato, con un’accelerazione soprattutto verso la fine della prima età del ferro.
Come si è visto, tali processi si colgono, almeno in parte, nel consolidamento dell’identità del gruppo intorno ai luoghi deputati alle attività di culto, nella prolungata venerazione delle tombe di defunti particolari seppelliti all’interno dell’abitato, nella volontà di definire/ridefinire i limiti dell’insediamento attra-verso la realizzazione dei primi sistemi di fortificazione o attraverso la concen-trazione dello spazio abitativo e la selezione di nuovi spazi funerari.
Altri elementi in tal senso si desumono, seppure in forme indirette e ideolo-gicamente mediate, dall’analisi della ritualità funeraria. Se per il Bronzo Finale le sepolture note dai quattro contesti insediativi esaminati sono pochissime e difficilmente si prestano a una riflessione approfondita sull’ideologia funeraria, con il passaggio al Primo Ferro il tessuto funerario diventa molto più cospicuo e articolato. Nella fase iniziale del PF1, agli inizi del processo formativo dei
50 Per le dinamiche insediative in area tarquiniese tra l’età del bronzo finale e la prima età del ferro vd.: MandOlEsi 1999, soprattutto pp. 126-154, 179-204; pErEgO 2005, pp. 191-211.
118 Teresa Marino
centri protourbani, l’adozione quasi generalizzata del rito incineratorio e di un corredo spesso limitato suggerisce il funzionamento di una norma funeraria tesa a celebrare un’ideologia egualitaria che suggelli la coesione politica della comu-nità nascente. A partire da un momento avanzato del PF1 inizia un processo di graduale articolazione delle pratiche funerarie, che si manifesta generalmente nell’introduzione dell’inumazione accanto all’incinerazione, nell’adozione di tipologie tombali più complesse, nella tendenza alla crescita di complessità dei corredi e all’emergere di differenziazioni qualitative e quantitative nella loro composizione; tali cambiamenti sono stati collegati al progressivo emergere di forme di differenziazione socio-economica e di stratificazione in senso gerar-chico della comunità. Il processo si fa ancora più evidente nel corso del PF2, e soprattutto verso la fine del periodo, quando si coglie l’emergere di gruppi eli-tari di stampo aristocratico, le cui sepolture spiccano notevolmente rispetto alle altre per ricchezza e complessità; tali sviluppi preludono alla formazione delle aristocrazie di età orientalizzante, che manifesteranno la propria ideologia, a li-vello funerario, con l’adozione della tomba a camera e del tumulo monumentale e attraverso l’eccezionale ostentazione di ricchezza nei corredi51.
2.3.6. Proiezione verso il territorio circostante Ulteriore conferma dell’alto livello di strutturazione raggiunto dalle comuni-
tà dell’Etruria meridionale costiera verso la fine della prima età del ferro sembra derivare dagli studi di carattere territoriale.
Dopo il processo di selezione insediativa che nel BF3 (e soprattutto nel BF3B) determina la scomparsa di oltre il 90% degli abitati dei periodi prece-denti e la concentrazione del popolamento verso le sedi delle future città etru-sche, nel PF1 il territorio circostante ai grandi insediamenti di Veio, Cerveteri, Tarquinia e Vulci appare quasi completamente “vuoto”. Tuttavia, l’individua-zione di alcuni nuclei insediativi di ridotta entità che mostrano continuità di occupazione tra il Bronzo Finale e il Primo Ferro o che sorgono all’inizio del Primo Ferro lungo il litorale e nell’entroterra – per lo più ai margini dei com-parti territoriali controllati in età storica dalle città etrusche – e il rinvenimento di numerosi reperti isolati nell’agro hanno suggerito l’ipotesi che fin dall’inizio del loro processo formativo i quattro centri protourbani si siano proiettati verso le aree circostanti e abbiano avviato la gestione del territorio con piccoli insedia-menti stabili e con l’occupazione temporanea o la frequentazione occasionale di particolari siti.
Un sensibile cambiamento si coglie nel corso del PF2, quando inizia ad au-mentare notevolmente il numero degli insediamenti distribuiti nel territorio e a differenziarsi la loro scala dimensionale: questo fenomeno di ripopolamento
51 Per un inquadramento generale dello studio della ritualità funeraria della prima età del ferro in Etruria si rimanda a: d’agOstinO 1995; 2005. Per l’Etruria meridionale costiera vd.: pacciarElli 2010b (in generale); dElpinO 2013, pp. 81-85, con bibl. prec. (per Cerveteri); bartOlOni et al. 1994 (per Veio); iaia 1999 (per Tarquinia e Vulci).
119Aspetti e fasi del processo formativo
è stato interpretato come una forma sistematica di “ricolonizzazione” del ter-ritorio da parte dei centri protourbani, in una fase ormai avanzata della loro strutturazione interna, per motivazioni legate al controllo di snodi strategici e alla possibilità di gestire risorse economiche sempre più ampie attraverso la cre-azione di una rete insediativa gerarchica; tale processo determina la formazione di un nuovo sistema di occupazione – articolato in centri “primari” e “seconda-ri” – che diventerà ancora più capillare nel corso dell’età orientalizzante52.
Bibliografia
accOncia v. 2012, Paesaggi etruschi in terra di Siena. L’agro tra Volterra e Chiusi dall’età del Ferro all’età romana, BAR IS 2422, Oxford.
andrEOtti a., bEttini M.c., gaMbOgi p., MatErrazzi s., zanini a. 1998, “Il bronzo finale e la prima età del ferro nell’Etruria settentrionale”, in Atti Manciano 1998, pp. 7-22.
Atti Chianciano Terme 2008, La città murata in Etruria, Atti del XXV Convegno di Studi Etru-schi e Italici (Chianciano Terme, Sarteano, Chiusi 2005), Pisa-Roma.
Atti Colle di Val d’Elsa 2002, M. ManganElli, E. pacchiani (a cura di), Città e territorio in Etruria. Per una definizione di città nell’Etruria settentrionale, Atti delle Giornate di Studio (Colle di Val d’Elsa 1999), Colle di Val d’Elsa.
Atti Firenze 1979, Il Bronzo finale in Italia, Atti della XXI Riunione Scientifica dell’IIPP (Fi-renze 1977), Firenze.
Atti Louvain-la-Neuve 2010, p. fOntainE (éd.), L’Étrurie et l’Ombrie avant Rome: cité et terri-toire, Actes du colloque international (Louvain-la-Neuve 2004), Bruxelles-Rome.
Atti Manciano 1998, n. nEgrOni catacchiO (a cura di), Protovillanoviani e/o Protoetruschi. Ricerche e scavi, Atti del III Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria in Etruria (Man-ciano, Firenze 1995), Firenze.
Atti Roma 2005a, g. bartOlOni, f. dElpinO (a cura di), Oriente e Occidente: metodi e discipli-ne a confronto. Riflessioni sulla cronologia dell’età del ferro in Italia, Atti dell’Incontro di Studi (Roma 2003), Mediterranea I (2004), Pisa-Roma.
Atti Roma 2005b, Dinamiche di sviluppo delle città nell’Etruria meridionale: Veio, Caere, Tar-quinia, Vulci, Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi e Italici (Roma, Veio, Cerveteri/
52 L’ipotesi dell’esistenza di un’organizzazione complessiva del territorio da parte dei centri protourbani già nel corso del Primo Ferro è stata formulata da F. di Gennaro e R. Peroni (di gEnnarO 1982; 1986; di gEnnarO, pErOni 1986; pErOni 1989; ulteriori considerazioni relative a specifici casi di studio sono in di gEnnarO 1983, 1984, 1995 e 1998) ed è stata ac-colta nella maggior parte dei successivi studi che si sono occupati delle dinamiche territoriali in Etruria meridionale costiera tra l’età del bronzo finale e la prima età del ferro (pacciarElli 1994b; iaia, MandOlEsi 1995; pacciarElli 2001; bOnghi jOvinO 2005; barbarO 2010; iaia, MandOlEsi 2010). Ad essa si è contrapposta la ricostruzione di M. Rendeli – che non ha trovato ampio seguito –, secondo cui è difficile presumere che nel Primo Ferro esista già una forma di gestione pianificata del territorio da parte di centri e comunità ancora in corso di formazione; in tale ottica, solo con il passaggio all’Orientalizzante si avrebbe la definitiva aggregazione dei centri urbani e inizierebbe lo sviluppo di un sistema di controllo e di organizzazione stabile del territorio circostante (rEndEli 1991, pp. 13-20).
120 Teresa Marino
Pyrgi, Tarquinia, Tuscania, Vulci, Viterbo 2001), Pisa-Roma.Atti Roma 2009, g. bartOlOni, M.g. bEnEdEttini (a cura di), Sepolti tra i vivi. Buried among
the living. Evidenza e interpretazione di contesti funerari in abitato, Atti del Convegno In-ternazionale (Roma 2006), ScAnt 14 (2007-2008).
Atti Roma 2010, a. cardarElli, a. cazzElla, M. frangipanE, r. pErOni (a cura di), Le ragioni del cambiamento. “Nascita”, “declino” e “crollo” delle società tra fine del IV e inizio del I millennio a.C., Atti del Convegno Internazionale (Roma 2006), ScAnt 15 (2009).
Atti Roma 2014, g. bartOlOni, l.M. MichEtti (a cura di), Mura di legno, mura di terra, mura di pietra: fortificazioni nel Mediterraneo antico, Atti del Convegno Internazionale (Roma 2012), ScAnt 19.2/3 (2013).
Atti Salerno 1994, p. gastaldi, g. MaEtzKE (a cura di), La presenza etrusca nella Campania meridionale, Atti delle Giornate di Studio (Salerno, Pontecagnano 1990), Firenze.
Atti Valentano 2010, N. nEgrOni catacchiO (a cura di), L’alba dell’Etruria. Fenomeni di conti-nuità e trasformazione nei secoli XII-VIII a.C. Ricerche e scavi, Atti del IX Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria in Etruria (Valentano, Pitigliano 2008), Milano.
babbi a. 2005, “L’insediamento protostorico di Isola Farnese. Considerazioni sull’età del Bronzo finale nel distretto veiente”, in Atti Roma 2005b, pp. 715-736.
baratti g., cataldi M., MOrdEglia l. 2008, “La cinta fortificata di Tarquinia alla luce della nuova documentazione”, in Atti Chianciano Terme 2008, pp. 155-169.
baratti g., MOrdEglia l. 2009, “Un’officina per la cottura di tegole a Tarquinia in età orien-talizzante”, in I mestieri del fuoco. Officine e impianti artigianali nell’Italia preromana, Of-ficina Etruscologia 1, Roma, pp. 83-99.
barbarO b. 2010, Insediamenti, aree funerarie ed entità territoriali in Etruria meridionale nel Bronzo Finale, Firenze.
barKEr g., rasMussEn t. 1998, The Etruscans, Oxford.bartOlOni G. 2006, “L’inizio del processo di formazione urbana in Etruria. Analogie e diffe-
renze venute in luce nei recenti scavi”, in M. bOnghi jOvinO (a cura di), Tarquinia e le civil-tà del Mediterraneo, Atti del Convegno Internazionale (Milano 2004), Milano, pp. 49-82.
bartOlOni g. 2009a, “I primi abitanti di Roma e di Veio”, in g. dElla fina (a cura di), Gli Etruschi e Roma: fasi monarchica e alto-repubblicana, AnnFaina XVI, Roma, pp. 93-117.
bartOlOni g. 2009b, “La sepoltura al centro del pianoro di Piazza d’Armi-Veio”, in Atti Roma 2009, pp. 821-832.
bartOlOni g. 2011, “Il popolamento nell’Etruria settentrionale tra l’età del Bronzo finale e la prima età del Ferro: una proposta di lettura”, in s. casini (a cura di), “Il filo del tempo”. Studi di preistoria e protostoria in onore di Raffaele Carlo de Marinis, NotABerg 19, Ponte-ranica, pp. 229-246.
bartOlOni g. 2012, “Una visita di Maria Bonghi agli scavi di Veio”, in c. chiaraMOntE trEré, g. bagnascO gianni, f. chiEsa (a cura di), Interpretando l’antico. Scritti di archeologia offerti a Maria Bonghi Jovino, Milano, pp. 55-65.
bartOlOni g., accOncia v., bElElli MarchEsini b., biagi f., cErasuOlO O., nEri s., pitzalis f., pulcinElli l., sarracinO d. 2014, “Progetto Veio: novità dalle ultime campagne di scavo”, in ScAnt 19.1 (2013), pp. 133-156.
bartOlOni g., bErardinEtti a., dragO l., dE santis a. 1994, “Veio tra IX e VI secolo a.C. Primi risultati sull’analisi comparata delle necropoli veienti”, in ArchCl 46, pp. 1-46.
bEllElli v. 2012 (a cura di), Le origini degli Etruschi. Storia, Archeologia, Antropologia, Roma.biEtti sEstiEri a.M. 2008, “L’età del Bronzo Finale nella penisola italiana”, in Padusa 44, pp.
7-54.biEtti sEstiEri a.M. 2012, “Il Villanoviano: un problema archeologico di storia mediterra-
nea”, in bEllElli 2012, pp. 249-277.biEtti sEstiEri a.M., dE angElis M.c., nEgrOni catacchiO n., zanini a. 2001, “La proto-
121Aspetti e fasi del processo formativo
storia della Toscana dall’Età del Bronzo recente al passaggio alla prima Età del Ferro”, in Preistoria e protostoria della Toscana, Atti della XXXIV Riunione Scientifica dell’IIPP (Firenze 1999), Firenze, pp. 117-166.
bOitani f. 2008, “Nuove indagini sulle mura di Veio nei pressi di porta Nord-Ovest (con ap-pendice di S. Neri e F. Biagi)”, in Atti Chianciano Terme 2008, pp. 135-154.
bOitani f., nEri s., biagi f. 2009, “La donna delle fornaci di Veio-Campetti”, in Atti Roma 2009, pp. 833-868.
bOnghi jOvinO M. 2005, “Città e territorio. Veio, Caere, Tarquinia, Vulci: appunti e riconside-razioni”, in Atti Roma 2005b, pp. 27-58.
bOnghi jOvinO M. 2009, “L’ultima dimora. Sacrifici umani e rituali sacri in Etruria. Nuovi dati sulle sepolture nell’abitato di Tarquinia”, in Atti Roma 2009, pp. 771-793.
bOnghi jOvinO M., chiaraMOntE trEré C. 1997 (a cura di), Tarquinia. Testimonianze arche-ologiche e ricostruzione storica. Scavi sistematici nell’abitato (campagne 1982-1988), Roma.
bruni s. 2010 (a cura di), Gli Etruschi delle città. Fonti, ricerche e scavi, Cinisello Balsamo.caMpOrEalE g. 2001 (a cura di), Gli Etruschi fuori d’Etruria, San Giovanni Lupatoto.cascinO r., di giusEppE h., pattErsOn h. 2012 (eds), Veii. The Historical Topography of the
Ancient City. A Restudy of John Ward-Perkins’s Survey, London.cataldi M., baratti g., MOrdEglia l. 2010-2011, “La cinta fortificata di Tarquinia: nuovi
spunti di riflessione”, in Bollettino della Società Tarquiniese d’Arte e Storia 38, pp. 5-28.cErasuOlO O. 2002, “Cerveteri – Vigna Parrocchiale. Una rilettura delle strutture protostori-
che”, in n. nEgrOni catacchiO (a cura di), Paesaggi d’acque, Atti del V Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria in Etruria (Sorano, Farnese 2000), Milano, pp. 765-770.
cErasuOlO O. 2008, “All’origine di Caere. Contributo alla conoscenza del processo formativo protourbano in un settore dell’Etruria meridionale”, in n. nEgrOni catacchiO (a cura di), Paesaggi reali e paesaggi mentali. Ricerche e scavi, Atti dell’VIII incontro di Studi di Preistoria e Protostoria in Etruria (Valentano, Pitigliano 2006), Milano, pp. 683-697.
cErasuOlO O., brunO a., gOri M. 2004, “Scavi nel complesso archeologico di Campetti a Veio: materiali e contesti dell’età del ferro”, in n. nEgrOni catacchiO (a cura di), Miti, simboli, decorazioni. Ricerche e scavi, Atti del VI incontro di Studi di Preistoria e Protosto-ria in Etruria (Pitigliano, Valentano 2002), Milano, pp. 593-598.
chaMpiOn t.c., gaMblE c., shEnnan s., WhittlE a. 1984 (eds), Prehistoric Europe, London.cOlOnna g. 1976, “Basi conoscitive per una storia economica dell’Etruria”, in Contributi
introduttivi allo studio della monetazione etrusca, Atti del V Convegno del Centro Interna-zionale di Studi Numismatici (Napoli 1975), Roma, pp. 3-23.
cOlOnna g. 2002, Il santuario di Portonaccio a Veio. I. Gli scavi di Massimo Pallottino nella zona dell’altare (1939-1940), MonAnt 58, 6.3, Roma.
cristOfani M. 1986, “Nuovi dati per la storia urbana di Caere”, in BdA 35-36, pp. 1-24.cristOfani M. 1996, “Recenti scoperte nell’area urbana di Caere”, in Notiziario dell’Università
di Napoli Federico II n.s. 2, pp. 73-78.cristOfani M., bOss M., burKhardt K., gilOtta f., MOscati p., pandOlfini M., santOrO p.,
barKEr g., nardi g., rEndEli M. 1992, Caere 3.1. Lo scarico arcaico della Vigna Parroc-chiale, Roma.
cristOfani M., Maggiani a., bEllElli v., guarinO a., guidi g.f., rEndEli M., trOisi g. 2003, Caere 4. Vigna Parrocchiale. Scavi 1983-1989: il santuario, la “residenza” e l’edificio ellittico, Roma.
cristOfani M., nardi g., rizzO M.a. 1988, Caere 1. Il parco archeologico, Roma.d’agOstinO b. 1995, “Considerazioni sugli inizi del processo di formazione della città in Etru-
ria”, in a. stOrchi MarinO (a cura di), L’incidenza dell’antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, Atti del Convegno (Anacapri 1991), Napoli, vol. I, pp. 315-323.
d’agOstinO b. 2005, “La città”, in Atti Roma 2005b, pp. 21-25.
122 Teresa Marino
d’agOstinO b. 2011, “Gli Etruschi e gli altri nella Campania settentrionale”, in Gli Etruschi e la Campania settentrionale, Atti del XXVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Teano 2007), Pisa-Roma, pp. 69-81.
daMgaard andErsEn h., hOrsnaE h, hOuby-niElsEn s., rathjE a. 1997 (a cura di), Urbani-sation in the Mediterranean in the 9th to 6th centuries BC., ActaHyp 7, Copenhagen.
dElpinO f. 2008a, “Misurare il tempo, valutare le misure del tempo. Il dibattito sulla cronolo-gia dell’età del Ferro italiana”, in a. lEhOërff (a cura di), Construire le temps. Histoire et méthodes des chronologies et calendriers des derniers millénaires avant notre ère en Europe occidentale, Actes du XXX Colloque International de Halma-Ipel (Lille 2006), Glux-en-Glenne, pp. 293-298.
dElpinO F. 2008b, “La morte ritualizzata. Modalità di sepoltura nell’Etruria protostorica”, in X. dupré ravEntós, s. ribichini, s. vErgEr (a cura di), Saturnia Tellus. Definizioni dello spazio consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico e celtico, Atti del Con-vegno Internazionale (Roma 2004), Roma, pp. 599-608.
dElpinO F. 2013, “D’Agylla à Caere”, in f. gaultiEr, l. hauMEssEr, p. santOrO (eds), Les Étrusques et la Méditerranée: la cité de Cerveteri, catalogo della mostra (Lens, Roma 2013-2014), Paris, pp. 77-85.
di gEnnarO f. 1979, “Contributo alla conoscenza del territorio etrusco meridionale alla fine dell’età del bronzo”, in Atti Firenze 1979, pp. 267-274.
di gEnnarO f. 1982, “Organizzazione del territorio nell’Etruria meridionale protostorica: ap-plicazione di un modello grafico”, in DialA 4.2, pp. 102-112.
di gEnnarO f. 1983, “Intervento nel corso della discussione”, in Nascita di una società urbana a Roma e nel Lazio, in Opus II.2, pp. 438-441.
di gEnnarO f. 1984, “Intervento nel corso della discussione”, in s. fOrsbErg, b.E. thO-MassOn (a cura di), San Giovenale. Materiali e problemi, Atti del Simposio (Roma 1983), Stockholm, pp. 97-100.
di gEnnarO f. 1986, Forme d’insediamento tra Tevere e Fiora dal Bronzo Finale al principio dell’età del ferro, Firenze.
di gEnnarO f. 1988, “Il popolamento dell’Etruria meridionale e le caratteristiche degli inse-diamenti tra l’età del bronzo e l’età del ferro”, in g. cOlOnna, c. bEttini, r.a. stacciOli (a cura di), Etruria meridionale: conoscenza, conservazione, fruizione, Atti del Convegno (Viterbo 1985), Roma, pp. 59-82.
di gEnnarO f. 1990, “Aspetti delle ricerche sull’assetto territoriale dell’area mediotirrenica in età protostorica”, in f.M. andraschKO (hrsg.), Gedenkschrift für Jürgen Driehaus, Mainz, pp. 203-224.
di gEnnarO f. 1995, “La Ferriera di Sutri”, in n. nEgrOni catacchiO (a cura di), Tipologia delle necropoli e rituali di deposizione. Ricerche e scavi, Atti del II Incontro di Studi di Prei-storia e Protostoria in Etruria (Farnese 1993), vol. II, Milano, pp. 277-279.
di gEnnarO f. 1998, “Le necropoli del Sasso tra Bronzo Finale e prima età del ferro. Il sepol-creto di Montetosto Alto”, in Atti Manciano 1998, pp. 527-528.
di gEnnarO f. 1999a, “L’età del Bronzo tra Toscana e Lazio”, in E. pEllEgrini (a cura di), Insediamenti preistorici e città etrusche nella media valle del fiume Fiora. Guida al Museo Civico Archeologico di Pitigliano, Pitigliano, pp. 9-17.
di gEnnarO f. 1999b, “Indizi archeologici di élites nell’età del bronzo dell’Italia mediotirreni-ca”, in Eliten in der Bronzezeit. Ergebnisse zweier Kolloquien in Mainz und Athen, Mainz, pp. 185-196.
di gEnnarO F. 2000, “Paesaggi di Potere: l’Etruria meridionale in età protostorica”, in g. caMassa, a. dE giuliO, f. vErOnEsE (a cura di), Paesaggi di Potere: problemi e prospettive, Atti del Seminario (Udine 1996), Roma, pp. 95-119.
di gEnnarO f. 2006, “Individuazione, formulazione e percezione comune di caratteri signi-
123Aspetti e fasi del processo formativo
ficativi degli insediamenti protostorici”, in Studi di protostoria in onore di Renato Peroni, Firenze, pp. 485-494.
di gEnnarO f. 2012, “I ritrovamenti protostorici del territorio di Formello e le fasi formative di Veio”, in i. van KaMpEn (a cura di), Il nuovo Museo dell’Agro Veientano a Palazzo Chigi di Formello, Roma, pp. 33-46.
di gEnnarO f., guidi a. 2010, “Ragioni e regioni di un cambiamento culturale: modi e tempi della formazione dei centri protourbani nella Valle del Tevere e nel Lazio meridionale”, in Atti Roma 2010, pp. 429-445.
di gEnnarO f., pErOni r. 1986, “Aspetti regionali dello sviluppo dell’insediamento protosto-rico nell’Italia centro-meridionale alla luce dei dati archeologici e ambientali”, in DialA 4.2, pp. 193-200.
di gEnnarO f., schiappElli a., aMOrOsO a. 2004, “Un confronto tra gli organismi protostatali delle due sponde del Tevere. Le prime fasi di Veio e di Crustumerio”, in h. pattErsOn (ed.), Bridging the Tiber. Approaches to Regional Archaeology in the Middle Tiber Valley, London, pp. 147-177.
EnEi f. 2001, Progetto Ager Caeretanus: il litorale di Alsium. Ricognizioni archeologiche nel ter-ritorio dei comuni di Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino (Alsium – Caere – Ad Turres – Ceri), Santa Marinella.
fulMinantE f., stOddart s. 2010, “Formazione politica a confronto in Etruria e Latium vetus: status quaestionis e nuove prospettive di ricerca”, in h. di giusEppE, M. dalla riva (a cura di), Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean, Proceedings of XVII International Congress of Classical Archaeology (Roma 2008), Bollettino di Archeologia on line I 2010/F/F1/3, pp. 11-22.
guaitOli M. 1981, “Notizie preliminari su recenti ricognizioni svolte in seminari dell’Istituto”, in Ricognizione archeologica. Nuove ricerche nel Lazio, Firenze, pp. 79-87.
guidi a. 2006, “The Archaeology of Early State in Italy”, in Social Evolution and History. Studies in the Evolution of Human Societes 5.2, pp. 55-99.
guidi a. 2008, “Archeologia dell’Early State: il caso di studio italiano”, in Ocnus 16, pp. 175-192.guidi a. 2009, “Sepolti tra i vivi. L’evidenza laziale”, in Atti Roma 2009, pp. 711-723.guidi a. 2010, “The Archaeology of Early State in Italy: New Data and Acquisitions”, in
Social Evolution and History. Studies in the Evolution of Human Societies 9.2, pp. 12-27.harris W.h. 1989, “Invisible cities: the beginnings of Etruscan urbanization”, in Atti del Sec-
ondo Congresso Internazionale Etrusco (Firenze 1985), Roma, vol. I, pp. 375-392.iaia c. 1999, Simbolismo funerario e ideologia alle origini di una civiltà urbana. Forme rituali
nelle sepolture villanoviane a Tarquinia e Vulci, e nel loro entroterra, Firenze.iaia c., MandOlEsi a. 1995, “Topografia dell’insediamento dell’VIII secolo a.C. in Etruria
meridionale”, in JAT III (1993), pp. 17-48.iaia c., MandOlEsi a. 2010, “Comunità e territori nel Villanoviano evoluto dell’Etruria meri-
dionale”, in Atti Valentano 2010, pp. 61-78.izzEt v.E. 2000, “The Etruscan Sanctuary at Cerveteri, Sant’Antonio: preliminary report of
excavations 1995-8”, in BSR 68, pp. 321-335.Maggiani a. 2010, “Volterra. Formazione della città e del territorio”, in Atti Louvain-la-Neuve
2010, pp. 35-61.Maggiani a., rizzO M.a. 2001, “Area sacra in località S. Antonio”, in a.M. MOrEtti sgubini
(a cura di), Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, catalogo della mostra (Roma 2001), Roma, pp. 143-145.
Maggiani a., rizzO M.a. 2005, “Cerveteri. Le campagne di scavo in loc. Vigna Parrocchiale e S. Antonio”, in Atti Roma 2005b, pp. 175-183.
MallEgni f., lippi B. 2009, “Considerazioni antropologiche sugli inumati nell’area sacra dell’abitato di Tarquinia”, in Atti Roma 2009, pp. 795-804.
124 Teresa Marino
MandOlEsi A. 1999, La “prima” Tarquinia. L’insediamento protostorico sulla Civita e nel terri-torio circostante, Firenze.
MandOlEsi a. 2012, “Scenari protourbani dell’Etruria tirrenica”, in A. MandOlEsi, M. sanni-balE (a cura di), Etruschi. L’ideale eroico e il vino lucente, catalogo della mostra (Asti 2012), Milano, pp. 19-29.
MarinO T. 2011-2013, Complessità e dinamismo dei processi insediativi tra Bronzo Finale e Primo Ferro in Etruria, Tesi di Dottorato di Ricerca, Università degli Studi di Salerno, a.a. 2011-2013.
MOrEtti sgubini a.M. 2005, “Risultati e prospettive delle ricerche in atto a Vulci (con appen-dice di A.M. Tocci)”, in Atti Roma 2005b, pp. 459-484.
MOrEtti sgubini a.M. 2006, “Alle origini di Vulci”, in M. pandOlfini angElEtti (a cura di), Archeologia in Etruria Meridionale, Atti delle Giornate di Studio in ricordo di Mario Mo-retti (Civita Castellana 2003), Roma, pp. 317-361.
MOrEtti sgubini a.M. 2008, “Le mura di Vulci: aggiornamento sullo stato della ricerca”, in Atti Chianciano Terme 2008, pp. 171-189.
MüllEr-KarpE h. 1962, Zur Stadtwerdung Roms, Heidelberg.nardi g. 1986, “Ricognizione nell’area urbana antica”, in a. EMiliOzzi MOrandi, a.M. sgu-
bini MOrEtti (a cura di), Archeologia nella Tuscia II, Atti degli Incontri di Studio (Viterbo 1984), Roma, pp. 15-21.
nijbOEr a.j., van dEr plicht h. 2008, “The Iron age in the Mediterranean: recent radiocar-bon Research at the University of Groningen”, in Proceedings of the XV World Congress of the International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences (Lisbon 2006), BAR IS 1871, Oxford, pp. 103-118.
pacciarElli M. 1994a, “Sviluppi verso l’urbanizzazione nell’Italia tirrenica protostorica”, in Atti Salerno 1994, pp. 227-253.
pacciarElli M. 1994b, “Territorio, insediamento, comunità in Etruria meridionale agli esordi del processo di urbanizzazione”, in ScAnt 5 (1991), pp. 163-208.
pacciarElli M. 2001, Dal villaggio alla città. La svolta protourbana del 1000 a.C. nell’Italia tirrenica, Firenze.
pacciarElli M. 2010a, “Verso i centri protourbani. Situazioni a confronto da Etruria meridio-nale, Campania e Calabria”, in Atti Roma 2010, pp. 371-416.
pacciarElli M. 2010b, “Forme di complessità sociale nelle comunità protourbane dell’Etruria meridionale”, in Atti Louvain-la-Neuve 2010, pp. 17-33.
pallOttinO M. 1984, Etruscologia, Milano.pErEgO l.g. 2005, Il territorio tarquiniese. Ricerche di topografia storica, Milano.pErOni r. 1969, “Per uno studio dell’economia di scambio in Italia nel quadro dell’ambiente
culturale dei secoli intorno al mille a.C.”, in PP 125, pp. 134-160.pErOni r. 1979, “Le ultime pagine di Ferrante Rittatore Vonwiller sul “Protovillanoviano””,
in Atti Firenze 1979, pp. 32-46.pErOni r. 1989, Protostoria dell’Italia Continentale. La Penisola italiana nelle età del bronzo e
del ferro, Bologna.pErOni r. 1992, “Villanoviano a Fermo?”, in La civiltà picena nelle Marche. Studi in onore di
G. Annibaldi (Ancona 1988), Ripatransone, pp. 13-38.pErOni r. 1994, “Variazioni sul tema del concetto di “Villanoviano” applicato alla Campania”,
in Atti Salerno 1994, pp. 37-48.pErOni r. 1996, L’Italia alle soglie della storia, Roma-Bari.pErOni r. 2000, “Formazione e sviluppi dei centri protourbani medio-tirrenici”’, in a. caran-
dini, r. cappElli (a cura di), Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città, catalogo della mostra (Roma 2000), Milano, pp. 26-30.
pErOni r. 2003, “Marciare divisi per colpire uniti”, in s. MarchEsini, f. pOccEtti (a cura di),
125Aspetti e fasi del processo formativo
Linguistica è storia. Scritti in onore di Carlo De Simone, Pisa, pp. 138-142.pinza g. 1905, Monumenti primitivi di Roma e del Lazio antico, MonAnt 15.pOcObElli g.f. 2004, “Vulci: il contributo della fotografia aerea alla conoscenza dell’area ur-
bana”, in g. cEraudO, f. piccarrEta (a cura di), Archeologia aerea. Studi di Aerotopografia Archeologica, I, Roma, pp. 127-143.
Pozzuolo 2013a, “Roma, località Pozzuolo (Veio) – Necropoli”, in Direzione Generale per le Antichità Sito Istituzionale. Scavi (www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/142/ scavi/scaviarcheologici_4e048966cfa3a/343).
Pozzuolo 2013b, “Prima di Veio: la necropoli dell’età del bronzo finale di Pozzuolo”, in So-printendenza Beni Archeologici Etruria Meridionale Sito Istituzionale. Scavi e Ricerche. Roma – Veio (www.etruriameridionale.beniculturali.it /index.php?it/284/roma-veio).
rEndEli M. 1991, “Sulla nascita delle comunità urbane in Etruria meridionale”, in AnnASto-rAnt XIII, pp. 9-45.
rEndEli M. 1993, Città aperte. Ambiente e paesaggio rurale organizzato nell’Etruria meridionale costiera durante l’età orientalizzante e arcaica, Roma.
rEnfrEW c. 1975, “Trade as Action at a Distance: Questions of Integration and Communi-cation”, in J.a. sablOff, c.c. laMbErg-KarlOvsKy (eds), Ancient Civilizations and Trade, Albuquerque, pp. 3-59.
ridgWay D. 1992, The First Western Greeks, Cambridge.rittatOrE vOnWillEr f., falchEtti f., nEgrOni catacchiO n. 1977, “Preistoria e protostoria
della valle del fiume Fiora”, in La civiltà arcaica di Vulci e la sua espansione, Atti del X Convegno di Studi Etruschi e Italici (Grosseto, Roselle, Vulci 1975), Firenze, pp. 99-165.
Roma 2008, M. tOrElli, a.M. MOrEtti sgubini (a cura di), Etruschi. Le antiche metropoli del Lazio, catalogo della mostra (Roma 2008), Verona.
sassatElli g. 2000, “L’espansione etrusca nella Valle Padana”, in M. tOrElli (a cura di), Gli Etruschi, catalogo della mostra (Venezia 2000), Milano, pp. 169-179.
schiappElli a. 2008, Sviluppo storico della Teverina nell’età del Bronzo e nella prima età del Ferro, Firenze.
shErratt A. 1993, “What Would a Bronze Age World System look like? Relations between temperate Europe and the Mediterranean in later prehistory”, in Journal of European Ar-chaeology 1.2, pp. 1-58.
stOddart s.K., spivEy n. 1990, Etruscan Italy. An Archaeological History, London.Tarquinia 2001, a.M. MOrEtti sgubini (a cura di), Tarquinia etrusca: una nuova storia, catalogo
della mostra (Tarquinia 2001), Roma.tOrElli M. 2009, “Exterminatio”, in Atti Roma 2009, pp. 805-819.van KaMpEn i. 2003, “Dalla capanna alla casa a Veio”, in i. van KaMpEn (a cura di), Dalla
capanna alla casa. I primi abitanti di Veio, catalogo della mostra (Formello 2003-2004), Formello, pp. 23-29.
vErgEr s. 2007, “La guerre des dates. Les chronologies de l’Âge du Fer italien”, in Les Dos-siers d’Archéologie 322, Juillet-Août 2007, pp. 92-93.
Ward-pErKins J.B. 1961, “Veii: the historical topography of the ancient city”, in BSR 29, pp. 1-123.
zanini a. 1994, “L’Età del Bronzo Finale nella Toscana interna alla luce delle più recenti ac-quisizioni”, in RScPreist 46, pp. 87-138.
zanini a. 1997 (a cura di), Dal Bronzo al Ferro: il II millennio a.C. nella Toscana centro-occiden-tale, catalogo della mostra (Livorno 1997-1998), Livorno.
zanini a. 2012, “Le origini etrusche. Il quadro di riferimento della protostoria”, in bEllElli 2012, pp. 85-104.
126 Teresa Marino
Discussione
F. di gEnnarO
Dovendo parlare prima di Alessandro Guidi credo di poter dire che condividiamo l’idea che il panorama offerto sia stato maturo ed equilibrato, specialmente pensando che a diffe-renza delle relazioni su un singolo centro, questa considera un territorio immenso. Proprio per l’equilibrio e la maturità dimostrati penso che Teresa Marino avrebbe potuto inserire in questo quadro anche Bisenzo e Volsinii comprendendo così nell’analisi tutta l’Etruria meridionale. Vorrei subito ricordare, per completezza della bibliografia, Renato Peroni, che di questi discorsi è stato un protagonista importante, segnalando un suo intervento al convegno di Studi Etruschi di Vulci, del 1977, che introduce idee ancora insuperate (l’abbiamo da poco messo in rete https://www.academia.edu/5621020/Intervento_di_di-scussione_al_X_Convegno_di_Studi_Etruschi_e_italici_1975_). Un primo argomento, naturalmente sintetizzato da Teresa Marino, consente in certo senso un primo tentativo di risposta a Marcella Frangipane sull’interrogativo del “perché”. Naturalmente non ab-biamo risposte sicure: si è scritto molto, si è detto molto, su argomenti che riguardano il perché, ma naturalmente non padroneggiamo l’argomento. È però importante far notare che, grazie alle nuove scoperte e a contributi di vari studiosi, tra cui ne ricordo uno di Massimo Cardosa, negli ultimi decenni il quadro si è arricchito, suggerendo che non si passa, come ipotizzavo nell’82, da 70/100 insediamenti del Bronzo Finale ai 5 insediamenti protourbani, ma il fenomeno di riduzione è progressivo dalla piena età del Bronzo, anche se alla fine assume una netta accelerazione. Ecco, non ho capito bene se Teresa sostiene uno spopolamento dell’agro nel BF3. Il BF3 è un momento in cui già c’è stato un forte processo di concentrazione per cui molti insediamenti importanti sono stati abbandonati, quindi lo spopolamento dell’agro a favore dei grandi centri in formazione è veramente graduale nell’ambito del lungo processo di concentrazione dell’insediamento. Nel BF3 insediamenti importantissimi come Luni sul Mignone o Isola Farnese, che è stato citato, sono già abban-donati e invece ne sopravvive, per sparire al termine della fase, un numero ben minore di 100, forse non più di 50, come Sorgenti della Nova, Monte Cimino e Narce.Un altro argomento di discussione potrebbe essere sulla pluralità delle necropoli dei centri protourbani. Anche su questo si è scritto parecchio; ricordo che anche i villaggi dell’età del bronzo hanno nuclei sepolcrali distinti; probabilmente questo riflette un approccio omoge-neo, che possiamo dire “circolare”, al territorio circostante. Un ulteriore importante riferi-mento è quello dedicato all’intervento, molto forte e sicuramente provocatorio, di Peroni sul “villanoviano” come fenomeno avulso da un significato etnico; ricordo quanto questo intervento sia stato importante e stimolante nel sottolineare la capacità quasi esclusiva dei centri protourbani di dialogare ad un certo livello. Altro argomento è la “datazione del processo”. Ovviamente un processo non si data quindi parliamo dell’evento, quello che io chiamo – qui forse ufficialmente per la prima volta – “sinecismo di tipo romuleo”, dando nome a un concetto di Marco Pacciarelli, di cui un esempio chiarificatore è proprio quello del binomio Civita e Monterozzi a Tarquinia. E, come abbiamo già detto questa mattina, perché questo evento non può che porsi ancora nell’ambito del BF? Ripeto la mia opinione secondo cui le manifestazioni formali del Primo Ferro (quindi i materiali “villanoviani”) sono il prodotto del nuovo modo in cui la comu-nità si è organizzata, da cui consegue che i primi materiali, portati, prodotti e usati dalle famiglie che vanno a occupare i nuovi insediamenti, prima della ristrutturazione e entrata a regime del sistema di produzione, siano di tipo precedente.Un’osservazione riguarda il concetto secondo cui i maggiori fiumi erano utilizzati come vie di collegamento, che non considera che fiumi come Fiora o Marta sembrano essere stati sempre difficilmente navigabili. Ma ciò ci consente di riprendere il discorso dei due livelli
127Aspetti e fasi del processo formativo
della viabilità preromana, che secondo me (di gEnnarO 2000) sono: il primo, la rete che tocca tutti i piccoli insediamenti e il secondo quello che si forma con i centri protourbani. Non si può continuare a dire che insediamenti quali quelli protourbani nascono lungo le strade; sono le strade che formano la loro nuova rete tra i nuovi insediamenti. Naturalmen-te tra i grandi centri protourbani e il mare ci saranno stati sistemi di viabilità significativi in cui certamente, laddove possibile, la viabilità fluviale che conosciamo, era praticata.Infine una riflessione importantissima di Teresa Marino riguarda gli abitati del BF che esi-stono già sul luogo degli insediamenti protourbani. Si può non essere del tutto d’accordo sull’ipotesi che da qui sarebbe partita l’occupazione dei grandi pianori, che darebbe una risposta a Marcella Frangipane e a tutti noi. Il vero dilemma da risolvere è se questi centri, cito solo la Castellina della Civita per Tarquinia o il lobo su cui si era ridotta Cerveteri fino al secolo scorso, abbiano avuto un ruolo superiore rispetto a quello di una possibile estesa organizzazione delle comunità di villaggio che, come sappiamo, non è detto fosse di natu-ra pacifica. Gli abitati citati potrebbero essere insediamenti che hanno vinto la selezione perché avevano particolari potenzialità territoriali e agrarie, ma potrebbero anche essere anche stati scelti da un’organizzazione più ampia che riconduciamo al modello della lega.
F. di gEnnarO 2000, “Paesaggi di potere: l’Etruria meridionale in età protostorica”, in Paesaggi di potere. Problemi e prospettive, Atti del Seminario (Udine 1996), Quaderni di Eutopia 2, Roma, pp. 95-119.
a. guidi
Cercherò di essere veloce per quanto lo consente l’argomento. Io ho solo tre punti. Primo è il punto importante delle “proto-sepolture” all’interno di questi abitati. Ora, io vorrei ricordare una cosa, non condivido tutto quello che ha scritto Andrea Carandini, ma sicu-ramente c’è una cosa che lui per primo ha detto e che io penso sia molto importante, ossia di mettere in rilievo che in questi abitati protourbani c’è un’alternanza tra abitati, spazi sacri e sepolture e che questo prefigura dei veri e propri quartieri e cioè – io non la trovo una bestemmia – le curie della tradizione antica. Di questo del resto molti altri ne hanno parlato, Torelli (1987) ha parlato di curie riguardo all’area di Tarquinia oggetto degli scavi dell’Università di Milano... Anche io ho scritto un articolo in cui ho ipotizzato (e ancora ci credo), che le sepolture femminili in aree sacre siano le sepolture delle Vestali perché è la tradizione che lo dice per i tempi storici. In più voglio dire che un altro aspetto di queste sepolture in abitato, ad esempio il famoso uomo di Tarquinia decapitato secondo Mallegni (MallEgni, lippi 2008), secondo me è qualcosa che si sposa all’evidenza delle persone sacrificate dentro Roma al Mamertino o all’Equus Domitiani e aggiungo che io stesso a Oppeano ho scavato in una grande fossa di rifiuti un inumato, sepolto prono, con il segno di una ferita alla mandibola, qualcuno cioè che evidentemente aveva fatto qualcosa di sconveniente (guidi, saracinO 2010). Cosa significa questo? Significa che ci sono delle esecuzioni ed esecuzioni significano violazioni di legge, il che vuol dire che c’era un corpo di leggi in questi centri. Il secondo aspetto è quello molto importante dell’etnogenesi/pole-ogenesi. Io però rimango a questo concetto, secondo me l’etnicità è un prodotto culturale, è una conseguenza della complessità non il contrario; ma questo è più un argomento da discussione generale, immagino. Infine, e questo è l’unico appunto che posso fare a Teresa ed è una cosa molto semplice, lei inizialmente parla di una terza posizione tra orientalisti e occidentalisti in cui è importante l’apporto esterno, in realtà in tutto quello che ci ha raccontato l’apporto esterno non si vede proprio. Cioè, io rimango della mia idea e si può finalmente dire con voce alta e chiara, e questo dovrebbe essere il più grande risultato di questo simposio che Marco ha meritoriamente organizzato, che in questa formazione urbana i fenomeni sono soprattutto spontanei, autoctoni, non eccitati o incoraggiati dall’e-
128 Teresa Marino
sterno, eventualmente si può dire, come io credo, che nel momento famoso del passaggio alla fase urbana o poco dopo, tutto l’apparato ideologico del potere, questo sì, viene da fuori. Ma io faccio sempre questa comparazione, è come se uno dicesse che il capitalismo italiano, che sicuramente è nato in Italia, sia stato portato dagli americani. Se uno vedesse tutto ciò che abbiamo di capitalistico, è tutto americano: il computer, l’organizzazione, i vestiti eccetera, ma tutto ciò ci porterebbe a dire che il capitalismo italiano l’hanno portato gli americani? Non credo.
guidi a., saracinO M. 2010, “Indagini archeologiche presso l’area “ex Fornace” ad Oppe-ano (Verona): questioni aperte”, in f. candElatO, c. MOratEllO (a cura di), Archeologia, Storia, Tecnologia, Verona, pp. 41-58.MallEgni f., lippi b. 2008, “Considerazioni sugli inumati nell’area sacra dell’abitato di Tarquinia”, in ScAnt 14.2 (2007-2008), pp. 795–804.tOrElli M. 1987, “Appunti per una storia di Tarquinia”, in M. bOnghi jOvinO, c. chiara-MOntE trErè (a cura di), Tarquinia: ricerche, scavi e prospettive, Atti del Convegno (Milano 1986), Milano, pp. 120-140.
g. bartOlOni
Non sono d’accordo con la dott.ssa Marino nel vedere a Veio, a Campetti un piccolo abi-tato fortificato della fine dell’età del bronzo. L’area non ha nulla in comune con i centri di altura protovillanoviani, siano essi fortificati o no, ben esemplificati nell’area da Isola Farnese. Le fortificazioni più antiche si pongono proprio nel momento di passaggio tra il Bronzo finale e l’età del Ferro, in concomitanza e penserei proprio in funzione della nascita del centro protourbano. Secondo Francesca Boitani, Folco Biagi e Sara Neri, che hanno presentato i risultati di scavo all’Accademia Pontificia, era connotato forse da un valore rituale più che strategico. Su tutto il pianoro e a Piazza d’Armi si trovano materiali di foggia protovillanoviana, che assomigliano a quelli più antichi del Gran Carro di Bolsena. Potrebbero essere resti dei vasi che Francesco di Gennaro ha definito “della nonna” portati da fuori o materiali d’abitato dell’inizio dell’età del ferro, che noi non riconosciamo, perché la fase IA di Veio non è conosciuta nemmeno dalle necropoli veienti. Si potrebbero mettere in correlazione cronologica l’impianto delle fortificazioni e l’operato a Veio del defunto deposto a Piazza d’Armi nella fase IA, interpretato come protagonista nella storia veiente (“il fondatore”?), e sicuramente oggetto di venerazione fino all’avanzato VI secolo a.C. Comunque penso che l’avvio del processo urbano sul pianoro di Veio non avvenga prima del passaggio tra Bronzo Finale e Ferro, più probabilmente proprio all’inizio dell’età del ferro, come sostenuto di recente da Francesco di Gennaro e da me.
M. rEndEli
Intanto dico subito una cosa su queste sepolture nella città. A me sembrano tutte nate sa-cre, per cui quella “tricotomia” che Alessandro ha pensato diventa una dicotomia, cioè nel senso che la sepoltura è connessa con l’area sacra e fa sistema con l’area sacra, quindi crea già un’enclave speciale rispetto a quello che c’è. E nei vecchi ricordi di un tempo lontano, perché dovrebbe essere negli anni ‘97-‘99 quando scavammo quelle inumazioni a S. Anto-nio, quelle inumazioni avevano uno spazio riservato anche nel momento in cui edificarono i templi, perché vengono rispettate, e sono particolarmente vicine sia alla capanna ovale che a quella rettangolare che, l’una sopra all’altra, si trovano sotto il secondo tempio.
g. bartOlOni
E quindi sarebbero sacrifici umani.
129Aspetti e fasi del processo formativo
M. rEndEli
E quindi non so…Rita Vargiu ha fatto lo scavo e poi io sono andato via quindi non ne ho saputo più niente e non credo siano state ancora pubblicate.
g. bartOlOni
Sono addetti al culto. Ma perché gli addetti al culto non stanno nelle normali necropoli?
a. guidi
Perché stanno come le Vestali in aree sacre.
M. rEndEli
Non so se sono maschi o femmine.
g. bartOlOni
Sono femmine. Però io trovo i maschi, e allora cosa sono?
M. rEndEli
Volevo fare un’ultima annotazione, per cui mi alienerò la simpatia di molti. Rispetto al primo intervento che ho fatto ne consegue automaticamente che dal mio punto di vista non esiste nessuna differenza tra protourbano e urbano: se noi parliamo di un processo è un processo, non sono due o tre o quattro, non è “pre”, “proto”, prima, dopo, avanti. Se noi diamo una scansione e introduciamo, come per la ‘pre-colonizzazione’, anche il concetto di protourbano, noi diciamo che esiste sostanzialmente, anche se inconsciamente, un’analisi a posteriori per cui noi sappiamo che gli stadi di quel processo devono finire in una forma urbana e se invece probabilmente questo non avverrà? Se accettiamo il fatto che poi sono tutte esperienze diverse? Sono tutte esperienze che hanno anche i loro errori, che hanno una storia molto lunga che non è una storia di 20 o 30 anni? Quindi, quando inizia, si avvia un processo che porterà a una formazione di tipo urbano oppure no, perché magari si inaridisce prima. Però, se noi diciamo che sin dall’inizio esiste, per esempio, una dicotomia tra abitato e necropoli, chiara e netta, noi abbiamo già detto che quello non è un processo proto-urbano ma è un processo di tipo urbano. Poi dobbiamo capire come funziona al suo interno e su questo, mi si permetta una citazione, Massimo lo scriveva nel ’99 in quel libro sulla città di Donzelli per Atene. Cioè, Atene acquisisce molto tardi la sua conformazione di città che noi conosciamo, nel IX, nell’VIII e nel VII secolo l’immagine di Atene è com-pletamente diversa ma noi non definiamo l’Atene del IX secolo un centro protourbano.
g. sassatElli
Io volevo tornare su quest’ultima cosa. Sono d’accordo con Marco Rendeli che usare ter-mini diversi può essere pericoloso. Però questi termini diversi non incidono sulla unità del processo che è molto chiaro e coerente. Sono solo un modo per capire meglio, non per segmentare il processo e sezionarlo in partizioni troppo precise. L’alternativa a tutto questo è che ci mettiamo a discutere per così dire “filosoficamente” e sul piano teorico su che cos’è città e che cosa non lo sia. Prendiamo atto che si tratta di un processo unitario che comincia, si sviluppa e arriva a compimento in modo diversificato e variegato. Ma il processo è assolutamente coerente, unitario e molto chiaro. È una comodità terminologica, senza implicazioni di carattere ontologico o di “significato”, se così si può dire, perché di fatto la realtà e i processi storici a cui si fa riferimento con questi termini sono molto chiari e coerenti.
130 Teresa Marino
Tab. 1. Elenco dei complessi archeologici del BF e del PF riportati nelle carte di fase (Figg. 3-11)..
Tab. 2. Legenda delle carte di fase (Figg. 3-11).
131Aspetti e fasi del processo formativo
Fig. 1. Contesti insediativi esaminati dell’Etruria meridionale costiera (rielaborazione da caM-pOrEalE 2001).
132 Teresa Marino
Fig. 2. a. Veio: altura di Isola Farnese, pianori della Città di Veio (A. Campetti; B. Macchia-grande; C. Comunità) e di Piazza d’Armi; b. Cerveteri: pianoro (A. Rocca o Caere Vetus); c. Tarquinia: pianoro de La Civita (A. Pian di Civita; B. Pian della Regina; C. Castellina della Civita; D. Poggio Cretoncini) e colle dei Monterozzi (E. Castello di Corneto); d. Vulci: pianori di Pozzatella (A) e de La Città (B, di cui fanno parte: C. Acropoli e D. Piccola Acropoli) (base cartografica IGM 1:25.000).
a b
c
d
137Aspetti e fasi del processo formativo
Fig. 7. Tarquinia, Civita - Monterozzi: a. BF1-2; b. BF3.
a
b
139Aspetti e fasi del processo formativo
Fig. 9. a. Tarquinia, Civita - Monterozzi, PF2 avanzato; b. Tarquinia, area costiera delle Saline, PF.
a
b