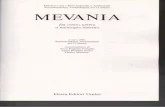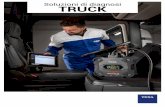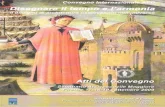Il monachesimo cistercense nella marittima medievale: soluzioni architettoniche
Nuovi dati dal santuario umbro di Villa Fidelia. Fasi preromane e soluzioni architettoniche
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Nuovi dati dal santuario umbro di Villa Fidelia. Fasi preromane e soluzioni architettoniche
SERGIO OCCHILUPO
NUOVI DATI DAL SANTUARIO UMBRO DI VILLA FIDELIA
FASI PREROMANE E SOLUZIONI ARCHITETTONICHE
Estratto da
BOLLETTINO STORICO DELLA CITTÀ DI FOLIGNOXXXV-XXXVI
(2012-2013)
FOLIGNO 2014
SOMMARIO
MARIO SENSI, Una contrastata impresa di Giacomo Trinci abatedi Sassovivo (1412-1440) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1
VERUSKA PICCHIARELLI, La pittura del tardo Medioevo nelle chiesedell’antica diocesi di Foligno. Esiti di un catalogo ragionato . . . . . . » 23
ADRIANO TINI BRUNOZZI, L’arme di Spello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 77VLADIMIRO CRUCIANI, La chiesa di San Salvatore a Foligno. I restauri
del 1971-1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 95
L’ORATORIO DEL CROCIFISSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 117
CONTI, METELLI, COLOMBATTI
III – ANNA CONTI, Oratorio del Crocifisso. Recupero delle superfici decorate, modellate in stucco, opere lignee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 119III – GABRIELE METELLI, Gli affreschi di Giovan Battista Michelini » 139III – FRANCESCO COLOMBATTI, L’intervento strutturale . . . . . . . . . . . . . . » 151
ELENA LAURETI, Una storia a latere della nostra Accademia Fulginia » 157PIERO LAI, Ritratto dell’Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 187ERICA BACIOCCHI, La rosa dell’Umbria di Giuseppe Bragazzi . . . . . . . . » 197DANTE CESARINI, Per la storia dell’idea di parrocchia nella Diocesi
di Foligno tra Ottocento e Novecento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 219
OMAGGIO A DOMENICO MUSTAFÀNEL PRIMO CENTENARIO DELLA MORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 231
BRUMANA, BUONOCORE, LUCIANI, MENGHINI
III – BIANCA MARIA BRUMANA, Domenico Mustafà e la tradizione dei cantanti evirati in Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 233
II SOMMARIO
II – MARCO BUONOCORE, La Biblioteca Vaticana e i suoi Fondi manoscritti d’interesse musicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 237 III – LUCIANO LUCIANI, Domenico Mustafà. Omaggio ad un can- tore sistino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 245 IV – MAURA MENGHINI, Domenico Mustafà. Aspetti biografici a cento anni dalla morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 257
SCHEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 265
SERGIO OCCHILUPO, Nuovi dati dal santuario umbro di Villa Fide-lia. Fasi preromane e soluzioni architettoniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 267
LUIGI SENSI, Hispellatia Valentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 291ROMANO CORDELLA, I graffiti di S. Claudio a Spello . . . . . . . . . . . . . . . . . » 299SILVESTRO NESSI, Gentile da Fabriano a Foligno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 313ARNALDO PICUTI, Dalla Cronaca malatestiana di Gaspare Broglio
Tartaglia. La strage di Nocera del 1421. La vendetta dei Trinci . . . . » 321MARIO SENSI, Il supplementum alla Pisanella di Nicola da Osimo
(† 1454 ca.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 325EMANUELA CECCONELLI, L’Incoronazione della Vergine di Pieran-
tonio Mezzastris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 337WALTER BALDUCCI, Palazzo Gentili Spinola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 343BRUNO MARINELLI, Una travagliata vicenda architettonica. La ristrut-
turazione settecentesca della chiesa di San Nicolò in Foligno . . . » 357FRANCO IVAN NUCCIARELLI, NICOLAS TINI BRUNOZZI, Una Immaco-
lata Concezione di Liborio Concetti quasi sconosciuta . . . . . . . . . . . » 367BRUNO MARINELLI, Per un catalogo del pittore Enrico Bartolomei.
(Foligno 1815 - Roma 1901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 375ROLANDO DOMINICI, La Madonna della Stella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 381ANNA MARIA MENICHELLI, La piazza di Foligno in un disegno di
Edmond du Sommerard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 385SERGIO ANDREOLI, Schede Bibliografiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 393CARLO ROBERTO PETRINI, Giovanni Bosi: Foligno, una stagione.
La città tra Ottocento e Novecento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 395
RICORDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 399
PIERLUIGI CASTELLANI, Un politico anomalo, un legislatore vero . . . » 401BENEDETTA BIONDI, Piero Cudini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 413DARIO ANTISERI, MARIO TIMIO, Fausto Bonora e il nuovo approccio
alla storia della medicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 417
IIISOMMARIO
MARIO SENSI, Mario Martini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 421SIRIO BALDACCINI, Feliciano Baldaccini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 427FABIO BETTONI, Feliciano Baldaccini archivista, bibiotecario e con-
servatore museale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 433LUIGI SENSI, Mario Brozzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 445MARIO SENSI, Sua Ecc. Bruno Fabi, magistrato di Cassazione . . . . . . . » 449MAURIZIO BUSSO, Un ricordo di Paolo Maffei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 457NICOLETTA NATALUCCI, L’avvocato Giuseppe Galligari . . . . . . . . . . . . . . » 461LUIGI SENSI, Leopoldo del Carpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 465ARNALDO PICUTI, Guglielmo Gorni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 467ELVIO LUNGHI, Pietro Scarpellini Pancrazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 475MARIO TIMIO, La famiglia Messini a Foligno: il medico, il prete, il
farmacista. Mariano Messini: principe della terapia medica e delleacque termali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 479
ANTON CARLO PONTI, Sergio Marini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 491GIOVANNI BOSI, Nazzareno Mancini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 495MARIO SENSI, Monsignor Arduino Bertoldo, vescovo di Foligno . . . » 499
Errata corrige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 507
Elenco dei Soci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 511
SERGIO OCCHILUPO
NUOVI DATI DAL SANTUARIO UMBRO DI VILLA FIDELIA
FASI PREROMANE E SOLUZIONI ARCHITETTONICHE*
Tra il 2007 e il 2009 si sono svolte due campagne di scavo sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Um-bria in seguito agli interventi straordinari di consolidamento e ristruttu-razione dei due muri di terrazzamento che delimitano il “Giardino all’i-taliana” della Villa Fidelia di Spello, nell’ambito dei Progetti PRUSST coordinati dalla Provincia di Perugia1. Si presentano, in questa sede, in
* Le opere di intervento sono rientrate nei Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) promossi dal Ministero dei Lavori Pubblici. La direzione scientifica degli scavi, condotti da chi scrive, è stata affidata alla dott.ssa M.L. Manca, funzionario archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria, che qui ringrazio per la disponibilità a ren-dere noti i risultati delle indagini.
1 Per una bibliografia essenziale sull’area del santuario umbro di Villa Fidelia, si vedano: L. SENSI, Spello, Casa Silvi, in AA.VV., Ville e insediamenti rustici di età romana in Umbria, Perugia 1983, p. 110; M. SENSI - L. SENSI, Fragmenta Hispellatis historiae. 1. Istoria della terra di Spello, di Fausto Gentile Donnola, in BSFoligno VIII, 1984, pp. 7-136; D. MANCONI, s.v. Spello, in EAA suppl. II, 1971-1994, pp. 355-356; D. MANCONI - P. CAMERIERI - V. CRUCIANI, Hispellum: pianificazione urbana e territoriale, in G. BONAMENTE - F. COARELLI (a cura di), Assisi e gli Umbri nell’antichità (Atti Assisi 1991), Assisi 1997, pp. 375-429; L. SENSI, Il teatro ro-mano di Hispellum, in BSFoligno XXIII-XIV, pp. 136-137; F. COARELLI, Il re-scritto di Spello e il santuario etnico degli Umbri, in Umbria cristiana. Dalla dif-fusione del culto al culto dei santi. Secoli IV-X (Atti Spoleto 2000), Spoleto, pp. 39-51; L. BAIOLINI, La forma urbana dell’antica Spello, in Città dell’Umbria, Roma, pp. 61-120; P. BONACCI - S. GUIDUCCI, Hispellum. La città e il territorio, Spello 2009, pp. 169-176; P. CAMERIERI - D. MANCONI, Le centuriazioni della Valle Umbra da Spoleto a Perugia, in Bollettino di Archeologia On Line I (Atti Roma 2008), 2010, pp. 31-37; P. CAMERIERI - D. MANCONI, La pertica della colonia latina di Spoletium nel quadro dei nuovi studi sulle centuriazioni della Valle Umbra, in Agri Centuriati 7 (Atti Borgoriccio - Lugo 2009), pp. 263-273; S. SISANI, I rapporti tra Mevania e Hispellum nel quadro del paesaggio sacro della Valle Umbra, in Annali della Fondazione per il «Museo Faina» XIX, 2012, pp. 423 ss.
268 SERGIO OCCHILUPO
sintesi i risultati delle indagini scientifiche effettuate in occasione dei due interventi di scavo, anche se limitati nella loro estensione e condotti in base alle esigenze di cantiere, soprattutto per mettere ordine, in un certo senso, alle numerose ipotesi ricostruttive dei resti del santuario antico, in particolare delle terrazze monumentali e dei loro accessi, basate spesso su interpretazioni prive di riscontri. A questo stato di incertezza hanno certamente contribuito le lacune sulle indagini, sempre molto limitate ed estemporanee, che si sono succedute nell’area della Villa e del teatro romano antistante. Le parziali pubblicazioni di reperti e di saggi di sca-vo ad oggi non permettono di avere una visione complessiva delle emer-genze archeologiche e della loro scansione cronologica2, per cui questo contributo vuole solo aggiungere un altro tassello alla ricostruzione della complessa struttura architettonica su cui si è impiantata la villa rinasci-mentale della famiglia Urbani.
L’intervento del gennaio-marzo 2007 ha riguardato la porzione meridio-nale del terzo muro di terrazzamento della villa3, nel punto in cui si col-lega con il convento delle Suore Missionarie d’Egitto (figg. 1 e 10, A). Lo scavo è stato condotto in un’area molto ristretta allo scopo di individuare eventuali emergenze e stratigrafie antiche relative alla fase di frequentazione del santuario e con l’intento di verificare l’esistenza o meno di un ingresso al sacello antico lungo il lato settentrionale del convento4.
Il secondo intervento del giugno 2009 è stato effettuato sul secondo muro di terrazzamento in corrispondenza di un’apertura già interpretata in
2 Ad oggi non si conoscono ad esempio i materiali venuti alla luce dalle in-dagini effettuate nell’area a S-W del teatro, nello stesso contesto di scavo da cui proviene l’arula con dedica a “Giovepadre” (v. più avanti), come il bronzetto votivo di V-IV sec. a.C. e le terrecotte architettoniche di II-I sec. a.C., quest’ultime più volte citate (M.J. STRAZZULLA, Le produzioni dal IV al I sec. a.C., in A. GIARDINA - A. SCHIAVONE (a cura di), Società romana e produzione schiavistica, II. Merci, mer-cati e scambi nel Mediterraneo, Bari 1981, p. 203; A. COMELLA, Le terrecotte archi-tettoniche del Santuario dello Scasato a Falerii, Perugia 1993, pp. 66-67, nota 114; MANCONI - CAMERIERI - CRUCIANI, Hispellum, cit., p. 389, nota 49 e p. 391, nota 54, e S. SISANI, Fenomenologia della conquista. La romanizzazione dell’Umbria tra il IV sec. a.C. e la guerra sociale, Roma 2007, pp. 178 s.), mentre per quanto riguar-da le ricerche compiute dalla Soprintendenza nella zona retrostante il “sacello di Venere” si veda ora P. CAMERIERI - D. MANCONI, Spello, Villa Fidelia: il santuario, in Bollettino per i beni culturali dell’Umbria 5, 2012, pp. 293-294, dove il rinve-nimento di una sepoltura d’infante ad enchytrismòs è forse da collegare alla fase tardo-imperiale di ristrutturazione del santuario.
3 La numerazione dei muri di terrazzamento, come delle terrazze, parte dalla zona inferiore del santuario verso quella superiore.
4 L’esistenza di un accesso o comunque di un collegamento con la terrazza infe-riore è supposto in MANCONI-CAMERIERI-CRUCIANI, Hispellum, cit., p. 387, tav. IV: 1 (ipotesi ricostruttiva del “sacello di Venere”), mentre più di recente in CAMERIERI - MANCONI, La pertica, cit., p. 269, fig. 3, si presenta una nuova ricostruzione con un’ingresso dal lato Sud.
269NUOVI DATI DAL SANTUARIO UMBRO DI VILLA FIDELIA
letteratura come uno stretto passaggio per l’accesso alla terrazza superiore5 (figg. 1 e 10, B). È stato quindi realizzato uno scavo degli strati di terra relativi al “Giardino all’italiana” che proprio intorno a questa apertura ten-devano a precipitare verso la terrazza sottostante rendendo inagibile l’area.
TERZO MURO DI TERRAZZAMENTO DEL SANTUARIO
Lo scavo ha interessato il muro di terrazzamento per una lunghezza di circa m. 23 a partire dal convento che, come è noto, si posiziona sui resti del tempietto dedicato a Venere nella cui cella, decorata da un pavimen-to a mosaico, fu ritrovata l’iscrizione dedicatoria dei duoviri quinquennali Marcus Granius e Sextus Lollius e parti di una statua di culto6 (figg. 1-2).
Nei pressi dell’ingresso originario alla villa degli Urbani (come detto ora sede del convento delle Suore Missionarie d’Egitto) sono state indi-viduate due fasi di pavimentazione in laterizio, attribuibili probabilmente alle ultime ristrutturazioni del complesso signorile tra il XVIII e il XIX secolo: un primo pavimento (m. 3 x 2,40 ca.) composto da mattoni con trama regolare posti sopra un massetto di malta e in relazione con tre sca-lini, sempre in mattoni, che garantivano l’accesso alla villa da nord, e un secondo pavimento (m. 1,90 x 1,80 ca.), più antico e in pessimo stato di conservazione, realizzato da laterizi e blocchetti di pietre posti a spina di pesce con croce centrale (fig. 3).
In questo punto lo scavo in profondità lungo il lato interno del terraz-zamento rinascimentale della villa (figg. 4-5) ha messo in luce una strut-tura muraria, orientata NNW/SSE, composta da scapoli di pietra calcarea di piccole dimensioni legati da malta cementizia. La struttura (figg. 6-7), completamente obliterata dal prospetto settecentesco sulla facciata “a vista’, mentre su quella interna è realizzata non in cassaforma, ma “contro-terra’, è riferibile al muro di terrazzamento del santuario antico di cui sono visi-bili altri resti nella parte opposta del complesso architettonico nei pressi del “Casino di Villeggiatura”7. Il muro si è conservato per una lunghezza
5 MANCONI - CAMERIERI - CRUCIANI, Hispellum, cit., pp. 384 sgg.: struttura dei terrazzamenti (tav. IV: 4); CAMERIERI - MANCONI, Le centuriazioni, cit., p. 36, fig. 15, dove si riporta ancora un accesso alla terrazza con una rampa laterale al muro.
6 Sulle due fasi costruttive del tempietto succedutesi tra l’età triumvirale e la prima età augustea si vedano da ultimi: CAMERIERI - MANCONI, Le centuriazioni, cit., pp. 31 ss. Sull’iscrizione (CIL XI, 5264) su lastra lapidea ormai perduta, ma di cui si conserva una riproduzione grafica di Vincenzo Tranquilli che alla fine del ’500 la vide “nel orto delli Baglione in Porta San Pietro” a Perugia, si veda S. STOPPONI, Da Orvieto a Perugia: alcuni itinerari culturali, in Annali della Fondazione per il «Museo Faina» IX, pp. 249 sg., fig. 18; Bonacci-Guiducci, Hispellum, cit., p. 173.
7 La struttura è riportata nel rilievo pubblicato in MANCONI - CAMERIERI - CRUCIANI, Hispellum, cit., tav. IV: 1, nei pressi dell’angolo S/E dell’edificio, tutta-via in quella sede si parla solo dell’esistenza nel santuario di due muri di terraz-
270 SERGIO OCCHILUPO
di circa 15 metri e presenta una serie di fori quadrangolari per il drenag-gio delle acque a circa 60/70 cm dal piano di campagna attuale, mentre i caratteristici rigonfiamenti, posti a distanza più o meno regolare, ricondu-cibili molto probabilmente alle diverse fasi di cantiere, attribuiscono alla struttura un solido ancoraggio al pendio retrostante. Sono attestate almeno due fasi realizzative di cui quella inferiore, di fattura più accurata e visibile a partire da quota m –1,60, molto probabilmente è da mettere in relazione con la monumentalizzazione del santuario tra l’età triumvirale e la prima età augustea (30-20 a.C.), mentre la parte superiore, caratterizzata da scapoli di pietra più grandi con minor presenza di malta, potrebbe testimoniare una fase di ristrutturazione di età tardo-imperiale, cioè quella costantiniana, di cui restano lacerti di muri nell’area retrostante il convento e al disotto della Chiesa di S. Fedele, nella parte N/W del santuario8.
La struttura si inseriva senza soluzione di continuità tra la cella e il pro-nao del tempietto (cosiddetto “sacello di Venere”) a sostegno di un terzo terrazzamento del santuario (fig. 4), venendo così a confermare quanto già detto dall’erudito spellano Fausto Gentile Donnola nella sua Historia di Spello dei primi decenni del “600: “E dove è detta Fidelia erano tre muri, come hoggi ancora se vedono in parte, uno sopra l’altro; e sopra quelli era et è un notabile spatio de terra...”9. La sua posizione esclude che in antico, o almeno nella fase di sistemazione scenografica delle terrazze, ci fosse, lungo questo lato del tempietto e alla base del podio del pronao, una scalinata o un’altra struttura relativa ad un passaggio dalla zona sottostante verso la terrazza superiore. Quest’ultimo va ricercato altrove nell’area meridionale della terrazza o, più probabilmente, verso Nord dove dalle recenti indagini è emersa una netta interruzione del muro in cementizio a circa 15 m dal limite del convento (fig. 5)10. L’ipotesi di un accesso da nord, laterale al
zamento, nonostante ne sia stato supposto un terzo proprio in corrispondenza di questo muro; si veda a proposito: S. SISANI, Umbria Marche (Guide Archeologiche Laterza), Roma-Bari 2006, p. 113; BONACCI-GUIDUCCI, Hispellum, cit., p. 173, fig. 288. Nelle successive pubblicazioni si dà per acquisito il dato della presenza del terzo terrazzamento anche se l’unica parte visibile, di appena m 1,25, si trova posizio-nata nella zona opposta al “sacello di Venere’.
8 MANCONI - CAMERIERI - CRUCIANI, Hispellum, cit., pp. 387-388 e p. 391, nota 56. L’edificio è stato identificato con il tempio dedicato alla gens Flavia menzionato nel Rescritto, vedi a proposito COARELLI, Il rescritto, cit., p. 46. A questi resti sono da aggiungere ora le strutture retrostanti il “sacello di Venere” e la tomba di cui alla nota 2. È da ricordare che dall’area della chiesa di S. Fedele proviene il Rescritto di Spello, forse reimpiegato come lastra di copertura di una tomba nell’area cimiteria-le antistante, di pertinenza nel XVIII sec. della Compagnia della Morte: L. SENSI, Sul luogo di ritrovamento del rescritto costantiniano di Spello, in Atti della Accademia Romanistica Costantiniana, XII Conv. Int. in onore di Manlio Sargenti, Napoli 1999, pp. 468 s.
9 SENSI-SENSI, Fragmenta Hispellatis, cit., p. 101.10 In questo punto il muro rinascimentale si collega direttamente alla fase più
antica sottostante a quota m –1,60, formando una sorta di “setto” molto irrego-
271NUOVI DATI DAL SANTUARIO UMBRO DI VILLA FIDELIA
tempio di Venere, sembra possa essere avvalorato anche dalla presenza di resti di opere murarie a circa m 4,5, di cui si intravedono solo le fonda-zioni relative ad un pilastro o ad una base di colonna (portico/propileo?) (ricostruzione a fig. 10, 2-3).
Lo scavo stratigrafico dell’area adiacente al muro, sebbene molto ri-stretta (circa m 1,50 di larghezza) e disturbata dalla presenza dell’apparato radicale dei vicini cipressi, ha successivamente permesso l’individuazione di più livelli di frequentazione al disotto di uno strato di crollo, con tegole e coppi, riferibile alla copertura del tempietto (figg. 4-5, A-C). La succes-sione stratigrafica prova l’intensa occupazione in questo punto del pendio già a partire dall’età preromana, in significativo collegamento con la zona a valle del santuario, nell’area del teatro, dove in seguito ad un intervento d’urgenza da parte della Soprintendenza furono rinvenuti, tra gli altri, un frammento di bronzetto schematico di V-IV sec. a.C., un’arula in arenaria con dedica in umbro a “Giovepadre” della fine del IV-III sec. a.C. e ter-recotte architettoniche di II-I sec. a.C. (fig. 2, 4)11.
Dallo scavo è stato possibile quindi individuare in sequenza questi li-velli di frequentazione:
– un crollo di tegole nell’area Sud vicino al convento riferibile alla copertura del tempietto12;
– un piano di frequentazione databile in età tardo-repubblicana (figg. 4-5, A), dove sono stati recuperati frammenti di antefisse, di cui una a testa silenica, con nimbo a foglie di forma triangolare con due sol-cature centrali e nervature laterali databili al II sec. a.C. (fig. 8)13;
lare. Proprio per questo motivo il muro di terrazzamento ha subìto i maggiori danni strutturali in quanto le diverse caratteristiche tecniche dei due muri (opera cementizia con scapoli di calcare legati da malta per il muro romano e blocchetti di calcare in assise regolari per il muro settecentesco) hanno reagito in maniera diversa alle pressioni del terreno soprastante. È probabile che il muro antico in questo punto si interrompesse per lasciare spazio ad un’apertura (v. fig. 9, freccia).
11 V. nota 2. MANCONI - CAMERIERI - CRUCIANI, Hispellum, cit., pp. 389 e 391, nota 54 (scavo del 1990). Per la basetta inscritta: D. MANCONI, Due capisaldi della Valle Umbra: Spello e Spoleto, in P. FONTAINE (a cura di), L’Étrurie et l’Ombrie avant Rome. Cité et territoire, (Atti Louvain 2004), Bruxelles - Roma 2010, pp. 209-210, figg. 23-24; D. MANCONI - A. CALDERINI, in SCREHTO EST. Lingua e scrittura degli antichi Umbri, Catalogo della mostra, Perugia-Gubbio 22 sett. 2011 – 8 gen. 2012, Perugia 2011, pp. 35-37, n. 27; SISANI, I rapporti, cit., p. 424.
12 Si tratta del primo strato riferibile ad epoca romana in cui però non sono stati trovati elementi datanti. È molto probabile che si possa collegare alla fase di rifacimento del tempietto di età triumvirale.
13 Sono stati recuperati un frammento di nimbo (inv. n. 677724 - H cm 9, largh. max cm 7, prof. cm 5,5) e un’antefissa mancante solo del coppo posteriore (inv. n. 677725). Quest’ultima (H cm 12,2, largh. max cm 16,5, prof. cm 8) è stata oggetto di una ripulitura sulla faccia anteriore da parte di G. Germini del Laboratorio di Restauro della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria. Caratteristiche: argilla arancio tendente al rosato in frattura, marrone-rosato in superficie, poco
272 SERGIO OCCHILUPO
– un livello precedente databile, in base ai materiali ceramici (ceramica sovradipinta e vernice nera)14, tra il IV e il III sec. a.C. (figg. 4-5, B);
– alcune tracce di frequentazione di un età ancora più antica, tra VI e V sec. a.C., nella zona nord dello scavo caratterizzato dalla presenza di buche e fosse caratterizzate da scarso materiale ceramico (figg. 4-5, C)15.
In particolare, nel livello di frequentazione di età ellenistica (IV-III sec. a.C.), costituito da un battuto di terra con grumi argillosi pressati e scaglie di calcare sulla superficie disposte in alcuni punti a formare una sorta di selciato (fig. 9), è da riconoscere molto probabilmente un’area scoperta nei pressi di un luogo di culto, forse monumentalizzato nel corso del II sec. a.C. (antefissa a testa di Sileno), ma che fu modificato in seguito dal sistema a terrazze16.
Tuttavia, allo stato attuale non è dato sapere se quello di Venere fosse il solo luogo di culto in questa zona del santuario o se ci fossero altri sacelli o altari dedicati a divinità diverse, anche se la presenza di strati di crollo con frammenti di tegole e pietre varie individuate a circa 20 metri di distan-
depurata con numerosi inclusi calcarei di varie dimensioni; tracce di colore bruno sul nimbo e sui capelli; matrice consunta con poca resa dei particolari del volto e orecchio sinistro non ben visibile; testa con leggera torsione verso sinistra; fron-te rilevata, sopracciglia, zigomi e guance sporgenti; occhi infossati; naso piegato verso sinistra; labbra serrate; capelli appena distinguibili ai lati e ciuffo centrale sporgente sopra la fronte diviso al centro; barba folta a ciocche leggermente on-dulate; nimbo composto da palmetta a 9 foglie, di cui non si conserva la prima di destra in basso, realizzate in modo schematico di forma triangolare con due sol-cature centrali parallele affiancate da piccole nervature oblique. Sul tipo: S. STOP- PONI (a cura di), Museo Comunale di Bettona. Raccolta archeologica, Città di Castello 2006, pp. 232 s. Il nostro tipo di antefissa sembra mancare di confronti strin-genti per cui risulta essere un’elaborazione intermedia tra il modello con foglie d’acanto semplificate ma ancora di tipo naturalistico (ad es. quello di dimensioni minori del tempio di S. Faustino di Perugia della fine del III sec. a.C.) e le sue più dirette emanazioni (Arna, Gubbio e Terni) di probabile produzione perugina e il modello di pieno II sec. a.C. in cui il nimbo è più standardizzato con foglie di forma triangolare con solcature parallele di produzione aretina, per cui si veda A. RASTRELLI, Santuari suburbani e di campagna nell’agro chiusino, in La coroplastica templare etrusca tra il IV e il II sec. a.C., Atti del XVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Orbetello 1988), Firenze 1992, pp. 311 ss.
14 Lo strato ha restituito, tra gli altri, alcuni frammenti di bucchero, una parete di skyphos a decorazione floreale, frammenti di coppe a vernice nera tipi Morel 2237, 2784 e 2827 e coppe di bucchero grigio ad orlo rientrante.
15 Si tratta di pareti di olle in ceramica grezza. Da tenere presente però che nel luogo è attestata una frequentazione almeno dagli inizi dell’età del Ferro (IX sec. a.C. ca.) come testimonia il rinvenimento di una parete di olla in ceramica d’impasto decorata con cordone ad impressioni digitali.
16 Per ora sono documentate solo le due fasi del “sacello di Venere” riferibi-li all’età triumvirale e a quella augustea (CAMERIERI - MANCONI, Le centuriazioni, cit.), mentre non si conoscono altre strutture più antiche cui riferire le antefisse di II sec. a.C.
273NUOVI DATI DAL SANTUARIO UMBRO DI VILLA FIDELIA
za verso nord potrebbero essere indizio di altre strutture santuariali, forse situate nell’area centrale del terrazzamento superiore (fig. 10, nn. 4 e 8). Le ultime ipotesi sulla presenza di altri templi nel santuario, oltre al tem-pio gemello a quello di Venere posizionabile in corrispondenza del “Casino di Villeggiatura”, ad esempio quello dedicato a Iuppiter, si sono concen-trate invece sul primo terrazzamento in basso attribuendo a quest’area i materiali dello scavo effettuato nei pressi del teatro17. Alla luce dei recenti rinvenimenti e in attesa della pubblicazione dello scavo del 199018, non si può escludere però che nella zona in epoca preromana fossero presenti più luoghi di culto, sia lungo l’arteria di collegamento con gli altri centri umbri sia lungo il pendio in continuità con il santuario d’altura principale del Monte Subasio, e che in epoca romana si sia voluto risistemare l’area inglobando i culti nello scenario del santuario a terrazze rivitalizzandoli in funzione propagandistica augustea.
SECONDO MURO DI TERRAZZAMENTO DEL SANTUARIO
L’area di intervento corrisponde, come detto, ad un’apertura nel mu-ro cementizio del santuario antico tra il secondo e il terzo terrazzamento, interpretata come uno stretto passaggio che poteva permettere di raggiun-gere, nella porzione destra del santuario, la parte alta gravitante intorno al tempietto di Venere (fig. 1 e 10, B)19.
All’inizio dello scavo, l’apertura si presentava con una tamponatura in blocchetti di pietre costruita a più riprese, forse già al momento della si-stemazione rinascimentale della villa, che nella parte superiore aveva ormai perso la sua originaria funzione provocando così, nel corso del tempo, un riversamento degli strati di terra dalla terrazza superiore a quella inferiore (fig. 12). Si erano quindi rese inagibili sia l’area soprastante sia l’area sot-tostante per la continua caduta di materiale.
Lo scavo, per ovvi motivi di sicurezza, è stato condotto inizialmente nel-la parte superiore lungo il muro settecentesco (saggio di ca. m 6,5 x 2,5), evitando il più possibile qualsiasi alterazione del “Giardino all’italiana”: la presenza delle siepi di bosso infatti non ha permesso un’estensione mag-giore dello scavo che sarebbe stato comunque necessario per il notevole salto di quota. Quindi si è provveduto successivamente allo scavo dell’a-pertura sottostante.
17 Sulla presenza di strutture in cementizio a monte dei terrazzamenti, quasi al centro della terrazza superiore: MANCONI - CAMERIERI - CRUCIANI, Hispellum, cit., p. 388, Tav. IV: 6; mentre sulla eventuale presenza del tempio di Iuppiter sulla prima terrazza in basso: SISANI, I rapporti, cit., p. 437.
18 Vedi nota 2.19 Così è interpretato ancora recentemente: CAMERIERI - MANCONI, Le centuria-
zioni, cit., p. 36, fig. 15.
274 SERGIO OCCHILUPO
Nella terrazza superiore la fondazione del muro della villa è stata individuata a circa m 2 dal piano del giardino (fig. 11). Questa si in-seriva direttamente sull’alzato del muro cementizio di epoca romana, mentre il piano del giardino rinascimentale era stato raggiunto livellan-do l’area con terra di riporto e ricoprendo definitivamente gli antichi strati di frequentazione che in questa indagine non è stato possibile esplorare. L’apertura nel cementizio era stata quindi tamponata da un notevole accumulo di pietre di varie dimensioni (“vespaio”) a circa m 3/3,50 dal livello del giardino.
Nella terrazza inferiore l’apertura, una volta ripulita dal materiale di crollo, si presentava come una nicchia/esedra ad arco di circa m 2,50 di base e m 4 di altezza nella parte centrale, con una piccola apertura nella parte alta, spostata verso destra e in comunicazione con la terrazza supe-riore (fig. 13). Lungo l’intradosso è ancora chiaramente visibile l’impronta dell’arco montato prima della messa in opera del cementizio, composto mol-to probabilmente da blocchi in travertino (dimensioni: cm 56 x 45 x 38; rispettivamente circa 5/3, 1/2 e 1/3 di piede romano), ormai completamen-te espoliati, molto simili agli archi di rivestimento delle mura urbiche della Hispellum romana20. Lo stesso muro cementizio conserva ancora nella zona destra dell’apertura il suo paramento antico in opus vittatum realizzato in blocchetti di calcare rosa (“lapis hispellatis”) per almeno 6 filari21, che si è verificato proseguire anche all’interno dell’esedra una volta che si è proceduto allo scavo degli strati di accumulo (figg. 14-15). La parte inferiore dell’esedra è occupata da una vasca quadrangolare (m 1,76 x 1,10) con pavimentazione in cocciopesto, spallette “a bauletto” ai lati e intonaco idraulico alle pareti. Il manufatto si presenta in discrete condizioni con alcune crepe nella parte destra dovute alla frattura dell’intera struttura cementizia, che però non pro-voca problemi di staticità, e con la parte anteriore espoliata. L’assenza di un qualsiasi elemento a chiusura della vasca non ci permette al momento di sta-bilire se in origine fosse destinata semplicemente alla raccolta d’acqua (vasca o catino di raccolta) o se invece funzionasse come fontana. La realizzazione di un’opera così complessa, cioè di un’esedra monumentale con vasca in cocciopesto e apertura nella parte superiore, lascia propendere verso questa seconda ipotesi, ma con molti interrogativi circa l’approvvigionamento idrico, il suo scarico verso valle e il collegamento con altre strutture simili colloca-te lungo i terrazzamenti del santuario. Le indagini effettuate in profondità sugli strati adiacenti al muro cementizio e prospicienti l’esedra non hanno tuttavia restituito elementi utili alla risoluzione del problema per l’intensa
20 Si veda in particolare l’arco e i piedritti della Porta Ventura. 21 Le dimensioni dei blocchetti (largh. cm 15/18; lungh. cm 10/22) sono sostan-
zialmente divergenti da quelle del paramento delle mura urbiche (largh. cm 15/30; lungh. cm 3/50).
275NUOVI DATI DAL SANTUARIO UMBRO DI VILLA FIDELIA
opera di sistemazione del giardino della villa22. A circa m –0,60 dal piano di campagna è stato possibile comunque isolare un piano di frequentazione antico in piccole scaglie calcaree e terreno compatto a copertura della fos-sa di fondazione del muro cementizio. Quest’ultima si presentava riempita quasi esclusivamente da argilla molto plastica, di colore grigio-verdognolo, con rari inclusi di grumi carboniosi, schegge di pietra calcarea e assenza di materiale ceramico. L’impiego dell’argilla lungo tutta la base del muro si può spiegare con le proprietà fisico-chimiche di questo sedimento, usato nell’antichità per l’elevata capacità di assorbimento d’acqua e per le speci-fiche proprietà plastiche, in questo caso utilizzate per attutire le eventuali dilatazioni e restringimenti della struttura muraria a seguito delle escursioni termiche e delle altre eventuali sollecitazioni meccaniche.
Dai dati raccolti, quindi, resta appurato che l’apertura oggetto di in-dagine non è dotata di alcun accesso alla terrazza superiore, così come era stato ipotizzato, ma è il risultato di una sistemazione prospettica della facciata del terrazzamento, cioè un’esedra monumentale con vasca o fon-tana per le abluzioni o per le esigenze cultuali, da collegare molto proba-bilmente all’altra apertura presente sul lato opposto al disotto del “Casino di Villeggiatura’ e alla grande esedra centrale del primo muro di terrazza-mento (fig. 10, nn. 5 e 7)23. La facciata dei terrazzamenti, alla luce della struttura dell’esedra caratterizzata dal significativo spostamento dell’aper-tura superiore verso il lato destro da cui possiamo supporre fuoriuscisse acqua, assume così una forte connotazione prospettica in rapporto agli assi visuali che accompagnavano i frequentatori del santuario durante l’ascesa24. L’acqua quindi sembra essere un elemento caratterizzante non solo per le esigenze cultuali, ma anche sotto il profilo simbolico. Si tenga presente in-fatti che nell’area a monte del santuario ben due cisterne erano destinate a rifornire di acqua il complesso sacro (la cisterna con orologio e fonte del “Casino di Villeggiatura” e quella in opera vittata visibile lungo la strada per Spello)25 e che sono state già più volte sottolineate le caratteristiche salutari e oracolari dei culti ivi praticati fin dall’età preromana: tra le di-
22 Tracce di aiuole delimitate da coppi posti in verticale sono state messe in luce lungo tutto il muro antico.
23 La nicchia nei pressi del “Casino di Villeggiatura” attualmente è adibita a locale caldaie ed è stata più volte rimaneggiata in epoca moderna, mentre per la grande arcata al centro del primo terrazzamento (alt. m 4 e largh. m 4,5, 13 x 15 piedi) si è supposto contenesse un ninfeo o una fonte lustrale con canalizzazione retrostante; MANCONI - CAMERIERI - CRUCIANI, Hispellum, cit., p. 386, Tav. IV: 2.
24 Si può supporre che dall’apertura superiore dell’esedra fosse visibile il tempio di Venere prima della risalita nella terrazza superiore. Si veda a questo proposito lo studio sulla struttura delle terrazze e sui giochi prospettici del santuario di Palestrina: F. COARELLI, I santuari del Lazio in età repubblicana, Roma 1987, pp. 37-84.
25 MANCONI - CAMERIERI - CRUCIANI, Hispellum, cit., pp. 387-388.
276 SERGIO OCCHILUPO
vinità attestate nel santuario sono da ricordare infatti, oltre a Venus, Mi-nerva, Nortia e Iuppiter26.
Infine, gli studi sulla valenza etnica del santuario di Villa Fidelia, pri-ma umbro poi romano, e sul suo collegamento con gli altri luoghi di cul-to della valle umbra con caratteristiche di intervisibilità, come il santuario dell’Aisillo recentemente scoperto nei pressi di Mevania27, possono assume-re, con i prospetti scenografici sopra delineati, connotati più precisi anche sul piano strettamente fisico. Il sistema di fontane, giochi prospettici e sta-di di risalita delle terrazze, legati molto probabilmente a momenti inizia-tici ed oracolari, sottolinea la valenza specifica dell’acqua come principale elemento salvifico creando un riferimento con quei luoghi (Aisillo e Lacus Clitumni) che dall’epoca augustea saranno sotto il diretto controllo della colonia di Hispellum.
In conclusione, se da un lato sono stati raggiunti nuovi risultati con la scoperta dell’esedra monumentale e del terzo muro di terrazzamento adiacente al tempietto di Venere che rimette in campo tutte le ipotesi ri-costruttive relative al santuario umbro, sia riguardo all’organizzazione dei terrazzamenti e dei percorsi di risalita verso i sacelli sia riguardo la struttura stessa dei prospetti dei muri (la presenza della fontana va vista naturalmente sotto il profilo dell’impianto prospettico del santuario anche in contiguità e in rapporto con il teatro sottostante), le recenti indagini hanno aperto nuove ipotesi interpretative che interventi molto limitati nel tempo e nel-lo spazio, come quelli di cui si è parlato, non possono contribuire più di tanto alla loro soluzione. Si può certamente intuire però che la topografia antica dell’area intorno a Villa Fidelia, lungi dall’essere ancora conosciuta nelle sue linee generali, lascia intravedere una presenza di culti, forse già attestati dall’epoca arcaica, molto articolata e complessa sancita ancora in età costantiniana dal Rescritto e dal collegamento con il Fanum Voltumnae28.
26 Su questo si veda di recente: SISANI, I rapporti, cit., pp. 435 ss.27 M. ALBANESI - M.R. PICUTI, Un luogo di culto d’epoca romana all’Aisillo di Bevagna
(Perugia), in MEFRA 121, 2009, pp. 133-179; Sisani, I rapporti, cit., pp. 418 ss.28 S. SISANI, Lucius Falius Tinia, primo quattuorviro del municipio di Hispellum,
in Atheneum 90, 2002, pp. 483-505; STOPPONI, Da Orvieto, cit.; COARELLI, Il rescrit-to, cit.; E. ZUDDAS, L’Umbria nell’era costantiniana, in Bollettino per i beni culturali dell’Umbria 5, 2012, pp. 61-70.
Fig.
1 –
Spe
llo (
Pg),
Vill
a Fi
delia
, ved
uta
aere
a: A
= a
rea
del t
empi
o di
Ven
ere
(sca
vo 2
007)
; B =
sec
ondo
mur
o di
ter
razz
amen
to
(sca
vo 2
009)
Fig.
2 –
Spe
llo (
Pg),
le e
mer
genz
e ar
cheo
logi
che
nell’
area
di
Vill
a Fi
delia
: 1
= te
mpi
o di
Ven
ere;
2 =
mur
i di
ter
razz
amen
to;
3 =
Chi
esa
di S
. Fe
dele
; 4
= ar
ea d
i ri
nven
imen
to d
ella
bas
e co
n is
criz
ione
um
bra
Fig. 3 – Spello (Pg), Villa Fidelia: area di accesso alla villa degli Urbani (ora con-vento delle Suore Missionarie d’Egitto)
Fig.
4 –
Spe
llo (
Pg),
Vill
a Fi
delia
, te
mpi
o di
Ven
ere
e te
rraz
zam
ento
: A
-C l
ivel
li di
fre
quen
tazi
one
prec
eden
ti al
la f
ase
triu
mvi
rale
-aug
uste
a
Fig.
5 –
Spe
llo (P
g), V
illa
Fide
lia, s
ezio
ne d
el te
mpi
o di
Ven
ere
e de
ll’ar
ea d
ello
scav
o: A
-C =
live
lli d
i fre
quen
tazi
one
prec
eden
ti al
la fa
se tr
ium
vira
le-a
ugus
tea
Fig. 6 – Spello (Pg), Villa Fidelia, terzo muro di terrazzamento
Fig. 7 – Spello (Pg), Villa Fidelia, terzo muro di terrazzamento
Fig. 8. – Spello (Pg), Villa Fidelia, antefissa a testa di Sileno dall’area del terzo muro di terrazzamento (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria, inv. n. 677725 – foto dell’autore)
Fig. 9 – Spello (Pg), Villa Fidelia, area di scavo del terzo muro di terrazzamento nel punto di intersezione con il muro rinascimentale (freccia)
Fig. 10 – Spello (Pg), Villa Fidelia, ipotesi ricostruttiva dei terrazzamenti: A = scavo 2007, B = scavo 2009. 1 – Tempio di Venere; 2 – terzo muro di terrazzamen-to; 3 – probabile accesso alla terrazza superiore; 4 – resti di crolli di strutture; 5 – esedre monumentali; 6 – accesso al secondo terrazzamento; 7 – ninfeo/fontana; 8 – resti di cementizio (rielab. dell’autore da MANCONI-CAMERIERI-CRUCIANI 1997)
Fig. 12 – Spello (Pg), Villa Fidelia, secondo muro di terrazzamento, esedra prima dello scavo
Fig. 13 – Spello (Pg), Villa Fidelia, secondo muro di terrazzamento, apertura superiore dell’esedra
Fig.
15
– Sp
ello
(Pg
), V
illa
Fide
lia,
seco
ndo
mur
o di
ter
razz
amen
to,
vasc
a de
ll’es
edra
e r
ives
timen
to i
n op
us v
ittat
um