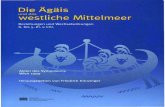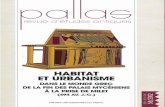Le case del periodo arcaico: le fasi G e F
Transcript of Le case del periodo arcaico: le fasi G e F
L’abitato etrusco del Forcello di Bagnolo S. Vito (Mantova):
le fasi arcaiche
a cura diRAFFAELE C. DE MARINIS, MARTA RAPI
Volume realizzato in occasione della mostra
Gli Etruschi a nord del Po. Le fasi di età arcaica dell’abitato del Forcello di Bagnolo S. Vito.
Bagnolo S. Vito (MN), Villa Riva Berni, 8 febbraio – 20 marzo 2005
Seconda edizione con aggiunte e correzioni, Firenze 2007
Le case del periodo arcaico: le fasi G e F
STEFANIA CASINI , CRISTINA LONGHI , MARTA RAPI
Lo scavo archeologico sta lentamente riportando alla luce le case della fase F(510-500 a.C.), che rappresentano un documento di straordinaria importanza nel-l’ambito di tutta la sequenza delle fasi insediative del Forcello, per la ricchezza deidati relativi alle strutture e per la presenza di materiali in deposizione primaria. Que-sta situazione fu determinata da un vasto incendio nel quale le strutture lignee, chein condizioni di normale degrado si sarebbero decomposte fino a scomparire com-pletamente, si sono conservate a livello di fondazione perché carbonizzate e i mate-riali contenuti nelle abitazioni sono rimasti in situ, cioè nel punto in cui sono cadutiin seguito al crollo, perché tutta l’area fu sigillata con uno spesso livello di argilla,che ha impedito che le attività successive intaccassero il deposito.
Le case della fase F, messe in luce nei settori R-S 18 e R 191, si sono rivelate edi-fici di notevole importanza sia per le dimensioni e la complessa articolazione fun-zionale, sia per l’abbondanza e la qualità dei materiali presenti. Le grandi quantitàdi ceramiche di importazione, fra cui il prezioso amphoriskos dello stile di Fikellura,una grande fibula d’argento rivestita di foglia d’oro e uno scarabeo di diaspro verdedi produzione fenicio-cipriota documentano in maniera eloquente che qui risiede-vano le élites sociali dell’abitato etrusco del Forcello.
È apparso, inoltre, evidente che queste abitazioni hanno una storia complessa esono il risultato di vari rifacimenti, a partire dalla sottostante fase G (520-510 a.C.).
La prosecuzione dello scavo nel settore R18, infatti, ha messo in luce un’abita-zione (G I) edificata circa 10 anni prima della casa F I, con la stessa tecnica costrut-tiva e con il perimetro e la disposizione degli ambienti perfettamente sovrapponibili.
A differenza delle case della fase F la struttura più antica non reca evidenze didistruzione violenta, poiché all’interno delle canaline di fondazione non è rimasta al-cuna traccia di travi carbonizzate e tutto lascia pensare che la casa sia stata smantel-
1 Per le notizie relative ai ritrovamenti dei settori R-S 18 si veda: R.C. DE MARINIS 1991, pp. 251-257;R.C. DE MARINIS, S. CASINI ET ALII 1995, pp. 538-542, fig. 19. Nel 2003 e nel 2006 la fase F è statamessa in luce anche in una porzione del settore R 19, ma le relazioni sono ancora inedite, al pari deidati relativi alla fase G del settore R 18.
83
lata, forse dopo un decennale periodo di utilizzo per costruirne una nuova: i livellidi accrescimento dovuti all’attività antropica sembrano essere stati rimossi insiemealle suppellettili e tutto è stato sigillato da un livello sabbioso-limoso sterile di spes-sore da 12 a 20 cm, su cui andrà a impostarsi la successiva fase F.
Se consideriamo che allo smantellamento si accompagna la stesura di questo li-vello sabbioso, si potrebbe ipotizzare che vi fosse l’intenzione di ovviare a incon-venienti dovuti a una possibile risalita del livello della falda. In effetti la primainondazione, collocabile entro la fine del VI secolo a.C., che superò il terrapienosenza però procurare danni alle strutture abitative, potrebbe avere una relazione conquesto innalzamento del piano delle abitazioni.
La fase G è stata indagata soltanto su un’area di circa 100 m2, di cui 80 occupatidall’abitazione G I, lungo i margini della quale due piccoli canali tra loro perpendi-
Fig. 35 - Planimetria della casa di fase G.
84
colari, con direzione SE/NW e NE/SW, avevano funzione drenante e di scolo. Almomento sono stati messi in luce 9 vani, di cui 4 integralmente e 5 solo parzialmente,poiché proseguono oltre i limiti di scavo. I due vani maggiori hanno il lato lungoorientato NE/SW e ciascuno ha una superficie di circa 21 m2, mentre i due minorihanno un’estensione di circa 7 m2 ciascuno.
Data la scarsità dei reperti rinvenuti non è possibile definire la funzione dei variambienti, ad eccezione del vano 4, interpretabile come cucina per confronto con lameglio conosciuta fase F. È caratterizzato, infatti, da un focolare semicircolare, ad-dossato alla parete meridionale, nell’identica posizione riscontrata nel vano 4 dellacasa F I.
Non sono stati trovati livelli di sabbia e limo pressati, solitamente utilizzati percreare i piani pavimentali, che in questa fase erano probabilmente costituiti da sem-plici battuti. Il piano di calpestio oggi risulta piuttosto irregolare, in quanto risentedel cedimento delle strutture sottostanti e del fenomeno di compattamento del depo-sito; ma questo inconveniente era forse già riscontrabile al momento dell’edifica-zione della casa di fase G, quando i dislivelli furono colmati con alcune stesure diterriccio. Le irregolarità del piano pavimentale sono comuni a tutti gli ambienti, maparticolarmente accentuate nel vano 3, in corrispondenza di quella che nella prose-cuzione delle indagini è risultata essere originariamente una profonda buca, forse unpozzo.
Un’ipotesi circa la destinazione d’uso a magazzino per le derrate alimentari puòessere avanzata per il vano 1 dotato di una grande buca forse per l’alloggiamento diun dolio, analogamente alla situazione riscontrata nel vano 1 della casa F I.
Fig. 36 - Coltello in ferro a lama serpeggiante dall’us 1001 (fase G).
85
86
La datazione della fase G si fonda sul ritrovamento di una lekythos a figure neredel Gruppo del Gallo, prodotta ad Atene tra il 520 e il 510 a.C. ca. La lekythos è statarinvenuta in frammenti nel piano di preparazione del focolare, costituito da cerami-che frantumate, e ci offre quindi un aggancio cronologico per la data di costruzionedella casa.
Una volta smantellata l’abitazione della fase G e ripulita l’area da tutto ciò cheera d’ingombro, fu steso, come si è detto, un livello limoso sabbioso compatto, sucui fu edificata la struttura di fase F (510-500 a.C.); lo scavo di questa fase ha inte-ressato un’area più ampia, i settori R-S 18 e R19, dove si stanno portando alla lucei resti di due abitazioni, F I e F II, distrutte da un incendio: mentre gli alzati e la co-pertura del tetto sono finiti in cenere, nelle canaline di fondazione si sono conservatele travi lignee carbonizzate che sostenevano le pareti. È quindi possibile ricostruirecon esattezza il perimetro delle case, la loro articolazione in vani grandi e piccoli edeventuali partizioni interne ai singoli ambienti. Inoltre, mentre gli arredi lignei dellesingole stanze sono andati bruciati, molti dei materiali di utilizzo quotidiano in ce-ramica o altro materiale duraturo, pur a volte gravemente danneggiati dal fuoco,sono stati lasciati in situ, cioè nel punto in cui caddero in seguito al crollo, con l’ec-cezione di alcune dislocazioni avvenute durante le operazioni di bonifica successiveall’incendio.
Le case, a pianta rettangolare, erano delimitate dai due piccoli canali di scolo edrenaggio, già presenti nella fase G, i pavimenti erano realizzati con stesure di limocompatto, le pareti edificate con travi di legno, probabilmente secondo la tecnicadel Blockbau, e le travature del tetto forse ricoperte con paglia pressata. Gli ambientiinterni erano divisi da tramezzi di legno.
La casa sino ad ora indagata più completamente (F I) doveva avere un’estensionecomplessiva di almeno 175 m2, di cui 140 sono stati scavati fino ad ora, suddivisi inquindici vani di forma rettangolare. Le cinque stanze centrali hanno dimensioni mag-giori, circa 21 m2 l’una, con il lato lungo orientato in direzione NE-SW. Vani più pic-coli, di circa 7 m2 l’uno, sono allineati lungo i lati sud-occidentale e nord-orientaledell’abitazione; l’estensione complessiva dei cinque vani minori finora posti in luceintegralmente è di circa 35 m2. Come è già stato precedentemente detto, la planime-tria della casa F I è perfettamente sovrapponibile a quella della precedente fase G.
Lo studio dei materiali rinvenuti in deposizione primaria in ogni singolo am-biente consente di definirne, nella maggior parte dei casi, la funzione. Nei vani dimaggiori dimensioni n. 4, 8, 11 e 12, è presente un focolare, mentre solo il vanogrande n. 3 ne è privo, al pari di tutti i vani di piccole dimensioni.
Il vano grande n. 4 era senza dubbio adibito a funzioni di cucina: un focolare diforma semiellittica era addossato alla parete sud-orientale, probabilmente foderatain questo punto da mattoni crudi e concotto. Questa parete è l’unica ad avere un’in-tonacatura di argilla, che doveva riparare la struttura lignea dall’azione del fuoco.Poco distante, sul pavimento, è stato rinvenuto un fornello portatile a piastra forata,altrove diverse macine in pietra trachitica con un macinello. Il vano era forse dotatodi scaffali che accoglievano i molti vasi, sia olle che ciotole di impasto fine e un
Fig. 37 - Planimetria delle case FI e FII nel settore R18 (fase F, fine del VI secolo a.C.).
87
mortaio ritrovati in numerosi frammenti sparsi sul pavimento. Sono stati rinvenuti iresti mal conservati di un coltellaccio in ferro. Anche in questa stanza vi erano moltipesi da telaio, specialmente nella zona accanto alla parete prospiciente il focolare.Limitandoci alla distribuzione dei materiali di importazione, notiamo che nella cu-cina vi erano una lekythos a figure nere della classe di Atene 581 e due coppette avernice nera, con orlo ingrossato aggettante verso l’esterno.
Il piccolo vano n. 1 fungeva da magazzino-dispensa: vi sono stati rinvenuti inframmenti un grande dolio cordonato, molte olle a corpo ovoide in ceramica di im-pasto grossolano e di diverse dimensioni e i frammenti di un’anfora corinzia B/cor-cirese.
Anche il vano n. 2 aveva un’analoga funzione: conteneva, infatti, derrate ali-mentari e le granaglie carbonizzate sparse sul pavimento fanno pensare alla presenzadi sacchi disposti in un angolo verso il lato prospiciente il canale di scolo. Un grandenumero di pesi da telaio e la traccia impressa sul pavimento da lunghi travetti dilegno carbonizzato fanno ipotizzare la presenza di un telaio verticale.
Il grande vano n. 3, adiacente alla cucina, era probabilmente arredato con mobiliin legno; può darsi che fosse adibito al banchetto. Nell’angolo nord-occidentale èstata rinvenuta un’anfora greca da trasporto di Taso e pochi frammenti di un vaso af.n. di forma chiusa, in quello sud-occidentale tre coppe attiche a vernice nera ditipo Bloesch C. Nella zona centrale della stanza non sono stati trovati materiali, macarboni in grande quantità e il pavimento è annerito, segno che vi è bruciato qualchearredo ligneo non più ricostruibile. Da questa stanza proviene una figurina votiva
Fig. 38 - Fornello fittile deformato dal calore dell’incendio,dal vano n. 4 della casa FI (fase F).
88
bronzea, di tipo appiattito e filiforme, fusa a stampo.Nel piccolo vano magazzino n. 9 vi erano due anfore greche da trasporto, una del
cd. tipo ionico-massaliota ed una di tipo corinzio B / corcirese. Verso l’incrocio trale grandi stanze n. 8 e 11 e i vani magazzino n. 9 e 10 sono stati rinvenuti moltissimiframmenti anforici da cui è stato possibile ricostruire tre anfore di Taso.
Dal vano 11, quasi completamente indagato, provengono molti frammenti di ce-ramiche fini, di anfore da trasporto e di ceramica attica a figure nere, soprattutto aridosso delle tramezze dei vani 8 e10 e parzialmente al loro interno. Dalle intensetracce carboniose qui rilevate, probabilmente in questo punto si doveva trovare unelemento di arredo su cui erano riposti i preziosi recipienti, fra i cui frammenti èstata rinvenuta anche una fibula d’argento ricoperta di lamina d’oro, del tipo ad arco
Fig. 39 - Grande olla cordonata dall’us 476 (fase F),rinvenuta nel vano n. 1 della casa F I.
89
digradante verso la staffa e fornito di una serie di appendici a globetto. Anche questo ambiente era dotato di un focolare di forma pressoché quadrango-
lare. Nella metà SW della stanza sono stati rinvenuti molti frammenti di ceramica at-tica: una cinquantina appartengono a una lekythos a figure nere, un centinaio a dueo tre coppe attiche del tipo C, e circa duecento a un cratere a colonnette (kelebe) afigure nere. Molti di questi frammenti sono fortemente deformati per effetto del ca-lore dell’incendio.
Poco si può dire del vano 8, dove alla scarsità dei frammenti ceramici fa riscontroun sottile strato di incendio e la presenza di una depressione ovale ricca di semi eframmenti di ossa carbonizzate. Al centro dell’area si trovava un piccolo focolare diforma quadrangolare che in un momento di ristrutturazione del pavimento venneparzialmente obliterato. È stato trovato anche il frammento di un bidente in robustaverga di bronzo a sezione rettangolare, forse pertinente a un attizzatoio o a un can-delabro. Presso la parete sud-orientale è venuto alla luce un prezioso oggetto di im-portazione, uno scarabeo egittizzante in diaspro verde scuro, inciso a intaglio sullafaccia piana con la figura del dio Bes che affronta un leone in posizione rampante.
I vani piccoli n. 5, 6, 7, 10, indagati solo parzialmente, non hanno rivelato par-ticolari indizi riguardo al loro utilizzo, mentre del vano grande n. 12 si è giunti, per
Fig. 40 - Pesi da telaio in terracotta dall’us 476 (fase F).
90
il momento, a mettere in luce la metà NE con un focolare quasi a ridosso della parete.
Di maggiore ricchezza doveva essere l’adiacente casa F II, esplorata su una su-perficie più limitata rispetto alla precedente, a causa del fatto che si trova a ridossodella capezzagna che attraversa il fondo del Forcello, e che è risulta anche menobene conservata, in quanto la stesura di argilla in questo punto era più sottile e ilavori agricoli ne hanno intaccato la parte sud-occidentale.
Il piano pavimentale risulta più elevato di 25 cm rispetto al piano della casa F Ie in esso è visibile il taglio di una canalina di fondazione, contenente una trave car-bonizzata che divide l’area in due vani: quello maggiore, di circa 26 m2, aveva al cen-tro un grande focolare di forma rettangolare e conteneva numerosi vasi per derrate,come dolii cordonati e grandi olle, tre coppe attiche del tipo Bloesch C, una coppaad occhioni a figure nere, una coppa del tipo top band stemless, uno skyphos dellaHeron Class, un amphoriskos dello stile di Fikellura, proveniente da Mileto. Nel-l’altro vano, di dimensioni minori, circa 9 m2, sono state raccolte stoviglie di cera-mica fine, in particolare piattelli, e di impasto grossolano e molta ceramica attica:coppe a vernice nera di tipo Bloesch C, una lekythos a figure nere, un’olpe e un’an-fora da trasporto di Taso.
All’interno del canale che divideva le due case, lungo la sponda della casa F II,in corrispondenza dei vani 9 e 10 della casa F I, è stata rinvenuta una grossa quantitàdi pesi da telaio, probabilmente scivolati al momento del crollo. Da questo indiziosi può supporre che anche la casa F II doveva essere dotata di un telaio verticaleposto in posizione analoga a quello della casa F I.
I diversi ambienti delle case della fase F dovevano contenere arredi lignei, comedimostrano la concentrazione dei carboni e la varietà delle essenze presenti: quercia,preponderante, e inoltre frassino, acero, carpino nero.
Dei numerosi manufatti in bronzo poco si è salvato: il calore dell’incendio li haridotti, nella maggior parte dei casi, ad ammassi informi. Frammenti di lamine, in al-cuni casi con ribattini, e parte di un manico indicano la presenza di una situla nellacucina della casa F I.
Interessante è la distribuzione delle fibule, che sembrano connotare i diversi am-bienti dal punto di vista del genere. Sembra che vi fossero spazi di pertinenza esclu-siva delle donne e altri di pertinenza maschile2. Nella casa F II e nei vani 1, 3, 8 e11 della grande casa F I sono stati trovati frammenti di fibule ad arco serpeggiante,caratteristiche del costume maschile, che invece appaiono del tutto assenti nella cu-
2 Per una prima analisi spaziale si veda R.C. DE MARINIS, G. BARATTI, C. LONGHI, C. MANGANI 2002,pp. 303-318.
91
cina (vano 4), dove le fibule sono esclusivamente di tipo Certosa e a piccola sangui-suga con anima in cotto, caratteristiche del costume femminile. Le anfore grecheda trasporto si trovavano nella casa F II e nelle stanze 3, 8 e 11 della grande casa FI, ma non nella cucina e nel vano 2 con il telaio.
Come è stato anticipato, quando l’incendio di carattere catastrofico della fase Fsi placò, lasciando ingenti macerie sul terreno, si preferì non asportare i resti, ma bo-nificare l’area con una stesura di argilla pura, della potenza variabile tra 20 e 70 cm.Poiché si è notato che alcuni frammenti, pertinenti agli stessi vasi si trovavano inpunti distanti tra loro, è possibile pensare che le macerie siano state in parte livellatee che nelle operazioni di stesura del riporto argilloso si sia verificato lo spostamentodi alcuni reperti. Oggetti pertinenti alla fase F sono stati trovati anche all’internodell’argilla sterile, forse inglobati durante la sua stesura.
La grande quantità di ceramica di importazione dalla Grecia consente la data-zione della fase F al lasso di tempo tra il 510 e il 500 a.C.3. Dopo la generale bonificaconseguente all’incendio, l’area non fu immediatamente riutilizzata ad uso abitativo,ma venne destinata allo svolgimento di attività artigianali documentate dalla fase E.
3 La datazione stabilita in R.C. DE MARINIS 1991/b, pp. 251-257 e in R.C. DE MARINIS, S. CASINI ET
ALII 1995, pp. 538-549 è stata meglio definita con il procedere delle ricerche e l’indagine dei livellipiù antichi dell’abitato.
92