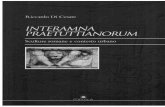F. Berti, N. Masturzo, Aree di culto ed elementi architettonici di periodo arcaico a Iasos (Caria)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of F. Berti, N. Masturzo, Aree di culto ed elementi architettonici di periodo arcaico a Iasos (Caria)
OSTERREICHISCHEAKADEMIE DER WISSENSCHAFTENPHILOSOPHISCH-HISTORISCHE·KLASSE
DENKSCHRIFTEN, 288. BAND
ARCHAOLOGISCHE FORSCHUNGEN
BAND 4
AKTEN DES SYMPOSIONS
DIE ÀGAIs UND DAS WESTLICHEMITTELMEER
BeziehungenundWechselwirkungen8. bis 5. Jh.v. Chr.
Wien, 24. bis 27.Marz 1999
veranstaltet von derForschungsstelleflir Archaologieder ÒsterreichischenAkademieder Wissenschaften,
dem Institut flir KlassischeArchaologieder UniversitatWienund dem OsterreichischenArchaologischenInstitut
HerausgegebenvonFRIEDRICH KRINZINGER
Redaktion:VERENA GASSNER,MrcHAEL KERSCHNER, ULRIKE Muss,GUDRUN WLACH
VERLAG DER OSTERREICHISCHENAKADEMIE DER WISSENSCHAFTENWIEN 2000
Vorgelegt vonk. M. FRlEDRlCH KIuNZINGER in der Sitzungam lO. Dezember1999
Gedrucktmit UntersttitzungdesBundesministeriumsfurBildung, Wissenschaftund Kultur in Wien unddesÒsterreichischenArchaologischenInstituts
Die DeutscheBibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatzfììr diesePublikationist bei derDeutschenBibliothek erhaltlich
Alle RechtevorbehaltenISBN 3-7001-2925-4
Copyright© 2000 byOsterreichischeAkademieder Wissenschaften
WienGesamtherstellung:Weitzer& Partner,Graz
FEDE BERTI - NICOLÒ MASTURZO
Aree di culto ed elementi architettonici di periodo arcaico a Iasos (Caria)
Gli elementiarchitettonicidi etàarcaicache ci siaccingeapresentaresono inbuonaparteinediti;su di essi si basa lalegittimità del nostrocontributo. Corre l'obbligo tuttavia di far precederel'analisi che di essi farà N.Masturzoda unbrevecommentointroduttivo, al quale si affida ilcompito di puntualizzarelo stato dell'argomento.
Nella piccolaisola entro cui, inperiodoarcaico, eraracchiusoil plessourbano sono preva-lentementei dati archeologicia configurarele aree sacre che ci sono note. Esse sono tre. Il gradodi conoscenzache neabbiamoè ineguale.
C ULTI
Il santuariodi Zeus Megistos
I ritrovamenti arcaici (una stipe all'interno di un naiskos-thesaurosdi IV sec.) trovano in ungruppo diiscrizioni di V-IV sec. il supportonecessario perubicarein area prossima aquello chepoi sarà il portoorientaledella città il santuariodi ZeusMegistose per essere ascritti alsantuario.La stipe non ci rivela quale fosse ladivinità alla quale vennerodedicatela coroplastica,vasella-me, statue (mutarimaneinfatti unaiscrizionein cario), rivelainvece(thymiateria)l 'indizio di unaqualcheautonomianei confronti dei dettami dellalex sacra,ovvero forme incruentenella prassirituale.
Il materiale, nella sua varietà ericchezza, riflette comunquel'estensionedel circuito com-mercialedi cui, tra il 550 ed il 480 ca. a. C.è partecipe la città. Né deve sorprendere che, in unsimile contesto, fenomenisincretisticiabbianoriplasmato le figure delpantheonindigenoe creatomodelli cultuali complessiJ •
Il culto di ArtemisAstias
È dal noto passo diPolibio (XVI 12) che apprendiamoi motivi per cui eravenerataa lasoslastatua diArtemis Astias . Plinio, N.H.XXXVI 12, scrive: ostenduntet Iasii Dianam manibuseorum (Boupalose Athenis)factam.
Da ciò traspaionosia la remotaantichitàdel culto , del cuisimulacrooffrono una immaginealcuneconiazionid'etàimperiale,sia latemperie artistica in cui lacittà si muovevain etàarcaica.
Dalla iscrizioneBliimel 1985, n. 251, apposta in etàcommodianasulla fronte dell'edificiocon esedre retrostante al Bouleuterion, si ricavò, sin dai nostri primiapprocci alla città ,l'ubicazionedel santuario.
Gli scavi hannosuccessivamenteportato alla scoperta, alcentro di tale vasta area , di unpiccolotempio in antis e, inreimpieghidi periodoimperialee tardoimperialein zonacontermine,di una lastradi fregio ionico con scena di caccia e di unapiccolatesta di Osiride di età saitica.Queste due opere arcaiche si collocano al vertice cronologico della documentazione scultoreapresente alasos; se laprima ha il poteredi evocare forme architettonichetemplari sperimentalima comunquedi granderespiro , la secondasembrerebbeinterpretare- come è testimoniato
l I ritrovamenti sono illustrati da Laviosa 1985 e Landolfi 1985. Per la statuaria(kouroi) anche Angiolillo 1995,85-93. Peri testi epigrafici Bllimel 1985, l;2,126; 233; 220=Sokolowsky 1955, n 59 (di controversa datazione) ePugliese Carratelli 1991,47-55,nr. 2--4.Per il graffito cario sukelebea f.n. Pugliese Carratelli 1986,149-151,tav.I e Gusmani 1988.L'epiclesidello Zeus iasio trova altre attestazioni: cfr. Laumonier 1958, 599 nota l, e ancora, adesempio, Bruneau 1970,242-245e 247. Laumonier 1958 suppose che iltemenosfosseextra murosper viadelluogodi ritrovamentodell'horos Bhìmel 1985, n. 234. Fenomeni di sincretismo in: Lebrun 1994.
217
IONISCHE KUNST UND 'IONISMEN' 1M W ESTEN: ARCillTEKTUR UNO DACHTERRAKOTTEN
altrove - quelle espressionidevozionaliche riallacciavanoalle proprieradici il fortunatoritornodi mercenari.
Ma nemmenociò - per quanto sia suggestivo - convalida lapresenzaqui del temenoscheospitava la statua di Artemis Astias,denominatadivinità I1poKa8Tl'YEl.lcov della città, una suppo-sizione alla quale, per traslato , si è venuta aggiungendola congetturache il tempioin antis fossededicatoad Apollo . Si dovrà piuttostoritenereche la divinitàpossedesse spaziextraurbani:losuggerisconola impossibilitàdi iscrivereArtemis, per la sua stessa natura , nel quadro strutturatodella città ele analogiecon il santuario della Kyndia a Bargylia, al quale Iasoscontendevaglistrani fenomeniche lo resero degno dimemoria?.
Il santuario di Demetra e Kore
Un luogo di culto urbano tardo arcaico è posto infine su unterrazzamentocirca a metà costa esovrastanteil porto occidentale.Non vi sonoiscrizioni o dedichee il regimedelle offerte nonappare così vario come avvieneall'interno del temenosdi ZeusMegistos;tuttavia la peculiaritàdei votivi ha fatto supporre che fosse dedicato aDemetrae Kore. Il caso merita note un poco piùestese che non iprecedenti, anche se le osservazioni che siproporrannosi basano su un terrenopoco solido , ovvero su un'analisi appena abbozzata e su dati parziali .
E' sufficiente un sempliceconfronto tra due rilievi realizzati a distanzadi anni l'unodall'altro" per constatare nonsoltantoil progressivodeterioramento, nel tempo, di resti che già almomentodella scopertarisultaronoassaitormentatima anche come le letture datenedifferiscanofra loro. Nericaviamoche all'inizio (terzo venticinquenniodel VI sec.) tutto siconcentrain unastruttura lievementeirregolaredi m Il x 7.8 orientata a Est, divisa in due ambienti.Nell'ambienteminore ,decentrata, si rinvenneuna eschara. Un breve tratto di muro aMeridione, rappresentatoin piantacome coevo,potrebbeessere l'indizio di un contrafforteo di un terrazzamentopresentelà dove lapendenzaera più ripida . Di analoga funzione - forse - unsecondomuro quasiparalleloe di forte spessoreun poco più aOccidente, del quale tuttavia il rilievo più recente coglie senzaesitazionela connessione con fasi più recenti .
D. Levi, pur temperandol'affermazione, ritenne di ravvisarenell'edificio la pianta di untempio prostilo",
A partiredalla fine del secolo gliavvenimentivi si sarebberosusseguiticon unadistruzione,una ricostruzione(ma solo alla fine del V sec.) el'avvio di una fase che giunge,seppurconqualcheintervento,sino alla soglie dellaromanizzazione.La persistenzadel culto è fuori di ognidubbio, sebbeneJohannowskysostenga: «Nulla disicuramentecollegabileal culto documenta...la faseposteriorealla conquistada parte di Alessandro»".
Alla fine del V sec. a.C. sarebbequindi stato eretto un recinto (con stoai?) di m 22 ca. di lato,al cui internosarebbevenuta a trovarsi la costruzionearcaicadismessa.Sul lato occidentaledelrecinto , unedificio orientatodiversamenterispetto al più antico, ovvero a sviluppo N-S, diviso indue ambienti diinegualeestensionee dotato forse dibanchine,sostituì il precedentenelle sue
2 Come per gli altri culti iasii di Apollo e di Zeus Megistos, anche per quello di Artemis Astias si veda Laumonier1958,594--597; sulla valenza ctonia dell'epiteto OpoKa811'YE!lWV Picard 1922,364. L'ubicazione del santuario, poiripresa da altri ,è in Levi 1967/68,564. La lastra con scena di cacciaè editada Laviosa 1972173. Per la testinaegiziaBerti 1992 , 95 figg. 3 e 4. Per il temp ioin antis,Laviosa 1978.
3 Levi 1967/68 : Il santuario dellaPuntaSud, 569-576con pianta a fig. 37;Johannowsky 1985 con pianta a fig. 2. E'recentela ripresa dello studiosull'argomentoda parte di W.Johannowskye di R. Bonifacio.
4 Levi 1970, 119.5 Johannowsky1985, 55; Levi 1967/68,573-574osserva invece: «Il culto entro alsantuario èdurato sicuramente fino
all'inizio dell'etàimperialeromana»e ancora, «La mult iformedocumentazionedella plastica fittile ci accompagnafino a una serie di graziosiprodotti di età ellenistica; in tale età, perquantoriguardala cerami ca, sipresentanoinabbondanzale coppemegaresi,mentrediventanosemprepiù rare le idrie»,
218
AREE DI CULTO ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PERIODO ARCAICO A IASOS(FEDE BERTI - NICOLÒ MASTURZO)
funzioni. Venneroosservateuna certaqual accuratezzanella costruzionedel muro, nobilitata diun paramentoin blocchettidi marmo,la persistenzadell'ingressosul lato orientale(un secondoaccessofu poi praticatoanchea Settentrione)e la presenzaall'esterno,a fianco dell'ingresso,della basein marmodi una statuafemminile panneggiata,ritrovata accantoin pochi frammenti.
Tuttavia la sequenza,così come è statasunteggiata,non convincené da unpunto di vistaarchitettonicostrutturale,né tanto menocronologico.A quest'ultimopropositova osservato,adesempio,che ladistruzionedi fine VI secoloviene desuntadalla «terrabruciata»dell'escharaeche scarsagiustificazionenellevicendedellacittà, foss'anchesolodi quellelegateagli anni finalidel V secolo, trova il conseguentee lunghissimoiato funzionale", che lo stessoJohannowskytentadi superarericorrendoall'ipotesidell'impiego perun certoperiododi apprestamenticultualinon stabili.
Troppoesili appaionod'altrapartei dati su cuipoggial'ipotesi che di untempiosi trattasse:nessunelementoarchitettonicorimanein realtàa suggerimel'esistenza.La collocazionedi unaescharaall'internodi un edificio (un oikos?)rientrainvecein unacasisticache sembrapeculiaredei santuariarcaici, pur lasciandospazioa meresupposizioniper ciò che concernela possibileforma del tetto".
La fase iniziale del complessovennestabilita in baseai materiali dell'eschara.Questacontenevaossabruciate,un tipo di lucerneche sidata- è vero- tra il VI e il V secolo,
epperòanchetre mascherea testafemminile e alcunestatuettefemminili di offerenti già delprimo quarto del V secolo.Ciò potrebbeconsentireun inquadramentocronologicodiverso. Inaltre parole,si ha lasensazioneche l'affermazionesecondola qualela creazionedel complessocultuale risalga al terzo venticinquenniodel VI secolo dipenda esclusivamentedalla isolatapresenzadi un kourosfittile" .
Quali gli aspetti del rito? Sono affidati alla esistenzadi un luogo deputatoall'offerta divittime (eschara),al significato insito nelle lucerne (svolgimentodi cerimonie notturne) e alcontenutodella stipe", della qualesi vorrebberoconosceremeglio i materiali e le loro variantiiconologiche, ancheperchéla devozionedei fedeli rimaselegataal luogo per molto tempodopoil V secoloe non sembrada escludere,comeforse avvenneper la divinità le cui offerte furonoraccoltenel naiskos del temenosdi Zeus Megistos,che con la fine dell'età arcaicatendanoaprevalereovvero a consolidarsialcuni dei molti aspettidi cui si componeval'ancestralefiguradivina.
Destinatialla ostensione(nell'edificio all'interno del qualefurono raccolti?)eranostatuettedi offerenti,moltedellequali reggonosul capounahydria e con l'altramanodoni (corona,patera,melograno,porcellino), la deamipoòpoç,fittili rappresentantiprodotti della natura,la coppiadidivinità femminili sedutesottoun velo, Kybele,unadivinità maschilebarbatacon polos.Sembra-no predominarele donne;tra le offerte recatefigura la stessamaschera'". Vi eranopoi kernoi ehydriskai a figure rosse,oggetti il cui significato si va semprepiù illuminando grazie a studiparticolarmenteacuti l l •
Ci si chiedetuttaviain qualmodoquestoquadrocambinel corsodel tardoIV e nel III secolo,allorquandoalle rappresentazionidella divinità e degli offerenti subentranole «tanagrines-".
6 Fabiani 1997, ad esempio, propone una interpretazione degli eventi della fine del V secolo diversa da quellacomunemente accreditata.
7 Si veda, ad esempio, Servais 1980, 72.8 Levi 1967/68,572figg. 39 e 43d= Johannowsky 1985, fig. 5;cfr. anche Levi 1970, fig. 6. Peril kourosfittile, Levi
1967/68, fig. 41= Johannowsky 1985, 58: non neè indicato il punto di rinvenimento.9 Levi 1967/68,573-576figg. 40. 42-45 e 47.
lO L'interessedel datoè stato colto da diversi studiosi; da ultimi Cipriani - Ardovino1991,348;sulla polivalenza deivotivi ibidem 347, nota 24.
Il Da Rolley 1965,471ss. (perkernoi) a Cipriani 1988,436ss. (per miniaturizzazione) e altri testi ancora.12 Levi 1967/68, fig. 46. Sarebbe da verificare, ad esempio, se non sia un caso chel'immaginedocumenti prevalen-
temente testine di adolescenti; si veda, al riguardo, ancorché in ambito magno-greco, quanto osservato da Greco1988,423-428.
219
IONISCHE KUN ST UNO ' IONISMEN' 1MWESTEN: A RCHITEKTUR UND D ACHTERRAKOTTEN
Come è stato notato!", non è dato diassegnarealle numerosecoppea rilievo ritrovate unruolo preciso(di offerta? di vasodestinatoa libagioni?), ma - afronte della composizionedellastipe, dovenel IV secolofiguravala solahydria miniaturizzata- è lecito chiedersise lacomparsaper certi aspetti innovativa di un vaso potorio (la «coppamegarese») non adombri mutamentinella prassirituale.
Il luogo è (ed era)privo di risorgive, né il solo culto demetriacosi compiacevadi talecomponente, eppuredal potere evocativo delle hydriskai ricaviamo l 'importanza che rivestìl'acquain questapiccolaspianatarocciosada cui sidominavail mare!".
Voci autorevoli ribadiscono che «in tutto il mondo greco» Demetrae Kore sono statevenerateextra muros" e soltantoun confronto a tutto campodell 'attribuzionecorrentecon ilvasto quadrod'insiemeche si èandatoconsolidandosull'argomentoporràil giustoaccentosullaspecificitàdel nostrosantuario,che facevapartedi unapiù ampiaareacultualee che siescluseavesseradici più antiche.
Aggiungeremoche, epigraficamente,il nomedi Demetracomparea Iasos negli anni finalidel IV secolonel testodella iscrizioneBlììmel 1985 , n. 216
•
(F. B.)
ELEMENTI ARCHITETTONICI
Com'ènoto, lericerchearcheologichea Iasosiniziaronoin manierasistematicae continuativanel1960, mettendoin luce nelcorsodi non molti anni esteseporzioni della città antica,con le suestrutture abitative e di culto'? (Fig . 135). Aquestomassiccio sforzo è solo in parteseguitalapubblicazioneparti colareggiatadegli scavi e dei ritrovamenti" . Fra i materiali inediti più inter-essantisonoalcunielementiarchitettonicidi periodoarcaico,che,essendostatiriutilizzati in muripiù recentio in strati sicuramente nonpertinenti, non sono almomentoassociabiliai vari resti distrutturedello stessoperiodoemersinei numerosiinterventicompiuti dalla missioneitaliana.Peraltro verso,l 'omogeneitàstilistica e il non estesointervallo cronologico, limitato al sestosecolo,in cui si collocanogli elementi, fanno supporreuna fase diintensorinnovamentodell'architetturadi culto a Iasos, probabilmenteanchesotto la spintadell'emulazionedei grandi santuaridellaregione.
Metodo di lavoro
Si è prima accennatoal fatto che ilmaterialequi presentatonon ècollocabilecronologicamentemediantecontesti di scavo; èpertantonecessarioesaminarloda un punto di vista stilistico,ipotizzandoper essodelle modificazioni grosso modo lineari e coerenti dell a forma. Questoprocedimentoci sembrasufficientementeattendibile per unalettura generale, mentrelo scarsonumerodi frammentidi Iasos nonconsentela definizionedi fenomeniparticolari,comepossonoesseregli attardamenti, la ripresadi modelli più antichi o la eventualepresenzadi maestranzeprovenienti da aree ditradizionenon omogenea.
PerDidyma, Efeso eSamosi ha unquadrosufficientementeampio, anche sedisomogeneonelle modalitàdi pubblicazione,dei materiali architettonici,che consentedi stabilire una prima
13 Pierobon 1985, 88-89.14 Il testo Bliimel 1985 n. 115, incompleto, documentain età romana la carica diloutrophorosassunta da unabambina;
cfr. da ultimo Pirenne-Del forge 1994, nota 36.15 Asheri 1988, 3.16 Pugliese Carratell i 1967/68,Iasus in libertatem vindicata,437-445 = Robert 1971.500-502; frutto di una integra-
zione è invece il nome di Demetranell'epigrafeBliimel 1985 n. 35.17 Una esposizione sintetica delle prime ricerche è in Levi 1985, 1 ss., con bibliografi a.18 11 materiale architettonicodi Iasosè in corso di studio e lo scrivente siè occupato a partire dal 1994 dell'esamedel
materiale arcaico, che è stato sistematicamente disegnato e schedato. Si da qui una complessiva anticipazione deirisultati della ricerca, riservandosi di offrire in altra sede una piùdettagliataesposizionedei singoli elementi. Per taleaffidamentoringraz io Fede Berti ,direttrice della Missione ArcheologicaItaliana a Iasos.
220
AREE DI CULTO ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PERIODO ARCAICO A IASOS(FEDE BERTI - NICOLÒ MASTURZO)
+
+
+
+
+
+
++
BACINO ORIENTALE
+ + +++
+
+ + + + + + +e ternplì di periodo ar-caico O classico
+
+
+-
+ + + +di
⦅ N セ
KoreIl
..セGM ..
+ -'4--0 + +
+
+
+
+
+
+
KURUN T
+
Area di.++ + 1;; -Ò:
Fig. 135: Pianta generale di Iasos con indicatele principali aree di culto
griglia di riferimenti formali e cronologici; tuttaviabisognerebbeanche disporre dei dati relativial materiale architettonico ritrovato a Mileto19 , al momento solo in parte edito, per avere unpanoramapiù esauriente dei modelli decorativi in usonell'area.
19 Ad esempio fra i materiali visibilinell'antiquariumsono tre diversi elementi dikyma del tipo I collocabili nellaseconda metà del VI secolo, mentre degli altri elementi molto frammentari si avvicinanoall'esemplarepiù anticodi Iasos del tipo II.
221
I ONtSCHE K UNST UND ' I o NtsMEN' 1M W ESTEN: ARCHITEKTUR UND D ACHTERRAKOTTEN
Fig. 136: L'elemento I 4203a di una assisa decorata con astragali nelmargine superiore esposto nell' antiquarium di Iasos
Provenienze
Nel descrivere gli ele -menti non si è ritenuto op-portuno rifars i alla nomen-clatura consuetadelle moda-naturead ovolo o adastraga-lo. Si ritiene cheper il perio-do in esame siaancoraevi-dente l' attinenza degli ele-menti decorativi alla tradi-zione vegetalizzantepropriadella corrente orientalizzan-te. Gli «ovoli» del kyma io-nico, sempre intervallati dal-la lancetta, sonoformati dalmargine e dal corpo dellafoglia; analoghedefinizionisi hanno per gli astragali, ri-conducibil i a una serie difoglioline col margine infe -riore rientrante e nascosto.
Degli elementi conservati a Iasos non sempreè accertata la provenienza.Il rinvenimento piùsignificativo sembra esserequello di alcuni frammenti decorati ad astragali nelmargine supe -riore, I 420320 (Fig. 136), attribuibili alla somm ità di unaparete, e di unkyma ionico che face vasicuramentepartedell ' assisa superiore, I 4204 (Fig. 137), provenientidall 'area ad estdellachiesaadiacenteal mausoleo «vicino all 'acquedottos " , detto del «Bahk Pazan»; dallo stessoluogoproviene un altro kyma, 14204b, notevolmente rovinato ma riconducibile ai precedenti. Ildiverso stato di con servazione, in un caso si ha unanotevolecorrosioneper esposizione agliagenti atmosferici men tre tutti gli altri frammenti mostranodi esserestati dissepolti solo direcente, e l'omogeneità del rinvenimento fanno ritenere probabile che si tratti di elementiprovenientida un edificio esistentenelle vicinanze. Per questomotivo, e ancheperla presenzadinuclei di notevole importanzamonumentalecome il complessosepolcraledel «Bahk Pazan»,molto più recentema chepoteva gravitarenella zona di unimportantecomplesso sacro, e lavicina grandechiesa a navate chepotrebbeesserestatacostruita, secondouna prati ca consueta,in sostituzionedi un cultoprecedente, si ipotizza l'esistenzain questazona di un santuario postofuori dal perimetro urbano?", con una collocazionefrequentenell ' area.
Dagli scavi dell ' agorà provengonoper il periodo arcaico, oltre alla nota lastra a rilie voattribuita al fregio di un edificio'" , dueframmenti di kyma ionico. Il tipo di kyma,notevolmenteincurvato e rientrante, con la foglia a terminazionepressappocosquadrata e rigonfi a nelcorpocentrale , sembraattribuibile preferibilmente, vista l'estrema frammentarietà dei pezzi, a capitellidi monumentivotivi o ad altari a piantacircolare . Nell'area dell'agoràe nel vicino peristilio, lacui attribuzionetradizionale" è discussanellaparte precedente" , sono attestate numerosefonda-
20 «I» indica il riferimento ai numeri dell'in ventario di Iasos.21 Levi 1965/66, 469ss.22 A rigore, la discontinua presenza di attestazioni archeologiche riferibili all' abitato nel suo complesso el'assenzadi
resti attribuiti a strutture difensive, non consentirebbe di parlare per questo periododi «perimetro urbano» . Vediinfra p. #.
23 Laviosa 1972/73, 397ss.24 Ad esempio: Laviosa 1978, 1095; La Rocca 1985, 36.25 Si veda supra p.#.
222
Fig. 137: Gli elementi ricomposti I 4204a di unkyma ionico espostinell'antiquariumdi Iasos
AREE DI CULTO ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PERIODO ARCAICO A IASOS(FEDE BERTI - NICOLÒ MASTURZO)
zioni e strutture databili inperiodo arcaico; tuttavia,mancando un lavorocomplessivo d'indagine suquesti resti, sembra prematu-ro trame indicazioni sulladistribuzione e trasformazio-ne dei culti qui praticati.
Dallo scavo del santua-rio attribuito al culto di ZeusMegistos proviene, per quan-to risulta, un unico frammento di elemento architettonico scolpito. La particolarità del disegno locolloca in una classe tipica di materiali ritrovata a Didyma e a Sam026
, comunemente definitacome capitellid'anta;come vedremo in seguito, tale indicazione non risulta del tutto soddis-facente.
L'assenzadi dati contestuali, e questo non solo per Iasos, rende anche difficile ricostruirel'ambito di effettivo impiego degli elementi rinvenuti. Nel caso dei frammenti14203e 14204sembra probabile la loro attinenza con le strutture di un tempio piuttosto che con un altare. Peralcuni elementi che hanno una forte rassomiglianza con ikyma ionici di capitelli o di altaricircolari, l'estremaframmentarietà, che non rende possibile rilevarne la curvatura, impedisce diattribuirli univocamente a questo genere di monumento.
Tipi
Kyma ionico I - È il tipo canonico, trasmesso e trasformato nel corso del tempo, nel quale lasporgenza massima si trova nella metà superiore del profilo,l'altezzadella foglia è maggioredella sua larghezza, la lancetta va ad occupareun'altezzasempre maggiore fra le due fogliecontigue sino a separarle completamente nel quinto secolo a.C.
La serie di Iasos sembra iniziare in un momento successivo al frammento attribuito alRhoikostempeldi Samo, che ha foglie per nulla rastremate in basso e minimo sviluppo in altezzadella lancetta",mentre nelKymation-Eckemolto corroso attribuitoall'altarele foglie mostranogià una leggera rastremazione della punta e un maggiore sviluppo dellaIancetta'";un analogodisegno si ritrova a Iasos, colkyma 1420429 (Fig. 137).
L'elemento1661730 (Fig. 138) è simile alkyma ionico del Poseidonaltardi Capo Mo-nodendri, dove trova maggiore sviluppol'altezzadella lancetta".
Più recenti sono due elementi non perfettamente conservati, I 662232 e I 662333 , che trovanoconfronto con unkyma ionico da Mileto conservato aBerlino?". L'ambito cronologico di questemodanature dov rebbe essere analogo a quello del tempio «A» diParos'",per altro verso didiversa tradizione esecutiva, che presenta la lancetta che non sale oltre i due terzi dell' altezza. La
26 Hahland 1964, 146 ss.27 Buschor 1957, 6 fig. 5.1.28 Buschor 1957, 6 fig. 4 e 5.2.29 lnv. 4204 (a, b, c), calcare grigio chiaro locale. Dimensioni (in mm): H 209 (a+b), 110 mx (c); L 870 mx (a+b), 200
mx (c); P 400 mx (a+b), 170 mx (c).30 Inv. 6617, calcare grigio stratificato locale. Dimensioni (in mm): H 184 (189 con la sporgenza della foglia);L 943
mx; P 410 mx.J1 Gerkan 1915, lO ss. tav. V.I e XIV.32 Inv. 6622, marmo insulare a grana evidente. Dimensioni (in mm): H 191; L 482 mx; P 380 mx.33 Inv. 6623, marmo insulare a grana molto evidente. Dimensioni (in mm): H 181; L 410 mx; P 330 mx.J4 Hahland 1964, fig. 92.J5 Gruben 1982b, 217 ss.
223
IONISCHE KUN ST UND ' IONISMEN' 11\1 W ESTEN: ARCHITEKTUR UND D ACIITERRAKOTTEN
modanaturadi Parossarebbecontemporaneao poco piùantica della analoga moda-natura realizzata nel tesorodei Sifni a Delfi".
Un elementoconservatounicamentenella parte supe-riore, 1669437 , sembra col-
Fig. 138: Il kyma ionieo I 6617 esposto nell'antiquarium di Iasos locarsi alla fine della serie
per il disegno ricostruibiledella foglia, chepresenterebbeuna formadiscretamenteappuntita.Successivialle modanaturediIasos, anche se non di molto, sembrano gli elementi ritrovati a Labraunda, che attestano latrasmissionedei modelli ionici anche nelle aree interne dellaCaria".
Kyma ionico II - Il profilo della modanaturaha lamassimasporgenzacirca a metà altezzaoppure più in basso,l'altezzadella foglia è grosso modo analoga alla sualarghezzae la lancettaè di modesto sviluppo. Il tipo, oltre che negli altaricircolari, è adoperato anche inmodanaturerettilinee, probabilmenteanch'essepertinentiad altari.È diffusamenteattestato a Didyma, sia pergli elementi rettilinei provenienti dallaOstterrasse sia per altri frammenti di minoridimensioni'" ,e anche ad Efeso si hanno alcuni frammenti di questo tipo" .
Il frammento I 66384 1 (Fig. 139), di grandi dimensioni, trova confronto per la strutturagenerale della foglia con unkyma attribuito all 'Artemision di Efeso" e con quelli di minoridimensioniscolpiti su alcuni altari circolari di Mileto'": Un altare dello stesso tipo di Mileto, perla più accentuatarotondità dell'estremitàdella foglia" , sembra esserecontemporaneoal piùrecente dei frammenti di Iasos, I 669545
•
Astragali - Due elementiframmentarima interamentericostruibili nel disegnocomplessivo,uno provenientedal quartierea sud del teatro, I 101046 , e l'altro erratico, I 660547 , pur presentan-
.do leggeredifferenzedi lavorazione dovrebberofare parte dellamedesimacornice. Il solco diseparazionefra il margine e la foglia non èparticolarmenteaccentuato, il corpo è ristretto rispettoall'altezzae i margini hanno profilo curvilineo oleggermentesquadrato. Questecaratteristichecifanno collocare i frammenti all'inizio della serie,confrontabili con gli analoghi elementi delPoseidonaltardi CapoMonodendri" e ai frammenti attribuitiall'Artemisionarcaico diEfeso".Un frammento provenienteda uno stratosuperficialedell'agorà,1207250 , è riconducibile aiprecedenti.
La modanaturaad astragali relativa ai frammentiinventariati con 1420351 (Fig. 136) ènotevolmentedifferente. Laseparazionefra corpo e margineè marcata, la larghezza del corpoè
36 Daux - Hansen 1987, 162 ss. e 241 ss.37 Inv. 6694, calcare compatto grigio chiaro locale. Dimensioni (in mm): H 87 mx; L 165 mx; P 79 mx.38 Thieme 1993, 47 ss., figg.3-8, tav. IX.39 Knaekfuss 1941, 148 ss. tavv. 224-226; Hahland 1964, 168 fig. 25.40 Hogarth 1908, 270 ss. fig . 82, Atlas tav. IX e X.41 Inv. 6638, calcare compatto grigio chiaro locale. Dimensioni (inmm): H 130 mx; L 275 mx; P 210 mx.42 Hogarth 1908,270, Atlas tav, IX .43 Koenigs 1996, 143, numero 2, fig. 2.44 Busehor 1957, lO fig. 8.145 Inv. 6695, calcare compatto grigio chiaro locale. Dimensioni (inmm ): H 100 mx; L 170 mx; P 150 mx.46 Inv. 1010, calcare compatto grigio chiaro locale. Dimensioni (in mm): H 86 mx; L 230 mx; P 135 mx.47 lnv . 6605, calcare compatto grigio chiaro locale. Dimensioni(in mm ): H 83 mx; L 207 mx; P 150 mx.48 Gerkan 1915, lOSS. tav. V.1, XII e XIII.49 Hogarth 1908,267ss,fig. 78, Atlas tav. V.50 Inv. 2072, calcare compatto grigio chiaro locale. Dimensioni (inmm): H 77 mx; L 99 mx; P 30 mx.51 Inv. 4203 (a, b, c), calcare compatto grigio chiaro locale. Dimensioni (inmm): H 273 (a), 272Cb), 210 (c); L 254
mx (a), 310 mx (b), 250 mx (c); P 620 (a), 370 (b), 520 (c).
224
AREE DI CULTO ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DJ PERIODO ARCAICO A IASOS(FEDE BERTI - NICOLÒ MASTURZO)
analoga all'altezza, i margini presentanounprofilo con sezione aleggeracuspide. I datiformali indicanola posterioritàdi questi fram-menti rispettoai precedenti,con unintervallodi tempoprobabilmenteconsistentefra la rea-lizzazionedelle due serie. Lamodanaturapiùrecente sembra essere più antica, ma non dimolto, degli astragali adoperati nel tesaurosdei Sifni aDelfi? e agli elementiattribuiti adun altare a Paros'" .
Terminazioni di Pilastro - Una serie diWangenpfeilerkapitelle,o terminazionidi pi-lastro anta a volutesovrapposterinvenuta a Fig. 139: Il frammento dikyma I 6638
Didyma'", caratterizzatacome per un analogoelemento di Iasos da volutemorbidamenteconvessee da un identicotrattamentodel margine edell' occhio, furonoprobabilmenteprodotti da unamedesimaofficina. L'elementodi Iasos" (Fig.140) sidifferenziasia per ledimensioni,la volutasuperiore(Figg. 141 e 142) è alta cm 9,5 (circaun terzo di piede) mentre a Miletol'altezzaè di cm 14,5 (circa mezzo piede), sia per iltrattamentoquasi miniaturistico del lato (Fig. 143), decorato a registrisovrappostidi foglie lanceolate,
I 3832 fronte dellavoluta
セ セ -=nセセ セセ ィセ セ セL↓ ャ ャ イM
JlI 3832 lato dellavoluta
Piantadell'elementoI 3832
Fig. 140: Disegno in proiezioni ortogonali del frammento13832di una terminazione di pilastro anta(il disegno in piantaè ridotto a 112 rispetto ai prospetti)
52 Daux - Hansen 1987, 79 ss.; 155 ss.53 Gruben 1982a, 184 ss. figg. 25-29.54 Knackfuss 1941, 142 ss.; Hahland 1964, 146 ss. nn. 1-4. fig.55 Inv. 3832, marmo. Dimensioni (in mm): H 114 mx; L 244 mx; P 377 mx.Bib1.: Laviosa 1978, 1097 tav. 349, fig.
9; Laviosa 1985, 51.
225
IONISCHE KUNST UNO 'IONISMEN' 1M WESTEN: ARCHITEKTUR UNO DACHTERRAKOTTEN
Fig. 141: Particolare della voluta del frammento13832 Fig. 142: Particolaredell'occhiodella voluta delframmento I 3832
Fig. 143: Lato della voluta del frammento I 3832
quando gli altriesemplarinoti dello stesso tipo hanno il latocompletamenteliscio, anche se inquesti ultimi non si puòescludereun trattamentopuramentepittorico, ora scomparso,delladecorazione.Dei frammenti in poros attribuiti ad un capitello d'antaritrovati a Samo, proba-bilmente più antichi56 , presentanouna decorazionea embricaturadi foglie tonde stilizzate,realizzatesu registri sfalsati mediantedue incisioni concentrichesemicircolari a compasso'",secondouna tradizione decorativache non ritroviamo negli elementi più recenti. Il motivodecorativoa foglia lanceolatatrova un piùprecisoconfrontocon unframmentoattribuito ad unasfinge-acroteriodel Rhoikostempeldi Sarno".Se a Samo iltrattamentoprivilegia il netto staccodelle foglie da unregistroall'altro a Iasos la foglia èscolpitain manierada esaltarnela minuziachiaroscurale,con unaintenzionedecorativache ci sembrarichiamarei monumentiscultorei deltardo arcaismo.
Da Samo proviene un elementoanalogo a quelli di Mileto e di Iasos, ma dimaggioridimensioni e con unalavorazionepiù secca.L'elementodi Samo per la scarsaaccuratezzad'esecuzione,indicatadalle irregolaritàdi lavorazionedel bordo della voluta,sembraessere unareplica locale di un modello di successodell'areamilesia'". Posterioreè un capitello d'antasempre daDidyma, di pieno V secolo come indica il disegno delkyma ionico, dalmarginedellefoglie ben diviso dal corpo e lalancettaa tutta altezza'" .
56 Un trattamento analogo del motivo si ritrova nei frammenti dell' Acropoli attribuiti allo «Hekatompedon» delsecondo quarto del VI sec. a.C; v. Wiegand 1904, 23 ss. fig.38-42, tav. III, e 88 ss. fig.94-95, tav. V; Travlos,Athen 258.
57 Kienast 1989, 257 ss.58 Buschor 1957,3fig. 2.2.59 Ziegenaus1957,93ss. fig. 100-101,tav. XII.60 Hahland1964,176ss. nn. 5. figg.32-34.
226
AREE DI CULTO ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PERIODO ARCAICO A IASOS(FEDE BERTI - NICOLÒ MASTURZO)
Per quantoriguardail tipo, è facile notare che tutti iblocchiconosciutipresentanouna stessaforma: in piantail blocco non èparallelepipedoma mostrasempre unaaccentuatarientranzaperl'incastrodi un altro blocco,inoltre si ha un leggero gradino nella parete di questarientranzacheprobabilmentedovevafacilitare l'appoggiodi un ulterioreelementopiano orizzontale,forse unalastra. Sel'hidria di Busiris indica unapossibilecollocazionedi questielementia volute sovrap-poste?", sonoulteriormenteda chiarire le loro effettive modalitàdi montaggioe l'aspettoarchi-tettonicocomplessivodei monumentiin cui trovavanoposto".
Conclusioni
Il materialedi Iasos quiesaminatorientranelle produzionidelle maestranzeattivenell'areaionicanel periodoanteriorealla rivolta del 499 a. C. Inquest'arearicorrono delle caratteristichenellalavorazionedei kyma ben distinguibili da alcuni altri esempiprovenientidalla vicina regioneinsulare, nella quale la fogliapresentaproporzionipiù allungatee appuntite'? . Se per lasculturasono attestati deirapportidiretti fra laIoniae le isole, con opere dinotevolefamaeseguiteproprioa Iasos da autori chioti(<<Bupalus et Athenisvel clarissimi in ea scienti ... Ostendumet IasiiDianammanibuseorum factam»,Plinio NH 36, 4,13)64,probabilmentelegati anche alsantuariodi Delo pertradizionefamiliare, laformazionedei modelli architettonicidovetteavvenireinveceprevalentementein ambito regionale, nei grandi santuari di Samo, Efeso e Mileto. In questifiorenti centri religiosi si consolidavala prassiesecutivadelle maestranze,attraversol'impegnoin monumentalirealizzazioniarchitettoniche,volte a tramandarela fama delsantuarioanche inregioni lontane e a rimarcarela ricchezzadella città su cuigravitavano.Se èmaggiormenteconosciutal'architetturadei grandi santuari, laripresadi modelli esecutivisimili nelle città menoimportantifa ritenereche imonumentipiù famosi fornissero i modellicompositividi riferimento,recepiti dalle maestranzeanche per lerealizzazionidi minore impegnoarchitettonico.
I rapporti dell'areaionica con le regioni del Mar Neroattraversole colonie milesie e conl'Occidentesono allo stato dellaricercaancora davalutarenella loroeffettivaportataper quantoriguardala trasmissionedei modelli architettonici.Se perHistria si ha uno studio accurato delmateriale architettonico di periodo arcaico'? che consentedi collocarlo in una fase di tardainfluenzaionica, alla fine del VI secolo e nel primoventenniodel secolo seguente, per le altrecittà, come peresempioPanticapeo,dalla qualeprovienel'interessantematerialeconservatoalmuseoPuschkindi Mosca,si ha unamaggiorecarenzadocumentaria.Per l'Occidentei rapportisembranomeno diretti emediati da altre tradizioni, secondo quanto mette in luce, sempre inquesta sede, lo studio di B.Barletta.
A Iasos lacreazionedella statuadi culto di Artemide'", riconducibileattorno al terzo quartodel VI secolo", e 1'attestazionedi vari elementiarchitettoniciche sipossonocollocarefra il terzoventennioe la fine del secolo,indicanosia lapromozionedel culto della deaattraversoun'operacapacedi acquistareuna famaregionale,interventoche seppurelegato probabilmentead unaritualitàsub divonon dovevaesseredisgiuntoda unconsonoinquadramentoarchitettonico,sia ungenerale rinnovamento monumentale, orientato soprattutto per questo periodo alla zonadell'istmo e alle suevicinanze. Per quantoriguarda l'abitato nel suo complesso,una letturasommariadei restirinvenuti negli scavi fasupporreuna suaestensionegià entro i limiti in seguito
61 Knackfuss 1941, 143; Hahland 1964, 160 ss.62 Per un suggerimento su una possibile proposta di ricostruzione, anche se riferibile ad un altare che presenta un
sistema decorativo completamente differente, si veda Étienne - Fraisse1989,459ss.63 Gruben - Koenigs1968,217fig. 23; Gruben - Koenigs 1970, 142 fig. 9a; Gruben1982,217ss. fig. 11 e 14.64 Si veda supra a p. 217.65 Theodorescu 1967, 95 ss.66 Si veda supra a p. 217 s.67 Per la contemporaneità di Bupalo e Ateni conil poeta Ipponatte, vissuto verso la LX olimpiade (Plinio NH 37, 4,
11), circa 540-537.
227
IONISCHE K UNST UNO 'IONISMEN' 1M W ESTEN: ARCHITEKTUR UNO D ACHTERRAKOTTEN
segnati dalle mura di periodo ellenistico, con una maggiore concentrazione, probabilmente, nellearee vicine agli approdi e, forse, la presenza di alcuni nuclei abitativi sparsi nel vicinoentroterra.
La fase conflittuale delle comunità greche con la Lidiaprimae con la Persia in seguito, nonsembrainfluir e sullo sviluppo della città per tutto il secolo,probabilmenteper la sua collocazione,di fatto , nell'area di influenza politica di Mile to' ", indicata anche dalla trasmissione, o forseformazione, della notizia del ruolo avuto dalla città vicina nella sua fondazione (Polibio XVI 12,2)69.Questo momento, che si può considerare il più splendido della città per ricchezza (<<1taÀ,ato-1tÀ,O\Ytoç;», Tucidide VIII 28, 3) e fama delle realizzazioni artistiche , sembra non trovare riscontrosuccessivamente, oltre che per le ovvie diff icoltà causate dalle guerre persiane, a causa dellaconcentrazione dei commerci nei grandi centri della Ionia, Mileto edEfeso,dell'unificazionedella Caria sotto la signoriaecatornnidee dello sviluppo, forse anche a seguito di sinecismi, dicentri concorrenti,come proprio sul lato opposto del«To ouc òvK6À,nov» (Tucidide VIII 26, 2;cfr. Polibio XVI 12, 1) avvenne conBargylia?".
(N. M.)
Bibliografi a
Angiolillo 1995
Asheri 1988
Berti 1992
Blumel 1985Bruneau 1970
Buschor 1957Cipriani 1988
Cipriani - Ardovino 1991
Daux - Hansen1987
Étienne - Fraisse 1989
Fabiani 1997
Gerkan 1915Greco 1988Gruben 1982aGruben 1982bGruben - Koenigs 1968Gruben - Koenigs 1970
Gusmani 1988Hahland 1964Hogarth 1908
S. Angiolillo, La città di Iasos e la sua scultura, in: Iasos di Car ia. Un contributo ferraresealla archeologiamicroasiatica. Progetti di lavoro e restauro (Ferrara 1995) 85 ss.D. Asheri, A propos des sanctuairesextraurbains en Sicile et Grande-Grèce : théories ettémoinages, in: Mé langes Pierre Lévequel. Centre de Recherches d'Histoire Ancienne -Annales littèraires del'Université de Besançon, 367 (Paris 1988) I ss.F. Berti ,MissionArchéologique Italienne de Iasos: compte rendu des travaux de 1991, in:XIV . Kazi Sonuçlari Toplantisi,n (Ankara 1992) 91 ss.W. Bliimel, Die Inschriften von Iasos (Bonn 1985).Ph. Bruneau, Recherches sur les cultes deDélosà l' époque hellenistique et à l'époqueimpériale (Paris 1970).E. Buschor, Altsamischer Bauschmuck AM 72, 1957, 1 ss.M. Cipriani, Il culto di Demetra nella chora pestana: lo scavo del santuario di Albanella,Atti CMGr 27, 1987(Taranto1988) 430 ss.M. Cipriani - A. M. Ardovino, Il culto di Demetra nella chora pestana, in: Anathema.Regime delle offerte e vita dei santuari nel Medi terraneo antico, Atti del convegnointernazionale a cura di G. Bartoloni, G. Colonna,C. Grottanelli, Roma 1989 (Scienz edell 'Antichità 3/4, 1989/90) 339-351.G. Daux - E. Hansen, Le tresor de Siphnos, FdDn. Topo graphie et architecture (Paris1987).R. Étienne - Ph. Fraisse, L' autel archaique del'Artemision de Délos, BCH 113, 1989,451 ss.R. Fabiani, Diodoro XIII 104,7 e la presunta distruzione di Iasos del 405 a.c., PP 293,1997, 81 ss.A. von Gerkan, Milet lA. Der Poseidonaltar bei Kap Monodendri (Berlin 1915).G. Greco, Il santuario di Capodifiume, Atti CMGr 27, Taranto1987 (1988) 423 ss.G. Gruben, Naxos und Paros l, AA 1982, 161 ss.G. Gruben, Der Burgtempel A von Paros, AA 1982, 197 ss.G. Gruben - W. Koenigs, Der 'Hekatompedos' von Naxos , AA 1968, 693 ss.G. Gruben - W. Koenigs, Der 'Hekatompedos'von Naxos und der Burgtempel von Paros,AA 1970, 135 ss.R. Gusmani, Karische Beitrage, Kadmos 27/2, 1988, 145 ss.W. Hahland, Didyma im 5. Jahrhundert v. Chr., JdI 79, 1964, 142 ss.D. G. Hogarth, British Museum . Excavations at Ephesus. The Archaic Artemisia (London1908).
68 Il conflitto fra regno di Sardi e Mileto si prolungò nel tempo senza registrare , per quanto tramandato, episodiparticolarmente cruenti e terminò con Aliatte a seguito di un accordo di ospitalità ed alleanza (Erodoto l 22, 4),confermatoin segui to da Ciro (Erodoto l141,4).
69 Cfr. La Rocca1985, 39. La tradizioneè stata fatta anche risalire alla fase finale del periodo miceneo, v.Laviosa1978, 1099.
70 Si veda la voce relativa in EAA II Suppl.1971-94 (A. Viscogliosi).
228
AREE DI CULTO ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PERIODO ARCAICO A IASOS(FEDE BERTI - NICOLÒ MASTURZO)
Johannowsky1985Kienast 1989
Knackfuss1941Koenigs 1996La Rocca1985
Landolfi 1985Laumonier 1958Laviosa 1972/73
Laviosa 1978
Laviosa 1985Lebrun 1994
Levi 1961/62
Levi 1965/66Levi 1967/68Levi 1970
Levi 1985Picard 1922
Pierobon1987
Pirenne-Delforge 1994
PuglieseCarratelli 1967/68
PuglieseCarratelli 1986PuglieseCarratelli 1991
Robert 1971Rolley 1965
Servais1980Sokolowsky 1955Studi 1985Theodorescu1967
Thieme 1993
Wiegand 1904
Ziegenaus1957
W. Johannowsky,Appunti sul santuariodi Demetere Kore, in:Studi 1985,55ss.H. J. Kienast, EinverkanntesAntenkapitell aus demHeraion von Samos,IstMitt 39,1989, 257 ss.H. Knackfuss,Didyma I (Berlin 1941).W. Koenigs, «Rundaltare.aus Milet, IstMitt 46, 1996, 141 ss.E. La Rocca,Mileto e Iasos nel VII secolo a.C: un'oinochoedel «Middle Wild GoatStyle 1», in: Studi 1985, 35 ss.M. Landolfi, La stipe votiva del santuariodi Zeus, in: Studi 1985, 59 ss.A. Laumonier,Les cultesindigènesen Carie,BEFAR (Paris 1958).C. Laviosa,Un rilievo arcaico di Iasos e ilproblemadel fregio neitempli ionici, ASAtene34/35, 1972173, 397 ss.C. Laviosa,Les fouilles de Iasos, in:Proceedingsof the Xth InternationalCongressofClassicalArchaeology,II (Ankara 1978) 1093 ss.C. Laviosa,Il santuariodi Zeus Megistose il suo kouros arcaico, in: Studi1985,47ss.R. Lebrun,Syncrétismeet cultesindigènesen AsiemineureMéridionale,Kernos7, 1994,145 ss.D. Levi, Le dueprimecampagnedi scavo a Iasos(1960-1961),ASAtene23/24 n.s., 1961/62, 505 ss.D. Levi, Le campagne1962-64a Iasos,ASAtene27/28 n.s.,1965/66,401ss.D. Levi, Gli scavi di Iasos,ASAtene29/30n.s., 1967/68,537 ss.D. Levi, La MissionArchéologiqueItaliennede Iasos,TurkAD 17/2, 1969(Ankara1970)117 ss.D. Levi, Venticinqueanni di scavi a Iasos, in:Studi 1985, 1 ss.Ch. Picard,Ephèseet Claros.Recherchessur lessanctuaireset les cultes del'Ionie dunord, BEFAR (Paris 1922).R. Pierobon,La ceramicae la vita della città: lecoppea rilievo ellenistiche,in: Studi1985, 83ss.V. Pirenne-Delforge,La loutrophorieet la «pretresse-Ioutrophore»de Sicyone,in: L'eau,la santé et lamaladiedans lemondegrec, Actes ducolloqueCNRS, 25-27nov. 1992 (aC. di R. Ginouvés,A.-M. Guimier-Sorbets,J. Jouanna,L. Villard), BCH Suppl 28 (1994)147 ss.G. PuglieseCarratelli, Supplementoepigrafico di Iasos, ASAtene 29/30 n.s.,1967/68,437 ss,
G. PuglieseCarratelli, Cari in Iasos,RendLinc40, 1986, 149 ss.G. PuglieseCarratelli,Decreti di Iasos in onore di giudicistranieri,RendLinc44, 1991,47 ss,J. Robert- L. Robert,Bulletin Epigraphique1971,500ss.C. Rolley, Le sanctuairedes dieuxpatrooiet le thesmophoriondeThasos,BCH 89, 1965,441 ss.J. Servais,Les deuxsanctuairesd'Aliki, in: Aliki I, ÉtudesThasiennesIX (1980) 1ss,F. Sokolowsky,Lois sacréesde l'Asie Mineure(Ecole Françaised'Athènes)(Paris 1955).Aa.Vv., Studi su Iasos di Caria, suppl. al BdA 31132, 1985.D. Theodorescu,Remarquessur la compositionet la chronologiedu kymation ioniquesuscitéespar quelquesexemplairesdécouvertsà Histria, Dacia 11, 1967, 95 ss.Th. Thieme, The architectural remains of archaic Labraynda, in: Les grands ateliersd'architecturedans le mondeegeén du VIe siec1eavo J.c.,Actes ducolloqued'Istanbul,23-25 mai 1991 (aC. di l des Courtils, l-Ch. Moretti). Varia Anatolica 3 (Paris 1993)47 ss,Th. Wiegand,Die archaischePoros-Architekturder Akropolis zu Athen (Cassel-Leipzig1904).O. Ziegenaus,Die Tempelgruppeim Nordendes Altarplatzes,AM 72, 1957, 87ss,
229