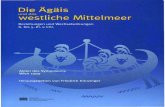F. Berti, N. Masturzo, Aree di culto ed elementi architettonici di periodo arcaico a Iasos (Caria)
BERTI G., CAPELLI C., CABELLA R. (2009), Le importazioni dalla Penisola Iberica (Al-Andalus) e dalle...
Transcript of BERTI G., CAPELLI C., CABELLA R. (2009), Le importazioni dalla Penisola Iberica (Al-Andalus) e dalle...
Parole chiave: Ceramiche islamiche (X-XII secolo); Bacini di Pisa; Analisi in sezione sottile.Riassunto: Le ceramiche islamiche (X-XII sec.) provenienti dall’al-Andalus e dalle Isole Baleari rinvenute tra i “bacini” di Pisa, appartenenti ai tipi “verde y manganeso”, “cuerda seca total” e “lustro metallico”, sono state riprese in esame inte-grando l’analisi archeologica con quella archeometrica in mi-croscopia ottica degli impasti e dei rivestimenti, costituiti da vetrine piombifere trasparenti od opacizzate con stagno. Per lo studio in sezione sottile sono stati utilizzati sia campioni già presenti nella banca dati di Genova, sia nuovi campioni selezionati, relativi non solo a ceramiche importate a Pisa, ma anche a materiali di riferimento provenienti dalla Spagna. Le nuove analisi, evidenziando la presenza di impasti differenti per composizione e tecnica, confermano l’ipotizzata molteplicità di centri produttivi nella Spagna meridionale.
Palabras clave: Cerámicas islámicas (siglos X-XII); Bacini de Pisa; análisis de lámina delgada.**** Resumen: Se analizaron cerámicas islámicas (de los si-glos X al XII d.C.) procedentes de la Península Ibérica y de las Islas Baleares, encontradas en yacimientos arqueológicos en Pisa y alrededores, incluyendo tipos conocidos como “verde y manganeso”, “cuerda seca total” y reflejo dorado, usando un sistema que integraba tanto los análisis arqueológicos como la arqueometría, específicamente a través de un microscopio óptico, tanto de la pasta como de los vidriados transparentes plumbíferos o de los estanníferos opacos. Los análisis de lámina delgada se hicieron tanto en viejas muestras de la base de datos genovesa como en nuevos ejemplares selectos tanto de cerá-micas importadas desde Pisa como de material de referencia español. Dado que indican la presencia de diferentes pastas y técnicas, estos análisis confirman la hipótesis de que el sur de España alberga abundantes centros de producción.
le importazioni dalla Penisola Iberica (Al-Andalus)e dalle Isole Baleari tra i bacini di Pisa
(secoli x-xII)
Graz ie l la Ber t i , C laudio Capel l i , Rober to Cabel la
Key words: Islamic pottery (10th - 12th centuries AD); Ba-cini from Pisa; thin section analyses.***Abstract: Islamic pottery (from the 10th to the 12th cen-turies AD) from the Iberian peninsula (al-Andalus) and the Balearic Islands found in archaeological sites in and around Pisa, including pieces known as green and manganese (verde y manganeso), “cuerda seca total”, and “metallic lustre”, were ex-amined using an approach that integrated both archaeologi-cal analysis and archaeometrics, specifically through an opti-cal microscope, of both the paste and the transparent lead or tin-opacified glazes. Thin section analyses were done both on old samples taken from the Genoa database and selected new samples of both ceramics imported from Pisa and reference material from Spain. Because they indicate the presence of different pastes and different techniques, these new analyses confirm the hypothesis that southern Spain had a host of pro-duction centres.
Mots clés : céramique islamique (Xe - XIIe siècles); “Bacini” de Pise; analyses de sections fines.**Résumé : La céramique islamique (du Xe au XIIe siè-cles) provenant de la péninsule ibérique (Al-Andalus) et des îles Baléares, qui a été découverte dans des sites archéologi-ques de Pise et de ses alentours et qui comprend des pièces de type ‘vert et manganèse’ (verde y manganeso), cuerda seca total et ‘lustre métallique’, a été examinée moyennant des analyses archéologiques et archéométriques, notamment au microscope optique, de la pâte et des couvertes plombifères translucides ou opacifiées à l’étain. Des analyses de sections fines ont été réali-sées sur de vieux échantillons de la base de données de Gènes mais aussi sur de nouveaux échantillons de pièces importées et trouvées à Pise et de matériels de référence d’Espagne. Ces nouvelles analyses, qui indiquent la présence de pâtes et de techniques différentes, confirment l’hypothèse de l’existence de centres de production au sud de l’Espagne.
*
Via N. Sauro 9,56123 PISA (Italy)e-mail: [email protected]
81Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval. Ciudad Real ( 2009 ) TOMO I / 81-88
*
1. Premessa. Il progredire delle conoscenze, con l’avanza-
mento delle indagini archeologiche in vari luo-ghi, ha reso sempre più evidente che per caratte-rizzare in modo preciso le particolari produzioni
ceramiche dei singoli centri produttivi non sono sufficienti le normali classificazioni, impostate sui caratteri morfologici e decorativi dei relativi og-getti. Queste, infatti, devono essere affiancate da informazioni concernenti le tecnologie impiegate
82 G. BERTI et alii: le IMpORTAzIOnI dAllA penIsOlA IBeRICA (Al-AndAlus) e dAlle IsOle BAleARI TRA I BACInI dI pIsA...
LERA & VENDRELL-SAZ, 2001; CHAPOULIE & alii, 2005):
• i rivestimenti vetrosi sono piombiferi (traspa-renti = vetrine; opacizzati con stagno = smalti);
• tali coperture sono stese su corpi ceramici già cotti (“biscotti”) e fatte vetrificare tramite una se-conda cottura (una triplice cottura è impiegata solo per tecniche particolari come quella del “lustro metallico”);
• in nessun caso è stato riscontrata l’interposizione di uno strato di “ingobbio” tra corpo ceramico e rivestimento vetroso (per il significato del termine “ingobbio” cfr. BERTI, CAPELLI & MANNONI, 2001. Per differenti tipi di “ingobbio” vedere anche BERTI, CAPELLI & GELICHI, 2006);
• è molto frequente l’impiego di rivestimenti vetrosi diversi sulle due superfici dei recipienti.
Senza ritornare sui problemi relativi alle data-zioni (cfr. per ultimo BERTI & GARCIA PO-RRAS, 2006), all’interno di una panoramica più ampia, che comprende altri prodotti della medesi-ma area, insieme a manufatti di provenienze diverse, sono stati scelti tre gruppi, tecnicamente uniformi, per i quali le provenienze vengono ipotizzate sulla base dell’integrazione dei risultati delle analisi sia tipologiche, sia archeometriche.
2.1. Le ceramiche in “Verde y Manganeso”.Otto “bacini”, inseriti sulle pareti delle chiese
di S. Piero a Grado e di S. Zeno in Pisa nell’ultimo quarto del X – primo quarto dell’XI secolo, appar-tengono alla categoria delle ceramiche smaltate po-licrome.
Tali manufatti, pur presentando tutti la super-ficie interna decorata in verde e in bruno (Cu + Mn), su un fondo a smalto stannifero bianco, e que-lla esterna rivestita da una vetrina piombifera, pro-vengono da almeno tre centri differenti.
2.1.1. I prodotti di Palma di Majorca (“bacini” nn. 18, 19, 53, 59, 62 e 11) 1.La provenienza di queste ceramiche (BER-
TI & TONGIORGI, 1981: 191-193) da Maiorca fu già riconosciuta negli anni Ottanta del secolo scorso (BERTI, ROSSELLÓ-BORDOY & TON-GIORGI, 1986). Già allora furono prelevati a Pal-ma di Maiorca, per un confronto, dieci campioni di prodotti locali. In quella occasione furono eseguiti anche dettagliati esami sui tipi morfologici e su-lle decorazioni. Sono attualmente a disposizione le
e la composizione delle materie prime utilizzate, e tali dati non si possono acquisire con un semplice esame macroscopico, ma soltanto attraverso idonee analisi di laboratorio.
Per raggiungere risultati soddisfacenti, che pre-vedono una risposta ad un numero non indiffe-rente di quesiti atti a caratterizzare le specifiche provenienze, sarebbe così auspicabile fare interagi-re sempre, durante ciascuna fase della ricerca, gli approcci archeologici e quelli archeometrici.
Se l’utilità di impostare le indagini in questa ot-tica era già evidente almeno ad una parte degli stu-diosi fino dagli anni Sessanta - Settanta del secolo scorso (cfr. ad esempio MANNONI, 1972; 1979; ARIAS & BERTI, 1973; ARIAS, BERTI & LI-VERANI, 1973; BERTI & TONGIORGI, 1981: 287-289), l’impossibilità di riuscire a pianificare delle ricerche sistematiche ha reso slegati tra loro i parziali risultati conseguiti nel corso del tempo.
Comunque, pur consapevoli di tale fatto, ogni volta che si presenta l’opportunità non ci lasciamo sfuggire l’occasione di riprendere in esame gruppi di ceramiche particolarmente interessanti, e a tal fine vengono esaminate, sulla base delle odierne conoscenze, sezioni sottili sia di vecchi campioni appartenenti alla banca dati conservata presso il DipTeRis dell’Università di Genova (iniziata già negli anni Sessanta da Tiziano Mannoni), sia di nuovi campioni.
In questa ottica, nel presente contributo viene proposta una revisione dei dati relativi a ceramiche fabbricate nella Penisola Iberica (al-Andalus) e ne-lle Baleari, importate a Pisa tra la fine del X secolo e il primo quarto del XII, impiegate come “bacini” nella decorazione architettonica.
2. I prodotti della Penisola Iberica (Al – Andalus) e delle Baleari tra i “Bacini” di Pisa (ultimo quarto x – primo quarto xII secolo). Le ceramiche pervenute a Pisa da queste aree
del Mediterraneo, nel periodo indicato, sono pro-dotti di centri diversi tra loro, come chiaramente attesta la varietà degli impasti e di alcune caratteris-tiche dei rivestimenti (da mettere in relazione con l’impiego di materie prime e tecniche di lavorazio-ne differenti). Pur tuttavia le stesse ceramiche pre-sentano alcune caratteristiche in comune (per ana-lisi approfondite su alcuni tipi di rivestimento cfr. anche PEREZ, SOTO & RAMON, 1999; MO-
83Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval. Ciudad Real ( 2009 ) TOMO I
sezioni sottili dei bacini di Pisa nn. 11 (3296), 18 (3297), 19 (3298) e 59 (3299) e di otto campioni di Maiorca (1/6006-8/6013).
L’insieme dei dodici campioni costituisce un gruppo piuttosto omogeneo, con uno scheletro ben caratterizzato dal punto di vista petrografico (fig. 1: Pi19, Ma4, Ma7). In genere, la massa di fon-do (< 0.1 mm) è particolarmente ricca di miche fini, mentre il quarzo è subordinato. Le inclusioni delle frazioni maggiori, non molto frequenti, sono costituite da resti di microfossili a guscio calcareo in gran parte dissociato dalla cottura (di dimensioni < 0.2-0.4 mm circa) e da frammenti, più o meno angolosi e di dimensioni talora superiori a 1 mm, di calcari micritici (spesso dissociati) (fig. 1: Ma4), siltiti o areniti ricche di miche simili a quelle della massa di fondo, argilliti ferriche o noduli limonitici e, occasionalmente, vulcaniti feldspatiche micro-cristalline con massa di fondo ossidata (fig. 1: Ma7). La matrice argillosa dell’impasto, di composizio-ne ferrico-carbonatica, è poco o non vetrificata e, tranne in alcuni casi, ossidata omogeneamente in tutta la sezione trasversale.
I rivestimenti vetrosi mostrano di norma una qualità poco elevata. Sono infatti ricchi di bolle e il contatto con il corpo ceramico ha un andamento irregolare. Lo spessore massimo è solitamente infe-riore a 0.2 mm (fig. 1: Pi19).
Su alcune sezioni dei campioni di Maiorca sono evidenti i resti del rivestimento sulla superficie in-terna che, sebbene molto alterato, appare essere sempre costituito da uno smalto stannifero. Sulle superfici esterne troviamo invece sempre una vetri-na piombifera trasparente, che appare generalmente in tonalità giallastre anche intense.
2.1.2. I prodotti di altri centri dell’al-Andalus (“bacini” nn. 2 e 22) 1.Sebbene la tecnica di esecuzione sia eguale ai
precedenti, l’analisi delle sezioni sottili (4513, 6556) di questi due esemplari (BERTI & TONGIORGI, 1981: 167, 193; cfr. anche BERTI & MANNONI, 1995: 435-436) mostra l’impiego di materie prime da un lato decisamente diverse da quelle di Maior-ca, dall’altro anche differenti tra loro.
Il corpo ceramico del n. 2 è costituito da una matrice carbonatica parzialmente vetrificata e da uno scheletro poco abbondante, formato da micro-fossili calcarei dissociati per la cottura (< 0.3 mm), da individui di quarzo e feldspato (< 0.6 mm) e da
frammenti subangolosi di gneiss che raggiungono 1 mm di larghezza (fig. 1: Pi2). Sul frammento ana-lizzato è visibile il rivestimento stannifero presen-te sulla superficie interna, che risulta molto sottile (di spessore omogeneo, circa 0.04-0.06 mm), non alterato e privo di bollosità. Per la vetrina esterna dobbiamo invece rifarci ai dati rilevati sui “bacini” rimossi negli anni Settanta (analisi XRD eseguite da Claudio Arias, in gran parte inedite nei dettagli; cfr. BERTI & TONGIORGI, 1981, p. 287 e scheda a p. 19-20).
L’impasto del bacino n. 22 presenta una ma-trice carbonatico-ferrica ossidata e uno scheletro costituito da una massa di fondo (< 0.1 mm circa) relativamente abbondante, formata da individui di miche, quarzo, feldspati e titanite accessoria, micro-fossili calcarei dissociati e rare inclusioni di dimen-sioni maggiori, costituite da quarzo (< 0.5 mm), resti di micro- e macro-fossili calcarei e litoclasti di calcare micritico (> 1 mm). Si osserva inoltre una discreta quantità di noduli limonitici (fig. 1: Pi22). Il rivestimento non è conservato in sezione sottile.
Si può ipotizzare che i due esemplari analizzati provengano da due fabbriche diverse dell’al-Anda-lus ancora da identificare. In ogni modo, l’attuale revisione permette da un lato di confermare, per il n. 2, la bassa probabilità di un’origine nordafricana (almeno da centri prossimi ad aree desertiche, le cui produzioni sono sempre ben caratterizzate dalla presenza di quarzo eolico; cfr. MANNONI, 1972; CAPELLI 2002-2003), dall’altro di non supportare un’ipotizzata provenienza da Malaga (avanzata in BERTI & MANNONI, 1995: 435), in quanto gli impasti tipici di tale centro sono ben distinti dalla presenza di scisti metamorfici acidi, in particolare filladi e micascisti (MANNONI, 1972; CAPELLI, GARCIA PORRAS & RAMAGLI, 2005).
Al momento disponiamo di pochi materiali per un confronto (forniti da J. Zozaya nel 1983: due reperti da Calatrava e tre da Qal’at Abd-al-Sa-lam; cfr. BERTI & MANNONI, 1987: 168, 171). L’unica sezione sottile disponibile (3294) è rela-tiva ad una forma chiusa da Calatrava, che non mostra precisi confronti con i due bacini di Pisa analizzati. L’impasto presenta una matrice carbo-natico-ferrica ed uno scheletro non molto ab-bondante, subangoloso e mediamente assortito, di dimensioni prevalentemente inferiori a 0.3 mm, costituito essenzialmente da quarzo (rari individui raggiungono 0.7 mm) e feldspati metamorfici. I
84 G. BERTI et alii: le IMpORTAzIOnI dAllA penIsOlA IBeRICA (Al-AndAlus) e dAlle IsOle BAleARI TRA I BACInI dI pIsA...
rivestimenti sono costituiti da uno smalto stanni-fero piuttosto spesso (< 0.3 mm), ricco di opaci-zzante e privo di bolle sulla superficie esterna, e da una sottile (< 0.1 mm) vetrina trasparente sulla superficie interna.
2.2. Le ceramiche a “Cuerda seca Total”.Tra i “bacini” di Pisa si trovano quattro esempla-
ri eseguiti con questa tecnica particolare (BERTI & TONGIORGI, 1981: 163-165). Il n. 6 è ancora in sito sulla chiesa di S. Zeno, dove fu collocato nell’ultimo quarto del X – primo quarto del XI secolo, mentre i nn. 31 e 63, distaccati, furono uti-lizzati nel medesimo periodo per decorare la chiesa di S. Piero a Grado. Il n. 154, invece, proviene dalla chiesa di S. Sisto e il suo impiego risale alla seconda metà o all’ultimo quarto del secolo XI.
Una copertura esterna con vetrina piombifera (trasparente) di colore giallo-bruno, è evidente su tutti gli esemplari rimossi, mentre per eseguire i motivi che figurano all’interno furono impiegati:
a) smalti stanniferi bianchi (impuri) o colorati in verde;
b) vetrina piombifera gialla, simile (o eguale) a quella impiegata sulla superficie esterna.
Le sezioni sottili del n. 31 di S. Piero a Grado (4404) e del n. 154 di S. Sisto (4406), come pure quella di un esemplare del contado di Lucca (4403), collocato su S. Michele di Castello nella seconda metà XI (cfr. BERTI & CAPPELLI, 1994: 56-58, 118-122), mostrano un impasto “generico”, costi-tuito da una matrice carbonatica semi-vetrificata, con rare e fini (< 0.2 mm) inclusioni di quarzo, miche e feldspati e resti di microfossili calcarei dis-sociati (fig. 1: Pi154).
Sebbene sia del tutto probabile la provenienza dei tre bacini da un medesimo centro dell’al-An-dalus, il luogo di fabbricazione non è al momento precisabile.
In archivio è inoltre presente la sezione sottile di una minuscola porzione dell’impasto del n. 63 (4405), impossibile da studiare. L’unico dato deter-minabile è il colore del corpo ceramico, che è rosso e non giallo chiaro come nel gruppo precedente: non si potrebbe escludere, pertanto, una produzio-ne differente.
2.3. Le ceramiche a “Lustro metallico”.Tra i “bacini” di Pisa figura un numero abbas-
tanza consistente di ceramiche decorate a “lustro
metallico”, riferibili a fabbriche dell’al-Andalus. Le prime attestazioni risalgono al primo quarto del XII secolo (BERTI & TONGIORGI, 1981: 262-266).
Già le analisi eseguite negli anni Settanta del secolo scorso a Lione, da Maurice Picon, avevano evidenziato almeno quattro gruppi di argille chi-micamente differenti (cfr. BERTI & TONGIOR-GI, 1981: 288; BLAKE & alii, 1992: 222 (note 63):
1) bacini nn. 241, 232, 218, 190, 165 (alto con-tenuto in Ca, basso contenuto in Fe);
2) nn. 201, 250 (composizione abbastanza si-mile a quella delle ceramiche del così detto “tipo Pula”);
3) nn. 249, 251 (composizione simile alle cera-miche prodotte a Murcia);
4) n. 169 (alto contenuto in Fe).Le superfici interne sono sempre rivestite con
smalti stanniferi bianchi, mentre quelle esterne possono essere coperte di smalto con lo stesso contenuto in Sn di quello interno o più basso, ma anche, addirittura, di vetrina piombifera non opa-cizzata (come, ad esempio, il n.190 - Analisi XRD eseguite da Claudio Arias, in gran parte inedite nei dettagli; cfr. BERTI & TONGIORGI, 1981: 287 e, nello stesso corpus, le schede relative a ciascun “bacino”).
I risultati dello studio delle sezioni sottili di sei esemplari confermano ed integrano quanto emerso dalle analisi chimiche, attestando pertanto l’esistenza, nell’area dell’al-Andalus, di più centri di produzione.
I nn. 165/4422, 190/6555), 218/4423 (Gruppo chimico 1) presentano una matrice carbonatica (nel n. 218 e soprattutto nel n. 190 sono presenti anche discrete quantità di ossidi di ferro diffusi, che fornis-cono all’impasto un colore giallo-arancio). I tre im-pasti (fig. 2: Pi165, Pi190, Pi218) sono relativamente simili (in particolare i nn. 165 e 218). Lo scheletro è prevalentemente fine (< 0.1 mm; max 0.3 mm) e angoloso. Il quarzo è dominante su feldspati e mi-che; nel n. 190 sono conservate inclusioni carbo-natiche (litoclasti calcarei, microfossili e frammenti di macrofossili), non visibili negli altri due impasti (se originariamente presenti, sono state dissociate dai processi di cottura). Il n. 190 si distingue anche per inclusioni più abbondanti (piuttosto scarse negli altri due) e di maggiori dimensioni medie.
Il n. 201/6557 (Gruppo chimico 2) è caratteriz-zato da una matrice carbonatica e da uno scheletro
85Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval. Ciudad Real ( 2009 ) TOMO I
relativamente abbondante, angoloso e di dimensio-ni fino a 0.4 mm, costituito da quarzo dominante su feldspati e frammenti di calcari (dissociati) e rare selci (fig. 2: Pi201). Le miche sono in pratica as-senti.
Il n. 249/4424 (Gruppo chimico 3) mostra una matrice carbonatico-ferrica sinterizzata ed uno
scheletro molto fine (< (0.1 mm) e relativamen-te scarso, costituito da individui di quarzo, miche, feldspati e titanite accessoria e da resti di micro-fossili sia calcarei (foraminiferi), sia silicei (di forma rettangolare molto allungata, indeterminati). Sono inoltre presenti numerosi grumi limonitici (fig. 2: Pi249).
Figura 1. Particolari in sezione sottile di alcuni dei campioni analizzati (area inquadrata: 1.3 x 1 mm; Np in Pi19, Nx nei rimanenti). Ma: scarti di produzione da Maiorca; Pi: Bacini di
Pisa; ca: calcare; fo: fossile; fs: feldspato; gn: gneiss; li: nodulo limonitico; qz: quarzo; sm: smalto stannifero; vu: vulcanite.
86 G. BERTI et alii: le IMpORTAzIOnI dAllA penIsOlA IBeRICA (Al-AndAlus) e dAlle IsOle BAleARI TRA I BACInI dI pIsA...
Il n. 169, infine, è nettamente distinto dagli altri per una matrice ferrico-carbonatica (schiarita verso le superfici) e per uno scheletro molto abbondan-te, angoloso, di dimensioni fino a 0.4 mm (fig. 2: Pi169), costituito da una componente metamorfica acida (frammenti di quarzo-micascisti e filladi, in-dividui di quarzo, miche e feldspati) e da una com-ponente sedimentaria (numerosi microfossili cal-
carei, principalmente foraminiferi, e frammenti di calcari e rare selci). Da notare come alcuni elementi dell’impasto siano confrontabili con quelli caratte-ristici di altre classi ceramiche riferibili all’area di Malaga (CAPELLI, GARCIA PORRAS & RA-MAGLI 2005).
Tra i sei sopra descritti, l’unico campione che conserva i rivestimenti in sezione sottile è il n. 190.
Figura 2. Particolari in sezione sottile di alcuni dei campio-ni analizzati (area inquadrata: 1.3 x 1 mm; Nx). Pi: Bacini di Pisa; ca: calcare; fo: fossile; mi: mica; qz: quarzo.
87Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval. Ciudad Real ( 2009 ) TOMO I
Lo smalto stannifero ha uno spessore medio e re-golare (0.15-0.20 mm) e include rare bolle e relitti di quarzo. Il piccolo tratto di vetrina (trasparente e incolore) presente sull’altro lato è invece di spessore irregolare e comunque molto sottile (< 0.1 mm).
Nuove analisi su altri bacini hanno messo in luce l’esistenza di un gruppo piuttosto omogeneo di impasti, probabilmente riferibili allo stesso atelier o centro produttivo del n. 249 della chiesa di S. An-drea, datato al primo quarto del XII secolo. Si tratta dei n. 161 (6553) del campanile di S. Sisto, coevo al precedente, e dei nn. 275 (6550) e 278 (6551) del campanile di S. Michele degli Scalzi, dell’ultimo quarto del XII secolo (BERTI & TONGIORGI, 1981: 267). Il centro in questione, indipenden-temente dal fatto che si tratti o meno di Murcia, avrebbe quindi prodotto per almeno tutto il XII secolo, utilizzando sempre le stesse materie prime.
Per quanto riguarda i rivestimenti, tratti di smal-to stannifero sono conservati nelle sezioni sottili dei nn. 161 e 278, con spessore rispettivamente basso (< 0.1 mm) e medio (fino a 0.2 mm).
3. Qualche considerazione conclusiva.Sebbene gli esempi riportati siano in nume-
ro abbastanza contenuto, e le analisi siano ancora a livello preliminare, appaiono già sufficienti per attestare una volta di più il significativo contribu-to dell’archeometria in merito alla localizzazione delle aree di provenienza, alla ricostruzione delle tecniche produttive e al miglioramento delle clas-sificazioni tipologiche. Non ci resta altro, a questo punto, che auspicare un’intensificazione delle in-dagini archeologiche e archeometriche integrate anche nei luoghi di produzione.
Referenze Bibliografiche.
Arias & Berti, 1973: ARIAS, C. & BERTI, G.: “L’analisi con fluo-rescenza a raggi X nello studio dei rivestimenti vetrosi di gruppi di ceramiche”, in Albisola, VI, p. 127 - 134.Arias, Berti & Liverani, 1973: ARIAs, C., BeRTI, G. & lIVeRA-NI, G.: “Analisi con fluorescenza a raggi X dei rivestimenti vetrosi monocromi nelle ceramiche egiziane dei secoli XI-XIII”, in Faen-za, lIX, p. 33 - 44.
Berti, Capelli & Gelichi 2006: BeRTI, G., CApellI, C. & GelI-CHI s.: “Trasmissioni tecniche tra XII e XIII secolo nel Mediterra-neo: il contributo dell’archeometria nello studio degli ingobbi”, in Atti IV Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (sAMI), s. Galgano - sI, Firenze, 2006, pp. 455-460. Berti, Capelli & Mannoni 2001: BeRTI, G., CApellI, C. & MAnnOnI, T.: “Ingobbio/ ingobbi e gli altri rivestimenti nei per-corsi delle conoscenze tecniche medievali”, in Albisola, XXXIV, p. 9-15. Berti & Cappelli, 1994: BeRTI, G. & CAppellI, l.: Lucca - Ce-ramiche medievali e post-medievali (Museo Nazionale di Villa Guinigi). I. Dalle ceramiche islamiche alle “maioliche arcaiche”. Sec.XI-XV (Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale, 19-20), Firenze, 312 p.Berti & Garcia Porras, 2006: BeRTI, G. & GARCIA pORRAs, A.: “A propósito de «una necesaria revisión de las cerámicas anda-lusíes halladas en italia»”, in Arqueología y Territorio Medieval, 13.1, p. 155 - 193.Berti & Mannoni, 1987: BeRTI, G. & MAnnOnI, T.: “Cerami-che medievali del Mediterraneo Occidentale: Considerazioni su alcune caratteristiche tecniche”, in A cerâmica medieval no Me-diterrâneo ocidental, IV Congresso Internacional AIECM2, lisboa, Mertola, 1991, p. 163-173.Berti & Mannoni, 1995: BeRTI, G. & MAnnOnI, T.: “Cérami-ques de l’Andalusie decorées en “verde y manganeso” parmi les “bacini” de Pise de la fin du Xe siècle”, in La Céramique Médié-vale en Méditerranée, VIe Congrès International AIECM2, Aix-en provence, Aix-en-provence, 1997, p. 435-437.Berti, Rosselló-Bordoy & Tongiorgi, 1986: BeRTI, G, ROs-sellÓ-BORdOY, G. & TOnGIORGI, e.: “Alcuni bacini ceramici di pisa e la corrispondente produzione di Maiorca nel secolo XI”, in Archeologia Medievale, XIII, p. 97-115.
Berti & Tongiorgi, 1981: BeRTI, G. & TOnGIORGI, l.: I bacini ceramici medievali delle chiese di Pisa. (Quaderni di Cultura Ma-teriale, 3), Roma, 303 p., CCXXIV Tav. Blake & alii, 1992: BlAKe, H., HuGHes, M., MAnnOnI, T. & pORCellA, F.: “The earliest Valencian lustreware? The provenance of the pottery from pula in sardinia”, in GAIMsTeR, d. & Re-dKnAp, M., Everyday and Exotic Pottery from Europe. Studies in honour of John G. Hurst, Oxford, p. 202–224.
Capelli, 2002-2003: CAPELLI, C.: “Ricerche petrografiche pre-liminari sulle ceramiche “eoliche” (2002-2003)”, in BOnIFAY, M., CApellI, C., MARTIn, T., pICOn, M. & VAllAuRI, l., “le littoral de la Tunisie: étude geoarcheologique et historique (1987-1997): la céramique”, in Antiquités Africaines, 38-39, p. 125-202.Capelli, Garcia Porras & Ramagli, 2005: CApellI, C., GAR-CÍA-pORRAs, A. & RAMAGlI, p.: “Análisis arqueométrico y arqueo-lógico integrado sobre azulejos vidriados hallados en contextos des los siglos XIV al XVI en liguria (Italia): las producciones de Málaga y savona”, in CARTA, R. (a cura di), Arqueometría y Ar-queología Medieval (Colección de Arqueología y patrimonio), Granada, p. 117-169.Chapoulie & alii, 2005: CHApOulIe, R., deleRY, C., dAnIel, F. & VendRell-sAz, M.: “Cuerda seca ceramics from al-Andalus, Islamic spain and portugal (10th-12th centuries Ad): Investiga-tion with seM-edX and cathodoluminescence”, in Archaeometry, 47 (3), p. 519-534.
Mannoni, 1972: MAnnOnI, T.: “Analisi mineralogiche e tec-nologiche delle ceramiche medievali. nota II”, in Albisola, V, p. 107 - 128.Mannoni, 1979: MAnnOnI, T.: “Analisi mineralogiche delle ce-ramiche mediterranee. nota VI”, in Albisola, XII, p. 229 - 239.Molera & Vendrell-Saz, 2001: MOleRA, J. & VendRell-sAz., M.: “Chemical and Textural Characterization of Tin Glazes in Isla-mic Ceramics from eastern spain”, in Journal of Archaeological Science, 28, p. 331–340.
Pérez, Soto & Ramón, 1999: peRez ARAnTeGuI, J., sOTO, M. & RAMOn CAsTIllO, J.: “examination of the ‘Cuerda seca’ deco-ration Technique on Islamic Ceramics from al-Andalus (spain)”, in Journal of Archaeological Science, 26, p. 935–941.
88