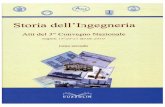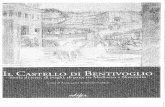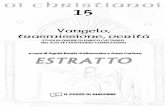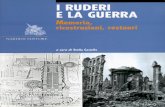A. PANE, Il fiordo di Crapolla nel paesaggio della Penisola sorrentina, in «Arkos», numero...
Transcript of A. PANE, Il fiordo di Crapolla nel paesaggio della Penisola sorrentina, in «Arkos», numero...
SCIENZA E RESTAUROEuro 16,00
NUMERO SPECIALE
Conservazione e valorizzazione
del paesaggio culturale della Penisola sorrentina
IL FIORDO DI CRAPOLLA
Atti della Giornata di studi (Massa Lubrense, 14 novembre 2009)
ISSN 1974-7950 Arkos
Rovine e paesaggio. Il trattamento architettonico dei ruderi
Stefano Gizzi 16
La tutela delle coste di Massa Lubrense nel Piano Urbanistico
Territoriale dell’area sorrentino-amalfitana
Alessandro Dal Piaz 26
La ricerca archeologica in Penisola sorrentina: un contributo
per la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio antico
Tommasina Budetta 29
La salvaguardia dell'ambiente nell’attività dell’Area Marina Protetta
Punta Campanella
Antonino Miccio 40
Il cantiere di San Fruttoso di Camogli (Genova): sintesi di un’esperienza
Claudio Montagni 44
ARKOS
Editoriale a cura di Stella Casiello 3
PERIODICO TRIMESTRALENUOVA SERIE -NUMERO SPECIALEIl Fiordo di Crapolla
IN COPERTINA:Massa Lubrense (Napoli), veduta delpaesaggio lungo la costa meridionale dellaPenisola sorrentina, caratterizzato dallasuccessione di profonde insenature. Sullasinistra, l'isolotto di Isca, posto in prossimitàdel fiordo di Crapolla.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONEEditinera s.r.l.Sede operativa: Largo Antonio Sarti4-5 00196 - RomaTel. [email protected]
DIRETTORE RESPONSABILEAdolfo Pasetti
DIRETTORE SCIENTIFICOClaudio Montagni
CONSIGLIO SCIENTIFICOGiovanna Alessandrini, LorenzoAppolonia, Giorgio Bonsanti, RobertoBugini, Giovanni Carbonara, RobertoCecchi, Maria Antonietta Crippa,Gino M. Crisci, Stefano Della Torre,Maurizio de' Gennaro, DonatellaFiorani, Mauro Matteini, RobertoParenti, Enrico Pedemonte, DanielaPinna, Paolo Scarzella
CORRISPONDENTIMaurizio Berti, Riccardo Forte, FabioFratini, Caterina Giannattasio, ElenaLeoncini, Maurizio Martinelli,AnnaMariaMecchi, Elisabetta Rosina, ValentinaRusso, Pietro Tiano, Marco Zerbinatti
Tutti gli articoli pubblicati- ad eccezione della sezione Flash -sono sottoposti a referaggio da partedella Direzione e del ConsiglioScientifico della rivista.Le norme redazionali per gli Autorisono scaricabili dal sitowww.arkospress.it
Altri testi e materiali proposti perrecensione o informazione potrannoessere inviati alla sede operativa diRoma
COORDINAMENTO REDAZIONALEAlfredo [email protected]
DIRETTORE MARKETINGEnrico Giovanni Arrighini
TRADUZIONE SUMMARYTraduzioni Madrelingua - Kaedra S.r.l.
PROGETTO GRAFICOAlessandra Calabrò
ABBONAMENTI E [email protected] di un numero € 16,00Abbonamento ordinario(4 numeri) € 50,00Abbonamento estero € 65,00Versamenti sul ccp 60343563intestato a Novamusa s.p.a., indicare:Abbonamento rivista Arkos Editinera.È possibile effettuare il pagamentoanche tramite carta di creditoseguendo le istruzioni presenti sulsito www.arkospress.it alla voce“Abbonamenti”
ISBN 978-88-8393-108-6Autorizzazione Tribunale di Cosenzan. 848 del 12/11/2008La pubblicità non supera il 45%
STAMPAStabilimento tipografico De Rose,Montalto Uffugo Scalo, ContradaPantoni, Cosenza
Finito di stampare Luglio 2010
1
I SESSIONE
Il paesaggio culturale tra conservazione, tutela e valorizzazione
Il fiordo di Crapolla nel paesaggio della Penisola sorrentina
Andrea Pane 50
I resti archeologici nella marina di Crapolla
Gianluigi de Martino 62
«Sull'orlo di un precipizio bagnato dal mare»: un percorso di
conoscenza per la conservazione dell'abbazia di San Pietro a Crapolla
Valentina Russo 70
Architetture rurali nell’ambiente del fiordo
Gianluca Vitagliano 82
Architettura fortificata in Penisola sorrentina:
conoscenza e conservazione della torre di Crapolla
Francesco Delizia 88
Tommasina Budetta, Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei
Teresa Caputo, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Napoli e provincia
Giulia de Angelis, AIAPP, sezione Magna Grecia
Sergio Fiorentino, Comune di Massa Lubrense, Assessorato alla Cultura
Stefano Gizzi, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Napoli e provincia
Antonino Miccio, Area Marina Protetta Punta Campanella
Stefano Ruocco, Archeoclub d’Italia, Sede di Massa Lubrense
Paolo Stampacchia, Università degli Studi di Napoli Federico II 94
II SESSIONE
Massa Lubrense: conoscenza, conservazione e valorizzazionedel fiordo di Crapolla
Tavola rotonda e dibattito
Coordina: Valentina Russo
Saluti
Leone Gargiulo, Sindaco di Massa Lubrense 7
Relazione introduttiva
La conservazione del paesaggio come problema culturale.
Il sito di Crapolla nella Penisola sorrentina
Stella Casiello 8
Sommario
NUMERO SPECIALE
Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Penisola sorrentinaIL FIORDO DI CRAPOLLA
Atti della Giornata di studi (Massa Lubrense, 14 novembre 2009)
a cura di Stella Casiello e Valentina Russo
50
remessa«La nostra epoca è decisamente quella del paesaggio»ha scritto recentemente Michael Jakob, evidenziando irischi di un approccio estensivo, da lui definito «omni-paesaggio», che rischia di annullare l’autentica espe-
rienza del reale, sostituendovi discorsi ed immagini1. In questa iper-trofica attenzione per il paesaggio, infatti, il suo stesso concettosembra fatalmente sfuggire ad una definizione univoca, impe-gnando filosofi, antropologi, ecologi, architetti in sottili scherma-glie dialettiche, dietro alle quali, nel contempo, il tema concretodella protezione e della trasmissione al futuro del paesaggio sci-vola spesso in secondo piano. É opportuno, dunque, prima diaffrontare nello specifico il tema del fiordo di Crapolla nel qua-dro della Penisola sorrentino-amalfitana, proporre alcune breviriflessioni sul concetto di paesaggio assunto alla base di questostudio.Diversi autori hanno sottolineato la prevalenza dell’elemento sog-gettivo nella nozione di paesaggio, qualificandola in maniera deltutto differente dai concetti, apparentemente affini, di territorio edi ambiente2. Ci riferiamo non soltanto alle citate riflessioni diJakob, ma anche alle efficaci e documentate argomentazioni diPaolo D’Angelo, che nel suo Estetica della natura, ripercorrendo lastoria della tutela del paesaggio dalla fine dell’Ottocento ad oggi,ha evidenziato l’alterno successo della locuzione di paesaggio inrapporto a quella, decisamente più diffusa nella seconda metà delNovecento, di ambiente3.É noto, infatti, che le origini della tutela del paesaggio – colloca-bili a fine Ottocento, in reazione alle rapide trasformazioni delterritorio indotte dall’industrializzazione – vedono prevalere lanozione estetica di paesaggio, pur ridotta alla sola contemplazio-ne del “panorama”, come confermano le prime leggi italiane diprotezione delle bellezze naturali del 1922 e del 1939. Nellaseconda metà del Novecento, invece, con la progressiva compro-missione dell’ambiente naturale, prevale la dimensione ecologicae biologica dell’approccio al paesaggio, al punto che il terminestesso viene soppiantato quasi del tutto da quello di ambiente,come testimonia la stessa denominazione del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, istituito nel 1975. In questi anni il tema delpaesaggio sembra finire relegato nella sfera degli esteti e dei filo-sofi, mentre gli ecologi più radicali portano avanti un concetto diambiente che arriva persino ad escludere la presenza umana e,dunque, la componente soggettiva del paesaggio prima richiama-ta. Si tratta, in sostanza di una opposizione tra una visione antro-
pocentrica ed una ecocentrica del paesaggio stesso. Nel contempo, sulfronte dei geografi, viene approfondito ulteriormente il tema delterritorio, che rischia, anch’esso, di negare la componente sogget-tiva insita nel paesaggio, proponendo una lettura “oggettiva” chedi per sé appare in contrasto con il carattere “indeterminato” delbello di natura, sul quale si era già opportunamente soffermatoTheodor Adorno. In questo contesto, l’uscita del volume diRosario Assunto Il paesaggio e l’estetica4 nel 1973 sembra porsicome un vero e proprio “sasso nello stagno”, ribadendo la com-ponente estetica e culturale del paesaggio, in aperta antitesi con leposizioni degli ecologi e degli ambientalisti.A distanza di oltre trent’anni da questo dibattito, possiamo rileva-re come il concetto di paesaggio sia tornato oggi decisamente inauge, tanto da divenire oggetto di una specifica ConvenzioneEuropea, ratificata dall’Italia nel 2006, e del nuovo Codice deiBeni Culturali e del Paesaggio. La definizione di paesaggio conte-nuta nella Convenzione, in particolare, sembra pienamente riven-dicare la componente soggettiva ed antropica del paesaggio,richiamando la percezione collettiva e la presenza dei fattoriumani come elementi determinanti del paesaggio5. Tale definizio-ne è stata quasi integralmente recepita nelle recenti modifiche(2008) al nostro Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, cheall’articolo 131 recita: «Per paesaggio si intende il territorioespressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattorinaturali, umani e dalle loro interrelazioni», precisando poi che «latutela del paesaggio (…) è volta a riconoscere, salvaguardare e,ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime»6.É dunque a partire da queste ultime definizioni che si intendeprocedere nell’analisi del paesaggio del fiordo di Crapolla, ade-rendo all’interpretazione proposta da D’Angelo, di paesaggiocome «identità estetica dei luoghi». Questa visione, tuttavia, lungidal trascurare gli aspetti geografici, geomorfologici, biologici,
P
IL PAESAGGIO CULTURALE TRACONSERVAZIONE, TUTELAE VALORIZZAZIONE
Il fiordo di Crapolla nel paesaggiodella Penisola sorrentina
Andrea Pane
II SESSIONE
51
ecologici, storici e culturali che segnano il territorio, li sintetizzain uno sguardo d’insieme che si arricchisce di tali conoscenze spe-cialistiche, senza le quali la percezione del paesaggio rischierebbesenz’altro di essere più povera e parziale, in analogia con quantoaccade in altri campi come la storia dell’arte, dove la conoscenzadel dato filologico concorre alla formulazione del giudizio estetico7.Particolare valore, in tal senso, dovranno assumere gli aspettiprettamente storici e culturali, elementi caratterizzanti l’interopaesaggio italiano8, che nel caso specifico di Crapolla si concretiz-zano in documenti materiali e immateriali, tra cui assumono par-ticolare rilievo le testimonianze letterarie, gli oggetti di culturamateriale, gli elementi etnoantropologici, fino alla dimensionesimbolica dei luoghi, quest’ultima molto significativa, come sivedrà, per gli aspetti mitologici e religiosi del fiordo di Crapolla.
Le caratteristiche del territorio
«Tra Sorrento e Salerno, vedi rocce tagliate a picco, spaccatureorride tra i monti, case incastrate ed appiattite sulla roccia da cuile distingue solo il colore, cadute di vigneti su pendici impervie,ed i monasteri-fortezze appollaiati a metà costa». Questa brevedescrizione, tratta dal Viaggio in Italia di Guido Piovene, scrittoalla metà degli anni cinquanta del Novecento9, sembra sintetizza-re efficacemente gli elementi più generali del paesaggio dellapenisola sorrentina nel tratto che prospetta sul golfo di Salerno.É tuttavia in un’immagine di poco successiva, dovuta ad AldoSestini, che ritroviamo implicitamente delineati i tratti essenzialidelle condizioni paesaggistiche del fiordo di Crapolla, tanto darenderlo – come si evidenzierà più avanti – un vero e proprio
paradigma del paesaggio di tutta la penisola: «I costoloni di calca-ri e dolomie (cretacei e triassici) scendenti giù dai Monti Lattari,spesso con linee accidentate, si rompono a grandi balzi successi-vi sull’azzurro cupo delle acque tirreniche e determinano unaserie di precipiti speroni, come quinte successive, tra le quali sfo-ciano al mare forre selvagge o si adagiano minuscole spiagge,dove i pescatori traggono in secco barche variopinte»10. Soltantodue luoghi, nell’intero tratto di costa compreso tra punta dellaCampanella e Salerno, contengono l’insieme degli aspetti appenadescritti da Sestini: si tratta dei fiordi di Furore e di Crapolla.Sul piano geomorfologico generale, il comprensorio della peniso-la, «imperniato sull’aggruppamento dei monti Lattari, offre unesempio di orografia estremamente complicata e dissimmetrica,che reca i segni di una idrografia remota e di una altrettanto anti-ca erosione»11. Dal punto di vista geologico, com’è ben noto, lapenisola sorrentina è infatti costituita per larga parte da un com-plesso calcareo di età cretaceo-miocenica, cui segue verso l’altoun complesso arenaceo12. L’area del fiordo di Crapolla, corrispon-dente ad una faglia, ricade generalmente nell’ambito del comples-so calcareo, con rocce di natura dolomitica particolarmente evi-denti alle quote più elevate delle pareti della gola. Queste ultimesono interessate, da entrambi i lati, da considerevoli cavità carsi-che, alcune molto ampie e profonde, che meriterebbero un’inda-gine specifica per rilevare eventuali tracce di antropizzazione prei-storica. L’analisi della carta geologica mostra, inoltre, la presenzadi un piccolo areale corrispondente ad un’alluvione antica, postotra i 100 e i 200 metri sul lato Est ed un affioramento di arenarienei suoli sui quali giace l’abitato di Torca (fig. 1).Dal punto di vista geografico, il fiordo di Crapolla si colloca a
The paper focuses on the landscape of the fiord of Crapolla, considered an epitome for the wholelandscape of the Amalfi coast in the Sorrento peninsula. The analysis follows a complex approach,updated with recent trends in landscape theory, and is based on a vision of landscape as “aesthe-tic identity of sites”, paying attention also to geographical, morphological and biological aspects.Special care concerns the historic themes, considering that Crapolla appears like an actual para-gon of a “cultural landscape”. The research about historical uses of the site over the centuriesstarts from mythology (the Siren’s legends) and then goes through the literature of the XIX andXX century, where the anthropological aspects of Crapolla come out, showing the hard life of“seafarers living in the mountains”. In fact, Crapolla’s fishermen lived at 300m above the sealevel, in the small hamlet of Torca. Particular attention is paid to the legal aspects and the plan-ning regulations, and also to the rules of the Area Marina Protetta (maritime protected area) ofthe Sorrento peninsula that provides specific regulations for the Crapolla fiord. Finally the paperoutlines some guidelines for the site’s preservation and improvement, particularly focusing on themaritime accessibility and the maintenance of the ancient paths coming from the mountains tothe sea.
SUMMARY
Figura 1Carta geologica della penisola sorrentina, particolare del
tratto compreso tra la punta della Campanella ed il fiordo
di Crapolla (da M. Civita, R. de Riso, P. Lucini, E. Nota
d’Elogio, Studio delle condizioni di stabilità dei terreni della
penisola sorrentina (Campania), in Geologia applicata e
idrogeologia, Bari 1975, vol. X, parte I).1
52
circa due miglia ad Est dall’estrema propaggine della penisolasorrentina, l’attuale punta della Campanella, denominata neitempi più antichi Athenaion, per la presenza di un santuario dedi-cato ad Atena di cui si dirà più innanzi. Il fiordo è dunque collo-cato sul fronte meridionale della penisola, morfologicamente epaesaggisticamente molto diverso da quello settentrionale dove sitrovano gli abitati di Sorrento e Massa Lubrense. Qui, infatti, adifferenza degli ambiti appena citati, il paesaggio è caratterizzatoda condizioni molto più estreme, che hanno da sempre reso piùdifficili gli insediamenti umani: declivi fortemente scoscesi o apicco, acque profonde con quasi totale assenza di spiagge, diffi-cili accessi dalle colline al mare. Il tratto di costa tra punta dellaCampanella ed il fiordo di Crapolla, tuttavia, fa eccezione rispet-to a quanto appena descritto per la presenza di una lunga spiag-gia, la marina del Cantone, compresa tra i promontori diMontalto e di Recommone.Proseguendo verso Est dopo il promontorio di Recommone esuperato l’isolotto d’Isca, si scorge una profonda gola nella roc-cia, il cui accesso dal mare si individua soltanto avvicinandosinotevolmente alla costa, rivelando un vero e proprio fiordo, conalte pareti laterali, che penetra in direzione Sud-Nord per oltrecinquanta metri dalla linea di costa esterna. Addentrandosi nelfiordo, si giunge ad una piccola spiaggia, sul fianco della quale sitrovano alcune fabbriche in muratura coperte a volta, ricovero dibarche e pescatori, e sulla destra un sistema di canalizzazione del-l’acqua, che immette in mare il rivo Iarito (o Viarito), originatodal sovrastante (e invisibile dal fondo della spiaggia) abitato diTorca. Più in alto, ancora sul lato destro, si rileva immediatamen-te la presenza di strutture di età romana, con tratti in opus reticula-
tum e volte in parte crollate (fig. 2). In corrispondenza di tali strut-ture si inerpica una lunga scalinata, con gradini in pietra calcarea,che conduce, dopo alcuni tornanti, ad una terrazza naturale postain corrispondenza dell’imboccatura del fiordo sul lato Est, diret-tamente prospiciente gli isolotti di Isca, Vetara e, più lontano indirezione Sud-Est, Li Galli. É qui che si rivelano i resti di un com-plesso religioso, l’abbazia benedettina di San Pietro a Crapolla.Come si vedrà più avanti, il carattere assolutamente particolaredel luogo ha, da sempre, affascinato viaggiatori e scrittori, susci-tando suggestioni anche negli archeologi, che per primi hannostudiato le fabbriche del fiordo nel Novecento, come P.Mingazzini e F. Pfister, che nel 1946 scrivevano: «Giace la mari-na di Crapolla in fondo ad un’insenatura strettissima e chiusa darocce strapiombanti a picco, che danno alla breve riva un aspetto
orridamente pittoresco»13. L’immagine di una «fauce marina»ricorre anche nelle pagine di Amedeo Maiuri, che nel 1949 visita-va attentamente i luoghi, annotando come Crapolla fosse «con lamarina di Furore lo spacco più profondo nella muraglia compat-ta della costa»14. Il parallelo con Furore appare particolarmenterilevante, in quanto anche quest’ultimo, ben più esteso e profon-do, presenta una marina con abitazioni di pescatori, architettoni-camente più articolate di quelle di Crapolla. Il tema del fiordo odella forra, del resto, è abbastanza comune nel paesaggio dellapenisola, benché soltanto nel caso di Crapolla e Furore sia asso-ciato ad un rapporto così intenso tra natura e architettura. Basticitare, infatti, a meno di un quarto di miglio da Crapolla, l’insena-tura di “Portiglione”, priva di manufatti e posta quasi di fronteall’isolotto di Isca, meno profonda di Crapolla ma caratterizzataanch’essa dalla presenza di un rivolo d’acqua (fig. 3). E si potreb-bero ancora menzionare due ulteriori, ridottissime insenature,collocate poco più ad Ovest, in corrispondenza dei due rivoli“Scrivanessa” e “Comunaglia”, riportati nella cartografiadell’Istituto Geografico Militare.Come già accennato, il fiordo è in stretto rapporto con l’abitatosovrastante di Torca, pur separato da un dislivello di oltre 300metri, di cui costituisce il naturale sbocco al mare, conferendodunque al piccolo borgo, in analogia con altri centri della costie-ra amalfitana, il carattere di un paese di «pescatori che vivono inmontagna». Alla pesca, comunque, doveva già in tempi remotiaffiancarsi un’attività agricola e pastorale, ancorché oggi pocoriconoscibile. La stessa origine del toponimo di Torca, infatti,sembrerebbe ricondurre, nell’interpretazione di Maiuri, ad un’an-tica presenza di ulivi, di cui oggi si rilevano scarse tracce15.Oggi il paesaggio circostante il fiordo di Crapolla appare preva-lentemente spoglio e caratterizzato soltanto da macchia mediter-ranea ed arbusti, con qualche albero isolato alle quote più elevatedove, secondo diverse testimonianze, un tempo dimorava unbosco di querce, mentre più in basso erano presenti olivi e carru-bi16. Non si riconoscono, nei terreni circostanti il fiordo, tracce diterrazzamenti, che appaiono invece ben evidenti in corrispon-denza del vicino fiordo di Portiglione. Diversa è invece la condi-zione di vegetazione del fondo della gola, alla quota della spiag-gia: qui la presenza dell’acqua dolce del rivo Iarito, che giungeformando una piccola cascata, insieme alla maggiore distanza dalmare e alla condizione ombrosa che prevale per molte ore delgiorno, ha consentito la formazione di una vegetazione molto piùfitta, con qualche albero di alto fusto (fig. 4).
Figura 2L’ingresso al fiordo di Crapolla dal mare, sulla destra le strutture resi-
due dell’approdo romano (foto A. Pane, giugno 2009).
Figura 3Il fiordo di Portiglione, segnato dal corso del rivo Corbo, anticipa per
molti aspetti, sebbene in scala ridotta, il paesaggio del successivo
fiordo di Crapolla, posto più ad est a meno di un quarto di miglio (foto
A. Pane, giugno 2009).
2 3
53
L’uso del sito nel corso dei secoli
La complessità degli usi che hanno segnato, sin dai tempi piùremoti, il fiordo di Crapolla rende più che mai appropriata, perquesto luogo, la locuzione di “paesaggio culturale”. Non è age-vole sintetizzare in poche righe vicende millenarie ed articolate,ma volendo enucleare gli aspetti più salienti non si può non pren-dere le mosse dal tema mitologico, legato al culto delle Sirene.Com’è ben noto, il più celebre ed aulico cenno al mito delleSirene si ritrova nell’Odissea, introdotto già nelle parole cheCirce rivolge ad Ulisse in partenza dall’isola di Eea, individuatasecondo la tradizione in Ponza17. La presenza del culto nella peni-sola sorrentina e l’identificazione delle isole delle Sirene con gliisolotti de Li Galli è successivamente confermata da Strabonenella sua Geografia, dove, concludendo la dettagliata delineazionedel Crater (golfo compreso tra capo Miseno e l’Athenaion, ovveropunta della Campanella), i luoghi sono così descritti: «Subitodopo Pompei c’è Surrentum, città della Campania da dove si pro-tende l’Athenaion, che alcuni chiamano promontorio delleSirene: sulla punta del promontorio c’è un tempio di Atena, fon-dato da Odisseo. Da lì all’isola di Capri, c’è un breve tratto dimare. Doppiato il promontorio, ci sono alcune isolette deserte erocciose, che chiamano Sirene»18. In realtà la controversa ubica-zione del tempio delle Sirene ha dato luogo ad un ampio dibatti-to19, ancora oggi irrisolto, benché studi recenti sembrino confer-marne la presenza presso la baia di Ieranto20. Quale che sia l’esat-ta ubicazione del tempio, probabilmente impossibile da definirein maniera certa, resta la stretta vicinanza del fiordo di Crapollacon l’area del culto, ancor più se si pensa alla diretta relazione trail fiordo stesso e le isole Sirenuse.Poco si conosce dell’antropizzazione preistorica della penisola,benché un archeologo come Maiuri ritenesse che «tutta la costaamalfitana straordinariamente ricca com’è di recessi, di grotte, difacili marine d’approdo e di ricovero, di acque sorgive e di selve,dové essere abitata fin dall’età preistorica»21. É certo, comunque,il rilievo fondamentale assunto dalla penisola sorrentina fin daitempi più antichi, per la sua particolare conformazione geografi-ca e per la posizione cruciale nell’ambito dei traffici marittimi cheinteressavano la costa tirrenica. Non a caso, nella celebre TabulaPeutingeriana – copia medioevale di una mappa romana, daricondurre forse ad Agrippa – la penisola è disegnata con accu-ratezza e ben collocata come spartiacque tra il golfo di Napoli equello di Salerno22.É stato più volte osservato che gli aspetti geologici e geomorfo-logici che qualificano la penisola – rendendola senz’altro uno deiluoghi paesaggisticamente più rilevanti dell’intera Campania –costituiscono una parte sostanziale dell’identità di questo territo-rio, con riflessi molto significativi anche sulla storia dei suoi usi.La stessa presenza del promontorio di punta della Campanella oAthenaion, costituiva senza dubbio un elemento di grande rilievoper la navigazione, introducendo al grande Crater citato daStrabone23. In tal senso, quindi, la stretta vicinanza del fiordo diCrapolla con il capo si prestava ottimamente a veloci soste, primadi affrontare la difficile navigazione attraverso la bocca piccola diCapri24 (fig. 5).Del resto, la naturale vocazione portuale del fiordo risulta evi-dente al primo sguardo. Per la sua conformazione sinuosa, conuna lieve curva verso Nord-Ovest, l’insenatura appare totalmen-te protetta dai venti dei quadranti settentrionali (maestrale, tra-montana, grecale) prevalenti, com’è noto, nel medio tirreno, con-figurandosi dunque come uno straordinario porto naturale, pro-tetto e ben nascosto alla vista. Viceversa, la sua apertura versoSud rende il fiordo molto esposto ai venti meridionali (scirocco,libeccio) frequenti in caso di tempeste, condizione tuttavia bilan-
Figura 4Il paesaggio collinare lungo il sentiero d'accesso a Crapolla, parzial-
mente invaso dalla vegetazione spontanea, con la torre di San Pietro
sullo sfondo. Sulla linea di orizzonte si distinguono i tre isolotti de Li
Galli, denominati in antico Sirenuse, e, più a destra, Vetara (foto A.
Pane, novembre 2008).
Figura 5Penisola sorrentina, particolare con Sorrento e Massa nelle mappe
aragonesi del Principato Citra, seconda metà XV sec. (BNF, Cartes et
Plans, GE AA 1305-5, pubblicata in F. La Greca, V. Valerio, Paesaggio
antico e medioevale nelle mappe aragonesi di Giovanni Pontano. Le
terre del Principato Citra, Acciaroli 2008). Tra i toponimi si riconosce
un “S.to Pietro in Crapula”, ubicato in corrispondenza del casale, men-
tre lungo la costa sud si distingue il sistema delle torri difensive ed il
suo stato prima del grande rinnovamento promosso in età vicereale.
Tra queste ultime se ne riconosce una priva di denominazione, posta
in corrispondenza dell’abitato di Torca, che coincide con la torre di San
Pietro a Crapolla.
4
5
54
ciata dalla presenza della spiaggia, che consentiva certamente ilrapido e sicuro tiro in secca delle imbarcazioni.Le ricerche archeologiche avviate da Mingazzini e Pfister, suffra-gate dalle riflessioni di Maiuri, hanno evidenziato il carattere diporto d’attracco a servizio delle ville romane poste sull’isolad’Isca e sulle isole delle Sirenuse. Per Maiuri, in particolare, «lamarina di Crapolla sembra esser posta proprio là per servir dapunto d’approdo di sbarco o d’imbarco per le isole delle Sirene»25
e certamente la presenza dell’acqua, con il rivo Iarito, costituivaun valore aggiunto di inestimabile portata per l’approvvigiona-mento delle ville ma anche, più in generale, per tutta la navigazio-ne tra il golfo di Napoli e quello di Salerno.Poco sappiamo della brusca interruzione nell’uso del sito in etàalto-medioevale, che Maiuri voleva ricondurre ad un evento natu-rale di straordinaria portata, come un’alluvione, capace di cancel-lare da tutto il versante amalfitano le tracce pur documentate dapiù fonti di gran parte degli insediamenti romani. A questa fasesegue – secondo Maiuri – un ripopolamento che inizia, come inetà primitiva, nuovamente dalle grotte, ma questa volta con lapresenza di monaci eremiti e poi di insediamenti religiosi, daiquali prenderà avvio il ritorno verso la montagna, cui consegueun duplice ed ambiguo rapporto degli abitanti con la costa ed iterritori collinari, in quella «vita di monte e di mare», per certiversi sopravvissuta fino ad oggi, che segna senza dubbio l’identi-tà del paesaggio della costiera amalfitana26. Il paesaggio che segnail fiordo di Crapolla in questo periodo – durante il quale siimpianta forse il primo nucleo dell’abbazia benedettina di SanPietro – sembra riconducibile ad un carattere del paesaggio agra-rio medioevale italiano ben evidenziato da Emilio Sereni fin dal196127. Si tratta di quello che egli definisce il «borgo inerpicato nelpaesaggio pastorale-agricolo del medioevo italiano», ricondottoalle necessità di difesa dalle scorrerie ed invasioni barbariche, cheappare particolarmente adatto a descrivere il contesto abitativo diTorca ed il suo rapporto con il sistema pastorale ed agricolo dellecolline digradanti verso il mare.Come già accennato, dunque, è l’abbazia a segnare l’uso del sitoper i secoli successivi al XII, periodo in cui si rinvengono, secon-do Filangieri, le prime testimonianze dell’insediamento religioso,che all’anno 1111 riferiscono di un monastero Capreolae in terri-torio di Massa28. Qualche riflessione, in proposito, merita il topo-nimo di Crapolla, secondo alcuni riconducibile ad ’'Aκρον’Aπóλλωνος, relativo cioè ad un promontorio sacro ad Apollo,tanto che lo stesso Beloch ancora nel 1890 richiamava tale etimo-logia29. Per Maiuri, tuttavia, il toponimo va ricondotto alle «boc-che dei pescatori: Crapolla come già pensava il Capaccio diCrapeolae con la stessa metatesi di Capri in Crapa», mentre «l’eti-mologia che escogitarono gli eruditi del settecento presupponen-do un Akra Apollonos serve solo a testimoniare l’acutezza inven-tiva di qualche buon filologo napoletano del settecento, stimola-ta dal vicino Promontorium Minervae»30.Ritornando all’abbazia, a dispetto delle citate testimonianzedocumentarie del 1111, va evidenziato che nessun cenno al com-plesso religioso, né all’approdo, si ritrova in una delle più detta-gliate descrizioni geografiche di età medioevale a noi pervenute,quella redatta da Edrisi (o al-Idrisi), plenipotenziario di reRuggero II, autore del cosiddetto “Libro di Re Ruggero”, scrittotra il 1139 e il 1154 in lingua araba31. Nel testo, infatti, dopo unalunga descrizione di Sorrento ed un cenno al capo Minerva, si fadirettamente riferimento al successivo approdo di Positano32.Occorre arrivare alla prima metà del Cinquecento per avere unadescrizione un po’ più ampia del sito di Crapolla, a firma diTeofilo Folengo, che insieme al fratello trascorse circa tre anninell’abbazia di San Pietro. Manifestando inediti accenti paesaggi-stici, infatti, egli scriveva intorno al 1533: «Crisogono: Per soddi-
sfare la tua curiosità, torno a Caprolla che io, però, chiamerei piùvolentieri Caprona, cioè chioma che scende dal capo. Così inter-pretano infatti questo nome. Alza un attimo gli occhi, ti prego,dal basso di questa collinetta, passo dopo passo, fino all'estremacima del monte e guarda attentamente se si può immaginare qual-che altra cosa che sia più somigliante. Osserva come quell'ertocostone che sporge sulla vetta palesi, a guisa di volto umano, unaspecie di fronte. Da quel costone fino al recinto delle case, su unpendio più dolce, si spandono come sulla fronte di un uomo, for-mando una bellissima capigliatura, prima gli ulivi poi un mirtetoche cresce intrecciato a svariati arbusti. Lì dove poi il monte, pie-gandosi un pochino in se stesso, crea un avvallamento veramen-te ameno ed aprico, dove si trovano le case ed i bei campi, e siveste di nuovo del verde olivo, da lì esso, aprendosi all'improvvi-so in un promontorio scosceso, corre giù fino al lido cavernoso.Questo, da una parte e dall'altra frastagliato e sinuoso, provocaspaventosi latrati per il continuo scontrarsi dei flutti»33.Ancora agli inizi del Settecento, nella guida del Parrino, il sito èmenzionato con una vocazione di approdo per imbarcazioni,vero e proprio «porticello, ove concorrendovi il giorno di Pasquadi Resurrezione molte barche, vi fanno sontuosa pesca e tornanocantando le Litanie»34. Un secolo più tardi, invece, con la defini-tiva soppressione dell’abbazia e le distruzioni occorse durante leguerre napoleoniche, il sito si riduce ad assumere un esclusivouso per attività di pesca, come testimonia la descrizione diMariana Starke del 1836, in cui i ruderi dell’abbazia, pur abban-donati, si conservano in buona parte ancora leggibili, mentre ilfiordo è citato come «porto usato giornalmente dai pescatori diSant'Agata che forniscono di pesce il mercato di Napoli»35.A partire dalla fine dell’Ottocento si susseguono i riferimenti let-terari dei viaggiatori e degli scrittori più attenti al paesaggio dellapenisola, tra cui spiccano, a diverse riprese, Francis MarionCrawford e Norman Douglas. Entrambi contribuiscono ad asso-ciare il mito delle Sirene al fiordo di Crapolla, raccogliendo ancheulteriori testimonianze e leggende sul sito, che forniscono unquadro variegato e complesso, in cui anche le attività dei pesca-tori sono oggetto per la prima volta di specifica attenzione. CosìCrawford, nel suo Coasting by Sorrento and Amalfi, pubblicato suuna rivista americana nel 1894, descrive il fiordo nel suo caratte-re nascosto alla vista, citando anche la pratica della caccia allequaglie con le reti a vela mobile sulle alture, cui sono conseguitenumerose morti violente per la caduta dall’alto: «Poi ancora roccee infine il riparato fiordo di Crapolla a malapena visibile dal mare,una improvvisa spaccatura quasi a perpendicolo nella immensaroccia che strapiomba di fronte alle isole delle sirene. Anche quici sono fantasmi a non finire di ragazzi e di uomini adulti che, percacciare le quaglie con le reti a vela mobile, sono precipitati percinquecento metri fino sul fondo della gola»36.É ancora Crawford ad introdurre per primo il tema dei pescato-ri, descritti come frequentatori notturni del fiordo: «scendono lanotte da Sant’Agata e quasi tutti tornano al mattino, portandocon sé quello che hanno pescato per venderlo al mercato delposto». Tra questi, emerge il personaggio di “Garibaldi”, che tra-scorre la gran parte dell’anno nel fiordo: «Anche qui vive un vec-chio solitario, una specie di spirito benigno del luogo sopranno-minato Garibaldi per via di una certa somiglianza con l’eroe deidue mondi (...) [che] riesce a sbarcare brillantemente il lunariocalando a mare di notte le lenze con cui prende il pesce persico,così apprezzato dai napoletani»37. Sul personaggio ritornerà conmaggiori dettagli anche Douglas, nel suo celebre Siren Land
(1911), precisando che egli «conosce meglio di chiunque altro ilmodo di catturare la cernia scaltrissima quando si nasconde tra gliscogliۛ». La pesca notturna è, nella descrizione di Douglas, esclu-sivamente estiva: «D’inverno, Crapolla è disabitata: le barche ven-
55
gono tirate in secco, oltre la portata delle onde, che mugghianocon cupo rimbombo nei burroni tutt’intorno», e soltanto il vec-chio Garibaldi «rimane qui per tutta la brutta stagione»38.Sono tuttavia gli aspetti mitologici e paesaggistici ad apparire par-ticolarmente efficaci nel volume di Douglas, che dedica un inte-ro capitolo a L’insenatura di Crapolla, definita come «uno dei luo-ghi più strani ed attraenti della Terra delle Sirene»39. Nel testosono sintetizzati molti degli elementi di valore paesaggistico chetuttora colpiscono il visitatore, insieme a brevi notazioni storicheche restituiscono l’evoluzione degli usi del territorio, come uncenno alla presenza delle querce, che a quei tempi ancora si rico-noscevano in gruppi sparsi lungo le pendici.Ma è forse la descrizione notturna dei luoghi, posta da Douglas aconclusione del capitolo, ad esprimere meglio lo spirito diCrapolla, che in parte si rinnova ancora oggi in chi si accosta alfiordo «in una notte di plenilunio, quando ogni contrasto si dis-solve nel dolce splendore della notte meridionale (…) e le duerocce che chiudono l’ingresso di Crapolla potrebbero esserescambiate facilmente con il portale di qualche reggia ossianica(…). Sembra di ammirare un quadro, non un poderoso bastionedi calcare; un quadro che naviga con voi; una specie di gigante-sco argenteo bozzetto concepito da William Blake nei suoi
momenti più folli, tra la veglia e il sonno»40.
Dopo le suggestive pagine di Douglas, una lunga descrizione di
Crapolla con accenti letterari si deve al citato Maiuri, che nelle sue
Passeggiate alterna riflessioni di carattere archeologico con attente
osservazioni sul carattere del paesaggio, sugli usi degli abitanti di
Torca, sui costumi dei pescatori, offrendo un quadro quanto mai
vivo del fiordo al 1949. Particolarmente interessanti si rivelano i
passaggi dedicati al sentiero di accesso da Torca: «Da terra vi si
giunge calandosi quasi a capofitto dalle ultime case di Sant’Agata
per un vallone che un tempo doveva essere tutto un grande quer-
ceto con qualche casolare sparso e oggi radi ulivi e radure di
magri seminati: gli ultimi duecento metri di dislivello tra il ciglio
della rupe e il mare si disperdono per una gradinata rocciosa da
far concorrenza alla scala fenicia di Anacapri (…) così lucidi e
consunti i gradini e i gradoni di roccia da far pensare alla consun-
zione che vi esercita solo il piede nudo dei pescatori che salgono
e scendono con il carico del pesce»41.
Allo stesso modo Maiuri descrive l’accesso al fiordo da mare,
rivelando sensazioni ancora oggi in buona parte percepibili dal
visitatore contemporaneo: «Oggi s’entra nella baia di Crapolla
sopra un mare di turchese e di opale tra due pareti di roccia che
si richiudono in fondo in un canalone inaccessibile in mezzo a un
groviglio di sterpi: nessun molo, né pontile di sbarco: la chiglia
s’insabbia nella ghiaia con un fruscio metallico e le barche vengo-
no tirate in secca sul greto una avanti all’altra e sono le cose più
vive smaglianti e allegre in quell’ombroso speco»42. Infine, le
riflessioni di Maiuri contribuiscono a definire meglio anche gli
specifici aspetti relativi alle attività di pesca nel fiordo, sintetizza-
te con un’efficace espressione: «Né donne né famiglia: la vita dei
pescatori di Crapolla è ancora quella dei naufraghi tra le isole
delle Sirene. Vanno a pesca la notte, dormono all’alba»43.
Suggestive immagini della pesca appaiono anche in brevi foto-
grammi del documentario Miti e paeaggi della penisola sorrentina
(1955) di Roberto Pane, girato in stretta relazione con il suo volu-
me Sorrento e la costa, pubblicato nello stesso anno44 (fig. 6). Il film
mostra infatti la spiaggia interamente occupata da gozzi da pesca,
tutti rigorosamente in legno ed a remi, con alcuni uomini intenti
ad ordinarne le attrezzature. Già nel 1949, tuttavia, Maiuri segna-
lava i rischi di depauperamento della fauna ittica di Crapolla per
l’uso sconsiderato della dinamite45.
Le più recenti testimonianze sui pescatori superstiti di Crapolla,
tutti residenti a Torca, emergono dal recente volumetto di
Antonino de Angelis Contatti (2003), che descrive una «spiaggia
frequentata solo di notte», mentre di giorno, «i pescatori restano
lontano dalla loro marina, intenti a curare l’uliveto e a zappare la
vigna»46. Una breve nota, infine, sul pescato del mare di Crapolla,
tratta dalle testimonianze dirette degli ultimi pescatori: se
Crawford cita il “pesce persico” e Douglas la cernia, va anche
annoverato, tra le prede ricorrenti ed abbondanti, il pesce San
Pietro, il cui nome non può non richiamare l’omonima abbazia
benedettina. Lo stesso pesce, del resto, è detto comunemente
“pesce gallo”, suggerendo un’ulteriore, curiosa assonanza con il
toponimo “Li Galli”.
Il fiordo di Crapolla nella normativa urbanistica e
di tutela vigenteIl quadro normativo che interessa il fiordo di Crapolla è piutto-
sto articolato, tanto sul piano paesaggistico-urbanistico che su
quello della tutela dell’ambiente, mentre molto attenuata appare
la tutela dei beni culturali ricadenti nell’area, per i quali non è, allo
stato, disposto alcun provvedimento diretto.
Procedendo in ordine gerarchico, il più ampio strumento norma-
tivo che interessa l’area è il Piano Urbanistico Territoriale della Penisola
Sorrentino – Amalfitana, redatto fin dai primi anni Settanta da un
gruppo di studio coordinato da Roberto Pane e Luigi Piccinato
ed approvato, con sostanziali varianti rispetto alla proposta origi-
naria, con Legge Regionale del 27 giugno 1987 n. 35. Nella defi-
nizione del PUT, il fiordo di Crapolla è compreso nell’ambito dei
paesaggi «a morfologia tettonica dominante», nei quali «le predet-
te strutture geologiche presentano, all’osservatore, importanza
dominante rispetto ai posteriori inserimenti della vegetazione
spontanea ed agraria e degli insediamenti umani»47. L’elemento
tettonico e geologico, dunque, classificato come «fenomeno ero-
sivo» nel caso specifico di Crapolla, costituisce elemento preva-
lente per la disciplina di protezione del paesaggio: «Questi pae-
saggi, indipendentemente dal loro valore estetico, sono un docu-
mento di particolari fasi di formazione della superficie terrestre,
e come tali vanno conservati nella loro condizione originaria.
Figura 6La spiaggia di Crapolla con i piccoli gozzi in legno a remi dei
pescatori, in una fotografia di Roberto Pane dei primi anni
Cinquanta, scattata nell’ambito della documentazione per il
suo volume Sorrento e la costa, 1955 (Fondo Fotografico R.
Pane, Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro,
Università degli Studi di Napoli Federico II).
6
56
Nessun intervento, neppure di semplice rimboschimento, puòtrovare giustificazione per questi ambienti, in quanto ne altere-rebbe la funzione documentaria»48.Ne deriva quindi che l’intero tratto di costa nel quale è compre-so il fiordo di Crapolla ricade nella “Zona Territoriale 1A –Tutela dell’ambiente naturale – 1° grado”. Il piano riserva a que-st’ambito la massima disciplina di tutela dell’ambiente naturale,considerando particolarmente rilevante la presenza di «maggioriemergenze tettoniche e morfologiche che si presentano prevalen-temente con roccia affiorante o talvolta a vegetazione sponta-nea». Il confine dell’area segue l’andamento della gola del rivoIarito, penetrando per alcune centinaia di metri all’interno dellaretrostante “Zona Territoriale 1B – Tutela dell’ambiente naturale2° grado”.La disciplina appena citata è stata integralmente recepita nelPiano Regolatore Generale di Massa Lubrense, redatto da ungruppo costituito da Guido Clemente, Alessandro Dal Piaz eArrigo Marsiglia nel 1992. La zonizzazione del Piano per l’areadel fiordo segue, infatti, pedissequamente il perimetro della ZonaTerritoriale 1A del PUT, assegnandola alla zona E1 di «tutela del-l’ambiente naturale di primo grado», per la quale, vietando «sban-camenti e riporti, mutamenti di destinazione della attuale ediliziaagricola, nuove edificazioni sia pubbliche che private, attraversa-menti di strade, funicolari, funivie e simili diverse da quelle previ-ste dal PRG, realizzazioni di elettrodotti aerei e di acquedottifuori terra, di impianti fognari e di depurazione affioranti o fuoriterra, interventi di dissodamento delle aree di vegetazione spon-tanea e/o rimboschimenti con essenze estranee alla tradizionaleflora locale», sono invece consentiti, «previa autorizzazione di cuiall’articolo 28 delle presenti Norme: la manutenzione ordinaria estraordinaria e il risanamento conservativo degli edifici documen-tati come esistenti al 1955; la rifazione di muretti a secco in pie-tra calcarea locale a sostegno di terrazzamenti con altezza nonsuperiore a ml 1,5 e larghezza non inferiore a ml 2,5; l’impiantodi essenze arboree e arbustive non in contrasto con la tradiziona-le flora locale negli spazi verdi di pertinenza delle residenze esi-stenti, la organizzazione compositiva dei quali non può esseremodificata. É d’obbligo la conservazione della vegetazione spon-tanea e la sistemazione, la manutenzione o il ripristino dei sentie-ri pedonali che consentono l’accesso pubblico al mare o a i luo-ghi panoramici o ai corsi dei rivoli e zone ambientali annesse,secondo le indicazioni delle tavole di piano»49.Concludendo il quadro normativo per l’ambito di tutela paesag-gistica va sottolineato, inoltre, che il fiordo ricade, per gran partedella sua estensione, tra i beni paesaggistici tutelati ipso iure dalCodice dei Beni Culturali e del Paesaggio all’articolo 142, cherecepisce quanto già disposto dalla legge Galasso. L’area diCrapolla, infatti, è quasi del tutto compresa entro i 300 metri dallalinea di battigia50, pertanto, oltre alla disciplina imposta dal PUT,si configura un vincolo paesaggistico diretto per tutte le particomprese entro la citata fascia dei 300 metri.L’ultimo aspetto in ordine cronologico, ma di grande impatto perle prospettive di tutela e valorizzazione del fiordo, riguarda iltema della tutela dell’ambiente marino, e, in particolare, la disci-plina imposta dal Regolamento dell’Area Marina Protetta diPunta Campanella (approvato con Decreto del Ministerodell’Ambiente il 12 dicembre 1997), nella quale ricade interamen-te l’intera area di Crapolla per le parti poste sul mare. Più preci-samente, l’AMP vincola, oltre alle acque marine, anche i «territo-ri costieri appartenenti al demanio marittimo»51. Ne deriva dun-que, per lo specifico caso di Crapolla, che la disciplina dell’AMPinteressa anche la spiaggia ed il tratto di sbocco in mare del rivoIarito. Nel Regolamento, l’intera area del fiordo di Crapolla rica-de nella zona B2 di riserva generale, compresa tra lo scoglio
Scruopolo e la punta a ponente della grotta Matera, nella quale èconsentito «il transito a motore alle imbarcazioni aventi le dimen-sioni massime di 7.50 m f.t. se a motore e 10 m f.t. se a vela, auto-rizzati dall’Ente Gestore» (art. 36). Ai margini dell’area stessa,inoltre, il Regolamento prevede un’area per ormeggio con gavi-telli (art. 28), denominata “Isca”. La disciplina dell’accesso e dellaattività consentite nel fiordo di Crapolla è infine oggetto di unospecifico articolo del Regolamento, rivolto sia al fiordo che allaBaia di Ieranto52.
Il fiordo e l’Area Marina Protetta di Punta della
Campanella: linee-guida di intervento per l’acces-
sibilità dal mareIn accordo con il concetto di valorizzazione definito dal Codicedei Beni Culturali e del Paesaggio, che nell’ultima versione inno-vata nel marzo 2008 si riferisce esplicitamente «ad assicurare lemigliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patri-monio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, alfine di promuovere lo sviluppo della cultura»53, il tema del miglio-ramento dell’accessibilità del fiordo di Crapolla – nel pienorispetto delle istanze di tutela e di contenimento dell’impattoantropico – costituisce senza dubbio un punto fondamentale.Si propone dunque una gamma di interventi a scala diversa, a par-tire dall’ambito territoriale – al fine di garantire il migliore inseri-mento di Crapolla nel sistema dell’Area Marina Protetta di Puntadella Campanella – fino a specifiche previsioni per l’accessibilitàvia mare dell’area del fiordo. La ricchezza delle tematiche cultu-rali evidenziate nelle pagine precedenti induce infatti a considera-re Crapolla come un esempio emblematico di paesaggio com-plesso, definibile anche come “museo diffuso”54, in cui convergo-no aspetti naturali, culturali, storici, archeologici, etnoantrpologi-ci, simbolici, come accade davvero in pochi luoghi della penisola.Ciò induce a poter considerare Crapolla, anche in virtù dellabuona conservazione dei caratteri prima citati, come un vero eproprio polo d’arrivo, sul quale impostare una serie di itineraritematici via mare che potrebbero interessare l’intero tratto dicosta compreso tra Sorrento e punta Sant’Elia.Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento dell’AMP55, sipotrebbe dunque immaginare l’organizzazione di visite guidatecon imbarcazioni a partire da Sorrento, Marina della Lobra oMarina del Cantone. Gli itinerari potrebbero privilegiare tanto iltema delle torri, molto diffuso nel tratto di costa citato, che quel-lo dei ruderi archeologici, presenti lungo tutta la costa (e in buonaparte ancora da approfondire con futuri scavi), fino a quello pret-tamente religioso, ponendo in relazione i resti dell’abbazia di SanPietro con i ruderi di punta S. Elia ad Est ed il complesso abba-ziale di S. Maria di Mitigliano ad Ovest (fig. 7).Per quanto riguarda la diretta accessibilità al fiordo, nonché ladisciplina delle visite e dello sbarco sulla spiaggia, si potrebbeindividuare per l’imbarco il pontile esistente di Marina delCantone. Da qui le imbarcazioni autorizzate potrebbero raggiun-gere il fiordo ed entrare seguendo un apposito corridoio delimi-tato da galleggianti e posto sul lato sinistro del fiordo (Ovest), inmodo da raggiungere una zona dove collocare un piccolo ponti-le mobile, eventualmente galleggiante, per facilitare lo sbarco.Tale pontile potrebbe configurarsi come un prolungamento idea-le del muro esistente che incanala le acque del rivo Viarito, termi-nando sulla battigia con una rampa e mantenendosi distaccato dalmuro per evitare di creare uno spazio residuale verso la pareterocciosa, accogliendo quindi le piccole imbarcazioni solo sul latodestro. In accordo con l’art. 39 del Regolamento dell’AMP, talivisite dovrebbero essere contenute entro un massimo di 100 per-sone al giorno, suddivise in gruppi di non più di 25 unità (fig. 8).
57
Analogo sistema d’accesso potrebbero seguire gli eventuali visita-tori giunti sul luogo con imbarcazioni da diporto, da ormeggiarenella specifica area gavitelli denominata “Isca” e prevista all’art.28 del Regolamento, trasferendosi sulle citate imbarcazioni auto-rizzate allo sbarco. Resterebbe consentito, come previsto all’art.39, l’accesso delle imbarcazioni «legittimamente custodite neidepositi esistenti previa autorizzazione da parte dell’EnteGestore», seguendo il citato corridoio d’entrata, al fine di garan-
tire la continuità delle attività di pesca, che costituiscono elemen-
to di forte identità del fiordo di Crapolla.
Un’ultima considerazione sul tema marino va rivolta, infine, alla
verifica di eventuali tracce di inquinamento nell’acqua del rivo
Iarito, che, confluendo direttamente a mare, potrebbero forte-
mente danneggiare il sito stesso e comprometterne la balneabili-
tà. Andrebbe quindi, in via preventiva, disposto un opportuno
monitoraggio dell’alveo nel tratto più prossimo all’abitato di
Torca, al fine di rilevare la presenza di eventuali scarichi abusivi o
non controllati.
7
8
Figura 7Valorizzazione del fiordo di Crapolla
nel contesto della penisola sorrentina:
ipotesi di itinerari turistici via mare,
incentrati sul sistema delle torri
(arancio), sulle presenze archeologiche
(giallo) e sugli insediamenti religiosi
(verde).
Figura 8Schema dell’accessibilità al fiordo diCrapolla via mare. A partire dal pontiledi Marina del Cantone l’accesso viamare, riservato alle sole imbarcazioniautorizzate, seguirebbe un corridoio dadelimitare con galleggianti lungo il latoovest, fino a raggiungere un eventualepontile galleggiante sulla spiaggia perfacilitare lo sbarco. Un limitato numerodi imbarcazioni private, di piccoledimensioni, potrebbe ormeggiarsi nel-l’area gavitelli “Isca”, prevista dalRegolamento dell’AMP.
58
I percorsi via terra. Linee-guida per l’accessibilitàL’accessibilità via terra del fiordo di Crapolla presenta senz’altroalcune difficoltà in rapporto ad un’auspicabile fruizione ampliata,per la presenza di un considerevole dislivello (oltre 300 metri) edi un sentiero piuttosto disagevole e poco riconoscibile per quan-to riguarda il percorso Monte di Torca-Torre. Ciò premesso, ilsistema dei percorsi da terra costituisce forse l’elemento di mag-giore identità del luogo, in virtù dei suoi usi storici che, come deli-neato precedentemente, hanno sempre mantenuto una strettissi-ma relazione con l’abitato sovrastante di Torca (fig. 9). Pur riser-vato a persone in buona forma fisica, o in qualche caso agliappassionati di trekking, il sistema dei percorsi da terra costitui-sce dunque l’accesso più significativo sul piano della comprensio-ne dell’evoluzione storica dei luoghi e della complessità degliaspetti naturali, culturali, storici ed etnoantropologici. Il migliora-mento della sua accessibilità rappresenta dunque un altro puntoessenziale.Per quanto concerne il percorso di discesa da Torca, l’analisi dellacartografia storica – rielaborata da Giovanni Visetti56 – confron-tata con quella attuale dell’Istituto Geografico Militare, evidenziaquanto segue. Il sentiero antico, originato dalla contrada di Serola,non seguiva per il primo tratto l’alveo del rivo Iarito, procedendopiù a monte verso l’abitato di Nubila e raccordandosi infine alla
chiesa di Torca, per poi scendere lungo il monte di Torca, attra-versando un’area indicata con il toponimo “Petrecale”. Tale con-dizione è oggi significativamente alterata dalla realizzazione diuna strada carrabile che giunge fino al ponte sul rivo Iarito, a par-tire dal quale si sviluppa il percorso pedonale vero e proprio,costituito da un primo tratto che attraversa la residua vegetazio-ne boschiva, ed un secondo – ben più rilevante sul piano paesag-gistico – che inizia in corrispondenza della frattura del fiordo,quando il visitatore scorge finalmente il mare, segnato ad Estdagli isolotti de Li Galli e di Vetara e ad Ovest dalla punta diMontalto e, più lontano, dall’isola di Capri. É questo il sentiero –costituito per lo più da gradonate in pietra calcarea – i cui ultimilavori di manutenzione risalgono a dopo il 1987. Le condizioniattuali evidenziano una diffusa presenza di vegetazione infestan-te ed alcuni tratti con mancanze degli elementi lapidei dei gradinio dei muretti di protezione esistenti. Tra gli interventi che andreb-bero proposti si evidenziano quindi la rimozione della vegetazio-ne infestante e, soprattutto, il ripristino degli elementi lapidei deigradini e dei muretti, in accordo con quanto consentito dal PRGvigente per le zone E1, impiegando pietra calcarea e malta a basedi calce.Diversi obiettivi dovrebbero invece porsi nei confronti del per-corso di discesa dal monte di Torca alla torre, ben più accidenta-to e poco riconoscibile del precedente, assente nella ricognizione
9
Figura 9Planimetria con i sentieri d’accesso al
fiordo di Crapolla da Sant’Agata e dal
monte di Torca.
Il miglioramento dell’accessibilità dovreb-
be comprendere anche interventi volti a
rimuovere la vegetazione infestante,
sistemare gradini e parapetti ed integrarli
ove necessario, in particolare nei tratti
più pericolosi del sentiero dalla spiaggia
alla torre.
59
1 M. Jakob, Il paesaggio, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 7 e ss.2 Si veda, ad esempio, quanto osservato in anni recenti da L. Scazzosi, Leggere e valutare i paesaggi. Confronti, in Id. (a
cura di), Leggere il paesaggio. Confronti internazionali, Gangemi, Roma 2002, p. 21.3 P. D’Angelo, Estetica della natura. Bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Laterza, Roma-Bari 2001, 20032.4 R. Assunto, Il paesaggio e l’estetica, Giannini, Napoli 1973.5 «“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni» (Convenzione Europea sul Paesaggio, Firenze,
20 ottobre 2000, ratificata dall’Italia con L. 9 gennaio 2006 n. 14).6 Art. 131 commi 1 e 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive
modifiche e integrazioni.7 Cfr. P. D’Angelo, op. cit., p. 163.8 «Il paesaggio italiano è per la massima parte paesaggio culturale» (ivi, p. 145). Sulla componente storica del paesaggio si
rimanda anche a C. Tosco, Il paesaggio come storia, Il Mulino, Bologna 2007.9 G. Piovene, Viaggio in Italia, (I ediz. Mondadori 1958), Baldini & Castoldi, Milano 2003, p. 475. Com’è noto, i testi del
volume di Piovene, originariamente destinati ad un ciclo di trasmissioni radiofoniche della RAI, furono composti tra il 1953
e il 1956, nel corso di un viaggio-inchiesta durato tre anni lungo tutta la penisola.10 La descrizione prosegue con ulteriori elementi fortemente caratterizzanti la costa di Crapolla: «La roccia – sulla quale si
aggrappano cespugli di piante sempreverdi e grandi fichidindia – appare tutta cariata da nicchie e volte, mentre alla base
si incava talora in grotte penetrate dal mare, fiabesche per luci e colori» (A. Sestini, Conosci l’Italia. Il Paesaggio, Touring
Club Italiano, Milano 1963, p. 147).11 Piano Territoriale di Coordinamento e Piano Paesistico dell’area Sorrentino – Amalfitana. Proposta, gruppo di studio
composto da R. Pane, L. Piccinato, G. Muzzillo, A. Dal Piaz, A. Filangieri, G. Vitolo, G. Gallo, A. Marsiglia, G. Francese,
ristampa a cura di Italia Nostra e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2007, p. 26.12 M. Civita, R. de Riso, P. Lucini, E. Nota d’Elogio, Studio delle condizioni di stabilità dei terreni della penisola sorrentina
(Campania), in Geologia applicata e idrogeologia, Bari 1975, vol. X, parte I, pp. 134-138.13 P. Mingazzini, F. Pfister, Formae Italiae. Regio I Latium et Campania, vol. II Surrentum, Sansoni, Firenze 1946, p. 157.14 A. Maiuri, La capitale degli agrumi e la capitale degli ulivi. Variazoni sul “tema” dai taccuini inediti, in Id., Passeggiate
sorrentine, a cura di B. Iezzi, Franco di Mauro, Sorrento 1990, p. 86.15 «Già il nome Torca della borgatella che sovrasta l’altopiano di Crapolla, dice che vi erano per lo meno uliveti e ulive da
spremere al torchio (...) e il proprietario di tutta la contrada montuosa del Monte Tore non trovò di meglio che servirsi di
quell’insenatura per depositarvi il raccolto del suo predio e per tenervi la familia di servi addetti ai servizi della terra, delle
isole e della pesca» (ivi, p. 89).16 Ivi, p. 86.17 «Giungerai per prima cosa alle Sirene che incantano tutti gli uomini che passano loro vicino. Chi senza saperlo si accosta
e ode la voce delle Sirene, non torna più a casa, i figli e la sposa non gli si stringono intorno, festosi: le Sirene lo stregano
con il loro canto soave, sedute sul prato; intorno hanno cumuli d’ossa di uomini imputriditi, dalla carne disfatta» (Omero,
Odissea, XII, 36-45, traduzione di M. G. Ciani, Marsilio, Venezia 1994).18 Strabone, Geografia. L’Italia. Libri V-VI, V, 8, a cura di A. M. Biraschi, Rizzoli, Milano 1988, 20076.
N O T E
dei percorsi storici effettuata dal citato Visetti. Si tratta di un per-
corso molto più vicino alle caratteristiche del trekking, sul qualenon sembra opportuno proporre interventi specifici, tanto per lasua naturale difficoltà che per il suo minore significato sul pianostorico. Molto più rilevante, tuttavia, è il tratto compreso tra latorre ed il fiordo, attualmente segnato da alcune difficoltà di indi-viduazione e da un’estesa presenza di vegetazione infestante, conalcuni tratti particolarmente pericolosi per l’assenza di protezioniper la caduta dall’alto. Per tale sentiero, dunque, sarebbe oppor-tuno prevedere un sistema di interventi volti a migliorarne deci-samente l’accessibilità e la leggibilità, rimuovendo la vegetazioneinfestante e realizzando opportune balaustre di protezione inlegno nei tratti più critici. Ultimo e più importante percorso èinfine quello compreso tra i resti dell’abbazia di San Pietro e laspiaggia, sul quale il tema del miglioramento dell’accessibilitàappare particolarmente rilevante, in quanto interessa anche unnumero più elevato di fruitori, comprendendo coloro che giun-gono a Crapolla via mare. Anche in tale caso potrebbero replicar-si gli interventi di rimozione della vegetazione infestante e di par-ziale ripristino di gradini e muretti.
ConclusioniGli interventi appena citati sono da intendersi a titolo semplice-
mente indicativo e scaturiscono da una prima riflessione di carat-
tere generale, condotta durante la redazione dello Studio di fatti-
bilità. Dal punto di vista operativo, tali indicazioni dovrannonecessariamente essere vagliate attraverso approfondimenti spe-cialistici successivi, relativi, innanzitutto, agli aspetti botanici enaturalistici, ma anche ai caratteri costruttivi che definiscono ipercorsi via terra. Dal punto di vista marino, inoltre, le propostedi fruizione del sito, con il relativo sbarco sulla spiaggia, richiede-ranno una specifica valutazione di compatibilità con le istanze diprotezione della fauna marina, da effettuarsi con l’ausilio di bio-logi marini ed ingegneri marittimi.Ciò premesso, si ritiene che solo una visione d’insieme – capacedi sintetizzare tanti diversi apporti disciplinari riconoscendone lesingole competenze – potrà garantire la sopravvivenza e la valo-rizzazione compatibile di un sito come il fiordo di Crapolla, peril quale appare valida, più che mai, la nozione di paesaggio cultu-rale complesso.
60
19 La citata indicazione sembra infatti contraddetta da quanto esposto dallo stesso Strabone nel libro I della sua Geografia,
dove, polemizzando con Eratostene sull’ubicazione omerica del sito delle Sirene, egli precisa: «(Dice… Eratostene) che leSirene alcuni le localizzano sulla Peloriade (ossia sulla Punta del Faro presso Messina), altri sulle Sirenuse, che distanoda quelle più di duemila stadi; e (dice sempre Eratostene) che queste (ossia le Sirenuse) sono un monte dirupato che sierge con tre cime, il quale divide il golfo di Cuma dal golfo di Posidonia (ossia il golfo di Napoli dal golfo di Salerno). Mané questo monte dirupato ha tre cime, né si erge affatto verso l’alto, ma dalle parti presso Sorrento spunta fuori un bracciolungo e stretto verso lo stretto di Capri, il quale su una parte della montagna ha il santuario delle Sirene, dall’altro, versoil golfo di Posidonia, ha tre isolette distese innanzi, deserte e sassose, che chiamano le Sirene; e su questo stretto vi èanche il santuario di Athena, dalla quale ha preso il nome anche quel braccio» (Strabone, Geografia, I, C, 22, citato in P.Mingazzini, F. Pfister, Formae Italiae. Regio I Latium et Campania, vol. II Surrentum, Sansoni, Firenze 1946, p. 45).Quest’ultimo passo ha indotto Mingazzini e Pfister ad ipotizzare la localizzazione del culto delle Sirene proprio in corrispondenzadella baia di Ieranto, superando definitivamente l’interpretazione proposta dal Beloch, che riteneva invece più probabilel’ubicazione del tempio in corrispondenza della Marina della Lobra, collegando il toponimo a “de-lubrum” (J. Beloch,Campanien. Geschichte und Topographie des antiken Neapel und seiner Umgebung, Breslau 1890; trad. It. Campania.Storia e topografia della Napoli antica e dei suoi dintorni, a cura di C. Ferone e F. Pugliese Carratelli, Bibliopolis, Napoli1989, p. 312). L’ipotesi Mingazzini-Pfister è stata tuttavia messa in dubbio in A. Maiuri, Surrentum, recensione a P.Mingazzini, F. Pfister, Formae Italiae, cit., in «La parola del passato», vol. I, 1946, pp. 391-394, ora in Id., Passeggiatesorrentine, cit., p. 53.
20 Più recentemente la Bonghi Iovino ha evidenziato come la descrizione che Strabone vuole confutare, relativa ad un«monte dirupato con tre cime», sembrerebbe coincidere proprio con i tre “pizzi” che concludono la baia di Ieranto versoEst, confermandone quindi la veridicità (M. Bonghi Iovino, Mitici approdi e paesaggi culturali. La penisola sorrentinaprima di Roma, Nicola Longobardi editore, Castellammare di Stabia 2008, pp. 31-33).
21 A. Maiuri, Le vicende dei monumenti antichi della costa amalfitana e sorrentina alla luce delle recenti alluvioni, inRendiconti dell’Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti di Napoli, vol. XXIX, 1955, ora in Id., Passeggiate sorrentine,cit., p. 57.
22 M. Bonghi Iovino, Mitici approdi e paesaggi, cit., p. 14.23 «Sappiamo bene come il ruolo dei capi e dei promontori fosse importante perché fungevano da punti di riferimento. Gliantichi avevano la percezione delle distanze e dei tempi di navigazione» (ivi, p. 36). Sull’importanza dell’acqua per lanavigazione vedi anche F. Russo, Le torri anticorsare vicereali con particolare riferimento a quelle della costa campana,in «Castella», n. 74, Istituto Italiano dei Castelli, Piedimonte Matese 2001.
24 Cfr. M. Bonghi Iovino, Mitici approdi e paesaggi, cit., p. 37.25 A. Maiuri, La capitale degli agrumi, cit., p. 88.26 «É la più accanita e ardita conquista della montagna che sia stata fatta nelle terre del sud: comincia dal mare e guadagnal’erta di grado in grado, colmando, spianando, incavando e portando terra dov’era sasso e piantando vigna e agrumidov’era sterpo e boscaglia, con la più ariosa architettura di pergolati che si distenda fra cielo e mare, tutto affidando amacerie di sassi intessuti a secco con la stessa abilità con cui gli italici costruivano le mura poligonali delle loro città.Questa singolare vita di monte e di mare in cui il più umile pescatore rivive ogni giorno, tra gli scogli spolpati delle Sirene,la vita del mito e ritrova la sera la sua donna e il terrazzino della sua casa ancora acceso dal fiammante colore dei gerani»(A. Maiuri, Le vicende dei monumenti antichi, cit., pp. 71-72).
27 Cfr. E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Roma-Bari 1961, 19723.28 R. Filangieri di Candida, Storia dei Massa Lubrense, Napoli 1910, rist. Napoli 1991, p. 647.29 J. Beloch, Campanien, cit., p. 314.30 A. Maiuri, La capitale degli agrumi, cit., p. 88.31 Il titolo originario dell’opera, nota comunemente come Geografia o “Libro di Re Ruggiero”, è Opus geographicum, siveLiber ad eorum delectationem qui terras peragrare studeant, oggi edito integralmente a cura dell’Università degli Studi diNapoli “L’Orientale”.
32 «E chi si propone [di andare ad Amalfi lungo] il litorale, va costeggiando da Stabia alla città di surr.nt (Sorrento) per trentamiglia. Sorrento giace su di una punta di terra che si protende in mare; è città popolata, con belle case, ricca di prodottie d’alberi. Ha vicino un canale di difficile accesso, nel quale, durante l’inverno, le navi non possono [entrare a] gettarl’ancora, ma vi sono rimorchiate. Vi si costruiscono navigli. Dalla città di Sorrento al râs m.ntîrah (Capo Minerva, oggiPunta della Campanella) dodici miglia. Da questa a b.s.tânah (Positano), piccolo porto, quindici miglia» (Edrisi (al-Idrisi),L’Italia descritta nel “Libro del re Ruggero”, testo arabo pubblicato con versione e note da M. Amari e C. Schiaparelli, Tip.Salviucci, Roma 1883, pp. 95-96).
33 Ioan. Bapti. Chrysogoni Folengii Mantuani Anachoritate Dialogi..., [1533], ed. ital. a cura di C.F. Goffis, Torino 1958, rip.in E. Puglia, Due eremiti nella Terra delle Sirene: Giambattista Folengo, Pomilio XIII, in «La Terra delle Sirene», 2, 1980,pp. 40-41.
34 D. A. Parrino, Nuova guida de' forastieri per l'antichità curiosissime di Puzzuoli..., [Della città di Massa Lubrense e dell'antico Ateneo, o Capo di Minerva], in Napoli presso Domenico Antonio Parrino, 1715, tomo II, p. 255.
35 M. Starke, Travels in Europe for the use of travellers on the Continent, and likewise in the Island of Sicily: where theAuthor had never been, till the year 1834..., Paris 1836.
36 F. M. Crawford, Coasting by Sorrento and Amalfi, in «The Century Magazine», vol. 48, n. 3, July 1894, pp. 325-336; trad.it. In barca a vela da Sorrento ad Amalfi ed altri storie, a cura di A. Contenti, Edizioni La Conchiglia, Capri 2004, pp. 33-34.
37 Ivi, p. 34.38 N. Douglas, Siren Land, London-New York 1911; trad. it. La terra delle Sirene, Esi, Napoli 1972; Edizioni La Conchiglia,Capri 2002, p. 134.
39 «Un sentiero scosceso (…) scende il pendio diventando sempre più ripido mentre procede fianco a fianco con il piccoloruscello, che termina in una cascatella in fondo alla gola. Non è cammino per una mattinata d’estate, quando il riverberodel calcare assolato è tremendo, tanto che c’è da chiedersi come riuscissero a sopportarlo i vecchi monaci che vivevanovicino al mare, nella badia di San Pietro di Crapolla. Molto probabilmente, allora il sentiero era ombreggiato dalle querceche, in gruppi sparsi si vedono ancora lungo le pendici, nei punti in cui il tagliarle sarebbe stato troppo pericoloso» (ivi, p. 133).
61
40 Ivi, pp. 153-154.41 A. Maiuri, La capitale degli agrumi, cit., pp. 86-87.42 Ivi, p. 91.43 Ibidem.44 R. Pane, Sorrento e la costa, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1955.45 «Il vecchio sordomuto con una berretta da commodoro esprime a gesti che la pesca va male perché si fa con la dinamite
e le acque son diventate fetenti di pesce morto» (A. Maiuri, La capitale degli agrumi, cit., p. 96).46 «A Crapolla scendono, sempre insieme, i fratelli Gennarino, Tiluccio e Peppino ‘e Zi Nicola. Età media, ottant’anni. Essi
pescano sempre nello stesso tratto di mare del quale conoscono non solo ogni corrente e refola di vento, ma anche tuttele pieghe e gli anfratti del fondale (…). Se si indovina l’ora giusta può capitare di incontrarli sul sentiero che, grazie ailoro vetusti polmoni di acciaio, risalgono coi cesti pieni di alici, retunni, triglie e scorfani coloratissimi» (A. de Angelis,Contatti. Persone e personaggi nella terra delle sirene, Edizioni La Conchiglia, Capri 2003, pp. 48-49).
47 Piano Territoriale di Coordinamento e Piano Paesistico dell’area Sorrentino – Amalfitana, cit., pp. 63-64.48 Ivi, p. 100.49 Articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Massa Lubrense, approvato con
Decreto del Presidente della Provincia di Napoli il 21 maggio 1992.50 «Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri
compresi in una fascia delle profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare» (Art. 142comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche eintegrazioni, che conferma la disciplina già introdotta dall’art. 1 della L. 8 agosto 1985 n. 431).
51 Quest’ultimo, com’è noto, è così definito all’art. 28 del Codice della Navigazione: «Fanno parte del demanio marittimo:a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastrache almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo».
52 «L’accesso alla Baia di Ieranto e nel Fiordo di Crapolla è consentito alle unità di servizio, di pesca professionale e alleunità adibite ad attività di visite guidate anche subacquee. L’accesso al fiordo di Crapolla avviene nel corridoio UNO ed èconsentito esclusivamente alle imbarcazioni legittimamente custodite nei depositi esistenti previa autorizzazione da partedell’Ente Gestore. É consentito lo sbarco alle spiagge della Baia di Ieranto e del Fiordo di Crapolla per visite di interessenaturalistico nella misura massima di 100 persone al giorno articolate in gruppi di non più di 25 unità. É vietata la vendita e lasomministrazione di alimenti e bevande» (art. 39 del Regolamento dell’AMP di Punta della Campanella, approvato conD. Min. Ambiente del 12 dicembre 1997).
53 «(…) In riferimento al paesaggio la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati» (art. 6comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni).Con le modifiche del marzo 2008, il concetto di valorizzazione dell’articolo 6 è stato specificamente esteso alla fruizione «daparte di persone diversamente abili», in coerenza con l’emanazione delle Linee Guida per il superamento delle barrierearchitettoniche nei luoghi di interesse culturale, approvate con D.M. 28 marzo 2008.
54 Anche per il vicino fiordo di Furore è stato istituito, da circa dieci anni, un “Ecomuseo del Fiordo di Furore”, censito anchenella guida di M. Maggi, Ecomusei. Guida europea, Allemandi, Torino 2002, p. 132. Se gli obiettivi e le attività previsteappaiono senz’altro condivisibili, gli esiti dell’intervento di restauro compiuto sulle architetture, le cui superfici sono stateintegralmente rinnovate, lasciano piuttosto perplessi.
55 «Le attività di visite guidate, anche subacquee, sono riservati ad armatori residenti in uno dei comuni del Consorzio diGestione della Riserva Marina di Punta Campanella. Le imbarcazioni sono dotate di licenze al traffico passeggeri per levisite guidate anche subacquee, noleggio e/o abilitate alla navigazione ad uso privato o in conto proprio per le sole visiteguidate subacquee ed attrezzate con casse per la raccolta di acque reflue dei residui fecali» (art. 31). «Annualmente,l’Ente Gestore vara un piano di utilizzo del servizio di visita guidata. Sono consentite, alle imbarcazioni al traffico passeggeri,visite guidate giornaliere fino ad un massimo di 14 unità. Mentre per le attività di immersione subacquea sono consentite,alle imbarcazioni abilitate a noleggio e/o a quelle abilitate alla navigazione ad uso privato in conto proprio nelle acquemarittime, visite guidate fino ad un massimo di 20 unità (…). É vietato l’utilizzo di impianti di diffusione della voce e disegnali sonori se non all scopo di fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate dai turisti trasportati e con ilvolume sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli stessi (…)» (art. 32 del Regolamento dell’AMPdi Punta della Campanella).
56 Carta Corografica del Promontorium Minervae nel 1799, elaborata da G. Visetti, 1998, parzialmente disponibile suwww.giovis.com/cartografia.htm, accesso febbraio 2010.
Andrea Pane (Napoli, 1971), architetto e dottore di ricerca in Conservazione dei beni architettonici, è docente a contratto di
Teorie e storia del restauro presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha conseguito ilDiploma di perfezionamento in Architettura dei giardini e assetto del paesaggio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II(2006). É stato relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali ed è autore di 47 pubblicazioni, incentrate tanto su temidi storia del restauro che su questioni di attualità relative alla tutela e alla conservazione. In quest’ultimo ambito ha redatto, incollaborazione, le Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, emanate dal Ministero per iBeni e le Attività Culturali con D.M. 28 marzo 2008. Ha svolto attività professionale nel campo del restauro anche in ambito uni-versitario, collaborando con l’Università IUAV di Venezia e con l’Università degli Studi di Napoli Federico II.É architetto presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani eFoggia.
P ROF I LO AUTORE