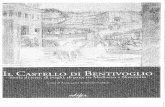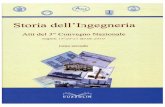Archeologia Etimologica: Origine neolitica ed emiliana di it. BRICIOLA < emil. BRISA 'briciola di...
Transcript of Archeologia Etimologica: Origine neolitica ed emiliana di it. BRICIOLA < emil. BRISA 'briciola di...
ARCHEOLOGIA ETIMOLOGICAOrigine neolitica ed emiliana di it. briciola < brisa 'briciola di
pane, negazione'di Mario Alinei
L'etimologia tradizionaleL'etimologia di briciola e del suo affine emiliano brisa (noto soprattutto per essere divenuto, nel dialetto, l'avv. della negazione), così come viene proposta nei dizionari etimologici, è tipica dell'approccio tradizionale: totale disinteresse per la 'cosa', e semplice ricerca comparata della maggiore somiglianza possibile. Una volta assodato che briciola è il diminutivo di bricia, ampiamente attestato con lo stesso significato (v. oltre), ci si rivolge a fonti antiche e a dizionari moderni, per scoprire in quale lingua (o, più raramente, in quale dialetto) si possa trovare una parola avvicinabile alla nostra; con risultati, naturalmente, che possono apparire anche soddisfacenti. I suoni diun sistema fonologico (così come le lettere dell'alfabeto), infatti, sono pochissimi, la struttura sillabica è universale, mentre le lingue e i dialetti sono innumerevoli; per cui le coincidenze, anche precise, non mancano mai. Nel nostro caso, di queste troppo facili coincidenze hanno approfittato, con qualche differenza nei dettagli, gli autori di tutti i dizionari etimologici, dal Diez al REW, al FEW, al PELI, al DEI, all'AEI, alVEI, al DELI e al LEI. Per citare la sintesi di quest'ultimo, a base dell'etimologia corrente c'è un antico scolio (Schol. ad Pers. I,76), che attesta brisare nel significato di exprimere uvam, cioè 'schiacciare l'uva', simile al brisa 'feccia d'uva' che è in Columella. Voce che si continua anche nell' ant. cat. brisa 'feccia d'uva'. Per cui la nostra briciola testimonierebbe «uno sviluppo semantico dall'originario senso di 'schiacciare l'uva' a quello di'rompere, spezzare, frantumare'», documentato dall'a.fr. brisier, fr. briser, ant. occ. brizar, e risalente a un non attestato verbo *briciare, a sua volta ritenuto di origine celtica. Solo il REW e il DEI negano il rapporto con il celtico: per il primo, l'origine è ignota; per il secondo si tratta, invece, di un "relitto iberico",cioè di una voce pre-IE. Tutto questo, naturalmente, nel contesto tradizionale della romanizzazione, e quindi senza neanche un accenno al rapporto della nozione della 'briciola' con la panificazione. Quanto poi sia ammissibile il passaggio semantico dallo 'schiacciare dell'uva' allo 'spezzare' – due concetti che hanno ben poco in comune – viene del tutto ignorato. Non solo lo
studio della 'cosa', ma neanche l'approfondimento semantico delle ipotesi proposte, fanno parte della tradizione etimologica.
Il nuovo contesto cronologico ed epistemologico dell'etimologia di briciola, alla luce del PCPCome dovrebbe ormai essere noto a tutti, il ruolo fondamentale della romanizzazione viene automaticamente a cadere dopo che l'archeologia ha accertato che non c'è stata un'invasione IE nell'età dei Metalli. Dopo di che, gli IE o sono autoctoni, come vuole il Paradigma della Continuità dal Paleolitico (PCP) [v. www.continuitas.org, con bibliografia], o risalgono necessariamente al Neolitico, come vuole il modello della Dispersione Neolitica (DN) di Colin Renfrew [1987]. Entrambe queste visioni, tuttavia, hanno in comune un corollario fondamentale e rivoluzionario: la formazione delle lingue e dei dialetti tradizionalmente chiamati "romanzi" ha luogo, necessariamente, molto prima di Roma. Per cui non è neanche necessario che il linguista storico, ormai non più "romanista", scelga fra l'uno o l'altro modello. Basta che si renda conto che la romanizzazione, con le nuove scoperte dell'archeologia, ha un ruolo decisamente marginale nella formazione delle lingue e dei dialetti che sono il suo oggetto di studi, e che il latino stesso esiste per lo meno fino dal Neolitico.
Anche per l'etimologo, ovviamente, il nuovo quadro cronologicoed epistemologico comporta conseguenze radicali, sia di metodo chedi sostanza: sul piano metodologico, in primo piano viene ora quella che ho chiamato l'autodatazione lessicale, cioè la collocazione della voce studiata in un preciso contesto storico e semantico, che ora può trovarsi in qualunque momento, dal Mesolitico in poi, per il PCP, e dal Neolitio in poi il modello della DN. Concentriamoci quindi sull'applicazione di questo metodoalla nostra briciola.
L'autodatazione di briciola (e di mica) e l'identificazione della cultura preistoricanel cui ambito è nata l'innovazioneGià dieci anni fa, in quella che è stata la prima illustrazione del PCP) [Alinei 1996-2000], avevo attirato l'attenzione sulla intrinseca antichità di uno sviluppo semantico come quella del nome della 'briciola di pane', che è diventato avverbio negativo: lo osserviamo nelle due famiglie lessicali, semanticamente parallele e (in Italia) geolinguisticamente contigue, di it. e tosc. mica, alto-it. mia, miga, minga, oïl mie e a.prov. miga mija etc., dal lat. mica ‘briciola, minuzzolo (di pane)’, e di emil.
brisa 'briciola', entrambe divenute rafforzativo di negazione e/o avverbio negativo. Scrivevo [Alinei 1996-2000 II: 857-858]: «se siparte da una visione antropologica e cognitiva della relazione frasviluppo intellettuale e linguistico […], è difficile pensare che due mutamenti semantici che vanno dal consumo quotidiano del pane ad astrazioni assolutamente elementari come la negazione possano essere collocati in epoca così recente, addirittura nei secoli successivi alla romanizzazione.»
Oggi aggiungerei, per rafforzare e confermare questa nuova datazione, che occorre anzitutto osservare che la negazione pura esemplice, in tutte le lingue IE, appartiene al lessico PIE, e risale quindi al Paleolitico: cfr. Pokorny [IEW], che s.v. *ně, *nē, elenca aind. ná, av. na-, gr. νε-, lat. ně, non, airl. na[ch],got. ni, asl. ne, itt. natta, etc.
Di conseguenza, qualunque innovazione lessicale che interessi questo ganglio cognitivo e linguistico deve essere, se non paleolitica, in ogni caso molto antica. Nel caso nostro, tuttavia,farei una distinzione che non avevo fatto allora: il lat. mica non si lega necessariamente al pane, ma può essere la 'particella, frammento, granello' di qualunque altro materiale, ed è quindi databile anche al Paleolitico; non a caso, una sua affinità con greco μικρός e con lat. minor è considerata possibile dal DELL; mentre briciola si riferisce soprattutto al pane (cfr. DELI); inoltre, se la mia nuova etimologia (v. oltre) è corretta, deriverebbe proprio dal nome di una parte del pane. Per cui la suadatazione sarebbe, per definizione, neolitica. E come già notavo nel mio libro citato, il suo areale di diffusione rafforza il quadro interpretativo proposto, dato che brisa è tipico della Pianura Padana, il ‘granaio d’Italia’. Non mi pare un caso, insomma, che proprio in quest'area sia stata scelta la {briciola di pane} come iconimo per innovare e rafforzare la negazione. Ed anche per quanto riguarda mica, il suo passaggio alla funzione negativa, sia in Italia che in Francia, non si lega probabilmente al suo significato originario di un 'frammento' qualunque, ma a quello di pane, e quindi al Neolitico. Ed anche i continuatori di mica, come negazione, sia in Francia che in Italia, sono tipici della metà pianeggiante del Nord, e non di quella montuosa del Sud1.1 . Per la Francia, devo le precise informazioni sulla distribuzione di mica a Elisabetta Carpitelli e a GuylaineBrun-Trigaud, che ringrazio. Quest'ultima precisa che « Dans l'ALF […], on ne voit que >> "pas" dans les négations pour le Sud». Le carte dell'ALF esaminate sono: 12 je ne les aide pas, 101 n'aie pas peur, 806 si nous ne mangeons pas, 817 pourquoi ne vous mariez vous pas, 897 ils ne viendraient pas, 898 pour ne
Ma vi è di più: per quanto riguarda brisa briciola e varr., la loro collocazione preistorica può andare oltre una generica attribuzione al Neolitico antico: possiamo addirittura identificare la cultura nel cui ambito l'innovazione lessicale è nata e si è diffusa. Vediamo sulla base di quali argomenti.
Anzitutto, indipendentemente dall'etimologia della parola, è del tutto evidente che briciola2 è un diminutivo di bricia. E se si osserva la carta 991 dell'AIS 'le briciole', si vedrà a colpo d'occhio che:
1. L'area di bricia/briciola è limitata al resto della Toscana, all'Emilia e alla Lombardia meridionale; anche la documentazione antica e i dizionari dialettali confermano cheessa è conosciuta (ed era usata) in un'area più vasta, ma sempre alto-italiana, e limitata alla sua parte centro-occidentale, con infiltrazioni nel trentino e nel veronese (cfr. LEI);
2. tutta la Toscana, tranne la Lunigiana e la Garfagnana, attesta il diminutivo briciola/-o, femminile o maschile; anche la documentazione antica mostra che la forma base in Toscana è rara;
3. la forma base brisa e varr. è invece tipica della Lombardia meridionale, dell'Emilia centrale e della Lunigiana e Garfagnana; la documentazione antica e i dizionari estendono,di nuovo, l'area all'alta Italia centro-occidentale;
4. le varianti attestate nella Lunigiana e Garfagnana toscane sono quelle sonorizzate, briża e briža, tipiche della bassa Padana e dell'alta Italia.
5. In tutta l'Italia centro-meridionale, a Sud di una linea che corrisponde al confine settentrionale delle Marche e dell'Umbria, e che a nord del Lazio attraversa le tre provincie orientali della Toscana (v. oltre figura 1 e 2), mollica è anche il nome della 'briciola'. Per cui, la distinzione concettuale fra 'mollica' e 'briciole' viene realizzata con mollica vs molliche, cioè con l'opposizione singolare vs plurale (cfr. AIS 989 'la mollica' e 991 'le briciole').
Inoltre, come appare dalla cartina della fig.1, che sintetizza
i dati della carta 991 dell'AIS, e ancor meglio da quella della
pas, 899 n'est pas encore, 1082 je ne peux pas, 1083 on ne peut pas, 1452 il ne vaut pas, 1409 tu ne vois donc pas.2 Considero it. briciolo, che ha più spesso il significato astratto di 'piccola quantità', un derivato di briciola. Per la discussione v. oltre.
fig. 2, che sintetizza i dati dell'ALT 286, è evidente che l'innovazione brisa/brisola, con la sibilante sonora, si è diffusa in Toscana dall'Emilia, e che in Toscana ha assunto la forma ipercorretta bricia/briciola, con la palatale sorda.
Figura 1: Areale di distribuzione di briża e varr. (quadrato pieno),
briciola e varr. (quadrato vuoto) e brìcoli (trangolo)
Figura 2: l'areale del tipo sonorizzato in Toscana (quadrato pieno) mostra lasua provenienza dall'Emilia (dall'ALT 286, modificato)
Il passaggio dall'emiliano brisa al toscano brigia > briciola ha seguito, insomma, lo stesso percorso che ho descritto recentementein Alinei [2010], secondo il quale il cagio 'caglio' lombardo-emiliano (da lat. coagulum), penetrato nella forma sonorizzata in Lunigiana e Garfagnana, nel resto della Toscana è poi divenuto cacio, come nome del formaggio (Alinei 2010).
Vi è però una differenza fondamentale fra la diffusione di cagio > cacio e quella di brigia > briciola: mentre questa si ferma, comesi vede dalla figura nr. 1, lungo una linea appena a sud di Forlì,Firenze e Grosseto, quella di cacio prosegue inarrestabile fino all'estremo meridione. Nel mio citato articolo sui nomi del caglio/formaggio, basandomi sulla datazione dell'invenzione del formaggio alle prime culturali pastorali del tardo Neolitico da parte degli archeologi, nonché su argomenti ergologici, ho potuto
concludere che la genesi e la prima diffusione del caglio-formaggio e del suo nome latino coagulum sono da collocarsi nell'ambito della cultura tardo-neolitica di Chassey (Francia meridionale) e della sua successiva diffusione in alta Italia; e la seconda, nell'ulteriore diffusione della cultura di Chassey-Lagozza dall'alta Italia fino all'estremo meridione italiano.
Va osservato, tuttavia, che mentre l'innovazione del formaggiorisale al tardo Neolitico, quella della panificazione risale al Neolitico antico. E il suo focolaio italiano, inoltre, non può essere cercato nella prima cultura neolitica in assoluto – quella della Ceramica Cardiale – geograficamente limitata alle coste dell'area italide mediterranea, e tecnicamente limitata all'introduzione delle specie domestiche, animali e vegetali, bensì nelle culture immediatamente successive, quando le prime comunità cerealicole, necessariamente sorte nella pianura, hanno avuto il tempo per perfezionare tutte le fasi della complessa tecnica che precede la panificazione, e cioè, dopo la zappatura e la semina (comuni alle altre coltivazioni), la mietitura, la legatura dei covoni, la trebbiatura, la pulitura, la crivellazione e la macinazione del grano, la preparazione della pasta e la cottura nel forno.
Ora, il punto cruciale per l'individuazione della cultura neolitica antica, nel cui ambito deve essere nata l'innovazione lessicale della brisa > briciola, è proprio nella sua nettissima frontiera meridionale, lungo la citata linea a sud di Forlì, Firenze e Grosseto, dove si incontra con la massiccia area centro-meridionale di mollica: in pratica, nella sua concentrazione in Lombardia meridionale, Emilia e Toscana occidentale e centrale. Vedremo, più oltre, come siano significativi anche i suoi riscontri in Francia meridionale.
Come ho già mostrato in un recente articolo, relativo a sdraiare e ai suoi affini agricoli lombardo-emiliani [Alinei in st.a], la sola cultura neolitica antica che mostri questo areale in Italia è quella di Fiorano (dal sito eponimo di Fiorano Modenese), del VI/V millennio, in parte coeva con le ultime fasi della Ceramica Cardiale. Il suo focolaio è nelle province di Reggio e di Modena, ma il suo areale si estende alla Romagna, allaToscana settentrionale e al Veneto meridionale (cfr. figura 3).
Fig. 3: Areale della cultura di Fiorano (da Seragnoli, 2007-2008, modicato)
E' utile ricordare, a questo punto, anche l'origine padana delnome della zappa, che con ogni probabilità continua quello del primo utensile neolitico, il bastone da scavo di legno, dal lat. cippus 'palo confitto nel terreno', con tipico passaggio 'padano' di/i/ breve tonico ad /a/ (cfr. Alinei [2000, 851-2, in st.b]). In effetti, si potrebbe ora ipotizzare che anche questa fondamentale innovazione tecnologica e lessicale sia nata nell'ambito della cultura di Fiorano, e che di lì sia stata diffusa in tutta l'Italia settentrionale dalla successiva cultura dei Vasi a Bocca Quadrata. Come è normale attendersi dal PCP, infatti, man mano chele corrispondenze archeologiche e linguistiche si infittiscono, diventano sempre più produttive, generando un circolo virtuoso di grande valore.
Anche l'attestazione di brisa lungo la sponda sinistra del Po, nel mantovano e nel cremonese (v. figura 1), coincide perfettamente con la cultura del Vho di Piadena, una delle prime culture neolitiche dell'Italia settentrionale (v. figura 4):
Figura 4: Areale della cultura di Vho di Piadena (da Seragnoli 2007-2008,modificato)
Analogamente, la presenza di brisa in Piemonte meridionale ha
un preciso riscontro nel sito neolitico di Alba e di Brignano-Frascata.
Per quanto riguarda la Francia, la carta1630 dell'ALF ('mie de pain') mostra chiaramente l'area di distribuzione del nostro tipo (v. figura 5):
Figura 5: Area di distribuzione del tipo brisa 'briciola' in Francia (dall'ALF 1630, modificata)
Le caratteristiche dell'area sembrano quindi corrispondere
abbastanza da vicino alla diffusione della Ceramica Cardiale «lungo la costa tirrenica e in Linguadoca, dove giungono influssi delle facies italiche» (Seragnoli 2007-2008, 87, enfasi mia). Ciòche sembra confermare che il tipo brisa in Francia è un prestito dall'alta Italia.
La nuova etimologiaPassando ora alla nuova etimologia, una valida alternativa all'origine celtica di briciola – insostenibile nel nuovo quadro cronologico – può essere cercata, a mio avviso, proprio nel suo principale concorrente in Italia, cioè mollica. Ecco gli argomenti:
(1) anzitutto, la stessa compresenza e contiguità delle due forme;
(2) in secondo luogo, il rotacismo della /ll/ di mollica, che in Toscana, nella forma morìcola (si noti il diminutivo) è attestato in cinque punti dell'Aretino, non lontano dall'Emilia-Romagna (cfr. ALT 286 'briciola'); (3) infine, la fondamentale tendenza – in quelle aree italidi che nel corso delle età dei metalli verranno poi profondamenteceltizzate (quindi, nella terminologia tradizionale, gallo-romanze, gallo-iberiche e gallo-italiche, fra cui, naturalmente, anche quella emiliana, lombarda e piemontese) – all'epentesi di una /b/ o /d/ fra nasale e liquida, talvolta con successiva caduta della nasale: è il fenomeno che sta allabase di sviluppi arcinoti come fr. chambre, sembler e tendre, dalat. camera, similare e teneru; e meno noti come cat. berena, emil. brenda, march. mbrenna ecc., da lat. merenda; cat. berenar e brenar, Lescun brená, Arrens berná, bearn. brená,
Lavedan abrená, monferr. ambreudée ecc., da lat. merendare (FEWs.vv. merenda, merendare); emil. ambrola ecc., da lat. medulla (tramite merulla); altoit. brizare ecc., da lat. meridiare (AIS VI, 1186, PP. 310, 311), e così via. Ecco, per illustrare meglio la diffusione del fenomeno, l'areale del tipo brenda e vocmbrenda, da lat. merenda (fig. 6):
Figura 6: Areale di brenda da lat. merenda (orizzontale) e di (voc.)-mbrenda(verticale)
(dall'AIS 1030 'merenda')
Come si vede, si tratta di un'area tipicamente emiliana, simile a quella di brisa, con un'estensione, nella variante nasalizzata, alle Marche.
Per cui, da un lato si capirebbe come la variante moricola (v. sopra) sia potuta passare a bricolo (attestata all'Elba, come abbiamo visto) e, dall'altro, come il lat. *mollicia (la cui esistenza è assicurata dalle forme valdostane molœs [accento su œ](ALF 1630 pp. 975, 985), molęs (p. 986), molęts (p. 987), Brusson mollęts, Ronco molęhi, e Val Soana miolìθi (e cfr. FEW s.v. mollica)), divenuto *moricia nell'area settentrionale caratterizzata dal rotacismo di /l/ (Rohlfs GS I, § 221), sia potuta diventare la base del successivo passaggio a brisa e a briciola.
RIFERIMENTI
AEI = Devoto, Giacomo, Avviamento alla Etimologia Italiana – Dizionario Etimologico, Le Monnier, Firenze, 1967.
AIS = Jaberg, K. e J.Jud, Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, Zofingen, 1928-1940, 8 voll.
ALF = J. Gillieron, J, - E. Edmont, E. (1968), Atlas linguistique de la France, Bologna, Forni Editore, 10 voll. (ediz. orig. Paris, H.Champion, 1902-1910, 11. voll.)#
Alinei, Mario [1996-2000], Origini delle lingue d'Europa, vol. I - La teoria della continuità, II: Continuità dal Mesolitico all'età del Ferro nelle principali aree etnolinguistiche, Il Mulino, Bologna.
*Alinei, Mario [2010], Archeologia Etimologica: alle origini del formaggio: da lat. coagulum 'caglio' a lat. caseus/-m 'formaggio'; *formaticum e *toma, in …
*Alinei, Mario [in st.a], Archeologia Etimologica: l'origine di sdraiare e dei suoi affini dialettali "agricoli", in…
*Alinei, Mario [in st.b], Origini neolitiche e latine di zappa, in… ALT = ALT-Web, in www.cultura.toscana.it.DEI = Carlo Battisti, Giovanni Alessio, Dizionario etimologico italiano,
Firenze, G. Barbèra, 5 voll., 1968.DELI = Manlio Cortellazzo, Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua
italiana, Bologna, Zanichelli, 5 voll., 1979.DELL = A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine
histoire des mots, Librairie C. Klincksieck, Paris, 2 voll., 1959-1960.
FEW = Von Wartburg, Walter, Franzosisches Etymologisches Wörterbuch, 1948-IEW = Pokorny, Julius, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern,
Francke Verlag, 1969, 2 voll.LEI = Max Pfister, Max, Lessico Etimologico Italiano, Wiesbaden, Ludwig
Reichert Verlag, Wiesbaden, 1979-.PELI = Bruno Migliorini, Aldo Duro, Prontuario etimologico della lingua
italiana. Torino, Paravia & C., 1958.REW = W. Meyer-Lübke, Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg,
Carl Winters, 1935.Renfrew, Colini [1987], Archaeology and language. The Puzzle of Indo-European
Origins, London, Jonathan Cape.Rohlfs GS = Gerhard Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi
dialetti, Torino, Giulio Einaudi editore, 3 volumi. Seragnoli, Laura [2007-2008], Il Neolitico, Dispense del corso a.a. 2007-2008,
Università degli Studi di Milano. VEI = Angelico Prati, Vocabolario etimologico italiano, Roma, MultigraficaEditrice, 1969.