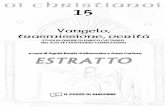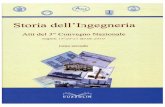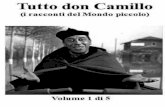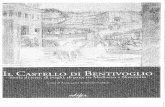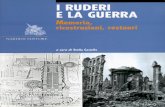A. PANE, Da Boito a Giovannoni: una difficile eredità, in «’ANAΓKH», n. 57 (numero...
Transcript of A. PANE, Da Boito a Giovannoni: una difficile eredità, in «’ANAΓKH», n. 57 (numero...
.ANArKH S7 NUOVA SERIEMAGGIO 2009Quadrimestrale di cultura, storia e tecniche della conservazione per il progetto
Autorizzazione del Tribunale civile e penale di Milano n. 255 del 22 maggio 1993
Direttore responsabile:Marco Dezzi Bardeschi
Hanno redatto questo numero:Marianna Carrera, Chiara Dezzi Bardeschi.
In questo numero contributi di:Mario Bencivenni, docente a controtto di Teorie e storia del restauro, Politecnico di Milano; Roberto Cassanelli, docente di Teoriae critica della Fotografia, Accademia di Belle Arti di Brera e docente di Storia e tecnico della Fotografia, Scuola di specializzazione in BeniStorici Artistici, Università Conolico di Milano; Chiara Dezzi Bardeschi, dottore di ricerco in Archeologia, docente o contratto di Restauroarcheologico, Politecnico di Milano; Gabriella Guarisco, professore associato di Restauroarchitettonico, Politecncio di Milano; ErmesInvernizzi, dottore di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana, docente a contratto di Composizione orchitenonico, Analisi dellaMorfologia urbano, Politecnico di Milano; Nora Lombardini, ricercatore in Restauro, Politecncio di Milano; Andrea Pane, orchitetto,docente a controne di Teorie e storia del restauro, Università di Napoli Federico Il; Silvia Perindani, diplomata all'Accademia di Brera;Sandro Scarrocchia, architetto e storico dell'arte, professore di Metodologia della progettazione, Direttore dello Scuola di restaurodell'Accademia di belle arti di Brera
Comitato scientifico internazionaleMounir Bouchenaki, Francois Burkhardt, Giovanni Carbonara, Francoise Choay, Philippe Daverio, Lora VincaMasini, Javier Gallego Roca, Werner Oechslin, Salvatore Setti s, Carlo SiniCorrispondenti italianiPiemonte e Val d'Aosta. Maria Adriana Giusti, Rosalba lentile, Liliana Pittorello; Lombardia.' Maurizio Bariani, RaffaellaColombo, Giorgio Macchi, Sandro Scarrocchia, Gian Paolo Treccani; Veneto: Renata Codello, Giorgio Gianighian,Domenico Luciani; Li[}uria:Stefano F.Mussa; Emilia Romagna: Aldo De Poli, Carla Di Francesco, Andrea Ugolini; Tosca-na: Mario Bencivennl, Giuseppe Cruciani Faboui, Maurizio De Vita, Daniela Lomberini; Lazio: Calogero Bellanca,Margherita Guccione, Maria Teresa Jaquinta, Giorgio Piccinato, Maria Piera Sette; Campania: Stella Casiello, Ales-sandro Castagnaro, Stefano Gizzi, Andrea Pane; tv1arche eAbruzzo: Claudio Varagnoli; Calabria e Basilicata: AlessandraManiaci, Simonetta Valtieri; Sicilia: Gaspare Massimo Ventimiglia, Franco Tomaselli; Sardegna: Elio Garzillo
Isaggi contenuti in questo numero di 'ANArKH sono stati rivisti da referee di nazionalità diversa da quella degli autori, selezionati percompetenza tra i membri del Comitato Scientifico Internazionale.
The articles published in this issue of 'ANArKH have been reviewed by the following international referees, selected among the membersof the International Scientific Committee.
prezzo di ciascun numera: Italia € 13,00 Comunità Europea € 16,00 resto del mondo € 22,00abbonamento annuale (3 numeri): Italia € 35,00 Comunità Europea € 5000 resto del mondo € 75,00abbonamenti e pubblicità: Alinea editrice srl- 50144 Firenze, via Pierluigi da Palestrina 17/19 r, te!. (055) 333428fax 055/331013 c.c.p. n. 11378502
Direzione, Redazione e Segreteria:Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, Politecnico di Milano20158 Milano, via Durando, 10Te!. : 02-23995656 Fax: 02-23995638/5669E-Mail: redazione.ananke@gmai!.com;[email protected]
© copyright Alinea editrice s.r.l. - Firenze 200350144 Fìrenze, via Pierluigi da Palestrina, 17/19 rossoTe!. 055/333428 - Fax 055/331013ISSN 1129-8219E-mail: [email protected]@alinea.ithMp:/www.alinea.it
tutti i diritti sono riservati: nessunaparte può essere riprodotta senza il consenso della Casa editricefinito di stampare nel maggio 2009stampo: Genesi Gruppo Eoitoriale - Cittò di Castello (PG)
~NArKH57.~UOVA SERIEMAGGIO 2009
NUMERO MONOGRAFICO: RILEGGERECAMILLO BOITO, OGGI
Editoriale
2 Baita a centocinquant'anni dal suo approdo a Milano (1859)Marco Dezzi Bardeschi
Rileggere Camillo Baita, oggi
Gabriella GuariscoMarco Dezzi BardeschiMario BencivenniChiara Dezzi BardeschiSandro Scarrocchia
61630486482
A rofondimenti
Baita in viaggio: frammenti di un discorso autobiograficoBaita, da Parma (1870) a Milano (1872): l'esordio ai congressiBaita a congresso: da Milano (1872) a Torino (1884)Baita e Giuseppe Poggi: trama di una frequentazione intellettualeBaita e il Restauro ArcheologicoL'Arte Industriale e il restauro in Camillo Baita
Roberto Cassane IliMarianna CarreraErmes InvernizziNora Lombardini
100110120128
L'eredità
Il Fondo fotografico di Baita all'Accademia di BreraBaita e il suo tempo: lo fotografia agli albori del restauroMemoria e invenzione in Camillo BaitaBaita e i marmi di San Marco a Venezia
Andrea PaneSilvia PerindaniSandro Scarrocchia
144155160
Da Baita a Giovannoni: una difficile ereditàBrera, 1912 e 1923: documenti per lo Scuola di restauroBrera, 2009: per la Scuola dedicata a Camillo Baita
L'eredità
~DA BOITO A GIOVANNONI: UNA DIFFICILEEREDITAANDREA PANE
Abstract: A well-established opinion points out Gustavo Giovannoni as an ideaI follower of Camillo Boito in the fieldof preservation and restoration of monuments. Giovannoni himself wrote about this legacy, introducing Boito as the firsttheorist of an "intermediate way" in restoration, set befween Viollet-Ie-Ducand Ruskin. Many differences, however, markthe personalities of Boito and Giovannoni, beginning from their biography ending to the cultural milieu that surroundedthem. But, at some time, some relationship could be confirmed, as the similar approach to history of architecture andthe common interest in architect's education. Above all, fwo questions seem more criticaI in their different approachesto the restoration: the problem of contemporary addition to the monuments and the interest for historic fabric of the city.
Un consolidato giudiziostoriografico individua in GustavoGiovannoni un ideale discepolo econtinuatore delle teorie di CamilloBoito in materia di tutela e restaurodei monumenti. In una visione line-are ed evolutiva della disciplina,lo figura di Giovannoni apparespesso collocata al termine di unpercorso che, a partire dalle prime
C Boito istanze "filologiche" evidenziateda Boito, condurrebbe-apparen-
temente senza contraddizioni ed incertezze - ad una verae propria dottrina "scientifica" del restauro, della qualeGiovannoni costituirebbe il principale codificatore ed inter-prete (l). In questa prospettiva, le personalità di Boito eGiovannoni sarebbero da porre in stretta relazione e le lororispettive vicende culturali risulterebbero segnate da notevo-li analogie e affinità, nonché da sporadici contatti diretti (2).Questa interpretazione si fonda su numerose evidenze, aprima vista difficilmente confutabili: l) l'impegno pubblicoin materia di restauro, finalizzato alla redazione di normecondivise e trosrnissibili a tutto il territorio italiano, che ponein evidente continuità i principi fatti approvare da Boito alIVCongresso degli Ingegneri ed Architetti Italiani del 1883,con il lavoro svolto da Giovannoni ad Atene nel 1931 e,
144
più ancora, nell'ambito del Consi-glio Superiore delle Antichità e Bel-le Arti per lo redazione della Cartaitaliana del restauro del 1932; 2) ilruolo di protagonista che entrambirivestono, in successione di tempo,nel dibattito per l'istituzione delleScuole di Architettura e per lo pro-mozione della figura dell'architetto;3) il rapporto storia-restauro, che,come ha osservato Zuccon i, sem- G. Giovonnonibra fondarsi, sia in Boito che inGiovannoni, su una visione della storia dell'architetturacome ambito di studio funzionalmente legato all'operativitànel restauro (3); 4) il rapporto storia-progetto, considerandoche entrambi credono fermamente, pur con diverse sfuma-ture, che un nuovo stile architettonico possa nascere soltantodalla conoscenza e dalla continuità con il passato [medio-evale per Boito; rinascimentale per Giovannoni), contra-stando pericolose "rotture" con lo tradizione. Ai quattropunti citati, infine, se ne può aggiungere un quinto, nonmeno significativo dei precedenti: lo ricorrente contraddi-zione tra teoria e prassi, che contraddistingue l'opera dientrambi nel momento in cui si cimentano direttamentenell'intervento sui monumenti. Se l'insieme di questi aspettisembra apparentemente confermare lo tesi di una sostan-
Giacomo Favretto, Una lezione anatomico nello Reale Accademia di belle Arti di Venezia, 7873, il dipinto esprime bene il rnilieu culturale di Baita, raHigurandotemi e suggestioni descritti nel suo racconto Un corpo (7870)
zia le continuità Boito-Giovannoni - riferita non soltantoall'ambito del restauro, ma più in generale a tutta lo sferaarchitettonica - non pochi sono i nodi critici, come si vedràpiù innanzi, che distinguono nettamente i due personaggi,anche in ragione del diverso contesto culturale nel quale sitrovano ad operare.Di un'esplicita eredità boitiana parlalo stesso Giovannoni nei suoi scritti,dichiarando, in diverse occasioni, ilproprio debito nei confronti del mae-stro milanese e proponendosi comecontinuatore di quella "teoria interme-dia", compresa tra gli estremi oppostidel restauro stilisfico e della conserva-zione integrale (4). Se lo sede piùautorevole per tali affermazioni risultasenz' altro lo voce "Restauro", redattada Giovannoni per l'Enciclopedia ita-liana nel 1936, non va trascurato chegià nel 1913, quando lo studiosoromano compone il suo testo fonda-mentale in materia di restauro deimonumenti - primo suo vero contribu-to sistematico al tema, ripreso piùvolte negli anni successivi - lo figuradi Boito, all'epoca ancora vivente,assume un rilievo centrale. Com'èben noto, il lungo testo trae origine dauna conferenza tenuta da Giovannonial primo Convegno degli ispettoriOnorari ai Monumenti e Scavi, svolto-si a Roma nell'ottobre 1912, e compare, col titolo Restauridi monumenti, nel primo numero del Bollettino d'artedell'anno successivo (5). il saggio rappresenta una signifi-cativa evoluzione del pensiero dello studioso romanosull'argomento, dopo le brevi riflessioni formulate dieci anniprima, quando - appena trentenne - aveva manifestato unatteggiamento favorevole al completamento dei monumenticitando esplicitamente Viollet-Ie-Duc, in opposizione 01-
l'orientamento conservativo emerso a conclusione del Se-conda Congresso internazionale di Scienze Storiche, inmerito alla vexata quaestio del completamento della faccia-ta del Duomo di Milano. Già in quell'occasione, sia purein nuce, Giovannoni aveva delineato lo necessità di riferirsiad una classificazione dei diversi tipi di restauro (6), al fine
di agevolare lo difficile trasposizionedelle teorie alla realtà operativa, ci-tando per lo prima volta Boito, asostegno dell'opportunità di comple-tare lo facciata del duomo milanese.È solo nel l 91 3, tuttavia, cheGiovannoni assegna un rilievo signifi-cativo al contributo di Boito, probabil-mente anche in ragione delle vicissitu-dini che avevano accompagnato locomplessa organizzazione del Con-vegno. Dal carteggio tra l'anzianoBoito ed il direttore Corrado Ricci,infatti, emerge come quest' ultimo aves-se in prima battuta invitato proprio ilmaestro milanese come relatore illu-stre per lo conferenza sul restauro deimonumenti, ripiegando- in seguito aldiniego di Boito, motivato da stan-chezza e dubbi sull'utilità dell'incon-tro - sul nome di Giovannoni (7). Lascelta di quest'ultimo aveva ricevuto,infine, il placetdello stesso Boito, cheaveva descritto lo studioso romanocome uomo «che sa fare e sa dire,
misurato e schietto, sperimentato e giovine» (8).il piccolo retroscena aggiunge, dunque, ulteriori significatial peso attribuito alla figura di Boito nella trattazione diGiovannoni. il pensiero del maestro milanese è introdotto altermine del lungo excursus storico dedicato all'origine delconcetto di restauro, che Giovannoni - in perfetto accordocon lo posizione di Viollet-Ie-Duc «<lemot et lo chose sontrnodernes»] e poi di Boito stesso (9) - ritiene di origine
145
recente, senza però trascurare una prima riflessione sulrapporto con le preesistenze dall'antichità classica alSettecento. Delineando lo "teoria intermedia" del restauro,Giovannoni riconosce infatti che «il più autorevole ed illustreassertore tra noi, coi precetti, coi consigli e con l'esempio,è stato Camillo Boììo». al quale attribuiscesoprattutto il merito di aver esteso agliedifici medioevali, «campo favorito deirestauratori moderni», indirizzi già in parteapplicati ai monumenti antichi, ma anchedi aver promosso il voto del Quarto Con-gresso degli Architetti e Ingegneri Italianidel 1883, che non esita a definire «quasiMagna Charta dei restauri moderni» (10).Non sorprende, dunque, che l'anzianoBoito manifesti in una lettera a Giovannonilo propria approvazione verso il saggio,rilevando che «inesso brillano due virtù cheper solito si escludono a vicenda, il caldosentimento dell'arte e il buon giudiziomisurato e pratico» (11 ).Poco più di dieci anni dopo, il riferimentoa Boito è più che esplicito nella raccolta discritti di Giovannoni Questioni di architet-tura nella storia e nella vita (Roma 1925),che richiama, dal titolo ai contenuti, il piùcelebre Questioni pratiche di Belle Arti,pubblicato da Boito a Milano nel l893.Nell'introdurre il volume, infatti, lo studiosoromano dichiara di aver ritenuto «nonozioso il seguire, modestamente e dalontano, l'esempio di quel grande e indi-menticabile maestro ch'è stato CamilloBoito, che all'arte ha reso così alti servigianche quando ha sostenuto, con lo suamirabile eloquenza, idee errate», raccogliendo saggi edarticoli apparsi in tempi diversi su temi architettonici (l 2). Traquesti figura, con lievi rielaborazioni, il citato saggioRestauri di monumenti, dove il giudizio su Boito è sostanzial-
EDILIZIA
mente confermato, con l'aggiunta di un'interessante postillasull'origine della pratica tassonomica in materia di restauro,che già costituiva l'ossatura dello scritto del 1913.Soffermandosi sulla ben nota distinzione tra monumenti vivie morti (da lui riferita esplicitamente a precedenti scritti di
Schmidt e Cloquet) (13), Giovannoni ri-chiama infatti lo suddivisione, proposta daBoito nel celebre dialogo Conservare orestaurare del 1886, tra restauriarcheologici, pittorici e architettonici, qua-si a voler giustificare e rafforzare la propriascelta di introdurre le cinque categorie deirestauri di consolidamento, ricomposizione,liberazione, completamento e innovazio-nel 14). Collocata ormai in una prospettivastorica, lo figura di Boito inizia dunque adassumere, per Giovannoni, il ruolo di veroe proprio" padre fondatore", come confer-ma lo relativa voce biografica per l'Enciclo-pedia Italiana, compilata dallo studiosoromano nel 1930, dove Boito è definitocome «vero fondatore degli studi di storiadell'architettura in Italia» e «legislatore indi-scusso» in materia di restauro (15). Inquest'ultimo campo, lo consacrazione de-finitiva della linea di continuità Boito-Giovannoni, giunge, come prima accen-nato, con lo voce "Restauro" del 1936,dove lo «teoria intermedia, sostenuta inItalia da C. Boito e da G. Giovonnoni» èpresentata dallo studioso romano come ilpiù moderno orientamento in materia (16).Fin qui, dunque, l'interpretazione lineareproposta da Giovannoni, alla quale si èattenuta lo storiografia per almeno un
cinquantennio, ponendola in discussione soltanto a partiredalla metà degli anni Ottanta del Novecento (17). A partireda questa data, infatti, il fiorire di scritti su Boito ha spessoevidenziato i limiti di questa apparente continuità, benché
CITTÀ
UOVA
c..,., ..... _
l'''I:~!!:!,",!:~I!!~!!!.I!!.'.~~~.!:'$'''-.J .....
146
a tutt'oggi manchi ancora un contributo che affronti nellospecifico il rapporto tra i due personaggi. L'intento di questebrevi note è quindi proporre un primo confronto rawicinatotra Boito e Giovannoni, partendo proprio dalle apparentiaffinità richiamate in premessa.L'analisi delle relative biografie evidenzia, in prima istanza,più differenze che analogie, a partire dalla constatazioneche le loro rispettive vicende - accomunate soltanto dainatali romani (Boito 1836, Giovannoni 1873) - risultanoseparate da un quarantennio particolarmente significativoper lo storia d'Italia: Boito è segnato fin dall'infanzia dalclima del moti risorgimentali (18), mentre Giovannonicresce nel fervore degli anni immediatamente successivialla presa di Roma, che aveva di fatto concluso il processodi unificazione. Opposti e quasi simmetrici risultano, adesempio, i rispettivi percorsi formativi: Boito, com'è bennoto, privilegia lo componente artistica, frequentando l'Ac-cademia di Belle Arti di Venezia, implementandola tuttaviacon il biennio matematico seguito presso lo Studio diPadova, che lo farà accedere al diploma di architetto civilenel 1855 (19). Giovannoni, per converso, fa seguire allasua laurea in ingegneria, conseguita presso lo Scuola diApplicazione di Roma nel 1895, il biennio dispeciolizzozione in Storia dell'Arte con Adolfo Venturi(1897-99) presso lo Facoltà di Lettere.Le loro prime esperienze di studio sembrano tuttavia percor-rere, idealmente, itinerari affini: Boito inizia a studiare lecostruzioni medioevali del Lazio e della Toscana con unaborsa di studio, concessagli grazie a Pietro Selvatico nel1856, nel corso della quale approfondisce in particolarel'architettura cosmatesca (20), mentre Giovannoni dedicaad edifici medioevali i suoi primi lavori sistematici di ricerca,sfociati nei due volumi sui monasteri di Subiaco del 1904ed in diversi contributi brevi, relativi ora all'attività deimarmorari romani dei secoli XII e XIII, ora ai battisteri, finoalla pionieristica proposta di schedatura delle strutturemurarie medioevali (21). Tale affinità cesserà tuttavia benpresto, se si confronta il peso assunto dall'architetturamedioevale nella riflessione e nell'operatività di Boito (basti
citare soltanto il volume Architettura del Medio Evo in Italiadel 1880), ben in linea con il suo tempo, rispetto alcrescente interesse di Giovannoni per il Rinascimento, a suavolta coerente con il fiorire di studi su tali temi in ambitoeuropeo a partire dai primi anni del Novecento (Si pensiall' enorme influenza di opere come Die Kulturder Renaissancein Italien di Burckhardt, tradotta in Italia già nel 1876).Soffermandoci ancora sulle biografie, potremmo rintraccia-re qualche vaga analogia tra due vite vissute in sostanzialesolitudine, benché Boito, a differenza di Giovannoni, sisposi due volte, soffrendo comunque dolori e separazioni(22). Profondamente diverso, tuttavia, ci appare il milieuculturale che circonda i due personaggi. Non si tratta,owiamente, della sola distanza, geografica e storica, chesepara lo Milano post-risorgimentale dalla Roma giolittianae poi fascista, ma soprattutto delle inclinazioni artistiche edel talento letterario di Boito, che, com'è stato più volteevidenziato, ha un peso molto significativo nel caratterizzar-ne lo personalità, ancorché egli stesso lo considerassecome un aspetto minore della sua multiforme attività (23).Partecipe - insieme al fratello Arrigo e personaggi comePraga e Tarchetti -della temperie scapigliata, Boito mostra,in ambito letterario, una spiccata propensione per losuggestione pittorica ed impressionistica tipica della brevenovella di viaggio, diffusa nella letteratura del secondoOttocento, come nelle Gite di un artista (24), insieme adun'irresistibile attrazione per temi più macabri, propri dellaScapigliatura, come lo vanità della bellezza, lo morte,l'anatomia, le ricerche scientifiche sulla conservazione deicadaveri (25), tutti temi densi di ricadute nel pensiero sulrestauro (26). Testimonianza eloquente di questo orizzonteculturale, come è stato più volte rilevato, è il racconto Uncorpo, che apre lo prima opera letteraria di Boito - loraccolta Storielle vane, pubblicata per lo prima volta nel1876 - dove i temi della medicina, dell'anatomia e dellafugacità della bellezza si mescolano alla dialettica tra realtàe immagine, sullo sfondo di una contesa, attualissima perl'epoca, tra ideale artistico-romantico e pensiero scientificopositivista (27). In una Vienna notturna e misteriosa, Boito
147
ambienta l'amore, dall'infelice epilogo, di una ragazza edi un pittore (alteregodello stessoCamillo), che ne ha ritrattoil corpo in un dipinto dedicato alla ninfa Aretusa. Labellezza della ragazza desta l'interesse di uno scienziatoimbalsamatore, sostenitore del predominio della chimicasullo spirito ed orientato a scoprire il principio scientificodella bellezza, il quale, non potendo disporre del corpodella giovane, ne acquista il ritratto del pittore. Atterrita dalpresagio di finire sul tavolo anatomico dello scienziato, loragazza muore incidentalmente cadendo nel Danubio,finendo per assecondare involontaria-mente il desiderio dell'imbalsamatore,mentre l'infelice pittore, sgomento allavista del corpo senza vita dell'amata sultavolo anatomico, si rassegna ariacquistarne il ritratto, abbandonando ilcorpo allo scienziato (28).Il talento letterario di Boito, particolar-mente incline alla breve novella o alladescrizione impressionistica di luoghi epaesaggi, si estende quindi anche nelloscrivere di temi architettonici, ai quali sidedica con medesimo impegno (29),raggiungendo un'agilità che non ha al-cun riscontro nella prosa controllata,ripetitiva e spesso retorica di Giovannon i, G. Giovannoni, rilievo e progetto di restauro difrutto della sua formazione eminentemen- s. Andrea ad Orvieto, 1930
ordinamento di studi per architetti civili (31), che anticipa icontenuti dei suoi più noti scritti successivi, mentre Giovannonisvolge già nel 1907 funzioni di relatore di una specificacommissione, nominata dall'Associazione Artistica fra iCultori di Architettura sul tema delle scuole di architettura,ponendo le basi per il suo più celebre scritto sull'argomento,pubblicato col titolo Gli architetti e gli studi di architettura inItalia nel 1916, dove è delineato il profilo dell'architettointegrale (32). Più precisamente, come ha osservato Giulia-no Ricci, si può rilevare un vero e proprio passaggio di
testimone da Boito a Giovannoni, checonduce, alla metà degli anni Dieci,all'affermazione di una "linea romana"nel dibattito sulle Scuole di Architettura,contro l'orientamento milanese sostenu-to da Boito. Non sembra un caso,infatti, che l'approvazione del decretoRosadi per l'istituzione della Scuola diRoma giunga proprio sulfinire del 1914,pochi mesi dopo lo morte del maestromilanese (33).Un analogo e ideale passaggio diconsegne è stato spesso evidenziatodalla storiografia in rapporto alla Dire-zione Generale per le Antichità e leBelle Arti, considerando il ruolo di pri-mo piano svolto da entrambi in diversi
organi consultivi, primo fra tutti il Consiglio Superiore, delquale Boito, già membro della Giunta Superiore, è nomina-to componente a partire dalla sua istituzione nel giugno1907 fino alla sua morte (35). In tale consesso, Boito siconfronterà con posizioni più conservative in materia direstauro, tanto che il più giovane Adolfo Venturi, nelle sueMemorie autobiografiche, ricorderà le proprie battagliecontro il perpetuarsi di attardate ricostruzioni, avallatespesso dagli stessi autorevoli colleghi Boito e D'Andrade(36). Meno di un anno dopo lo morte di Boito, nel maggio1915, Giovannoni entrerà a far parte della secondasezione del Consiglio come supplente (34), rimanendovi
te tecnica, pur con i successivi innesti umanistici. ProprioGiovannoni, del resto, riconoscerà più volte a Baito lo dote diuna" mirabile eloquenza", descrivendo sé stessoinvece come«poco più di un muratore che ha scambiato lo cazzuola conlo penna» (30).Ritornando ai temi centrali di queste note, possiamo riscon-trare una palese eredità tra i due personaggi nell'interesseper il problema della formazione degli architetti, presentesia in Boito che in Giovannoni fin dagli anni giovanili, cuientrambi dedicheranno in seguito una parte significativadelle rispettive esistenze. Appena ventiduenne, Boito pub-blica, nel novembre 1858, una Proposta di un nuovo
148
come membro effettivo per oltre venticinque anni, durantei quali svolgerà, ben più di Boito, quel ruolo di super-ispettore itinerante per lo penisola da lui stesso ricordato altermine della sua vita (37). In quest'ambito, com'è noto, lostudioso romano assumerà spesso le vesti di mediatore traistanze contrapposte, propendendo per soluzioni di com-promesso tra conservazione e ripristino non sempre felici.Affiora, dunque, un'ulteriore affinità che sembra accomunareBoito e Giovannoni, sottolineata in seguito spesso dai lororispettivi detrattori: una sorta di aurea mediocritas, di super-ficialità da "orecchiante" (nel giudizio diMeloni su Boito) (38), quasi un rovesciodella medaglia di quella efficace visione disintesi di problemi complessi che rappre-senta, invece, il più significativo caratteredistintivo delle loro personalità e che ne hain buona parte determinato il successo.Piuttosto diverso per i temi trattati, macomune negli intenti, è l'impegno che siaBoito che Giovannoni protendono nellapubblicazione di un periodico con finali-tà educative per lo diffusione della tradi-zione artistica e architettonica naziona-le. È il caso, per Boito, di Arte italianadecorativa e industriale, rivista finanziatadal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, cheil maestro milanese contribuisce a fondare nel 1890-91,per poi dirigere in prima persona dall'anno successivo finoalla sua cessazione nel 191 l . Obiettivo della rivista -caratterizzata da un grande formato e da un notevolepregio tipografico, che contempla anche diversecromolitografie - è quello di diffondere lo conoscenzadella tradizione italiana in campo decorativo, rivolgendo-si alle scuole di disegno e più direttamente agli artigianie alle maestranze (39). Non sembra troppo azzardatorintracciare almeno un'eco di tali temi nella nascita diArchitettura e arti decorative, fondata e diretta daGiovannoni e Piacentini nel1921, benché quest'ultima siproponga soprattutto come riferimento per lo neonata
Scuola superiore di architettura di Roma, mantenendocomunque una notevole attenzione ai temi dell'arreda- I
mento e della decorazione.In tema di tradizione architettonica, nell'ambito più genera-le del binomio storia-progetto, emerge del resto una notevo-I~ affinità tra i due personaggi, già accennata in premessa.E stata giustamente evidenziata l'importanza centrale del-l'introduzione al volume Architettura del Medio Evo in Italia- forse il contributo più importante di Boito - e il fatto cheessa si intitoli significativamente Sullo stile futuro dell'archi-
tettura italiana. Nella prospettiva boitiana,infatti, lo studio degli edifici medioevali,e in particolare dei loro principi, deveservire d'insegnamento per il presente,evitando lo pedissequa imitazione. Boitoassurge dunque al ruolo di protagonistadi quel variegato filone neomedievalista«di stampo "etico"», che segna l'Italia dall860 al l890, fondato sulla preoccu-pozione di definire uno stile architettonicoadatto a consolidare l'identità nazionaledel neonato Stato unitario (40). Questointento si delinea ben chiaro in Boito findal l 872, con il breve saggio L'architet-tura della nuova Italia, dove già emerge
un interesse per le questioni di "linquo" in architettura, conattenzione alle declinazioni regionali, tra lequali primeggial'architettura lombarda dall'XI al XIII secolo, insieme «allemaniere municipali del Trecento» (41). In tale panoramafarà eccezione soltanto lo città di Roma, dove lo spaventoper le sue antiche grandezze architettoniche convinceràBoito a negare ogni possibilità di affermazione dellinguag-gio neomedievale (42).Se sostituiamo al contesto culturale del secondo Ottocentolo retorica del regime fascista, ed alla fortuna dell'architet-tura medioevale quella del Rinascimento, possiamo ritrova-re un analogo atteggiamento anche in Giovannoni. Ilprogressivo interesse per l'analisi delle architetture traQuattro e Cinquecento, infatti, è condotto dallo studioso
149
romano con occhio attento ai problemi dell'attualità, dandoluogo, su questa via, ad una peculiarità tutta italiana del farestoria dell'architettura, emblematicamente rappresentata dalsuo rapporto con lo figura di Bramante (43). Diversamente daBoito, tuttavia, l'esito delle riflessioni di Giovannoni sul temasembra avere un'influenza più attenuata sulla culturaarchitettonica contemporanea, segnata anche dalla contro-versa diffusione del Movimento moderno, evidenziandoquindi un ruolo molto meno egemonico, nel campo dellanuova architettura, rispetto al suo predecessore.Analizzando infine gli aspetti relativi alla conservazione eal restauro, emergono alcune significative differenze tra gliorientamenti di Boito e Giovannoni, in parte già delineatedalla storiografia, ma che sembra opportuno evidenziareulteriormente. Il tema più significativo riguarda le aggiunte,per le quali lo stesso Boito manifesta una posizione ambi-gua, ma parzialmente possibilisto in merito all'architettura alui contemporanea. Com' è noto, nel citato dialogo Conser-vare o restaurare del 1886, il maestro milanese riporta isette punti votati tre anni prima al IV Congresso degliIngegneri e degli Architetti Italiani, rispettando fedelmente iltesto degli atti, che al punto 2 recita: «Le aggiunte orinnovazioni si devono compiere nella maniera nostracontemporanea, awertendoche, possibilmente, nell'appa-renza prospetti ca le nuove forme non urtino troppo conl'aspetto del vecchio edificio» (44). Quando, pochi annidopo, Boito ripubblica il celebre dialogo nella sua antolo-gia Questioni pratiche di belle arti (1893), questo passag-gio subisce due piccole ma significative correzioni: «Leaggiunte o rinnovazioni si devono compiere con caratterediverso da quello del monumento, awertendo che, possibil-mente, nell'apparenza prospetti ca le nuov~ forme nonurtino troppo con il suo aspetto artistico» (45). Escomparso,dunque, l'invito a ricorrere all'architettura contemporanea,mentre l'accordo prospettico si riferisce n?n più al vecchioedificio, ma al suo aspetto artistico. E in quest'ultimaversione, non a caso, che Giovannoni cita il passaggio delvoto del l883 nel proprio saggio del 191 3 (46), attenuan-done ulteriormente lo portata nel redigere lo Carta italiana
150
del restauro del 1932, dove si raccomanda, per leaggiunte, «un carattere di nuda semplicità e di rispondenzaallo schema costruttivo» (47).Possiamo concludere soffermandoci su un' ulteriore, sostan-ziale distanza, che segna i due personaggi Boito eGiovannoni in tema di conservazione: il rapporto conl'ambiente urbano e lo città, riconducibile non soltanto adevidenti ragioni cronologiche. Considerando infatti che ildibattito europeo sull'argomento si sviluppa proprio neglianni in cui Boito è ancora pienamente attivo - basti pensarealle date dei celebri contributi di Camillo Sitte (1889) eCharles Buls (1893) sul tema dell'estetica delle città (48)-sorprende che il maestro milanese non vi dedichi grandeattenzione. La sua visione dell'ambiente, testimoniata dalcelebre intervento del 1883 in favore della conservazionedella Venezia che scompare - dove citando il tessutominore di Sant'Elena e Santa Marta osserva che «non è adire che in una città monumentale basti serbare all'ammira-zione dei contemporanei e dei posteri i monumenti: convie-ne serbare ai monumenti l'ambiente» (49) - resta infattiquella dell'artista, che non sembra interessato agli aspettitecnici e operativi del problema. Singolare, in tal senso, èl'invito-citatoda Zucconi -che lo stesso Sitle rivolge a Boitonel 1903, proponendogli di collaborare alla neonatarivista Der Stadtebau, riconoscendogli di aver contribuitoattivamente a salvare Venezia dalle minacce degli igienistisul finire del secolo (50).Su questo tema, il passo avanti compiuto da Giovannonisarà invece, com'è ben noto, molto significativo, proprioin virtù della sua capacità di sintetizzare in una visioneunitaria lo cultura artistica e l'esperienza tecnica degliingegneri sanitari, proponendo un'originale via interme-dia per lo trasformazione urbana, di cui non vi è alcunatraccia anticipatrice in Boito. Questo passaggio sembrarappresentare, simbolicamente, lo fatale nemesi dellavisione artistica ottocentesca del problema, che propriointorno alla metà degli anni Dieci del Novecento sta peressere definitivamente soppiantata dalla nascente figuradell' architetto integrale (51 ).
l. Cfr. A BElLINI, Boito tra Viollet-Ie-Duc e Ruskin?, in A GRIMOlDI (a cura di),Omaggio a Camillo Boito, Franco Angeli, Milano 1991, pp. 159-160 e G.ZUCCONI, L'invenzione del passato. Camillo Baita e l'architettura neomedievale1855-1890, Marsilio, Venezia 1997, pp. 43-44.2. «Capitolo ancoro tutto da chiarire al di là delle mitologie, il rapporto tra i duepadri putotivi della storia architettonica italiana meriterebbe uno studio a sé, apartire dalla rare occasioni di confronto diretto' (G. ZUCCONI, Dal capitello allacittà. Ilprofilo dell'architetto totale,in G. GIOVANNONI, Dal capitello alla città, G.Zucconi (a cura di), [eco Book, Milano 1997, pp. 38).3. «Più che i padri di una "scienza e tecnica del restauro", Boito e Giovannoniappaiono come i caposcuola di un indirizzo che tende a risolvere le questioninel terreno dell'empiria, in un curioso mélange di amore per lo storia, di buonsenso, e soprattutto di fiducia nelle proprie doti istintive di progettista. [ ... ) Perentrambi, i problemi appartengono ad un medesimo circuito che lasciaintravedere finalità soprattutto operative: studio dei monumenti, formazionedell'architetto costituiscono lo premessa ad un imervento non arbitrario sulpatrimonio. Inserita in questo ciclo, lo storia dell'architettura ritrova "una funzionepratico quale quella di fornire determinazioni complete nei lavori di restauro";questa affermazione di Giovannoni potrebbe essere condivisa anche da Boito.Anzi suona più vicina alle tesi di chi, come l'autore di Senso, non concedenessun margine di autonomia all'analisi storica' (Ivi, pp. 38-39).4. Cfr. A BElLINI, Brevi note per una discussione su alcuni aspetti di un testo diGustavo Giovannoni, in "Pollodìo", VII, n. 14, luglio-dicembre 1994, p. 291 ;A GRIMOlDI, A ciascuno il proprio Boito. Interpretazioni passate e recenti di unprotagonista dell'Ottocento, in M. MADERNA, Camillo Boito. Pensiero sull'archi-tettura e dibattito coevo, Guerini studio, Milano 1995, pp. 12 e ss.5. G. GIOVANNONI, "restauro dei monumenti, in La tutela delle opere d'arte inItalia, Atti del I Convegno degli Ispettori Onorari dei Monumenti e Scavi (Roma,22-25 ottobre 1912), Roma, 1913; poi, col titolo Restauri di monumenti, in"Bollettino d'arte", VII, n. 1-2,gennaio-febbraio 1913, pp. 1-42, da cui si cita.L'estesa conferenza di Giovannoni si era svolta "con proiezioni" nel pomeriggiodel 23 ottobre 1912. Nel corso dei lavori, inoltre, lo studioso aveva propostolo pubblicazione di un fascicolo integrativo al "Bollettino d'arte" da intitolarsi Attie notizie, contenente informazioni utili per gli ispettori (Cronaca del I Convegnoin Roma degli Ispettori onorari dei monumenti e scavi, ivi, pp. 70-71). Il rilievodi primo piano assunto da Giovannoni oll'incontro va riferito - più che alla suaqualifica di ispettore onorario, ottenuta appena due anni prima nell'ambito dellaprovincia di Roma - all'influente ruolo di rappresentante e past-president( 191o-l l) dell'Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura.6. Nel breve scritto, Giovannoni definisce quattro diversi tipi di restauro (<<diriparazione, di sostituzione di alcuni elementi, di completamento, di rinnova-mento'), osssrvcndo che il voto promosso dal Congresso sembra legittimaresoltanto il primo tipo. Tale atteggiamento - fondato sull'assunto «che il culto deimonumenti si esplichi lasciandoli il più possibile nello stato in cui sono' -condurrebbe, secondo lo studioso, od «imitare gli Arabi che lasciano andarein isfacelo i loro monumenti per non ìoccorli: e solo quando sono caduti e lovolontà d'Allah si è compiuta, ne costruiscono degli altri a loro posto'. Controi rischi di quest'orientamento, citando implicitamente lo stesso Viollet-Ie-Duc(richiamato già in precedenza per mostrare l'inapplicabilità pratica dei solirestauri di riparazione), Giovannoni avanza argomentazioni opposte: «noi"restauratori" riteniamo invece che meglio si proweda o custodire le opere che
segnano i capisaldi dei grandi periodi dell'arte e della coltura, studiandonel'essenza e cercando di ridurle complete come avrebbero dovuto essere'. Piùavanti, tuttavia, lo studioso ammette un limite nei confronti degli edifici antichi,nei quali «non si hanno più monumenti vivi, ma ruderi', anticipando così lo piùnetta distinzione in monumenti "vivi" e "morti", ripresa da precedenti contributibelgi e francesi ed esplicitata meglio negli anni successivi. Gli impliciti richiamiai principi del restauro stilisìico proseguono comunque con altre considerazioni,tra cui quelle sulla necessità - da parte degli architetti restauratori - di «spogliarsidella loro personolitò>, che tuttavia appaiono riferite soprattutto all'esigenza diconoscere a fondo l'architettura del passato prima di qualunque intervento (G.GlOVANNONI, I restauri dei monumenti e il recente Congresso Storico, in "Annalidella Società degli Ingegneri e degli Architetti Italiani. Bollettino", a. XI, n. 19,10 maggio 1903, pp. 253-259). Cfr. anche A CURUNI, Gustavo Giovannoni.Pensieri e principi di restauro architettonico, in S. CASIEllO (a cura di), La culturadel restauro. Teorie e fondatori, Marsilio, Venezia 20053, pp. 282-284 e C.VARAGNOll, Sui restauri di Gustavo Giovannoni, in M. P. SmE (a cura di),Gustavo Giovannoni: riflessioni agli albori del XXI secolo, Bonsignori, Roma2005, pp. 21-22.7. Le interessanti lettere sono state pubblicate da G. GUARISCO,Notizie da Brera:il carteggio Boito-Ricci, in G. GUARISCO (a cura di), Milano restaurata: ilmonumento e il suo doppio, Alinea, Firenze, 1995, pp. 58-61.8. Baita prosegue: «Quando lo vedi fammi lo cortesia di dirgli come san lietoch'egli debba trattare dei monumenti' (lettera di Baita a Ricci del 29 settembre1912, Ivi, p. 61 nota 23).9. Boito condividevo lo tesi di Viollet sulla modernità del concetto di restauro,fondandola sulla mancanza di uno stile contemporaneo in architettura, motiva-zione addotta anche da Morris nel manifesto della SPAB (cfr. P. TORSEllO,Restauro architettonico. Padri, teorie, immagini, Franco Angeli, Milano 1984,19977, pp. 17-20).Anche Giovannoni, tra le numerose cause richiamate sullemoderne origini del restauro, cita l'assenza «di uno vera fede artistica, di unproprio unico, ben affermato senso stilistico>. aggiungendo tuttavia che esso «èlo condizione ideale di fronte ai monumenti antichi' (G. GIOVANNONI , Restauridi monumenti ... ci!., p. 2).1O.lvi, pp. 11-12.11. Lettera di C. Baita a G. Giovannoni del 1913, citata in G. ZUCCONI, Dalcapitello alla città ... cit., p. 38 e n. 62. Il positivo giudizio è confrontato daZucconi con l'opposto atteggiamento che Boito aveva manifestato tre anniprima, in qualità di membro della commissione per lo cattedra di Architetturatecnica presso lo Scuola per Ingegneri di Padova, dove a Giovannoni avevapreferito Daniele Donghi.12. G. GIOVANNONI, Questioni di architettura nella storia e nella vita, Societàeditrice d'arte illustrata, Roma, 1925; Biblioteca d'arte, Roma, 19292, da cuisi cita, p. 7. Anche i sottotitoli delle due raccolte rivelano alcune analogie:Restauri, Concorsi, Legislazione, Professione, Insegnamento è quello di Baita,Edilizia, Estetica architettonica, Restauri, Ambiente dei monumenti, è quello diGiovannoni (cfr. anche G. ZUCCONI, Dal capitello alla città ... cit., p. 39).13. G. GlovANNONI, Questioni di architettura ... cit., p. 127 e nota l . Lo studiososi riferisce in particolare ai testi di j. P. SCHMIDT, L'architecte des monumentsreligieux, Paris, 1874 e L. ClOOUET, La restaurotion des monuments anciens, in"L'Ernulction", 1902.14. Per le tre categorie introdotte da Baita si veda C. BOITO, I nostri vecchi
151
monumenti. Conservare o restaurare?, in "Nuova Antologia", a. XXI, fase. XI,l giugno 1886, pp. 490 e ss.15. G. GlOVANNONI,Baita, Camillo, in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettereed Arti, val. VII, IstitutoG. Treccani, Roma 1930, p. 295. È molto significativo,come ha rilevato Zucconi, che Baita rappresenti, insieme a Raffaele Cattaneo,una delle due sole personalità "non-romane" per le quali Giovannoni cura lovoce per l'Enciclopedia (G. ZUCCONI,Dal capitello alla città, cit., p. 31).16. G. GIOVANNONI,Restauro, in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere edArti, val. XXIX,IstitutoG. Treccani, Roma 1936, p. 128. Nell'ultima rielaborazionedei propri scritti in materia di restauro, Giovannoni dichiarerà che lo «teoriaintermedia [ ... ] ora è universalmente accettata. In Italia l'ha per primo formulatail Boito e poi l'ha completata il Ciovonnoni> (G. GlOVANNONI," restauro deimonumenti, Cremonese, Roma s.d., 1945, p. 30)17. Cfr. A. GRIMOlDI,A ciascuno il proprio Baita ... cit., pp. 12 e ss.18. È nota lo sua partecipazione, appeno dodicenne, ai moti del 1848 comecombattente 01fianco del padre Silvestro, pittore di professione ma anche capobattaglione della Guardia Nazionale (P.NARDI,Vita di Arrigo Boito, Mondadori,Milano, 1942, passim).19. Come ha rilevato Giuliana Ricci, Boito frequenta soltonto due dei quottroonni previsti dalla legge per conseguire il titolo di dottore in matematica. la suaè quindi una sorta di laurea "per titoli" e l'esercizio della professione di architettogli è concesso da un attestato firmato dal marchese PietroSelvatico il26 ottobre1855 (G. RICCI,Dall'archivio dell'Accademia di Brera: precisazioni sui primirapporti di Camillo Boito con Milano e sul suo impegno di riformatore delladidattica, in A. GR/MOLO/lacura di), Omaggio a Camillo ... cit., p. 43 e nota26)20. G. MANO, Baita, Camillo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XI,IstitutoEnciclopedia Italiana G. Treccani, Roma, 1969, p. 238; G. RICCI,Boito,Camillo, in C. OlMO (a cura di), Dizionario dell'architettura del XX secolo, voI.I, U. Allemandi, Torino-london, 2000, p. 272.21. Cfr. G. GlovANNONI,L'architettura dei monasteri sublacensi, in P. EGIDI,G.GIOVANNONI,F. HERMANIN,V. FEDERICI,I monasteri di Subiaco, Ministero dellaPubblica Istruzione, Roma, 1904; G. GIOVANNONI,Proposta di un "Corpus" deiBattisteri dai bassi tempi al secolo XIII, in Congresso Internazionale di scienzestoriche(Roma, 1-9aprile 1903), VII, Roma, 1905, pp. 37-38; G. GIOVANNONI,I capitelli nel primo Medio Evo, in "Bollettino della Società degli Ingegneri edegli Architetti Italiani, a. XIII, n. 2, 8 gennaio 1905, pp. 25-27; G.GIOVANNONI,Risultatidegli studi su alcuni gruppi di marmorari romani dei secoliXII e XIII, in "Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura. Annuario",MCMIV-MCMV, 1906, pp. 9-1 l; G. GIOVANNONI,Proposta per lo compilazio-ne di uno schedario delle strutture murarie medievali, in "Associazione Artisticafra i Cultori di Architettura. Annuario", MCMIV-MCMV, 1906, pp. 37-39.22. Boito sposa nel 186210 cugina polacca Cecilia de Guillaume, separan-dosi pochi anni dopo, e nel 1887 Madonnina Malaspina dei marchesi diPortogruaro. la sua vita, già segnata dall'abbandono del padre negli annidell'adolescenza e dalla precoce scomparsa della madre nel 1859, saràfunestata da ulteriori dolori: nel 1867 perderà il suo unico figlio Casimiro,mentre nel giugno 1898 morirà anche lo seconda moglie (cfr. P. NARDI,Vita diArrigo Baita, cìt.. pp. 40, 52-53, 109-112,243-244,550,618). Sul primomatrimonio si vedano anche le lettere di Camillo al fratello Arrigo del 1862,pubblicate in C. BOITO,Pensieri di un architetto del secondo Ottocento, M.
152
MADERNA(a cura di), Archinto, Milano 1998, pp. 57-75, dove si intreccianoanche importanti tappe dell'attività professionale di Camillo, come il restaurodella parta Ticinese a Milano.23. Interessante,in proposito, è una lettera giovanile al fratello Arrigo, datata 16dicembre 1861 e citata dalla Mazzi, dove Camillo, riferendosi alla creativitàletteraria, confessa il timore di restarecfra il gregge dei mediocri in sempiterno [ ... ]forse nella mente mi difetta lo fantasia, forse nel cuore mi manca lo volontàprepotente, ardita, disprezzatrice e vincitrice di ogni ostacolo, dalla qualepossono uscire le opere grandi e durature' (M. C. /I/\All1, Nota introduttiva, in C.BOITO,Gite di un artista, M.C. Mazzi (a cura di), De luca, Roma 1990 (I ed.Hoepli, Milano 1884, p. XXVIII).Anche una successiva letterasembra confermareil rapporto controverso con il componimento letterario: «M'è rimasto tempo discrivere l'Articolo per lo Nuova Antologia lunghetto. Ora mi rimettoa una Novella,per vedere se il cervello non mi si è arrugginito' (letteradi Camillo al fratello Arrigoda Padova, datata 29 marzo 1874, in C. BOITO,Pensieri di un architetto, cit.. p.107). Un'efficace sintesi dell'opera di Boito con attenzione alle relazioni trainteressi architettonici e letterari è stata compiuta di recente da E. DElLAPIANA,Camillo Baita (1836-1914), in A. RESTUCCI(a cura di), Storia dell'architetturaitaliana. L'Ottocento, Electa, Milano, 2005, pp. 622-639.24. Si vedanoM. C. /I/\All1, Nota introduttiva, in C. BOITO,Gite di un ... cit., pp.XXVI-XXXV,e l'introduzione critica di C. CRETElLAin C. BOITO,Storielle vane,Pendragon, Bologna, 2007, in particolare alle pp. 10-19.25. Ivi, pp. 19-36. Cfr. anche E. GIACHERY,Boito, Camillo, in Dizionariobiografico degli italiani, voI. XI, IstitutoEnciclopedia Italiana G. Treccani, Roma,1969, p. 24 l, che, riferendosi alle citate Storielle vane, osserva come <unosguardo ai motivi di questa raccolta ci richiama senza equivoci all'atmosferadella Scapigliatura, sebbene lo stile si tenga lontano da certi effetti truculenti cheappaiono frequentemente nelle pagine degli sccpiqlioti>26. Cfr. G. RacCHI,Camillo Boito e le prime proposte normative del restauro,in "Restauro", a. III, n. 15, settembre-ottobre 1974, pp. 57-88; C. DI BIASE,Camillo Baita, in S. CASIEllO(a cura di), Lacultura del restauro, Marsilio, Venezia,20053, p. 168.27. C. BOITO,Un carpa, in C. BOITO,Storielle vane, cit., pp. 87-1 25. la raccoltaè stata riedito con riferimento al testo della terza e definitiva edizione del 1895.Per l'interpretazione del racconto in chiave di contrapposizione tra idealeromantico e positivista si veda A. CARlI, "Un corpo": storiella vana fra arte eanatomia, in G. ZUCCONI,T. SERENO(a cura di), Camillo Baita. Un protagonistadell'ottocento italiano, IstitutoVeneto di Scienze, lettere ed Arti, Venezia, 2002,pp. 193-206. Cfr. anche M. A. CRIPPA,Baita e l'architettura dell'Italia unita, inC. BOITO," nuovo e l'antico in architettura, M. A. CRIPPA(a cura di), Jaca Book,Milano, 1989, pp. XXXIV-XXXVI.28. «Vi è una singolare gamma di variazioni sul tema: autentico/inautentico,che è coperta e nascosta dal tema: vita/morte, o meglio: vita organica/meccanicismo; il tema dell'oggetto e della sua immagine, richiama quelloplotinianoeficinianodel Rinascimento' (G. RacCHI,op. cit., p. 66). È di qualcheinteresseprecisare che nella prima versione del racconto, apparso sulla "Nuovaantologia" nel giugno 1870, il finale differiva sensibilmente - in chiave piùmacabra e scapigliata - per lo scelta del pittore di distruggere e bruciare il ritratto(cfr. C. CRETElLA,Nota al testo, in C. BOITO,Storielle vane ... cit., pp. 82-83).29. cTutti gli scritti di Boito possiedono qualità narrative, tradiscono espedientiretorici, rivelano tecniche sopraffine, proprie di uno scrittore' (G. ZUCCONI,
L'invenzione del passato ... ciI., p. 15).30. G. GIOVANNONI,Parole oscure e pensieri chiari, in G. GIOVANNONI,Architetture di pensiero e pensieri sull'orchitettura, Apollon, Roma, 1945, p. 94.31. G. RIccI, Dall'archivio dell'Accademia ... ciI., p. 42.32. Già nel 1907, Giovannoni individua quattro punti fondamentali per loformazione dell'architetto, desumendoli in parte dalle riflessioni di Boito: <1. unacompleta preparazione artistica che gli renda familiari i mezzi con cui il pensierod'arte può plasmarsi [ ... l; 2. una preparazione tecnica paragona bile, puressendo un campo più ristretto, a quella degli ingegneri civili [ ... l; 3. una colturagenerale vasta e varia ed una facoltò di saper studiare per proprio conto chesolo può esser data da una scuola superiore; 4. una conoscenza ben basatadella Storia dell'Architettura e di quella dell'Arte, che lo renda familiare con lospirito stessodei periodi artistici che hanno preceduto il nostro', (G. GIOVANNONI,Relazione della Commissione per le Scuole di Architettura, in 'AssociazioneArtistica fra i Cultori di Architettura, Roma. Annuario', MCMVI-MCMVII, 1908,porzialmente ripubblicato in G. GIOVANNONI,Dal capitello alla città ... ciI., pp.127-128). Questo "bagaglio" di conoscenze è meglio precisato nel 1916:<Non meno di cinque valigie gli occorrono: lo prima è una coltura generalevasta e varia, non inferiore a quella di verun altro professionista [ ... l. Lasecondaè una preparazione artistica completa, iniziata fin dall'adolescenza, che glirenda congeniali le altre arti, che formi in lui il senso sicuro delle proporzioni [ ... l.Terzo, una preparazione scientifica e tecnica che nel campo delle costruzionicivili sia paragona bile a quella dell'ingegnere [ ... l. Quarto, una conoscenzaben basata della Storia dell'Arte e di quella dell'Architettura, che gli facciaconoscere, più che le forme, lo spirito stessoed il significato dei periodi d'Arteche hanno preceduto il nostro. Quinto, infine, una pratica fatta di esperienza,dei tanti problemi spiccioli di costruzione, di amministrazione, ecc., chepresenta lo vita reale' (G. GiOVANNONI,Gli architetti e gli studi di architettura inItalia, in "Rivistad'Italia", XIX,val. I, fasc.lI, febbraio 1916; col medesimo titolo,Unione editrice, Roma 1916, da cui si cita, pp. 11-12). Suquesto tema si vedaanche L. DESTEFANI,Le scuole di architettura in Italia. Il dibattito dal 1860 al1933, Franco Angeli, Milano, 1992, pp. 117-119.33. G. RICCI,Dall'archivio dell'Accademia di Brera ... ciI., p. 50. Sull'istituzionedella Scuola di Roma si veda P. NICOLoso, Gli architetti di Mussolini. Scuole esindacato, architetti e massoni, professori e palitici negli anni del regime, FrancoAngeli, Milano, 1999, pp. 23-28.34. Il Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti, istituitocon legge 386 del27 giugno 1907, tiene lo suaprima riunione il25 gennaio 1909. Boitoèmembrodella seconda sezione, intitolata "Arte medioevale e moderna", insieme adAlfredo D'Andrade, Pompeo Molmenti ed Adolfo Venturi (R. DAlIANEGRA,Lariforma del serozio di tutela (1902-1915), in M. BENCIVENNI,R. DAlIANEGRA,P.GRIFONI,Monumenti e istituzioni, Il, Soprintendenza per i Beni Architettonici eAmbientali per le province di Firenze e Pistoia, Alinea, Firenze, 1992, p. 201).35. <Eragran miseria di criterii: ma Dio volle che poi ricostruttori come CamilloBoita, contraffattori dell'antico come il sapiente architetto D'Andrade, siconvertissero a un principio molto semplice: l'antico non si rifà [ ... l. Se ne fossestata per tempo riconosciuta lo giustezza, non avremmo avuto il restauro [ ... ldella Sala delle Assi nel Castello di Milano, dell'altar maggiore del Santo aPadova, delle cappelle absidali di San Francesco a Bologna. [ ... l Quantebattaglie sostenutequasi sino ad oggi! AI Palazzo del Podestà, d'arte forestieraa Bologna e della fine del Quattrocento, si voleva metter lo bardatura
balognese, perfino le merlature: insorsi nel Consiglio Superiore per le Belle Arti,anche contro i miei compogni Boito e D'Andrade, quando li vidi piegare' (A.VENTURI,Memorie autobiografiche, Hoepli, Milano, 1927; Allemandi, Torino1991, da cui si cita, pp. 77-78). È interessante rilevare che Venturi comprendetra i restauri ricostruttivi da censurare anche lo ricomposizione dell'altaredonatelliano compiuta da Boito nella Basilica del Santo.36. A. CURUNI,Riordinodelle carte di Gustavo Giovannoni. Appunti per una biografia,in "Archivio di Documentie Rilievidei Monumenti", 2, Roma 1979, p. 16.37. Cfr. G. GIOVANNONI,Quesiti di restauro dei monumenti, in G. GIOVANNONI,Architetture di pensiero ... ciI., pp. 173 e ss.38. Ilgiudizio è citato ed ampiamente commentato in G. ZUCCONI,L'invenzionedel passato ... cit., pp. 12 e ss.39. Cfr. O. SELVAFOLTA,Boito e lo rivista Arte Italiana Decorativa e Industriale:il primato della storia, in M. MADERNA,Camillo Boito. Un protagonistadell'ottocento italiano ... cit., pp. 133-166.40. <Lanostra storia non ha quasi nulla a che vedere con ilgothic revival; il nostroè un neornedievclisrno di stampo" etico" ove non trova posto lo replica di modellialla modo> (G. ZUCCONI,L'invenzione del passato ... cit., p. 20).41. Ivi, pp. 147-159.42. <Chi vorrebbe mai in una città come Roma introdurre i garbi del Medio Evoo le novità ingegnose dell'orte infranciosata [sìc] moderna? Roma è lo sola città,dove l'architettura classicamente accademica possa trovare anche al giornod'oggi un qualche sviluppo' (e. BOITO,Spavento delle grandezze di Roma.Bestemmia palitica intorno alloro carattere. L'architettura romana d'oggi, cheè sgomentata. Ricerca vana di un suo stile futuro, in "Nuova Antolog io" , vol. XXX,settembre 1875, p. 190). Sul controverso rapporto tra Boito e Roma si vedanoanche P. TORSEllO,Restauro architettonico, ciI., pp. 117-123; A. GRIMOLDI,Camillo Boito e il gusto dominante: significato fra i contemparanei, fortuna trai posteri dei precetti boitiani, in A. GRIMOLDI(a cura di), Omaggio a CamilloBoito ... ciI., p. 193; V. FONTANA,Baita e l'architettura del suo tempo, in CamilloBaita. Un protagonista dell'ottocento ... ciI., pp. 41-42.43. Cfr. e. THOENES,Bramante-Giovannoni, il Rinascimento interpretato dall'ar-chitettura fascista, in "Casabella", n. 633, aprile 1996, pp. 64-73.44. e. BOITO,I nostri vecchi monumenti. Conservate o restaurare?, ciI., p. 503(il corsivo è nostro).45. e. BOITo,I restauri in architettura. Dialogo primo, in e. BOITO,Questionipratiche di Belle Arti, Hoepli, Milano, 1893, ora in e. BOITo,Il nuovo e ... cit.,p. 124 (il corsivo è nostro).46. Cfr. quanto osservato in proposito da R. A. ETUN,Modernism in ItalianArchitecture, 1890-1940, Mit Press,Cambridge-London, 1991, pp. 127-1 28,che attribuisce erroneamente a Giovonnoni lo modifica del testodel 1883, senzacitare lo versione pubblicata da Boito in Questioni pratiche nel 1893.47. Norme per il Restauro dei Monumenti, in "Bollettino d'arte", vol. XXV,serieIII, fasc. VII, gennaio 1932, p. 326.48. Cfr. A. PANE,Dal monumento all'ambiente urbano: la teoria del diradamentoedilizia, in S. CASIELLO(a cura di). La cultura del restauro ... cit., pp. 293-314.49. e. BOITO,Venezia che scompare. Sant'Elena e Santa Marta, in "NuovaAntologia", 15 ottobre 1883, p. 630.50. G. ZUCCONI,L'invenzione del passato ... ciI., pp. 268 e ss.51 . Su questi aspetti cfr. G. ZUCCONI,La città contesa. Dagli ingegneri sanitariagli urbanisti (1885-1942), jcco Book, Milano, 1989.
153
~NA-rKH-57.NUOVA SERIEMAGGIO 2009
Editoriale
Marco De:zziBardeschi
Camillo Bai/o: lo stonc:
Boito a centocinquant'anni dal suo approdo a Milano ('859)
Gabriella GuariscoMarco De:z::z:iBardeschi
Mario BencivenniChiara De:z::z:iBardeschi
Sandro Scarrocchia
Approfondimenti
Boito in viaggio: frammenti di un discorso autobiograficoBoito, da Parma ('870) a Milano ('872): l'esordio ai congressiBoito a congresso: da Milano ('872) a Torino ('884)Boito e Giuseppe Poggi: trama di una frequentazione intellettualeBoito e il Restauro ArcheologicoL'Arte Industriale e il restauro in Camillo Boito
Roberto CassanelliMarianna Carrera
Ermes InvernizziNora Lombardini
l'eredilà
" fondo fotografico di Boito ali'Accademia di BreraBoito e il suo tempo: la fotografia agli albori del restauroMemoria e invenzione in Camillo BoitoBoito e i marmi di Son Marco a Venezia
Camillo Boito è oggi una figura di riferimento nel panoroma dell'Italia Unita. Si vuole qui,restituirne la complessità di critico, architetto, studioso e insegnante.I contributi raccolti in questo numero si concentrano - com'è obiettivo prevalente della no-stra rivista - sull'attività di Boito come testimone eccellente e principale motore teoreticodel rinnovamento della cultura del restauro in Italia, un'attività che naturalmente trova ilsuo principale lievito critico nelle allargate palestre, da lui frequentate sempre con gran-de successo, dei Congressi nazionali (artistici e tecnici), con i conseguenti auspicati effetticollaterali sul rinnovamento dell'insegnamento, una interminabile crociata, quest'ultima,ancora oggi aperta ed in piena evoluzione sui presupposti da lui stesso fissati che ci pare siapreciso dovere, sia nostro che delle nuove generazioni, di cercare almeno di non ignorare.
Andrea PaneSilvia Perindani
Sandro Scarrocchia
Da Boito a Giovannoni: una diHicile ereditàBrera, '9' 2 e '923: documenti per la Scuola di restauroBrera, 2009: per la Scuola dedicata a Camillo Boito
ISSN nò~-&21~
lUJ.Illl