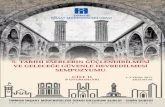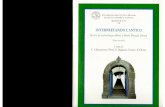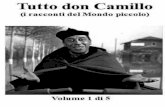IL CARDINALE CARLO CAMILLO MASSIMO E LA RISCOPERTA DEI TEATRI ROMANI DI TERRACINA E DI SAGUNTO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of IL CARDINALE CARLO CAMILLO MASSIMO E LA RISCOPERTA DEI TEATRI ROMANI DI TERRACINA E DI SAGUNTO
opuscula fossanovensia
Giuseppe papi
il cardinale carlo camillo massimoe la ‘riscoperta’ dei teatri romani
di terracina e di saGunto
fossanovammxii
GIUSEPPE PAPI
IL CARDINALE CARLO CAMILLO MASSIMOE LA ‘RISCOPERTA’ DEI TEATRI ROMANI
DI TERRACINA E DI SAGUNTO
PREFAZIONEDI
FERNANDO GARCÍA SANZ
INTRODUZIONEDI
FRANCESCO MANNINO
POSTFAZIONEDI
STEFANO PAGLIAROLI
FOSSANOVA
MMXII
Il libro è stato stampato presso la Tipografia Selenedi Stefano RonciLatina, via Moncenisio, 8-10
La responsabilità per tutti i materiali (immagini e documenti) pub-blicati in questo studio è di Giuseppe Papi
2012 Centro Studi Fossanovesi
Comune di Roccasecca dei VolsciProvincia di Latina (L.R. 32/78 e L.R. n. 17/2007). Progetto: “Se-greti in archivio. Il cardinale Camillo Massimo e l’esilio a Rocca-secca (1658-1662)”
PREFAZIONE
Giuseppe Papi nos rescata del pasado la figura del Carde-nal Máximo quien en lúcidos documentos nos narra su lle-gada a España enviado por Inocencio X como nuncioapostólico. Son años complejos, delicados y muy difícilespara la Corona española que aun siendo todavía el mayorpoder de la tierra ya ha comenzado a sentir la gravedad delas crisis internas (Portugal, Cataluña) y externas (el eternoproblema de las posesiones europeas y la tradicional ene-mistad de Francia) que la conducen por el camino de lainapelable decadencia. La política papal está en medio,como lo ha estado siempre, de las relaciones exteriores dela Corona Hispánica. Por todo ello, el papel del CardenalMaximo no va a resultar sencillo o, dicho de otro modo, vaa ser muy interesante.
Pero no son las páginas que siguen a estas líneas unrelato de vicisitudes diplomáticas. Papi, haciendo honor asu ilustre paisano, da rienda suelta a lo que al Cardenal se-guramente importaba transcendentalmente, es decir, la cul-tura y el arte. Máximo no lo sabía pero una de las razonespor las que pasaría a la historia sería por el retrato que unode los mayores genios de la pintura universal le realizó du-rante su segundo viaje a Italia, Diego Velázquez. Él mismofue considerado un «insigne pintor» por el famoso trata-dista español Antonio Palomino de Castro (El Parnasoespañol pintoresco laureado, 1724) y fue conocido ya ensu época por su magnífica colección de arte. No es extrañoentonces que los meses que pasó en la costa levantinaespañola esperando la venia para poder viajar a Madrid,
los dedicara a la observación y descripción de monumen-tos históricos como es el caso del teatro de Sagunto sobreel que se detiene a comparar con el teatro de Terracina.
Es obvio que el lector de estas páginas podría consi-derar el relato de Papi como una sencilla anécdota histó-rica. Los que hemos dedicado parte de nuestras vidas ainvestigar en la historia de las relaciones entre España eItalia, quizás hemos relegado con demasiada frecuencia elpapel que las personas – consideradas individualmente –juegan en esas relaciones. Y más si tratamos de relacionesculturales, los ojos de los protagonistas, sus visiones delotro y de lo otro, de lo ajeno, puede llegar a construir unpanorama desde luego complejo, pero por ello más rico ytambién más autentico de la realidad*.
Fernando García SanzDirector de la Escuela Española
de Historia y Arqueología del CSICRoma
6
PREFAZIONE
* Per comodità dei lettori, presentiamo una traduzione italiana della prefazione di Fernando García Sanz:«Giuseppe Papi recupera per noi dal passato la figura del Cardinale Massimo, il quale per mezzo di perspi-cui documenti ci racconta il suo arrivo in Spagna, inviato da Innocenzo X come nunzio apostolico. Sono annicomplessi, incerti e molto difficili per la Corona spagnola, la quale, pur essendo ancora la più grande po-tenza al mondo, ha già incominciato a risentire della gravità delle crisi interne (Portogallo, Catalogna) edesterne (l’eterno problema dei possedimenti europei e la tradizionale inimicizia verso la Francia), che laconducono sulla strada di una irreversibile decadenza. La politica papale sta, come lo è sempre stata, nelmezzo delle relazioni esterne della Corona spagnola. Per questa ragione, il ruolo del Cardinale Massimo nonrisulta agevole, anzi, detto altrimenti, è della più grande responsabilità. Ma queste pagine non sono un re-soconto di vicissitudini diplomatiche. Papi, conferendo onore al suo illustre compatriota, lascia emergere quelche di sicuro più intimamente importava al cardinale, cioè la cultura e l’arte. Il Massimo non lo sapeva, mauno dei motivi per cui sarebbe passato alla storia sarebbe stato il ritratto che fece di lui uno dei più grandigeni della pittura mondiale durante il suo secondo viaggio in Italia: Diego Velázquez. Ancora, egli fu con-siderato «pittore insigne» dal famoso trattatista spagnolo Antonio Palomino de Castro (El Parnaso españolpintoresco laureado, 1724) e nel suo tempo fu noto per la magnifica collezione d’arte. Non stupisce quindiche, i mesi che passò sulla costa orientale spagnola in attesa del lasciapassare per Madrid, li dedicasse allaosservazione e alla descrizione di monumenti storici come appunto accadde per il teatro di Sagunto, sulquale si sofferma effettuando un confronto con il teatro di Terracina. È possibile che il lettore di queste pa-gine giudichi la trattazione di Papi come una semplice narrazione aneddotica. Noi che abbiamo dedicato partedella nostra vita all’approfondimento della storia delle relazioni tra la Spagna e l’Italia forse troppo spessoabbiamo sottovalutato il ruolo che singoli personaggi – presi individualmente – hanno giocato in tali rela-zioni. Ma, se ci occupiamo di relazioni culturali, quel che i protagonisti hanno visto, le loro opinioni suglialtri e sul diverso, sull’estraneo possono condurre alla ricostruzione di un panorama ben altrimenti com-plesso, e per questo più ricco e anche più autentico, della realtà [S. Pagliaroli]».
INTRODUZIONE
Il pomeriggio di sabato 18 febbraio 2012 venne inviato almio indirizzo di posta elettronica un messaggio di Giu-seppe Papi, caro amico nonché valido autore di vari studistorici, che mi chiedeva di fare l’introduzione al libro IlCardinale Massimo e la ‘riscoperta’ dei teatri romani diTerracina e di Sagunto e a caratteri maiuscoli precisava:«sono a tua disposizione massimo due pagine per l’intro-duzione»; al messaggio era allegata una semplice bozzadel testo del libro in argomento, che per la prima volta hopotuto leggere nella forma che mi perveniva, senza nu-merazione delle pagine, priva delle foto, priva o incom-pleta di note[*]. Pochi giorni dopo, la sera del giovedìsuccessivo, incontrai l’Autore, cui diedi la mia disponibi-lità per quel che mi era stato richiesto.
Ovviamente, per poter introdurre il testo storico-lette-rario del Papi, dovevo prima leggerlo accuratamente alfine di trarne considerazioni e giudizi aderenti ai dati difatto ed improntati ad imparzialità, limitati in ogni caso a
[* Mi corre l’obbligo di far presente che il 18 febbraio 2012 le fo-tografie, putroppo, non erano ancora pronte; mentre la redazione fi-nale del testo, come è facile constatare, è rimasta quasi intatta rispettoall’impaginato pressoché definitivo, note comprese, pervenuto viainterretiali all’amico Francesco Mannino (le cui importanti rifles-sioni occupano in realtà sei pagine, rispetto alle due previste: il chenon diminuisce, anzi accresce ancor di più, se vi fosse mai stato bi-sogno di ribadirlo, l’alta stima nei suoi confronti e l’onore di poterospitare un suo scritto all’inizio di questo mio lavoro). G. Papi].
quel ‘massimo’ di due pagine. Mentre ero accinto a taleinterpretazione dello scritto che doveva condurmi ad unapresentazione consapevole dell’ambito definito del temaoggetto della trattazione, intervennero diversi solleciti daparte dell’Autore acciocché urgentemente consegnassil’introduzione da pubblicare; l’urgenza si accoppiava cosíalla limitazione grafica imposta.
Per aderire, quindi, al desiderio dell’Autore ho stilatocon fretta e stringatezza la presentazione dell’opera lette-raria Il Cardinale Massimo e la ‘riscoperta’ dei teatri ro-mani di Terracina e di Sagunto, che di conseguenzarisulterà limitata e non esauriente. È un ottimo lavoro di ri-cerca, ben documentato e ben scritto, che inizia con unaPremessa, continua con La vita di Carlo Camillo Massimocui seguono Terracina un ‘museo’ storico all’aperto eCarlo Camillo Massimo e i teatri romani di Sagunto e Ter-racina; vi è quindi una Postfazione di Stefano Pagliaroli edinfine un’appendice con scritti di L. Rossini (del 1846) eS. Moscati (1966), ma quel che sovrasta ogni altra consi-derazione in questo studio è la sorprendente rivelazionedell’esistenza dei piú antichi documenti – due lettere diCarlo Camillo Massimo, l’una del 13 marzo 1654, l’altradel 30 aprile 1661 – riguardanti il teatro romano di Terra-cina, la cui vera ubicazione è stata supposta soltanto intempi recenti, verso il 1957.
Nella prima lettera il Massimo paragona la scena delteatro romano di Sagunto in Spagna (che è tuttora uno deiteatri di età romana piú conservati) a quella del teatro diTerracina, poiché entrambe volgono le spalle alla pianura.Nella seconda lettera egli dice «In Terracina vi è un thea-tro antico con la scena assai conservata». Queste citazioni
8
INTRODUZIONE
riguardanti la scena inducono a supporre che il resto del-l’edificio teatrale doveva essere poco conservato o pocovisibile.
Alle obiezioni che possono e devono farsi a tali noti-zie desidererei dare alcune risposte. La vita di Carlo Ca-millo Massimo, nato a Roma nel 1620 dal nobileantichissimo casato dei Massimo e morto nella sua cittànatale nel 1677, ci fa sapere che egli si laureò all’età diventisei anni, fu patriarca di Gerusalemme, feudatario diRoccasecca (dei Volsci), ove risiedette dal 1658 al 1662 efece edificare od ornare edifici civili e religiosi, impor-tante ecclesiastico, nunzio apostolico in Spagna dal 1654al 1658 e nel 1670 cardinale, ma soprattutto ci documentaampiamente sulla grande cultura ed intelligenza di questopersonaggio, appassionato di arte e di storia, pittore eglistesso, che ebbe relazioni con illustri personaggi – quali ilviaggiatore e collezionista Cassiano dal Pozzo, i pittori Ni-colas Poussin, Claude Lorrain, Carlo Maratta, lo scrittoree storico dell’arte Giovanni Pietro Bellori – e fu collezio-nista di epigrafi, reperti archeologici (tra cui pitture anti-che, mosaici, capolavori di statuaria e glittica – qualigemme e cammei – romana), monete, libri e quadri, cheraccolse nel suo palazzo delle Quattro Fontane di Roma,acquistato nel 1664.
Carlo Camillo Massimo non era quindi uno sprovve-duto bensí un uomo che possedeva gli idonei strumentimentali per comprendere e giudicare ciò che vedeva: egliinfatti vide a Sagunto quello che era veramente un teatroromano abbastanza conservato; pertanto non vi sono ra-gioni per supporre che nel 1654 abbia comparato realtà ar-chitettoniche – l’una a Sagunto l’altra a Terracina – tra di
INTRODUZIONE
9
loro diverse. La consapevolezza del teatro a Sagunto è evi-dente: lo descrive accuratamente parlando dei gradini adat-tati al declivio del colle, dei portici che lo circondano diordine dorico ripartiti in tre ordini l’uno sopra l’altro, delsemicircolo, cioè della cavea, capace di diecimila spetta-tori, della scena lunga quattrocento palmi che volge lespalle alla pianura «conforme come si vede nel teatro diTerracina», del pulpito quasi tutto in piedi e del porticodietro la scena di cui parte è tutto in piedi. Può veramenteammettersi che un viaggiatore attento e preparato quale ilMassimo, che ha descritto con precisione di linguaggio ilpulpitum, ossia il proscenio dove agivano gli attori, e fi-nanco la porticus post scaenam in Spagna, abbia fatto unparagone con qualcosa di difforme esistente a Terracina eda lui chiamato teatro? Evidentemente no! Aggiungiamo,per quanto possano valere le espressioni verbali adoperate,che nella lettera adopera la parola «conforme», che ha il si-gnificato di corrispondente, e la particella passivante conil verbo transitivo al tempo presente «si vede», che la-sciano intuire un riferimento ad una visione diretta e per-sonale del teatro di Terracina avvenuta da parte di coluiche scrive. Non è quindi ipotizzabile ritenere che il teatrodi Terracina coincidesse per il Massimo con i resti monu-mentali del cosiddetto tempio di Giove ‘Anxur’ e più pre-cisamente con il fronte del suggestivo imponente porticatoa dodici arcate posate su pilastri massicci visibile a di-stanza che era ed è la sostruzione artificiale di parte delterrazzamento del complesso templare denominato di‘Juppiter Anxurus’, poiché tale porticato è totalmente dif-forme dal teatro romano spagnolo e dalla scena del teatroromano, scena che non aveva all’interno arcate aperte;
10
INTRODUZIONE
inoltre per la disposizione orografica del complesso, ac-centuata dalla sostruzione, questa pretesa scena teatralenon volge le spalle alla pianura ma al mare.
Questo complesso ubicato sul monte poteva esserechiamato ‘Teatro’ soltanto da coloro che non avevano unaminima idea di cosa fosse un teatro romano e dove essopotesse sorgere. I teatri pubblici romani, infatti, sorgevanoall’interno delle città o, al massimo, in posizione prossimaall’abitato facilmente raggiungibile dai cittadini dell’ag-glomerato urbano per assistere alle funzioni cui era depu-tato; non sarebbe mai sorto sulla sommità di un montedistante dal nucleo della civitas.
Una crassa ignoranza a tal proposito dimostrerà lo sto-rico terracinese Domenico Antonio Contatore (1672 circa-1741), nella sua opera De historia terracinensi libriquinque, stampata a Roma nel 1706, e nel successivo ma-noscritto ‘Historie Terracinesi’, databile tra il 27 ottobre1713 ed il dicembre del 1714 e tra l’8 marzo 1716 ed il 18marzo 1718 (come dimostrato con sagacia ricostruttiva daR. Bianchi nell’introduzione alla trascrizione del mano-scritto), che addirittura identifica due teatri a Terracina:uno a «Sallissano», con «belle muraglia fatte di quadri, egrossi macigni senza calce» che sono invece le strutturedi una villa romana, ed un altro «su la cima del Monte S.Angelo, ch’era attaccato al reggio palazzo, dove dimoravaTeodorico re de Goti. L’autore si dice fusse l’istesso Teo-dorico nominato», affermazione assurda poiché non è am-missibile che un re barbarico alla fine del V secolo ed agliinizi del VI costruisse ex novo un teatro. Dobbiamo sup-porre pure che al tempo del Contatore i resti della scena delteatro fossero definitivamente scomparsi sotto costruzioni
INTRODUZIONE
11
piú recenti sorte sulla base della rinascita civile e demo-grafica di Terracina alla fine del 1700; tra il 30 aprile 1661(data della seconda lettera del Massimo) ed il 14 aprile1704 (data della visita a Terracina di monsignor LorenzoCorsini, tesoriere generale di Clemente XI, e del suo in-contro con il Contatore) intercorrono circa quarantatréanni. D’altra parte diversi edifici romani, tra cui un tempioesastilo-periptero con cella fornita di abside e con un por-ticato all’intorno di ventiquattro colonne, e resti epigraficie architettonici della zona del Foro Emiliano disegnati daBaldassarre Peruzzi (1481-1536) nella sua venuta a Ter-racina databile intorno al 1520, secondo il Wurm, o al pe-riodo 1511-1513, secondo il Bruschi, poco meno di duesecoli dopo non vengono citati dal Contatore in quanto an-ch’essi scomparsi alla sua epoca. A maggior ragione nonpoterono essere visti dai viaggiatori, artisti e storici suc-cessivi che vennero in Terracina.
Sebbene al tempo del Peruzzi e del Sangallo il Gio-vane (1484-1546) Terracina fosse ricca di vestigia romaneanche in pianura (terme, anfiteatro, cippi ed epigrafi), i dueartisti toscani ne scelsero soltanto alcune secondo gli in-teressi di ricerca che li guidavano. Così avvenne per altriviaggiatori che di Terracina ricordarono soltanto poche tes-timonianze romane rispetto alle numerose di cui abbon-dava. La scena del teatro, che supponiamo probabilmentevisibile in ambienti ormai resi sotterranei dalle costruzionisopra realizzatevi, fu tra i resti del passato dimenticati.Dobbiamo quindi essere grati alla passione del Papi, allasua intelligente ricerca tra fonti librarie ed archivistiche,alla sua capacità di trarre conclusioni e di esprimerle inmaniera valida e suadente, se le prime notizie di età mo-
12
INTRODUZIONE
derna sul teatro romano di Terracina finalmente emergonodall’oblio. Papi si conferma con questa sua nuova operacome uno dei piú validi storici del territorio.
Francesco ManninoPresidente della Società per la Storia Patria
della Provincia di Latina
INTRODUZIONE
13
PREMESSA
Questo opuscolo ha tratto spunto, in modo del tutto ca-suale, da alcune mie ricerche dedicate alla figura di CarloCamillo Massimo, patriarca di Gerusalemme e feudatariodi Roccasecca (località che nel 1872 ha aggiunto al proprionome la specificazione, che tuttora mantiene, «dei Volsci»)e si concentra in particolare su due lettere della sua corri-spondenza, che consentono di affrontare il mistero storico*
riguardante l’esistenza del teatro romano di Terracina inetà tardo-rinascimentale e di istituire un inedito e sugge-stivo parallelo con un analogo e più celebre monumentoesistente in Spagna, nella lontana Sagunto (che il cardi-nale ebbe occasione di visitare al tempo della sua nunzia-tura apostolica, 1654-1658).
Consegnando alle stampe questa mia fatica letteraria,desidero rivolgere un doveroso e particolare ringrazia-mento al professor Stefano Pagliaroli non solo per i fon-damentali suggerimenti bibliografici, ma soprattutto perle incisive cure critiche ed editoriali che ha voluto gene-rosamente riservare alla prima stesura del mio lavoro, ac-cogliendolo nella serie degli «Opuscula Fossanovensia»del Centro Studi Fossanovesi “Tommaso d’Aquino”.
* I più recenti risultati scientifici sull’argomento, che convergono– sulla scia di una ormai lunga tradizione – nel datare verso la metàdel XX secolo la riemersione archeologica del monumento, sono con-segnati all’importante volume Il teatro romano di Terracina e il tea-tro romano nell’antichità, Atti del Convegno,Terracina, 6 marzo2004, Roma 2007.
Per consigli e aiuti, ringrazio: la professoressa LisaBeaven; il professor Roberto Marzocchi; l’archeologoMarco Mannino; l’architetto Carmine Di Capua; la fami-glia Massimo di Roma (che mi ha consentito di accederealla consultazione dell’Archivio); i direttori e tutto il per-sonale dell’Archivio di Stato di Roma, dell’Archivio diStato di Latina, dell’Archivio di Stato di Frosinone, del-l’Archivio Capitolino di Roma, della Biblioteca Aposto-lica Vaticana, della Biblioteca Nazionale Centrale diRoma, della Biblioteca Angelica di Roma, della Biblio-teca Statale del Monumento Nazionale di Casamari, dellaBiblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma, dellaBiblioteca della Scuola Spagnola di Storia e Archeologiadi Roma e della Biblioteca Comunale ‘A. Olivetti’ di Ter-racina.
Mi auguro che questa ricerca possa far nascere unavera amicizia tra le comunità di Roccasecca dei Volsci (pa-tria ideale di Carlo Camillo Massimo), di Terracina e diSagunto: custodi, queste ultime, di due straordinari teatriromani.
G. P.
Roccasecca dei Volsci, 20 gennaio 2012.
16
PREMESSA
TAV. I Arsoli, Castello Massimo, Salone principale: M. BENEFIAL(1684-1764), Roccasecca (affresco; vd. p. 18).
TAV. II Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe:G. F. GREUTER, Il trionfo dell’amore (incisione su disegno di C. C. MASSIMO;vd. p. 18).
TAV. V N. T
INDAL(1687-1774)-P. RAPINDETH
OYRAS(1661-1724), carta nautica del M
editerraneo (qui con la sovra-
scrittura della probabile rotta seguita dal Massimo al tempo del viaggio in Spagna) (vd. p. 21).
TAV. VI Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delleStampe: C. C. MASSIMO, Altare di Sant’Agata (disegno; in bassostemmi con le api Barberini; vd. p. 22).
TAV. VII Roma, Collezione privata Stefano Massimo: veduta di Roccasecca dalla collina di San
Raffaele (anonimo della metà del XVII secolo; vd. p. 22).
TAV. VIII a-b Roccasecca dei Volsci, Tempietto di San Raffaele, costruitoed affrescato sotto la direzione artistica di C. C. Massimo (1659; vd. p. 23).
TAV. IX Roccasecca dei Volsci, Tempietto di Santa Maria della Pace, fattoerigere da C. C. Massimo (1661; vd. p. 24).
TAV. X Roccasecca dei Volsci, Tempietto di San Raffaele: Madonna conTobit, Tobia e l’arcangelo Raffaele (affresco) (vd. p. 24).
TAV. X
II Roccasecca dei Volsci, Tem
pietto di San Raffaele: piscina probatica (affresco; vd. p. 18).
TAV. XIII Roma, Palazzo alle Quattro Fontane: edificatosu progetto di Domenico Fontana, fu acquistato nel 1664da C. C. Massimo (oggi proprietà Del Drago) (vd. p. 26).
TAV. X
IV Palazzo M
assimo a R
occasecca dei Volsci in una cartolina dell’inizio del Novecento (collezione
G. Papi, per dono di Franco V
itelli; vd. p. 27).
TAV. XV Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe:C. C. MASSIMO, Gloria (disegno; vd. p. 28).
TAV. X
VII U
. ALDOVRANDI, D
e piscibus et de cetis, Bononiae 1613, Ppp2v (= 724): ‘Phoca’ (o ‘V
itulus marinus’) (vd.
p. 24)
LA VITA
Carlo nacque a Roma il 20 luglio 1620 da Giulia Serlupie da Giacomo Luigi del nobile casato dei Massimo, unodei più antichi di Roma (una tradizione, che oltrepassa lefitte tenebre del Medioevo romano, fa risalire le originidella famiglia all’illustre condottiero romano Quinto FabioMassimo soprannominato ‘Cunctator’, cioè ‘Temporeg-giatore’)1.
La precoce e assidua frequentazione dei più privile-giati ambienti culturali dell’Urbe favorì la sua poliedricaformazione, che poté spaziare dalle discipline scientifichea quelle umanistiche; ed è fuor di dubbio che, per il suo fu-turo di mecenate e collezionista, sia stato decisivo l’in-gresso nella cerchia del cardinale Francesco Barberini. Maforti erano, a vario titolo, contatti e parentele dei Massimo,con altre potenti famiglie romane: il bisnonno Luca avevasposato Virginia Colonna e il nonno Carlo Clarice Giusti-
1 Per la biografia mi limito qui ad alcuni cenni essenziali: T. DI
CARPEGNA FALCONIERI, Il cardinale Camillo Massimo (1620-1677).Note biografiche attraverso una spigolatura dell’archivio Massimo,in Camillo Massimo collezionista di antichità. Fonti e materiali,Roma 1996, 27-44; R. MARZOCCHI, “Facere bibliothecam in domo”.La biblioteca del cardinale Carlo Camillo Massimo (1620-1677),Verona 2008, 11-46 (del libro esiste una precedente e rarissima emis-sione del 2005, identica a quella del 2008, che ho consultato graziealla cortesia dell’amico Stefano Pagliaroli, che l’ha ricevuta in donodall’editore veronese Mauro Bonato). Vd. anche il recente breve pro-filo di C. TERRIBILE, Massimo, Carlo Camillo, in Dizionario biogra-fico degli Italiani, LXXII, Roma 2008, 1a-3a.
niani; suo zio Ascanio (1547-1613; ebbe sepoltura pressola chiesa collegiata di Santa Maria Assunta di Roccasecca;TAV. I) aveva sposato Virginia Giustiniani, sorella di quelVincenzo che nel suo palazzo di Roma, oggi sede del Se-nato della Repubblica, aveva costituito una prestigiosa pi-nacoteca personale (celebre anche per numerose opere delCaravaggio). Certo, anche il giovane Carlo non fu dameno: nella sua totale dedizione allo studio delle belle arti,incominciò, già durante l’adolescenza, a collezionare og-getti artistici di ogni genere, grazie anche alle enormi di-sponibilità economiche (tra le sue amicizie si annoveraanche quella con Cassiano dal Pozzo).
Nel 1640, alla morte dello zio Camillo Massimo I, ot-tenne l’investitura del feudo di Roccasecca e la nomina aerede universale con il nome di Carlo Camillo MassimoII (ereditò un patrimonio di 250000 scudi).
Carlo amava molto dipingere (prese lezioni private daNicolas Poussin, pittore di fama europea; TAV. II). Perquanto concerne la Galleria Giustiniana sono importanti idue seguenti documenti. Una lettera del Massimo «a’ go-vernatori della famiglia Giustiniana di Genova» (TAV. III)2:
Illustrissimi signori miei osservandissimi, la buona memoriadel signor marchese Vincenzo Giustiniani, mio zio (che sia incielo!), mi lesse una sua poliza disponente li rami della Gale-ria Giustiniana a servitio della famiglia e, lasciandomela sigil-lata, mi ordinò che, doppo la sua morte, dovessi aprirla enotificarla. Et, essendo piaciuto a Dio di chiamar detto signormarchese a sé, havendola fatta aprire e leggere alla presenza di
18
LA VITA
2 Lettere memorabili dell’abbate MICHELE GIUSTINIANI [...], InRoma 1669, C7v [62] n° XIV («Di Camillo de’ Massimi a’ governa-tori della famiglia Giustiniana di Genova: sopra la Galleria Giusti-niana»).
quelli che furono anche presenti all’apertura del suo testamento,come appresso, ne mando qui dentro acclusa la copia alle SS.VV. Illustrissime, acciò possano dar qui ordine a chi Le parràdella Loro volontà, ché da me in questo, come in altra cosa chesi degnaranno comandarmi, saranno prontamente servite, con-forme all’obligatione che devo al sangue dal quale sono nato.E, baciando per fine le mani alle Sig. VV. Illustr(issime), Leprego dal Sig. Iddio ogni felicità. Di Roma, il 1° dell’anno 1638.
Delle SS. VV. Illustrissime servitore affetionatissimo, Ca-millo de’ Massimi.
E una precedente dello stesso zio Vincenzo Giustiniania Camillo (TAV. IV a-b)3:
Illustrissimo signor nipote, io prego la S. V. che sia contenta diprendersi cura che tutti li rami intagliati della Galeria Giusti-niana restino nella famiglia Giustiniana di Genova, li cui go-vernatori e congregatione mi debbano favorire di procurare che,da i detti rami – con farne stampare quantità moderata per cia-scheduna volta, senza eccede il numero di docento per ognivolta –, se ne cavi quel maggior utile che se ne può sperare ra-gionevolmente e che, del ritratto che si caverà da essi, con farlodepositare in più sicuro luogo che parerà, se ne debba far’in-vestitura e comprarne monti camerali o altre entrate più sicureche si potrà: li quali monti et investiture sudette siano ferme enon si possino vendere né alienare in qualsivoglia modo et, incaso d’estintione o di reduttione, si debba il capitale di nuovo,sempre che verrà il caso, rinvestire in altri monti et entrate,come s’è detto di sopra, con ogni diligenza e cautela possibile.Et il frutto, che s’anderà cavando alla giornata dalla detta in-vestitura de’ monti o d’altre entrate, come sopra, sia distribuitoannuatim da i deputati di detta famiglia a i poveri più misera-
19
LA VITA
3 Vd., nello stesso volume, C8r-v [63-64] n° XV («Al signor Ca-millo Massimo»).
bili Giustiniani scritti ne i libri della Repubblica di Genova Se-renissima, regolandosi con la loro propria conscienzia e per lamera carità christiana.
Perché, havendo io fatta quest’opera di far intagliare le cosedella mia Galeria, messa e raccolta insieme per un’humor pec-cante havuto di lunga mano con spesa continuata più che me-diocre, non solamente nel costo delle statue, ma anco nellostesso intaglio de’ rami, e conoscendo [conscenendo ed.] be-nissimo che questa spesa si poteva applicare ad altro uso pio epiù utile al prossimo, ho voluto in qualche parte supplire al miomancamento con applicare questo ritratto che farà de’ rami, ilquale, se sarà custodito, non sarà se non d’emolumento d’al-cune migliaia di scudi per doversi distribuire a’ poveri della fa-miglia Giustiniana, già che nel tittolo della Galeria Giustinianami paio necessitato, per emendare l’errore che mi sarà appostoda qualcheduno, a pregare V. S. che si prenda questa cura peramor mio.
Vincenzo Giustiniano [Gii- ed.], mano propria.
Oltre che dello stesso Poussin, fu insigne protettore dicelebri artisti, tra i quali il Lorrain, il Velázquez, Carlo Ma-ratta. Appena ventenne commissionava all’incisore PietroSanti Bartoli (forse coadiuvato da Pietro Aquila) una copiadi un manoscritto celeberrimo: il ‘Virgilio Vaticano’.
Si laureò a La Sapienza di Roma all’età di ventiseianni; nel 1646 divenne cameriere segreto del Papa e l’annosuccessivo canonico di San Pietro in Vaticano. La sua car-riera politico-religiosa ebbe un importante avanzamento il10 settembre 1651, quando ottenne la nomina di clericusdella Camera Apostolica per intercessione del cardinaleOttaviano Raggi: e tale incarico rappresentava notoria-mente un significativo gradino per l’ascesa al cardinalato.
In quel giro d’anni, nei quali cade la nomina a patriarcadi Gerusalemme (sulla quale influì la protezione accorda-
20
LA VITA
tagli dal cardinale Fabio Chigi, il futuro papa AlessandroVII), si intensificano le sue premure per il feudo rocchi-giano. Nell’ottobre del 1652 papa Innocenzo X autoriz-zava la translatio a Roccasecca delle reliquiae del martiresan Massimo, rinvenute proprio da Carlo Camillo a Roma,nel maggio del 1651, all’interno dell’area cimiteriale diSan Callisto4: ma la venerazione riservata ad esse non fucerto dettata da soli ed esteriori motivi di omonimia.
Nel dicembre 1653, poiché la famiglia Massimo era sìdi orientamenti politici filospagnoli, ma aveva anche buonicontatti con la Francia, Carlo Camillo fu nominato – comesi è già avuto occasione di accennare – nunzio apostolicoin Spagna: e l’incarico aveva per l’appunto lo scopo di-plomatico di contribuire a rafforzare le relazioni tra il papae il re di Spagna, oltre che tra quest’ultimo e i Francesi.
S’imbarcò a Civitavecchia nel gennaio del 1654 condestinazione la penisola iberica, approdando a «Vinaros,spiaggia di Valenza» (TAV. V)5: ma, avviatosi alla volta diMadrid, mentre si accingeva ad assumere il delicato inca-rico, sorsero negli ambienti della Corte madrilena alcuneinattese difficoltà, rese più complicate da intrighi politiciai quali certamente non fu estranea la stessa Curia romana.
Ma il ‘congelamento’ della nunziatura si rivelò per altriversi propizio per Carlo Camillo: il quale, durante il lungoperiodo di attesa, non perdette l’occasione per visitaremolte città, animato dall’insopprimibile e antica passioneper la ricerca e per lo studio delle belle arti e insieme dal
21
LA VITA
4 Per cui rimando al mio studio: Una statua, due storie: san Mas-simo di Roma e san Massimo d’Aveia, Priverno 2010.
5 Vedi più avanti, 38. Di un’interessante e inedita relazione ode-porica del viaggio sto ultimando l’edizione, che pubblicherò prossi-mamente.
concreto desiderio di arricchire di nuovi pregiati reperti lesue straordinarie collezioni. Nel frattempo, il cardinaleGian Giacomo Trivulzio, ambasciatore del re di Spagna aRoma, procedeva nel dichiarare nulla la nomina di CarloCamillo, perché non concordata preventivamente con il re.Ma si trattava, come era facile immaginare, di un pretestodi natura squisitamente politica: il nobile milanese infattiaveva ragione di considerare Carlo Massimo un perico-loso filofrancesce a causa della sua ben nota amicizia conesponenti della famiglia Barberini (TAV. VI).
Solo con l’ascesa al soglio pontificio di Fabio Chigi, il7 aprile 1655, che assunse il nome di Alessandro VII –questi, rivestendo la carica di segretario di stato, aveva po-tuto seguire molto da vicino la controversia diplomaticaalla quale si è fatto cenno –, Carlo Camillo, già nel mag-gio del 1655, poté incominciare a svolgere le funzioni dinunzio apostolico della Santa Sede in Spagna. Tre annidopo, il 21 luglio 1658, intraprendeva la via del ritorno el’11 ottobre successivo giungeva a Roma. In città lo at-tendeva l’ennesima sorpresa. Nel nuovo clima politicogravava adesso sulla sua reputazione l’eccessiva ‘vici-nanza’ agli interessi della Spagna: e tale accusa ebbe effettideterminanti sul futuro della sua carriera. Il mutamento re-pentino della politica estera vaticana imponeva a questopunto il ‘sacrificio’ dell’alto prelato. Certo, se per CarloCamillo Massimo II questa sentenza papale rappresentòuna catastrofe, si può affermare, con il senno di poi, cheper la comunità rocchigiana essa costituì un raro colpo difortuna: perché a partire dal 14 ottobre 1658, quando egligiunse nel suo feudo del Lazio meridionale (e, come è bennoto, si trattò di un vero e proprio confino), il piccolopaese collinare acquisì rinomanza e celebrità proprio gra-zie alla stabile dimora dell’illustre ospite (TAV. VII).
22
LA VITA
Il soggiorno a Roccasecca si protrasse per quattro anni.Oltre a fitte e quotidiane corrispondenze epistolari (le suemissive appaiono spesso indirizzate ad artisti, antiquari,collezionisti d’arte, letterati ecc.), poté coltivare i predi-letti interessi musicali, anche testimoniati dalle richiestedi invio di particolari spartiti custoditi nelle sue residenzeromane.
Rivoluzionaria e splendida – come era da aspettarsi –fu l’iniziativa edilizia ed architettonica da lui promossa nelpiccolo e suggestivo castrum. Qui, proprio nel cuore del-l’antichissima fortezza medioevale6, fece edificare la pro-pria sontuosa dimora (attuale Palazzo Massimo, sededell’Amministrazione Comunale): che nella cappella pri-vata del cardinale fu presto decorata dall’affresco di unaNatività di pregevole fattura artistica.
Nel 1659, sulla cime della collina che domina il paese,faceva costruire la chiesuola (o tempietto) di San Raffaele(TAV. VIII a-b), ornata tuttora da spettacolari affreschi: e,a questo proposito, sarà opportuno sottolineare che in queltorno di tempo egli ripetutamente sollecita al riguardo, tra-mite il Bellori, il grande Nicolas Poussin (dal quale avevaricevuto lezioni nell’arte del disegno)7. Due anni dopo, ai
23
LA VITA
6 Le origini del sito si perdono nelle tenebre dell’Alto Medioevo,come provano inequivocabilmente i documenti pubblicati negli ul-timi anni da Stefano Pagliaroli: FAVONII LEONIS PRIVERNATIS De lau-dibus et commoditatibus Priverni oratio, introduzione, edizionecritica e traduzione a cura di S. PAGLIAROLI, con la collaborazione diE. ANGELINI, Fossanova 2006; S. PAGLIAROLI, Una visita al mona-stero di Santa Maria delle Canne di Sonnino, Fossanova 2011; Il ‘ca-stellum’ di Priverno nel Medioevo, Fossanova 2011.
7 Vd. passim i riferimenti contenuti nello spoglio del Registro 276(anni 1658-1663) dell’Archivio di Palazzo Massimo di Roma effet-tuato dal MARZOCCHI, “Facere bibliothecam in domo”..., 564-617.
piedi dell’erta sulla quale sorge Roccasecca (l’attuale lo-calità Casini), faceva costruire un secondo tempietto,quello della Madonna della Pace (TAV. IX), al cui internosi ammira un affresco rappresentante la Vergine col Bam-bino (forse di epoca precedente). È opportuno far presente– né risulta che gli storici dell’arte, allo stato degli studi,abbiano fornito interpretazioni convincenti – che rimaneancora sospesa la questione della paternità architettonicadei due menzionati monumenti e delle straordinarie operepittoriche che custodiscono (TAVV. X-XII): ma non si potrà,a questo punto, prescindere dall’indirizzare risolutamentel’indagine nell’Urbe, concentrando l’attenzione sugli arti-sti (si pensi alle clamorose missive che chiamano in causanientemeno che il Poussin) con i quali (o a proposito deiquali) il Massimo, in quegli anni, intrattiene fitti commerciepistolari (si pensi a Giovan Pietro Bellori, che, per inciso,
24
LA VITA
Ringrazio Stefano Pagliaroli – le cui ricerche, negli scorsi anni, sisono svolte indipendentemente dalle mie – per avermi procurato leimmagini digitali degli originali da lui scattate in loco, alla presenzadel dottor Carlo Massimo, la mattina del 9 luglio 2008. Presento dun-que qui una rapida rassegna di significative lettere inviate da Rocca-secca al Bellori: Reg. 276, 320r-321v (MARZOCCHI 578), 14 giugno1660; 337v, 18 luglio 1660 (MARZOCCHI 579); 346v, 9 agosto 1660(MARZOCCHI 580-81); 355r (MARZOCCHI 581-82), 30 agosto 1660;385v, 25 ottobre 1660 (MARZOCCHI 583-84); 402r (MARZOCCHI 585),22 novembre 1660; 488r (MARZOCCHI 592), 13 giugno 1661. Mi ri-prometto di ritornare sull’argomento, al fine di verificare se il Pous-sin abbia in qualche modo corrisposto ai desiderata del Massimo:dalle lettere al Bellori l’artista risulta impossibilitato a causa di serimotivi di salute. Vedi anche, per tutte le problematiche concernenti ilMassimo protettore di artisti, il recente lavoro di L. BEAVEN, An ardentpatron. Cardinal Camillo Massimo and his antiquarian and artisticcircle: Giovanni Pietro Bellori, Claude Lorrain, Nicolas Poussin,Diego Velazquez, London-Madrid 2010.
il 12 ottobre del 1661 fu ospite di Carlo Camillo)8. A ri-prova che la cosiddetta ‘storia locale’ (nella fattispecie diuna piccola località come Roccasecca in età barocca) puòfornire imprevedute e decisive risposte a problemi rimastiinsoluti per chi li abbia affrontati prescindendo, per unaragione o per un’altra, dalle culture autoctone e munici-pali.
Nella tranquillità dell’amena località ausonia, il pre-lato trovò sollievo e conforto anche negli studi classici ecerto approfittò delle disperse (ma enormi) risorse ar-cheologiche disseminate sul territorio dell’antica coloniaromana privernate per arricchire le proprie collezioni (edè continuo in quegli anni il via vai da Roma di corrieri emessi del Massimo incaricati, al riguardo, delle più dispa-rate commissioni): di enorme valore la sua collezione nu-mismatica9, composta da più di due migliaia e mezzo dipezzi, molti dei quali aurei, e talora rarissimi o unici. Perquanto concerne la grande collezione epigrafica10, che an-noverava importanti iscrizioni latine e greche, parte di essaera allestita all’interno del palazzo di Roccasecca (una diesse permane tuttora murata nella parete dell’edificio, al-l’inizio della scalinata che conduce al piano nobile).
Ma va da sé che questo esilio, seppur dorato, se da unaparte non poteva soddisfare tutti i molteplici interessi diCarlo Camillo, dall’altra certamente continuava a frustrare
25
LA VITA
8 Roma, Archivio Massimo, Registro 276, 540v. Il Massimo, il 13ottobre 1661, scrive una lettera a don Domenico Gerardi dichiarandoche la sera prima era giunto a fargli visita il Bellori.
9 M. C. MOLINARI, La collezione numismatica, in Camillo Mas-simo collezionista..., 159a-91.
10 M. BUONOCORE, La collezione epigrafica: iscrizioni latine e gre-che dei Massimo nel codice 1684 della Biblioteca Angelica, in Ca-millo Massimo collezionista..., 193a-202b.
le sue mai sopite ambizioni di conseguire nuovi traguardidella carriera ecclesiastica: e deve essere probabilmenteinquadrato in questo contesto il favore da lui accordato,nel 1659, alle nozze di Laura Ginetti (nipote del cardinaleMarzio, rampolla della famiglia feudataria di Velletri edella limitrofa Roccagorga) con suo fratello Fabio; un av-venimento che dovette rappresentare per lui l’occasione direcuperare prestigio e contatti con gli ambienti più in-fluenti della Città Eterna.
Ma, finalmente, il lungo esilio rocchigiano ebbe con-clusione. Nel 1663 Camillo Massimo è di nuovo a Romae lì il 19 febbraio 1664 acquista una prestigiosa residenzasignorile: il palazzo delle Quattro Fontane (TAV. XIII), giàMattei11, sede congeniale per le sue collezioni d’arte e in-sieme vero e proprio ‘investimento’ in vista dell’auspicatoreinserimento nella politica e nella cultura dell’Urbe12:
L’atrio superiore [è] adornato di statue, di bassirilievi et di testeantiche. Tra le pitture delle camere: due storie di Mosè, la fa-vola di Apolline che s’innamora di Dafne, di Nicolò Pusino;Hercole che uccide i serpenti, picciola figura di Annibale Car-racci; paesi di Claudio Lorenese; et opere di insigni maestri co-lorite ad olio, sicome nelle volte delle camere a fresco diGiuseppino, de gli Albecci et di altri.
26
LA VITA
11 Il Palazzo, poi in parte modificato, oggi appartiene alla famigliaAlbani Del Drago.
12 Nota delli musei, librerie, galerie et ornamenti di statue e pitturene’ palazzi, nelle case e ne’ giardini di Roma, In Roma 1664, ed.Roma 1664, B5r-v [= 33-34]. Vd. anche G. FUSCONI, Un taccuino didisegni antiquari di Raymond Lafage e il palazzo delle Quattro Fon-tane a Roma, in Camillo Massimo collezionista..., Roma 1996, 45a-65b: 50a-b e n. 9 (a p. 63b).
Riprendeva intanto (giugno 1665) il suo servizio negliambienti della Curia. Più tardi, il 6 maggio 1670, venivanominato ‘maestro di camera’ da papa Clemente X,quando ormai il suo sogno di vestire la porpora cardinali-zia stava per essere esaudito: fu proprio papa Altieri a cre-arlo cardinale il 22 dicembre 1670, colmandolo diprebende, rendite e benefici. Come era da aspettarsi, CarloCamillo destinò gran parte di tali ingenti entrate all’accre-scimento delle sue già vastissime collezioni: anzi eraormai, se si può dir così, un vero e proprio connoisseur edestimatore tra i più celebri di Roma. Negli anni 1672-1673otteneva la direzione del cantiere di Palazzo Altieri e dellaCappella di Santa Maria Sopra Minerva, che pare rievo-care, scintillante di finti marmi e decorazioni, la citatachiesuola di San Raffaele a Roccasecca dei Volsci.
Nel conclave del 1676, dal quale uscì eletto papa In-nocenzo XI, il cardinale Carlo Camillo Massimo II ottenneun voto. Ammalatosi, si spegneva a Roma il 12 settembre1677, nel suo palazzo alle Quattro Fontane, all’età di cin-quantasette anni, lasciando un vuoto incolmabile negli am-bienti culturali dell’Urbe.
Le preziose collezioni furono ereditate dal fratelloFabio Camillo III, unico erede all’interno di quel ramodella famiglia. Questi commissionò la stesura di un in-ventario generale dei beni presenti al palazzo delle Quat-tro Fontane e nelle dimore fuori Roma, compresa quella diRoccasecca (TAV. XIV). La vendita di tale patrimonio con-sentì di saldare tutti i debiti accumulati dal defunto cardi-nale, ma comportò purtroppo la dispersione dei pezzi piùpregiati della sua pinacoteca (tra i quali celebri capolavoridi Claude Lorrain, Gaspard Dughet, Guido Reni, CarloMaratta, Nicolas Poussin).
La ‘libreria’ (insieme con otto busti antichi), ricca di
27
LA VITA
preziose opere, fu acquistata da monsignor Giovan Fran-cesco Ginetti, tesoriere della Camera Apostolica13. Tra idisiecta membra della collezione numismatica, si anno-vera la porzione approdata nelle raccolte della regina Cri-stina di Svezia. Tutto fu tristemente disperso insomma, daimosaici alle statue, dai disegni alle antiche pitture, dalleepigrafi ai libri antichi, ai manoscritti. Il palazzo alle Quat-tro Fontane, con sculture e suppellettili, fu venduto al car-dinale Francesco Nerli: una parte di pitture antiche,mosaici e capolavori di statuaria e glittica greco-romana futrasferita nel Palazzo Massimo alle Colonne e ceduta du-rante il XVIII secolo a vari istituti museali privati e pub-blici stranieri (celebre il gruppo cosiddetto di Castore ePolluce oggi al Prado di Madrid14).
Chi per la prima volta visiti Roccasecca dei Volsci puòverificare che il patrimonio architettonico ed artistico sei-centesco vi raggiunge alti e distinti livelli di bellezza e displendore. Benché per noi sia difficile ricostruire tutte lecaratteristiche del sito durante la dimora del cardinale, pos-siamo tuttavia constatare, in quello che a lui è sopravvis-suto, l’inconfondibile impronta del finissimo gusto diCarlo Camillo (TAV. XV).
28
LA VITA
13 Per una descrizione della libreria, vd. il riferimento bibliogra-fico nella nota precedente.
14 Camillo Massimo comprò per sé, dalla collezione Ludovisi, il ce-lebre gruppo. In questo embrionale concetto di tutela, impedire la di-spersione del patrimonio significava semplicemente, nelle stesseparole del Massimo, che da Roma non dovesse «levarsi cosa alcuna»(TERRIBILE, Massimo..., 2b).
TERRACINA, UN ‘MUSEO’ STORICO ALL’APERTO
Carlo Camillo si recò spesso a Terracina (Roccasecca ap-parteneva anche allora alla diocesi terracinese, della qualeera titolare in quegli anni il vescovo Francesco Maria Ghi-slieri), senza dubbio anche per ammirare, come studioso ecultore d’arte, i monumenti e le vestigia dell’antico centro(TAV. XVI).
Il Massimo era molto attratto dalle antiche vestigia maanche affascinato dalle stranezze naturali (botaniche, fau-nistiche ecc.) e dagli eventi curiosi che si verificavano nelsuo feudo e nei territori limitrofi. A Roccasecca aveva sco-perto una caverna «tutta adornata, tanto nelle pareti comenella volta di sopra, di scherzi della natura rappresentandofigure, cavalli, altri animali e forme di alabastro generatodalla cadenza dell’humido»15. Riferì che a Terracina, nelmese di marzo del 1661, era stato catturato un pesce sor-prendente, come documenta la lettera del 4 aprile 1661 alsolito Giovan Pietro Bellori: «il mese passato [...] in Ter-racina fu preso su la riva del mare, che dormiva vicin al-cune case pastorali, un pesce straordinario: credo io chefosse vitello marino»16. Per documentarsi sullo strano
15 Lettera al Bellori del 25 gennaio 1662: MARZOCCHI, “Facere Bi-bliothecam in domo”..., 6 (Reg. 276, 594v-95r).
16 MARZOCCHI, “Facere Bibliothecam in domo”..., 590 (Reg. 276,461r). La presenza di questo animale nel tratto costiero di Terracinaè molto importante sotto l’aspetto faunistico. Esso è senza dubbio daidentificare con una ‘foca monaca’, documentata nell’Adriatico apartire dal Cinquecento; vd., con numerosi rimandi a fonti prece-denti, W. KLINGER, Note sulla presenza storica della Foca Monaca
‘pesce’ (TAV. XVII), Carlo Camillo avrà consultato librispecifici presenti della sua biblioteca17.
Terracina era ed è una città piena di storia, di fascinoe di colore. Le pietre, scolpite con maestria, parlano e rac-contano la storia di un prestigioso passato, del quale oggirimangono solo cicatrici. I particolari di un capitello, diuna colonna tortile, di un architrave, di uno stipite, di unaepigrafe, di un mosaico, di una monofora o di una bifora,del lastricato di una piazza, di frammenti di statue, rive-lano, a mio giudizio, un’innata attitudine artistica del po-polo terracinese. Nei muri delle case, spesso costruite conmateriali lapidei provenienti da spoliazioni di antichi mo-numenti (TAV. XVIII)18 si scoprono massi romani scalpel-lati, pietre cesellate con straordinaria perizia, stipiti,architravi di portali, iscrizioni: insomma un vero paradisoper gli studiosi dell’antichità e della sua faticosa ‘soprav-vivenza’ attraverso i secoli, per giungere fino a noi (TAVV.XIX-XX).
Del fascino di questa atmosfera io stesso in più occa-sioni ho potuto sperimentare i benefici effetti e le conti-nue sorprese: e, di queste ‘spigolature’, tanto piùinteressanti, quanto più imprevedute, mi riprometto di dareconto prossimamente in un’apposita pubblicazione. Nelloscorso anno, ad esempio, perlustrando in più occasioni idintorni del grande complesso della chiesa di San Cesa-
30
TERRACINA UN ‘MUSEO’ STORICO ALL’APERTO
nell’Adriatico, «La ricerca», 57 (giugno 2010), 6a-10b. Vd. ancheDelle caccie, di E. RAIMONDI [...], In Napoli 1626, Ff4v [= 456] n°CLXXXVII («Della Foca o Vitello Marino»).
18 MARZOCCHI, “Facere Bibliothecam in domo”..., 432 n° 1194.19 Mi limito a rimandare all’egregia disamina di F. MANNINO, Un
esempio di spoliazione medioevale di un teatro romano, ne Il teatroromano di Terracina..., 705-12.
reo – anche, all’occasione, in compagnia di amici comePiefrancesco De Angelis, Venceslao Grossi e Stefano Pa-gliaroli –, mi è accaduto di riconoscere frammenti di epi-grafi e di sculture altomedievali perfettamente mimetizzatinei contesti cromatici delle facciate di alcuni edifici di queiparaggi (anzi, talora anche completamente occultati da ve-getazioni spontanee: TAV. XXI).
E mi sta a cuore sottolineare in questa sede il caratteredi vero e proprio ‘cantiere’ o ‘museo’ all’aperto della cittàterracinese. Certo, le ferite del tempo ne hanno segnato,talora con conseguenze irreparabili, la variegata fisiono-mia. Del resto, nel passato, bisogni e necessità pratiche in-combenti hanno, sempre e dappertutto, prevalso sullepreoccupazioni di conservare le bellezze artistiche del-l’antichità, e questo anche in ambienti di cultura. Intendodire che non si facevano troppi scrupoli a demolire un tem-pio o una chiesa per rifonderne i pezzi in edifici di altranatura e finalità: di qui il panorama di frammenti ‘erratici’sopravvissuti sporadicamente nelle sedi più impensate (vd.TAV. XXII per un’iscrizione del 1283, la cui lettura e tra-duzione devo alla cortesia di Stefano Pagliaroli).
Tale ‘museo’ dovette essere particolarmente vitale inetà barocca, quando – per limitarmi a un cenno rapido edessenziale – molti monumenti di Terracina non avevanosubito le ‘aggressioni edilizie’ dei secoli successivi: sipensi alla già menzionata antica sede vescovile di San Ce-sareo o ai conventi di San Domenico e di San Francesco(TAV. XXIII) o alle stesse antichissime porte cittadine. E,d’altra parte, alla rinascita o alla meravigliosa risurrezionedi quel mondo antico celato nelle viscere della terra pote-vano, come ho detto, contribuire non solo ritrovamenti ca-suali, ma anche eventi di ordine naturale o anchericonducibili a precise responsabilità degli uomini (si pensi
31
TERRACINA UN ‘MUSEO’ STORICO ALL’APERTO
al bombardamento devastante dell’ultima guerra). Sonopertanto fermamente convinto che Camillo Massimo abbiaavuto durante la vita più volte occasione (e soprattutto trail 1658 e il 1662) di visitare Terracina, prima che la cittàfosse sfigurata da quel lento e continuo processo di inter-venti edilizi o urbanistici che culminerà nell’età di papaPio VI19 con quel grande progetto di bonificare tutta la Pa-lude Pontina (e enorme fu l’esigenza di dare alloggioanche alle popolazioni dei paesi limitrofi che a Terracinatrovarono allora lavoro), il quale però, dopo i primi grandientusiasmi, rimase limitato al ristabilimento della viabi-lità sull’Appia (TAV. XXIV)20.
32
TERRACINA UN ‘MUSEO’ STORICO ALL’APERTO
19 A. BIANCHINI, Storia di Terracina, Terracina 1952, 267-83.20 Si vedano i contributi raccolti in Pio VI, le Paludi Pontine, Ter-
racina. Catalogo della mostra, Terracina, 25 luglio-30 settembre1995, a cura di G. R. ROCCI, Terracina 1995.
TAV. XVIII Terracina, via della Palma, facciata di casa medievale con bifora: frammento di
bassorilievo da urna cineraria (vd. p. 30).
TAV. X
IX Terracina, via Posterula (sul retro della C
attedrale): frammento di cornice lapidea al-
tomedievale (vd. p. 30) .
TAV. XX T
erracina, via Anita Garibaldi, 98: materiali lapidei di spoliazione di epoca
medievale (tre fram
menti di capitelli floreali, un fram
mento di colonna, un fram
mento
di pilastro intarsiato co
n motivi floreali e una co
rnice curvilinea co
n intrecci; vd. p. 30).
TAV. X
XI Terracina, via A
nita Garibaldi, 98: fram
mento di m
osaico romano a tessere bianche
e frammento di architrave con iscrizione dell’inizio del Settecento (vd. p. 31).
TAV. XXII Terracina, Palazzo degli Azzi: lapide con iscrizione del 1283 («In anno Dom
ini
MCCLX
XXIII G
regorius de A
sso em
it domum
istam [N
ell’anno del Signore 1283 Gregorio
di Asso comprò questa casa]») (vd. p. 31).
TAV. X
XIII C
ittà del Vaticano, Biblioteca A
postolica Vaticana, Gabinetto delle Stam
pe,Ashby, D
isegni, 252: E. S. PER
CY(1782-1847), Villa a Terracina
(disegno con matita
nera e acquerellature di grigio). Il titolo è fuorviante: si tratta, in realtà, del convento diSan Francesco, prim
a della distruzione del portico d’ingresso alla chiesa (riconoscibileper il cam
panile, ancora presente nella struttura; vd. p. 31).
TAV. XXIV Terracina, località Le Mole: so
struzione della via Appia so
pra le so
rgenti della
dea F
eronia (foto scattata dal mulino di proprietà della famiglia Cipolla; si ringraziano Piero
e il figlio Francesco; vd. p. 32).
TAV. XXV a-b Sagunto, schizzo delle strade della città (da M. GONZÁLESSIMANCAS, La Acrópoli, sus excavaciones y el teatro romano, Madrid [c.1920], 51); J. MOULINIER (1753-1828), pianta generale della città di Mor-viedro (Sagunto) (vd. p. 33).
TAV. XXVI Sagunto, veduta d
el teatro romano e d
ella città (fotografia di fine O
ttocento; vd. p. 33).
TAV. X
XVII Sagunto, veduta generale del teatro rom
ano, sovrastato dal castello (fotografia difine O
ttocento; vd. p. 34).
TAV. XXVIII Sagunto, porta principale del teatro romano con muratura inopus vittatum (fotografia di fine Ottocento; vd. p. 34).
TAV. X
XIX Sagunto, vista sulla cavea
e ingresso del teatro romano (fotografia di fine O
ttocento; vd.p. 35).
TAV. XXX C
ittà del V
aticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. L
at. 1564, 89r: m
iniatura medievale della c
olon
iaromana (da CASTAGNOLI, L
e “f
orm
ae”..., Fig. 6; vd. p. 37 e n. 25).
TAV. XXXI M. GIUSTINIANI, Della scelta delle lettere memorabili [...], InNapoli 1683: L4r [= 247] (vd. p. 37).
TAV. XXXII M. GIUSTINIANI, Della scelta delle lettere memorabili [...], InNapoli 1683: L4v-5r [= 248-49] (vd. p. 37).
TAV. XXXIII M. GIUSTINIANI, Della scelta delle lettere memorabili [...], InNapoli 1683: L5v [= 250] (vd. p. 37).
CARLO CAMILLO MASSIMOE I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
C’è una lettera di Carlo Camillo, datata «Valenza, 13 dimarzo 1654», nella quale, ottemperando a una espressa ri-chiesta rivoltagli dall’abate Michele Giustiniani, egliscrive che, per il momento – e non si può escludere chealtre missive della medesima natura possano prima o poiriemergere –, invierà una breve selezione di sue osserva-zioni autoptiche concernenti fatti di particolare sugge-stione.
Nella missiva, è senza dubbio interessante il conciso‘dialogo’ che egli instaura con le fonti antiche e con l’etàmedievale: Annibale che distrusse Sagunto (TAVV. XXV a-b-XXVI) e i Romani riservarono a Cartagine il medesimotrattamento; i Mori che lasciano i segni della loro occupa-zione, a partire dall’inizio dell’VIII secolo, delle regioniispaniche. Dalle iscrizioni sparse qua e là il Massimo ri-cava informazioni relative ai duoviri dell’antica coloniaromana. Né rimane escluso dalla sua acuta disamina il pa-trimonio di tenaci tradizioni consolidatesi anche a livellolocale (anche se, talora, storicamente improbabili o deltutto fantasiose), come quella riguardante l’origine delnome ‘Sagunto’ e la sepoltura del mitico Zacinto: dove ilnostro coglie l’occasione per fornire un dettaglio architet-tonico e scultoreo del sepolcro, che – precisa – è di stile io-nico (vd. anche qui infra, un puntuale riferimentoriguardante lo stile dorico). Si noti ancora il riferimentoalle «rovine di edificii ricoperti di verdeggiante ellere» –Carlo Camillo era un appassionato botanico, come prova
il catalogo della sua ‘libreria’ –; e qualunque fatto anticorichiama puntualmente la sua attenzione (si pensi al «suolosparso di vasi rotti, simili alla terra cadmia» o al riutilizzo,entro contesti edilizi allotrii, di resti antichi, come fram-menti di statue ecc.). Interessante anche la digressione suun reperto bellico: quell’«ariete antico», ormai corroso daltempo, sul quale l’illustre visitatore si sofferma meravi-gliato e compiaciuto.
Ma ancor più potente e suggestiva è la descrizione delteatro romano, in rovina (TAVV. XXVII-XXVIII), dell’an-tica Sagunto, quel «Colosseo» – così ritenuto dagli abi-tanti locali, per ovvia e facile analogia con la più celebrecostruzione dello stesso genere –, sul quale egli si soffermarivelando caratteristiche strutturali al suo tempo ancoraben evidenziate, come i tre ordini di arcate di «ordine do-rico». E la stessa, plurisecolare, tradizione locale di studi21
potrà trarre qui spunti decisivi per una ricostruzione ideale,ad esempio, della scena («sarà lunga da quattrocentopalmi») e delle gradinate del teatro, che – calcola il Mas-simo – potrebbe ospitare diecimila spettatori.
Sagunto fu la causa determinante della seconda guerrapunica (218 a. C.): assediata, dopo otto mesi di eroica di-fesa, la città fu distrutta. Di questo episodio è memoria inun celebre motto latino risalente allo storico Tito Livio:«Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur», che pos-siamo tradurre con «Mentre a Roma si discute, Saguntoviene espugnata». Nel 212 fu recuperata e ricostruita daiRomani (e fu celebre per la produzione dei fichi e la fab-bricazione di vasi). Le invasioni barbariche la debilitarono
34
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
21 Vd. i riferimenti bibliografici in E. HERNÁNDEZ HERVÁS, El tea-tro romano de Sagunto, Valencia 1989, in particolare il capitoloquarto, pp. 53-55 («Historia del teatro»).
35
fatalmente e fu certo abbandonata dopo quelle saracene.La ‘conquista cristiana’ di Sagunto ebbe luogo nel 1239ad opera delle truppe guidate da Giacomo I il Conquista-tore, re di Aragona. A partire da allora datano gli edificicristiani; e Sagunto cambiò nome diventando ‘Morviedro’(nel 1877 fu ripristinato il nome antico di ‘Sagunto’: in ca-stigliano era ‘Morviedro’; in valenciano ‘Morvedre’– forsedal latino ‘muri veteres’; ma vedi anche più avanti la pro-posta etimologica di Carlo Camillo Massimo, al tempodella sua nunziatura apostolica in Spagna –).
Tra i moltissimi che, nei secoli XVI-XIX, hanno for-nito compiute descrizioni del teatro saguntino22, nessuno –per quanto mi consti – ha mai fatto cenno al già menzio-nato ordine architettonico con cui era costruito il teatro (siveda il passaggio relativo a «li portici, che lo circondano,di ordine dorico, ripartiti in tre ordini, l’uno sopra l’altro»)e alla presenza di una parte del portico dietro la scena. Ilteatro è adagiato sul pendio dell’acropoli con corridoi ri-cavati nella roccia e volte che sostengono la cavea, benconservata: la struttura è realizzata in opus cementicium erivestita in opus vittatum (muratura realizzata con bloc-chetti quadrangolari di pietra, disposti a strisce orizzon-tali; TAV. XXIX). Proprio Camillo è stato il primo a fornirele misure della scena e della capienza della cavea23.
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
22 Mi limito a rinviare alla Disertacion sobre et teatro y circo de Sa-gunto, ahora villa de Murviedro, compuesta por don E. PALOS Y NA-VARRO [...], En Valencia 1793.
23 Alla fine del Settecento dà le misure del teatro saguntino S. STRA-TICO, Dell’antico Teatro di Padova, In Padova 1795, «Si può calco-lare per approssimazione la capacità dell’antico Teatro di Padovadalle misure riscontrate col fatto delle sue vestigie. Il cerchio, la di cuimetà forma la base della gradinata, del portico e dell’orchestra ha il
36
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
Per inciso, colgo l’occasione per rammentare un fattostorico. Al tempo dell’occupazione napoleonica della Spa-gna (in tutta la penisola iberica ci furono insurrezioni po-polari) risale la seguente testimonianza relativa alla presadi Sagunto da parte degli Italiani guidati dal generale Giu-seppe Palombini24:
La presa di Sagunto [27 ottbre] è il migliore risultato della bat-taglia e ne ingrandisce la vittoria. Solo dopo di aver percorse lediverse opere che l’inimico ha elevato su quel masso di montesi può riconoscere il pregio di avere col guadagno di una bat-taglia conquistato una fortezza che ci avrebbe fatto spargeremolto sangue. Sagunto ben armata e approvvigionata diverràuna piazza imprendibile.
Proprio il teatro saguntino offre a Camillo Massimol’occasione di uno straordinario e imprevedibile confronto– che appare a noi tanto più significativo e singolare, nonfosse altro che per la folgorante puntualità della scelta tranumerose altre possibilità che il panorama dell’archeolo-gia italiana avrebbe potuto offrirgli –, che muta il quadro
diametro di piedi 250. Perciò assegnando ad ogni spettatore lo spaziodi piedi 2 poll. 4 in lunghezza, che è la misura per larghezza del gradonella scalinata, e di 18 pollici in larghezza, indi escludendo gli spazjdelle precinzioni, de’ vomitorj, delle scalette per il passaggio da unaprecinzione all’altra, la grossezza del muro che circonda il Teatroesternamente, ciò che la larghezza del podio supera quella de’ gradie le basi delle colonne del portico, risulta prossimamente che questoTeatro era capace di 6400 spettatori [...]. Il diametro di Sagunto eradi piedi 256, e perciò era della capacità all’incirca del Padovano».
24 Storia delle campagne e degli assedj degl’Italiani in Spagna dalMDCCCVIII al MDCCCXIII, corredata di piani e carte topografiche[...] da C. VACANI, Milano 1823, 167.
37
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
delle conoscenze storiche di un’altra colonia romana (TAV.XXX25), stavolta molto più vicina a noi: Terracina. Egliistituisce infatti un paragone tra il teatro di Sagunto equello di Terracina: ma, come è noto, la ‘riscoperta’ delteatro terracinese, in una zona congeniale della città alta,risale al 1957 e fino ad oggi gli studiosi sono stati indottia credere o a ritenere che in precedenza i resti di tale tea-tro giacessero sepolti e occultati sotto varie ‘ondate’ di in-terventi edilizi e che di esso, ad esempio in etàrinascimentale, si ignorasse addirittura non solo l’ubica-zione, ma anche l’esistenza. Ecco il testo della lettera(TAVV. XXXI-XXXIII)26:
All’abbate Michele Giustiniani Illustriss(imo) e reverendis-s(imo) sig(nor) mio osser(vandissimo).
Richiede la lettera di V. S. Illustriss(ima) che io corrispondaall’espressione del Suo affetto con rendimento di grazie et allacuriosità della notizia del mio viaggio col raguaglio, se non dicose impensate e nuove, almeno con le già note per fama. Et,perché la brevità di questa non può comprendere ciò che sa-rebbe sufficiente ad un volume, sodisfarò in parte all’erudizionedi V. S. Illustrissima et all’amore che Ella tiene verso le cose an-
25 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat.1564r, 89r. Traggo l’immagine da F. CASTAGNOLI, Le “formae” dellecolonie romane e le miniature dei codici dei gromatici, «Atti dellaReale Accademia d’Italia. Memorie della Classe di Scienze Morali eStoriche», s. VII, 4, 4 (1943), 83-118: 107-09 n° IV e Fig. 6 (ringra-zio Stefano Pagliaroli per avermi fatto dono di una rarissima copiadell’originale dell’estratto).
26 Lettere memorabili dell’abbate M. GIUSTINIANI [...], In Roma 1669,V8r-9v [= 471-474] n° XCVII («Di monsig. Camillo de’ Massimi, chie-rico di camera, patriarca di Gerusalemme e nuntio apostolico in Spa-gna»), poi in Della scelta delle lettere memorabili raccolte dall’abateM. GIUSTINIANI [...], In Napoli 1683: L4r-5v [= 247-50].
38
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
tiche col narrarLe solo quello che ho visto delle ruine dell’an-tico Sagunto, che furono ricompensate da quelle di Cartagine.
Sbarcato a Vinaros, spiaggia di Valenza, con buon caminosi passò a Morviedro. Questo nobil municipio era situato in unapianura di bellissima vista su la falda di un monte.
Hoggi ancora si vedono le vestigie di grandissime mura co-strutte di pietre quadrate di notabil grandezza, su le quali ap-poggiano li muri antichi moderni fattivi da i Mori, quandooccupavano la Spagna. Nella parte più alta del sito vi è una grantorre: solo la parte inferiore è antica, sostenuta da pilastri io-nici, et impropriamente chiamano il ‘Sepolcro di Hercole’. Po-trebbe essere il sepolcro di Zacinto, suo compagno, descrittoda Silio Italico in questi versi [Puniche, 1, 273-75]:
Haud procul Herculei tollunt se littore muri,clementer crescente iugo: queis nobile nomenconditus excelso sacravit colle Zacynthus.
Non lontano dal lido si levano le mura di Ercole,dove comincia l’erta: ad esse il nobile nomeconsacrò Giacinto, sepolto sulla cima del monte[traduzione di S. Pagliaroli]
Poco distante vi è un teatro, che chiamano ‘Colosseo’,mezzo rovinato: ma ancor si vedono i gradi, adattati al declivodel monte, et li portici, che lo circondano, di ordine dorico, ri-partiti in tre ordini, l’uno sopra l’altro. Il semicircolo sarà ca-pace di diecimila sedili. La linea retta della scena sarà lunga daquattrocento palmi: questa volge le spalle alla pianura, con-forme si vede nel teatro di Terracina. Il pulpito è quasi tutto inpiedi, come anco parte del portico dietro la scena.
Il resto della campagna è sparso di rovine di edificii rico-perti di verdeggiante ellere, che hanno dato cagione al nomemedesimo di ‘Morviedro’, quasi ‘Mura verdi’. Nelle modernecase si vedono murati molti fragmenti di statue togate, oltre aquelle che giacciono nel suolo sparso di vasi rotti, simili alla
39
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
terra cadmia, con lettere antiche spagnole e romane nel me-demo pezzo. Vi sono molte inscrittioni, ma per lo più de’ ‘duo-viri’ del municipio.
Vi è anche alla porta del luogo moderno una grande in-scrittione hebraica, che ignorantemente applicano a Salomone,in essa né pur nominato, et con eguale errore mostrano per idolile statue togate.
Nella chiesa dentro al castello posa sul pavimento (che perlunghezza tutto l’ingombra) un ariete antico, ch’è una trave dilegno tarmato, lunga da cinquanta palmi, che, diminuendosidalla testa di Montone (che ‹è› grosso sei palmi), a guisa di pi-ramide finisce in due palmi. Dalla cima al fondo è traforata e vipassa un canapo di materia, come di seta, grosso mezzo palmo,che viene raccomandato nel collo della testa del montone a tretravetti di ferro, l’uno quadro, grosso un palmo, posto nelmezzo con l’incassatura similmente di ferro in forma di croce,e gl’altri due tondi, grossi mezzo palmo l’uno. Vi sono puranche molti altri travetti e perni di ferro che dovevano esseredel restante della macchina, che hora non vi è più.
Anderò osservando in altre parti gl’altri oggetti di erudi-zione per appagare l’animo di V. S. Illustrissima, la quale sa va-lersene per base delle scienze più gravi che L’adornano. E restobaciandoLe divotamente le mani. Valenza, 13 di marzo 1654.
Di V. S. Illustrissima e reverendiss(ima) devotiss(imo) ser-vitore, Camillo, patriarca di Gerusalemme.
Ma c’è di più: a confermare l’esistenza di cospicui esuggestivi resti del teatro romano di Terracina al tempo delMassimo parrebbe intervenire un’altra lettera dello stessoCarlo Camillo, anch’essa completamente trascurata, indi-rizzata al Bellori il 30 aprile 1661, dunque durante il pe-riodo della ‘cattività’ rocchigiana.
Il Bellori, come è ben noto, in quel momento stava vi-sitando Napoli e dintorni al seguito del ‘consigliere’ del re
40
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
di Francia il «S(ignor) di San Lorenzo» (Jean-Patrocle Pa-risot; TAV. XXXIV)27:
Al signor Bellori.Hoggi ricevo l’eruditissima lettera di V. S. con le notizie
curiose delle antichità viste e tanto più mi è stata grata, quantola considero prossima a lasciarsi goder qui nel ritorno da Na-poli, poiché la curiosità del S(ignor) di San Lorenzo, havendovisto la parte interiore del Latio, non vorrà lasciare di vedere an-cora quest’altra più nobile per la via Appia e per diverse altrememorie che la rendono curiosa al pari della maggiore brevitàper il ritorno a Roma.
In Terracina vi è un theatro antico con la scena assai con-servata; seguono le vestigie di quella gran via uguagliata con in-numerabili archi all’uso de’ ponti. Si vedono ancora le vestigiedel Foro Appio e sul mare la favolosa habitatione di Circe.
Presso a Piperno le rovine della villa di Seiano con unagrandissima conserva d’acque intiera, arcuata sopra a pilastri,e nel piano li vestigi dell’antico Priverno; e, se V. S. si dispo-nesse di far honorare questo luogo dal detto S(igno)re di San
27 Roma, Archivio di Palazzo Massimo, Registro 276, 471r. Un’edi-zione provvisoria è nell’utile lavoro del MARZOCCHI, “Facere biblio-thecam in domo”..., 591-92, dal quale mi sono distanziato nei seguenticasi (mia la lezione che precede): «uguagliata] om. Marz.», «Seiano]Sciano Marz.», «intiera, arcuata] om. Marz.», «Metabo] MetauroMarz.», «Amaseno] Amasseno Marz.», «da suveri] om. Marz.», «non]ma Marz.», «disporvisi] disporvici Marz.», «temo] terro Marz.», «onon Le] om. Marz.», «o~mani] om. Marz.». Migliore l’edizione dellaBEAVEN, An ardent..., 414 n° 50, dove si correggano le seguenti svi-ste: «dal] da Beaven», «Metabo] metallo Beav.», «suveri] sugheriBeav.», «violentarla] volentarla Beav.», «Rocca Secca] RoccaseccaBeav.». Ringrazio Stefano Pagliaroli per aver allestito la presentenuova edizione dell’importante lettera e per avermi anche procuratol’immagine digitale dell’originale da lui scattata in loco (vd. supra, 23n. 7).
41
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
Lorenzo, haveriamo anche che mostrargli li monti ricettacolidel fuggitivo Metabo, molti nobili acquedotti, oltre al fiumeAmaseno con le ripe ombrate da suveri, celebrato da Virgilio.Ben credo che V. S. sarà stanco di vedere il lago Averno, ilmonte Miseno, il ponte di Caligola e le altre famose memoriedell’antichità: ma forse havrà miglior albergo qui che in Pi-perno, dove ho ordinato che, giungendovi V. S., subito me loavvisino per violentarla a salir questo monte: non perché iodubbiti che la sua gentilezza non sia per disporvisi il S(ignor)di San Lorenzo, ma perché temo che questa lettera o non Legiunga in tempo o si smarrisca. E senza più a V. S. bacio lemani. Rocca Secca, 30 aprile 1661.
Anche questa seconda testimonianza riveste un valoreeccezionale. Il paesaggio archeologico, con il suo retag-gio di arcaiche suggestioni, rimane limpidamente deli-neato dalla penna del Massimo, come quegli«innumerabili archi all’uso de’ ponti»: e si pensi a ben noteruinae di tal genere proprio nei pressi di Terracina. Inte-ressante la menzione delle «vestigie del Foro Appio»: doveè facile constatare che il Massimo, come tutti i suoi con-temporanei e predecessori umanistici e rinascimentali28,ignorava di quella località, sommersa sotto i fanghi dellapalude, l’esatta ubicazione (che appare qui molto più pros-sima a Terracina di quanto non sia realmente); così comeera praticamente d’obbligo la menzione della «favolosahabitatione di Circe», cioè del promontorio Circeo.
Per quanto concerne il territorio della limitrofa Pri-verno – che il Massimo, da Roccasecca, poteva ammirarein tutta la sua vastità –, egli fa menzione delle «rovinedella villa di Seiano» (attuale colle Sant’Ermo; TAV.XXXV), che compaiono anche nella coeva Oratio del no-
28 FAVONII LEONIS PRIVERNATIS De laudibus..., 183.
42
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
taio privernate Favonio Leo29, oltre che dei «vestigi del-l’antico Priverno» che si trovano «nel piano»30. Il celeber-rimo racconto virgiliano del «fuggitivo Metabo», re deiVolsci, e della figlia Camilla e del fiume Amaseno si ag-giunge a impreziosire l’ameno quadro paesaggistico e sto-rico-culturale ‘dipinto’ da Carlo Camillo (e mi premeavvertire che la toponomastica dei monti vicini a Privernoè tuttora ricca di perspicui rimandi a queste antiche leg-gende: a Roccasecca dei Volsci, nei pressi della localitàdenominata ‘La Lucerna’, la volta di una sostruzione inopus incertum di epoca romana reca il nome suggestivo di‘Grotta della Camilla’).
Ma, tornando al teatro di Terracina, è per noi straordi-naria la testimonianza dell’esistenza di una «scena assaiconservata» (TAV. XXXVI), addirittura negli anni 1654-1661. Di essa saremmo stati indotti a dubitare, se ci fos-simo basati sugli studi precedenti il 1957: che del teatro –come ho avuto già occasione di rammentare – non ave-vano potuto accertare né l’esistenza né l’ubicazione. Sipensi alla grande e fondamentale monografia dedicata allastoria di Terracina da Domenico Antonio Contatore: il Dehistoria terracinensi, pubblicato a Roma nel 1706, con-tiene infatti una sezione intitolata «De theatris terracinen-sibus»31, nella quale l’autore perlustra, quasi dispe-ratamente, tutti i dintorni della città (compreso il tempio diGiove ‘Anxur’) alla ricerca di ogni traccia archeologica
29 FAVONII LEONIS PRIVERNATIS De laudibus..., 181-82.30 FAVONII LEONIS PRIVERNATIS De laudibus..., 103 n. 1; PAGLIA-
ROLI, Una visita..., 14-15 e Il ‘castellum’..., 185-92.31 De historia terracinensi libri quinque, auctore perillustri ac excel-
lentissimo domino D. A. CONTATORE, Romae 1706, Rr3v-Ss1r [= 318-21].
43
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
riconducibile ad antichi edifici con possibile destinazione‘teatrale’ (TAV. XXXVII).
Ma non è qui il caso di indugiare su questa nobile eben nota tradizione di studi, che a partire dal solito arche-tipo umanistico dell’Italia illustrata di Biondo Flaviostende le sue propaggini fino al Novecento inoltrato, pas-sando per l’immancabile fra’ Leandro Alberti (dove si notiil riferimento, a mio giudizio errato, al «theatro quadro,appresso il monastero di S. Angelo»; TAV. XXXVIII)32:
Oltre a Terracina, seguitando la via Appia, ritrovassi l’ultimaporta della città, posta fra il mare et l’altissima rupe: luogo in-vero molto stretto et forte, tagliato co’l ferro. Et ivi nel sasso al-quanto alto vedesi una habitatione artificiosamente cavata, ovedimorano alcuni per guarda de’l stretto luogo: addimandano glihabitatori del luogo questa la ‘Rocca della Città’. Sì come ioposso congieturare questo è quel luogo di cui dice Livio nelventesimo primo libro, ove fu mandato Minutio da Fabio Mas-simo dittatore per fortificarlo, ch’era sotto Terracina et sopra ilmare, acciò non potesse passare Anniballe per la via Appia perandare a saccheggiare il territorio di Roma. Sopra lo gibbo deldetto monte scorgiesi un theatro quadro, appresso il monasterodi S. Angelo, ch’è vicino al detto aspero monte. Benché io hab-bia veduto molti theatri et amphitheatri, così nell’Italia, comeetiandio fuori, non però ho mai veduto lo simile a questo.
Tre secoli più tardi, alla metà dell’Ottocento, nel 1846,anche il famoso architetto e incisore Luigi Rossini – giàautore del famoso Viaggio pittoresco, nel quale sono ospi-tate alcune sue importanti illustrazioni dei luoghi più ca-
32 Descrittione di tutta Italia, di f. LEANDRO ALBERTI [...], In Bolo-gna 1550, V4v-V5v [= 120v-121v]: V5v [= 121v].
44
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
ratteristici di Terracina (TAV. XXXIX a-b33) e dei suoi din-torni – dedicava alla città tirrenica un affascinante scritto34,che abbiamo ritenuto opportuno riportare integralmentequi in appendice (60-65).
Ma, dovunque si rivolga lo sguardo alla ricerca di ap-pigli o di conferme, rimane singolarissima la notizia diCarlo Camillo Massimo, e parrebbe non trovare l’egualeneppure tra i più immediati suoi contemporanei. Si pensi aun osservatore acutissimo e curiossimo come il grande JeanMabillon35, che, passando per Terracina, ne censì tutti i fatti
33 Quasi incredibile – e oggi praticamente caduta nell’oblio – la vi-cenda che ha interessato l’illustrazione n° LXXII del menzionatoViaggio pittoresco da Roma a Napoli colle principali vedute di am-bedue le città, delle campagne e dei paesi frapposti, disegnate dalvero ed incise da L. ROSSINI, architetto [...], Roma [c. 1839], nellaquale si legge la seguente didascalia: «Porta della città di Beneventonel Regno di Napoli, in oggi del papa». In realtà, come dimostrato daG. LUGLI, I monumenti romani nelle incisioni di Luigi Rossini, «Ca-pitolium», 8, 10 (ottobre 1932), 469-84: 481-82, si trattava precisa-mente della porta d’ingresso alla città di Terracina (lo stesso Luglinotò le notevoli affinità tra questa e una celebre incisione della portaterracinese eseguita precedentemente da Carlo Labruzzi).
34 Pubblicata in L. ROSSINI, Intorno ad alcune antichità di Terra-cina. Al chiarissimo sig. cavaliere Giovanni de Angelis, «Album.Giornale letterario e di belle arti», 13 (1846), 226a-27b e in Letteradel signor prof. L. ROSSINI, architetto, incisore, al sig. dottor Braun,«Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica», (ottobre1846), 145-48. Vd. anche Monumenti dello Stato Pontificio e rela-zione topografica di ogni paese. Opera di G. MAROCCO, VI, Roma1836, 140-52; Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s.Pietro sino ai nostri giorni [...]. Compilazione del cavaliere G. MO-RONI [...], LXXIV, In Venezia 1855, 151a-211a.
35 Iter italicum litterarium dom IOHANNIS MABILLON et dom MI-CHAELIS GERMAIN [...] annis MDCLXXXV et MDCLXXXVI, LuteciaeParisiorum 1687, N2v-3r [= 100-01].
45
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
d’interesse storico-culturale, oltre che di costume – comeha recentemente mostrato Stefano Pagliaroli36 –, rilevando,in una realistica battuta conclusiva, che le esalazioni infettee malariche della vicina Palude debilitavano la popolazionelocale: «Miserabile spectaculum est videre illius loci opi-danos cadaverosa omnes facie, etiam iuvenes adolescenteset teneras puellas: haud dubie ex aeris contagio [È uno spet-tacolo tristissimo vedere che gli abitanti di quel luogohanno tutti visi cadaverici, anche ragazzi adolescenti e te-nere fanciulle: senza dubbio a causa dell’aria contagiosa(traduz. di S. Pagliaroli)]».
Quanto finora esposto torna a grandissima lode dellecapacità di analisi dell’illustre prelato, che nel periododella sua permanenza a Roccasecca ebbe occasione di af-finare i suoi giudizi estetici sull’amata antichità, che po-teva rivivere visitando il suo feudo e le località limitrofe.E, come si avrà modo di precisare subito nella parte con-clusiva del presente studio, oggi, con l’ausilio di imma-gini aeree (TAV. XL) e di strumentazioni di analisitopografica molto avanzate, è facile notare che gli edificicresciuti nel tempo sui margini dell’antico teatro terraci-nese hanno fondamentalmente rispettato l’andamento cur-vilineo del suo emiciclo (TAV. XLI)37: edifici che, standoalmeno alle parole del Massimo, dovevano affacciarsi alsuo tempo su una «scena assai conservata» (TAV. XLII).
E certo al suo acuto spirito di osservazione poté ba-stare anche lo scorcio di una gradinata – riemersa, come lapossiamo oggi ammirare, dagli scavi (TAV. XLIII) – per
36 PAGLIAROLI, Una visita..., 19. 37 Vd. anche infra, 73-78: 76, la pionieristica e suggestiva analisi
di Sabatino Moscati, che mi è stata segnalata da Stefano Pagliaroli.
46
CARLO CAMILLO MASSIMO E I TEATRI ROMANI DI SAGUNTO E DI TERRACINA
leggere ‘filologicamente’ il contesto urbano ed edilizio delcuore della città di Terracina e per immaginare di esseretornato per un momento in quella età remota, nella qualefurono integri e frementi di spettatori i due teatri romani diTerracina (TAV. XLIV: dove si noti l’andamento curvili-neo, al quale ho già fatto riferimento, degli edifici sullosfondo) e di Sagunto (TAV. XLV).
CONCLUSIONE
Ma veniamo, finalmente, a noi. Le prime notizie certe con-cernenti l’esistenza di un teatro romano di Terracina risal-gono, come ho avuto occasione di rammentare, alla metàdel XX secolo, cioè a circa sessanta anni fa, al tempo dellaricostruzione degli edifici abbattuti nel corso della Se-conda Guerra Mondiale (il bombardamento da parte delleforze aeree americane ebbe luogo il pomeriggio del 4 set-tembre 1943 e distrusse anche buona parte del centro sto-rico). Si legge al riguardo in un’autorevole guida38:
Talune strutture murarie conservate presso la Piazza di PortaNuova subito a Nord del Capitolium, e precisamente alcunitratti di tre muri curvilinei romani concentrici, e l’andamentogenerale curvilineo dei fabbricati moderni della zona induconoa sospettare che esistesse un antico teatro. Solo approfonditi enotevoli lavori di saggio o di scavo potranno mutare in certezzaquella che sinora è verosimile induzione.
Da tenere invece distinta la presenza di un anfiteatroposto in pianura39:
Poco ci resta del monumento, ma questo poco è sufficiente perpoterne integrare la pianta. La muratura in reticolato di buona
38 S. AURIGEMMA-A. BIANCHINI-A. DE SANTIS, Circeo, Terracina,Fondi, Roma 1957, 28 (a pag. 29 fig. n° 8 un rilievo basato su taleipotesi dell’esistenza di un teatro romano).
39 BIANCHINI, Storia..., 378. I resti sono tuttora visibili in via Mar-tucci.
48
CONCLUSIONE
fattura, con tessere piuttosto piccole di pietra locale, consentedi datare l’edificio al primo secolo dell’impero. L’asse mag-giore dell’edificio è di m. 90 ed il minore di m. 68.
Ma, ripeto, anche in età rinascimentale e anche in se-guito, nessuno ha mai fatto cenno al teatro romano terra-cinese. Né possedette di esso alcuna notizia l’architettoBaldassarre Peruzzi (1481-1536)40, che ebbe modo diesplorare personalmente la città, lasciando importantissimiappunti e rilievi archeologici concernenti il Foro di Terra-cina (ivi, del teatro romano, non c’è alcuna traccia). Ma èinfinita la schiera dei viaggiatori, storici, cartografi, poeti,pittori – grandi, minori, minimi; illustri e sconosciuti –che, tra il XVI e il XIX secolo hanno lasciato testimo-nianze concernenti Terracina: anch’essi senza mai fare laminima menzione di un teatro romano.
Come ho già avuto modo di accennare, le indagini ar-cheologiche tuttora in corso41, mostrano che il teatro ro-
40 Per cui mi limito ai seguenti riferimenti bibliografici: Baldas-sarre Peruzzi. Pittura, scena e architettura nel Cinquecento, a curadi M. FAGIOLO e M. L. MADONNA, Roma 1987; C. TESSARI, Baldas-sarre Peruzzi. Il progetto dell’antico, Milano 1995; Baldassarre Pe-ruzzi. 1481-1536 [...], Milano 2005 (in particolare il contributo di A.C. HUPPERT, Baldassarre Peruzzi as archaeologist in Terracina, 213-23). Il Peruzzi – per inciso – fu anche progettista di Palazzo Mas-simo alle Colonne.
41 Il paziente recupero del teatro romano di Terracina, che prose-gue a singhiozzi ormai da parecchi lustri tra mille difficoltà burocra-tiche ed amministrative, si deve anche alla preziosa opera delladottoressa Nicoletta Cassieri, funzionario della Soprintendenza Ar-cheologica per il Lazio, che da anni si adopera per valorizzare l’areaarcheologica; per cui si veda l’importante saggio: N. CASSIERI, Le in-dagini nel complesso del teatro-portico di Terracina, ne Il teatro ro-mano di Terracina..., 509-25.
TAV. XXXIV Roma, Archivio di Palazzo Massimo, Registro 276, 471r: let-tera di C. C. Massimo del 30 aprile 1661 con l’invito rivolto all’amico Gio-van Pietro Bellori a visitare la città di Terracina e altre località vicine aRoccasecca (vd. p. 40).
TAV. XXXV Priverno, Archivio privato Silvio Barsi: rovine della cosiddetta‘Villa di Seiano’ in località Colle Sant’Ermo (vd. p. 41).
TAV. XXXVI Terracina, sito del teatro romano: particolare della scena, con muro in o
pus
retic
olat
ume base di colonna (vd. p. 42).
TAV. XXXVIII ‘Ricostruzione’ del tempio di Giove proposta alla fine dell’O
ttocento dall’archeologo Pio
Capponi (da S. V
INDITTI, T
erra
cina
. Pae
sagg
io e
legg
ende, Foligno 1901; vd. p. 43).
TAV. XXXIX a L. ROSSINI, Viaggio pittoresco, illustrazione n° LXXII:«Porta della città di Benevento, nel Regno di Napoli, oggi del Papa»: si tratta,in realtà, della porta d’ingresso a Terracina, come precisato da GiuseppeLugli nel 1932 (questi fece notare come il Rossini ebbe forse presente unprecedente disegno di Carlo Labruzzi: XXXIX b) (vd. p. 44 e n. 33).
TAV. XL Terracina, foto aerea scattata pochi anni dopo il bombardamentodel 1943: in puntinato l’area di sedime del teatro romano, che verrà indivi-duato soltanto nel 1957 (vd. p. 45).
TAV. X
LI Latina, Archivio di Stato, Im
poste Dirette, M
appa n° 1574: Terracina (su concessione del Ministero per i B
enie le A
ttività Culturali; vd. pp. 45 e 52).
TAV. XLII Terracina, sito del teatro romano: particolare della scena con capitello dorico riverso,
base di colonna e muro in o
pus r
etic
olat
um(vd. p. 45).
TAV. XLIII Terracina, sito del teatro romano: edifici di epoca medievale emoderna sorti sulla gradinata (vd. p. 45).
TAV. XLIV Terracina, sito del teatro romano: panoramica degli edifici costruiti sopra la c
avea; oltre la casa medievale
con bifora, si nota lo sviluppo curvilineo delle abitazioni che seguono il perim
etro del teatro (vd. p. 46).
TAV. XLV
I Terracina, sito del teatro romano: a
ditu
sorientale con muratura in o
pus
ince
rtum
(vd. p. 49).
TAV. XLVII Terracina, sito del teatro romano: casa costruita sulla scaenautilizzando nella muratura una colonna scanalata (vd. p. 50).
TAV. XLV
III Terracina, ruderi del teatro inglobato nel fabbricato curvilineo costruito sulle
sue fondamenta, nella zona della summa
cave
a(vd. p. 50).
TAV. X
LIX Terracina, area del portico del teatro rom
ano con frammento di colonna scanalata (vd. p. 50).
49
CONCLUSIONE
mano di Terracina, durante i secoli, è stato oggetto di in-cisivi restauri e riadattamenti. Il primo impianto del teatro,in opus incertum (TAV. XLVI), è di età tardo-repubblicana:ed è considerato il primo teatro romano in muratura nelLazio (tale primato era detenuto dal teatro di Pompeo (55a. C.; l’emiciclo raggiungeva il diametro di 160 metri epoteva ospitare con 27000 spettatori; l’edificio, isolato echiuso, esibiva all’esterno una possente struttura architet-tonica a tre ordini che sosteneva la cavea). In precedenzai teatri erano realizzati in legno (ed erano spesso ancheconsiderati luoghi pericolosi di aggregazione popolare evalutati negativamente per gli influssi deleteri che pote-vano esercitare sui giovani). In seguito il teatro ebbe al-l’interno della città una funzione sociale più consistente: disvago, certo, ma connessa con la cultura e la religione,oltre che con la propaganda politica (si pensi alle effigi dipersonaggi più o meno celebri o ambiziosi che lo decora-vano nelle zone di maggiore visibilità).
Durante il periodo imperiale, tra Augusto e Tiberio, ilteatro di Terracina subì alcune trasformazioni architetto-niche, seguite da ulteriori restauri in età flavia e da unamassiccia ristrutturazione in età severiana: sviluppò il pro-prio carattere monumentale, in perfetta consonanza con igusti e le attitudini di quell’età. A partire dal IV secolo peròincomincia il declino di questo genere di istituzione: in-curia, ostilità ideologiche e religiose, periodi di grande po-vertà, mancanza di manutenzione fecero sì che decadesse,anche tra la popolazione, ogni interesse per gli spettacoliteatrali. Questi enormi edifici divennero vere e proprie‘cave’ esposte ad ogni genere di furto e spoliazione; e aTerracina, con ogni probabilità, durante il VI secolo, altempo della Guerra Gotica, il teatro dovette subire un de-vastante incendio, con conseguenti crolli e il totale ab-
50
CONCLUSIONE
bandono dell’area. Molte colonne dei portici furono uti-lizzate in altri contesti edilizi (TAV. XLVII); e, forse, ancheper decorare la sede vescovile di San Cesareo.
Una sicura peculiarità del teatro terracinese è la suaposizione sul pendio della collina: la probabile summacavea è celata dalle successive costruzioni medioevali emoderne ed è pertanto estremamente difficile immaginarese sarà mai possibile recuperare parti della sua strutturaoriginaria (TAV. XLVIII). Gli ultimi risultati degli scavi ar-cheologici consistono nel ritrovamento di un basamentodi colonna che conferma l’esistenza di una porticus postscaenam quadrangolare colonnata (TAV. XLIX), con laparte centrale scoperta (una restituzione grafica è stata ese-guita dal dottor Maurizio Marchetti; TAV. L42).
Quali affinità possono essere ipotizzate tra il teatro diTerracina e quello di Sagunto (TAV. LI)? Anche il teatro diTerracina poggia in effetti la cavea sul declivio rocciosodella collina, adattandosi all’orografia del terreno, comequello spagnolo; ancora, il palcoscenico ed il portico di Ter-racina sono collocati nella parte pianeggiante, accanto alForo Emiliano, diviso da quest’ultimo dal percorso dellavia Appia; inoltre, il portico che era dietro la scena in am-bedue i teatri. Per quanto concerne la cavea (o gradinata)del teatro di Sagunto, essa aveva tre ordini di posti: lostesso, spero, potrà essere dimostrato per il teatro di Terra-cina. Ancora, il teatro di Sagunto, come credo quello di Ter-racina, non fu pensato come un ‘teatro alla greca’, aperto
42 Vd. N. CASSIERI, Terracina: ricerche nell’area del teatro romano,in Studi in onore di Arturo Bianchini, Atti del 3° Convegno di studistorici sul territorio della provincia, Terracina, 26 novembre 1994,presso Villa comunale ex Tomassini, Formia 1998, 349-71: 370 Tav.I (disegno a cura di M. MARCHETTI, del quale vd. ibid. l’appendice Ilteatro romano di Terracina: analisi architettonica, 359-61).
51
CONCLUSIONE
sul paesaggio sottostante: al contrario, anche per difficoltàdi illuminazione e di acustica che potevano insorgere al-l’interno della struttura, aveva davanti alla cavea, attorniatada alti portici a più ordini architettonici, una barriera visivacomposta dalla scena, con alle spalle appunto il portico43.
Le relazioni delle due città, con i propri teatri romani,sono state, comunque, profondamente diverse, perché in-fluenzate dalle dissimili particolarità orografiche, storicheed urbanistiche dei loro centri urbani. L’area del teatro ro-mano di Sagunto si è salvata in quanto utilizzata per scopimilitari sin dall’antichità: era uno spazio adatto per racco-gliere e radunare i soldati; inoltre il monumento, a livellotopografico, è sito extra moenia ed è ‘schiacciato’ tra l’an-tistante città e un castello fortificato alle spalle.
A Terracina la situazione storica ed urbanistica è di-versa. L’area teatrale è inglobata al centro storico, all’in-terno delle mura civiche. La vicinanza della sedevescovile, della cattedrale di San Cesareo, del castelloFrangipane (o Rocca Traversa), della sede del Comune, harichiesto l’ingiusto sacrificio della zona archeologica perdare spazio all’espansione urbanistica dell’area.
Le costruzioni a monte del Foro Emiliano, contiguealle mura cittadine, hanno infatti seguito l’andamento cir-colare del teatro romano: questo dato architettonico è vi-sibile già ad occhio nudo, ma risulta anche dalleplanimetrie catastali e da foto aeree o satellitari. La letteraal Bellori certifica, a mio personale giudizio, la visibilitàarchitettonica di una parte del teatro romano nella metà
43 Purtroppo, il crollo del portico terracinese, dovuto ad eventi natu-rali, ai saccheggi ed incendi del periodo medioevale, il riempimentodella cavea con materiali di scarto durante i secoli, le costruzioni ditorri e di case nell’area monumentale, hanno tenuto celato per secoli ilsito del teatro, sino ai bombardamenti della seconda guerra mondiale.
52
CONCLUSIONE
del Seicento e soprattutto della scena, allora in buono statodi conservazione. Nell’area era probabilmente anche rico-noscibile una parte del portico, perché la sede del Comunenon era ancora stata costruita44 (tale sede, come è noto, fudistrutta da un bombardamento nel 1943). E aggiungeròche, dopo aver esaminato varie planimetrie catastali no-vecentesche (in particolare la mappa urbana di Terracinaoggi conservata a Latina, Archivio di Stato, Imposte Di-rette di Latina, Mappa n° 1574: vd. qui supra, 51, e TAV.XLI), ho maturato la convinzione, sulla base della fisio-nomia urbanistica di quell’area, che parte dei ruderi delteatro (come appunto la scena) potevano in effetti esserevisti da diverse angolature: dalla centrale piazza Urbano II,dalla via Celia Macrini, da via dell’Archetto, da via dellaPalma e da vicolo delle Palme. La piazza e le strade citate– coinvolte dai già menzionati bombardamenti (come viaSalita Castello, via Porta Nuova, via della Scifa) – eranoesattamente poste nell’area che interessava la scena e lacavea, come è possibile rilevare esaminando il fascicoloDistrutti di Terracina presso il medesimo Archivio di Statodi Latina. E personalmente mi domando se lo stesso topo-nimo di via dell’Archetto – questa via congiungeva piazzaUrbano II a via della Palma, che tagliava perpendicolar-mente il centro del teatro – non possa ricondursi all’anticapresenza di un arco (evidenziato anche dalla restituzionegrafica della mappa) che facesse parte della vastissimacompagine del teatro romano terracinese (una galleria, unelemento della cavea, vomitoria?).
A Terracina, nei precedenti scavi, ma anche in quellipiù recenti, sono state rinvenute pareti intonacate, fram-
44 Vd. Lettera... e Dizionario, 161b.
53
CONCLUSIONE
menti di basi, decorazioni, capitelli, colonne, statue, epi-grafi ed altri materiali che documentano la magnificenzadel teatro. Le indagini archeologiche in corso e quelle fu-ture avalleranno la testimonianza misteriosa e affascinantedi Carlo Camillo (TAVV. LII-LIII)? Non escluderei che ilMassimo, esperto e competente nel disegno, possa averpure realizzato alcuni schizzi di parti architettoniche delteatro, che spero, con l’aiuto della Dea Bendata, di poterindividuare, custoditi e ‘dispersi’, in qualche archivio.
POSTFAZIONE
Tevlo~ su;n Qew/
Il 9 gennaio 2012 l’amico Giuseppe Papi ha voluto sotto-porre alla mia attenzione e alla mia lima l’originaria ste-sura, che gelosamente e amichevolmente conservo (e maifuturo opusculum fossanovense fu fin da subito destinatoa più miracolosa avventura editoriale), della sua concisanotitia sui teatri romani di Terracina e di Sagunto. Nonposso che salutare con gratitudine l’ingresso di questaestrema ‘tessera’ nel ‘mosaico’ di contributi di varia eru-dizione che hanno arricchito l’attività culturale del “Cen-tro Studi Fossanovesi”; una tappa che, tra l’altro, segna unimportante avanzamento nella carriera letteraria di Giu-seppe Papi (per il cui più che trentennale curriculum, cheometto qui di ripercorrere, si rimanda ai lavori già citatipiù su a p. 21 n. 4 e nel risvolto di copertina).
Venendo a noi, è ammirevole la capacità dello studiosodi valorizzare, con entusiasmo e dedizione, dettagli sto-rico-culturali del nostro territorio.
Certo, non mi nascondo come la ricerca di difficili ve-rità storiche si alimenti di continui dibattiti: e, sapendo che,in questo, l’autore consente fermamente con me, credo siaqui opportuno, non dico munire un po’ la strada a questasua ricerca, ma almeno prescriverle un antidoto contro al-cune possibili asperità, che potrebbero angustiarne la so-pravvivenza nella repubblica delle lettere pontine. Delresto, lo stesso Giuseppe Papi è ben consapevole dellagrande eco che, senza dubbio, seguirà alla pubblicazionedi questa sua ‘audace’ proposta storiografica. Anzi, è pro-
56
POSTFAZIONE
prio su suo suggerimento che aggiungo qui alcune notepostfative a conclusione della sua ricerca, e a preventivocontraltare, ripeto, di eventuali detrazioni o polemiche pre-testuose (del celebre Zoilo, come la storia insegna, Apollonon gettò mai via lo stampo). E, ancora, lo stesso GiuseppePapi sa che la parrhsiva, la disinteressata e sincera libertàdi parola è tipica dell’atmosfera fossanovese e del caratteredei suoi abitanti: migliore e sopravvissuta eredità di altritempi dello Stato Pontificio. Dunque, il teatro romano diTerracina. Ma cosa dicono i nudi fatti? Vediamoli in ra-pida successione e sine ira et studio.
La tradizione degli studi storici terracinesi – promossie condotti da autori sia ‘esterni’ sia ‘interni’, e talora ad-dirittura ‘intimi’, alla città – si stende uniforme a partiredalla metà del Quattrocento, con Biondo Flavio, fino acongiungersi agli ultimi risultati critici di più recente pub-blicazione; e popola quel lungo arco temporale una folla dinomi illustri (mi tornano ora in mente Leandro Alberti,Domenico Antonio Contatore, Luigi Rossini, Marie-Renéde la Blanchère: ma sono certo di averne dimenticati mol-tissimi altri). A questa plurisecolare tradizione di studi nonsolo è mancata la soddisfazione di sperimentare il ritrova-mento materiale di un teatro dentro Terracina (sito, comeora sappiamo, proprio al centro della attuale città alta), maanche di imbattersi in qualunque segno o indizio, che neadditasse o certificasse, in qualche epoca o in qualcheforma, anche la sola esistenza in loco. Ora, cosa si ricavadalle due lettere di Carlo Camillo Massimo ripubblicateda Giuseppe Papi?
La lettera del 1654 è scritta e spedita dalla Spagna e,stando al dettato concreto del suo contenuto, Terracina rap-presenta in quel momento per il Massimo niente più che unrapido e fugace termine di paragone: la lettera, infatti, se
57
POSTFAZIONE
è importantissima per la quantità di informazioni che for-nisce a proposito del teatro romano saguntino (e, certo,d’ora in poi gli studiosi spagnoli non potranno più ignorarequesto singolare documento), a Terracina, come è facileconstatare, essa dedica soltanto un rapidissimo cenno,come appunto spesso accade al secondo e fugace terminedi un paragone.
Quale esperienza diretta o cognizione il poco più chetrentenne Carlo Camillo potesse avere nel 1654 del ‘pa-norama’ archeologico di Terracina, sarebbe, mi pare, unquesito degno di essere posto. E, a questo proposito, miauguro che ulteriori indagini archivistiche – che lo stessoGiuseppe Papi promette – possano produrre prove, se nondi visite a Terracina del Massimo durante gli anni del suoesclusivo tirocinio romano, almeno di contatti epistolari odi scritture di altra natura che documentino sue amicizie orelazioni con esponenti della cultura locale o comunquesue curiosità erudite concernenti i complicati e disastratiresti edilizi di epoca romana sepolti e confusi, entro lemura di Terracina, sotto invasivi strati di culture e civiltàsovrappostesi e succedutesi a partire dalla tarda antichità(culture, come è noto, spesso del tutto indifferenti alla con-servazione dell’antico, se non fiere e orgogliose di di-struggerlo assimilandolo e riciclandolo).
In una parola: che cosa poteva conoscere nel 1654 ilMassimo di un teatro ignoto (per quanto ad oggi si sappiao sia stato possibile accertare) a tutti i suoi predecessori econtemporanei (e successori)? E non sarà che, più sem-plicemente, egli, magari anche per averne sentito discor-rere entro le più elette cerchie dell’antiquaria edell’erudizione romana di metà Seicento (nelle quali ilMassimo appare pienamente e proficuamente inserito inquegli anni), non potrebbe essere, dicevo, che egli fosse a
58
POSTFAZIONE
conoscenza dell’esistenza dei resti di quel vistoso monu-mento collocato sulla cima del monte che sovrasta Terra-cina, a proposito del quale un suo celeberrimo con-temporaneo, Athanasius Kircher (1602-1680), scriveva(come già fra’ Leandro Alberti un secolo prima di lui)45:
Omnia circumsita loca antiquis aedificiorum ruderibus plenasunt et inter caetera ibidem in monte vicino iuxta monasteriumS. Angeli nobile theatrum se spectandum praebet, cui vix par inItalia facile reperias
Tutti i luoghi che sono intorno [a Terracina] sono pieni di rovine diedifici antichi e tra gli altri, lì su un monte contiguo, nei pressi delmonastero di Sant’Angelo, si offre alla vista un insigne teatro, delquale difficilmente in Italia troveresti l’equivalente
E sulle orme del lavoro del Kircher (vero e proprioBaedeker per l’epoca) non poteva non muoversi il Conta-tore, il quale, sulla base di meticolose ricerche locali, iden-tificava anche lui quei fastosi rudera romani con il sito diun antico teatro46:
supra apicem montis Terracinae imminentis (vulgo ‘Il monteS. Angelo’) illud [...] celebre theatrum conspicitur
45 ATHANASII KIRCHERII Latium id est Nova et parallela Latii tumVeteris tum Novi descriptio [...], Amstelodami 1671, D1rb-va: D1va[25b-26a: 26a]. Per quest’edizione, presente nella biblioteca del Mas-simo, vd. MARZOCCHI, “Facere Bibliothecam in domo”..., 160 n°1095 e n. 286 (e 410-11 n° 1095); per altre opere del Kircher posse-dute da lui: 131 n° 264 e n. 88 (e 212 n° 264), 145 ni 669-70 e n. 173(e 304 ni 669-70), 160 n° 1090 e n. 283 (e 409 n° 1090), 160 n° 1096e n. 287 (e 411 n° 1096), 173 n° 1472 (e 487 n° 1472).
46 De historia ..., Rr3v-Ss1r [= 318-21]: Rr3v-4r [318-19] (vd. anchesupra, 42 e n. 31).
59
POSTFAZIONE
sulla cima del monte che sovrasta Terracina (nella lingua del popolo‘Monte Sant’Angelo’) si ammira un famoso teatro
È lapalissiano il riferimento ai resti del cosiddetto tem-pio di Giove ‘Anxur’. E mi domando se a quest’ultimo sipossa o debba risolutamente adattare l’espressione delMassimo: «La linea retta della scena sarà lunga da quat-trocento palmi: questa volge le spalle alla pianura, con-forme si vede nel teatro di Terracina».
E deliberatamente ho addotto l’auctoritas del Conta-tore: un letterato del quale ho recentemente rivendicato lagrandezza (già soltanto la sua latinitas potrebbe valerecome una moderna e salutare lezione di prosa e di stile) edavanti al quale, una volta per tutte, occorrerà assumereuna posizione che vorrei auspicare coerente, magari inco-minciando a promuovere una traduzione italiana del suocapolavoro. La nobile e talora vacillante ‘stadera’ deglistudi storici pontini non dovrebbe ammettere tergiversa-zioni eventualmente contraddittorie: poiché non risulta cheTerracina possa, in generale, esibire o produrre testimonipiù autorevoli del Contatore per colmare amplissime la-cune della sua storia, sarà prudente guardarsi con la piùavvertita circospezione dall’invocarne l’autorità tutte levolte che torni più comodo e dal respingerla quando ilvento invece che dal mare prenda a spirare, supponiamo,da terra. D’altra parte, se le testimonianze, per tre lunghisecoli, corrono tutte per un verso, come possiamo ergercinoi contro l’autorità degli uomini dell’epoca? Forse innome di argomenti ex silentio? La storia non si scrive conil ‘senno del poi’, ma innanzitutto osservando il mondodei nostri avi, fin dove sia possibile, con los ojos de losprotagonistas e senza attribuire loro cose che non si so-gnarono mai né di dire né di pensare.
60
POSTFAZIONE
Questa è la mia prima minuscola obiezione. Veniamoalla lettera del 1661 a Giovan Pietro Bellori.
Si è visto che la lettera è un invito rivolto al destinata-rio e a un suo illustre ospite (i quali, in quel momento,stanno visitando i dintorni di Napoli) avente lo scopo evi-dente di farli salire a Roccasecca durante la via del ritornoa Roma: ed è altrettanto evidente come in quel momentoil Massimo, nella desolazione e solitudine dell’esilio roc-chigiano, cerchi in ogni modo di allettare tale sosta fa-cendo leva sui pregi storico-artistici più eminenti delterritorio. Ma gli allettamenti non furono, pare, sufficienti,perché i due tirarono diritto verso Roma (come si ricava dasuccessive missive del Massimo; e dubito che l’invitogiungesse troppo tardi), senza neppure fermarsi per unabreve visita a Roccasecca, che – se fossero tornati per lavia litoranea – si offriva loro addirittura come comodatappa lungo la strada.
Ora, l’elemento caratterizzante della missiva è il cennoesplicito ed inequivocabile che vi si fa all’esistenza di unteatro terracinese, del quale ancora una volta è chiamata incausa (senza l’aggiunta di ulteriori dettagli né topograficiné di altra natura) la «scena», addirittura ben «conservata»(«In Terracina vi è un theatro antico con la scena assai con-servata»). Che fine ha fatto questa «scena»? Intendo dire:se essa fu davvero così ben visibile e conservata al tempodel Massimo (al punto da poter essere additata da lui comeuna ‘presenza’ monumentale degna di essere ammirata daillustri ospiti), chiunque domanderebbe qui come mai nes-suno in precedenza si fosse accorto di una ‘presenza’ ar-chitettonica di tali mole e natura quali in generecaratterizzano simili manufatti. O, ammettendo anche cheessa, contro ogni aspettativa, si fosse all’improvviso ‘ma-terializzata’ con il suo sesquipedale alzato di non so quanti
61
POSTFAZIONE
metri o fosse stata integralmente riportata alla luce, po-niamo, nel corso degli anni Cinquanta del Seicento, quiqualcuno domanderebbe ancora come immediatamentedopo essa potesse misteriosamente dissolversi non la-sciando la minima traccia di sé: e infatti, appena pochi lu-stri più tardi il Contatore – la cui giovinezza è cro-nologicamente contigua alla senilità del Massimo, a suavolta contemporaneo del Kircher –, il Contatore, che purealacremente vaglia ed esamina le vestigia antiche di queiparaggi, dell’esistenza di quella «scena» non ha il minimosentore (e infatti individua altrove, come abbiamo visto, il«theatrum» dell’antica colonia romana terracinese). E, sedavvero la sesquipedale «scena» terracinese menzionatadal Massimo fosse stata quella destinata a riemergere tresecoli dopo, a quale libera e aperta «pianura» avrebbe maipotuto essa volgere le «spalle» alla metà del Seicento,quando il caos edilizio da quelle parti era infinito edenormi edifici, in lotta gli uni con gli altri oltre che controla storia, ostruivano da ogni lato, non dico il respiro critico,ma anche semplicemente qualunque vista lungimirante? Ameno che tale «scena» fosse in realtà ormai adibita ad abi-tazione per i Terracinesi dei ceti meno abbienti e facoltosiin un momento di grande depressione economica. E allorasì, la contingente funzione ‘pratica’ poté impedire per unbuon tratto il riconoscimento della vera natura di quellemura: ma solo finché le vigili autorità dell’epoca, scopertotale incredibile abuso, non osarono più dilazionarne la do-verosa e ormai improcrastinabile demolizione!
Ma la storia non si scrive, purtroppo, con i ‘se’. E per-mane il dubbio che per il Massimo quella «scena assaiconservata» fosse il compatto fronte e il suggestivo ordinedi archi del cosiddetto tempio di Giove ‘Anxur’, con i suoiinquietanti resti monumentali sovrastanti Terracina.
Mi fermo qui. Ma – sia detto tra noi – io rimango fer-manente persuaso che alla Provvidenza (o, come dicel’amico Giuseppe Papi, alla Dea Bendata) non si debbamai osare di porre limiti. E continuo a ritenere che, da unaparte, non si possa assolutamente escludere una eventualee sensazionale persistenza, in età barocca inoltrata, di co-spicui resti monumentali di un teatro romano nel cuore diTerracina alta: perché, se è vero che nessuno mai lo af-ferma, è d’altra parte indubitabile che nessuno mai – pun-tualmente, vorrei dire – lo neghi. E, dall’altra, non trovereimai il coraggio di dubitare delle capacità ‘speculative’ diun nobile il cui feudo confinava con il monastero di SantoStefano di Fossanova. Insomma non mi permetterei maidi dar forma all’ingrato sospetto che il Massimo possa es-sere rimasto vittima di uno dei più formidabili e imbaraz-zanti fraintendimenti o abbagli (magari provocato dairiverberi del chiarore lontano dell’«Anxur» oraziano) chel’erudizione pontina annoveri nei suoi annali.
Ma, come osservavo all’inizio, questo pionieristico‘affondo’ di Giuseppe Papi nel panorama così poco cono-sciuto della storia di Terracina – valga come monito lostraordinario affresco premesso dal presidente FrancescoMannino a questo lavoro – in piena età barocca costituiràl’utile punto di partenza per nuove ricerche, delle quali lostesso autore si candida già principale promotore.
Né mi accadrà mai di pentirmi di aver deciso che dellaquinquennale avventura editoriale del Centro Studi Fos-sanovesi, nata con un divertissement presentato a Rocca-secca dei Volsci il 27 gennaio 2007, s’intonasse così, ejxajprosdokhvtou, l’erudito e piacevole kuvkneion a\sma.
Stefano Pagliaroli
62
POSTFAZIONE
TAV. L Terracina, ‘ricostruzione’ del teatro romano di M. MARCHETTI, inCASSIERI, Terracina..., 370 Tav. I (con l’aggiunta di didascalie; vd. p. 50).
TAV. LI Sagunto, ricostruzione ipotetica del teatro rom
ano (da S. LARAORTEG
A, El teatrorom
ano de Sagunto: génesis y construcción, Valencia 1991; qui con l’aggiunta di didascalie;vd. p. 50).
TAV. LII Terracina, area del teatro con frammento di capitello dorico, forse parte della fr
ons
scae
nae(vd. p. 53).
TAV. LIII P. S. BARTOLI, Ritratto del cardinale Carlo Camillo Massimo(1620-1677) eseguito nel 1671: dal frontespizio del volume Antiquissimivirgiliani codicis fragmenta et picturae ex Bibliotheca Vaticana [...],Romae 1741 (vd. p. 53).
TAV. LIV L. ROSSINI, Viaggio pittoresco, illustrazione n° XLII: «Vedute dellapiazza e Cattedrale di Terracina» (vd. p. 67 n. 49).
TAV. LV
Città del Vaticano, B
iblioteca Apostolica Vaticana, G
abinetto delle Stampe, Stam
pe II3 (1, 61): B
. OLIV
IERI, Veduta degli avanzi del Palazzo di Teodorico Re dei G
oti sul promontorio
di Terracina [...] (acquaforte, 1795; vd. p. 69 n. 51).
TAV. LVI Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Gabinetto delle Stampe, Cicognara
V 4095 (2): W. B
YRNE(1743-1805), Te
rrac
ina(acquaforte; vd. p. 71 n. 53).
TAV. LVII Terracina: «Veduta dal monte S. Francesco» (da S. VINDITTI, Ter-racina. Paesaggio e leggende, Foligno 1901; vd. p. 72 n. 56).
TAV. LVIII Veduta di Terracina (disegno a matita, 3 ottobre 1831; proprietà della Fondazione M
arco Besso
di Roma; vd. p. 72 n. 56).
TAV. LX Terracina, incrocio tra via Pertinace e salita Annunziata: resti di un arco qua-
drifronte sulla via Appia, con basolato ben conservato; è visibile il muro di contenimento
realizzato con tecniche costruttive di varie età (vd. p. 75 n. 60).
TAV. LX
I L. ROSSIN
I, Viaggio pittoresco, illustrazione n° XLVII: «G
rotta al Lago di Fondi ove si dice che Sejano salvòla vita a Tiberio. Le rovine in avanti sono della città A
mycla; il paese è Sperlonga» (vd. p. 78 n. 61).
TAV. LXII Roma, Archivio Capitolino, Canale di Terracina: fotografia dell’anno 1892 della Società Italiana
per le Strade Ferrate del Mediterraneo (vd. p. 78 n. 62).
TAV. LXIV a-b Terracina: veduta dell’area archeologica del teatro durantegli scavi (vd. p. 78 n. 64)
TAV. LXV M. TRABUCCO: acquaforte della casa medievale con bifora nelsito del teatro (anno 1992) (vd. p. 78 n. 64).
❧
Riproponiamo qui due ‘capolavori’ completamente di-menticati degli studi archeologici terracinesi, che, ciascunonel suo genere, bene rappresentano, nella relazione di dueillustri visitatori, la situazione della città alta verso la metàdell’Ottocento e un secolo dopo, immediatamente a ri-dosso della ‘scoperta’ del teatro romano. Scorci potenti,anche animati dalla sua vocazione professionale, si sta-gliano nella relazione del Rossini (1846). Profetico e at-tualissimo il Moscati (1965), nel quale l’eredità della piùautentica lezione dell’antiquaria ottocentesca – centoventianni non sono pochi per lo sviluppo spirituale di una na-zione – è divenuta più attenta alle vicende antropiche47.
47 I riferimenti in nota (anche per le tavole LIV-LXIII, che abbiamocolto l’occasione di inserire), a corredo dei due lavori, sono stati ag-giunti da noi.
I48
Nel soggiorno che ho fatto per pochi dì in Terracina misono trovato presente agli scavi che l’ingegnere in caposig. Paolo Cavi stava eseguendo di tutto il piano dellapiazza avanti la cattedrale49, sulla cima della città antica,pel solo oggetto di rifarlo nuovo di selci, dandogli un mi-gliore scolo e una più dolce declività. Ivi, alla profonditàdi circa un metro in certi luoghi ed in altri meno, si è ri-trovato tutto l’antico pavimento di grandi lastre rettango-lari della lunghezza poco più di un metro, larghe metri 0,70 e grosse 10 centimetri, della pietra di que’ monti Ap-pennini, ove è sovrapposta la suddetta città. Si vede chetal pavimento gira sotto tutte le case moderne costruitesopra di esso, come il palazzo del comune e tutte le altreabitazioni ed una specie di torre de’ bassi tempi: sicché sa-rebbe importantissimo che così bel pavimento, che vantal’antichità di tanti secoli, rimanesse scoperto e facessebella mostra di sé, meglio che una moderna selciata. Ma iproprietari di tutte quelle case non vorrebbero che si ab-bassasse di tanto l’antico piano, temendo ch’esse potes-
48 L. ROSSINI, Intorno ad alcune antichità di Terracina. Al chiaris-simo sig. cavaliere Giovanni de Angelis, «Album. Giornale letterarioe di belle arti», 13 (settembre 1846), 226a-27b; Lettera del signorprof. L. ROSSINI, architetto, incisore, al sig. dottor Braun, «Bullettinodell’Instituto di Corrispondenza Archeologica», (ottobre 1846), 145-48 (con numerose varianti, a partire da quella più macroscopica: ilnome del destinatario della missiva!).
49 TAV. LIV.
sero patire: né comprendono che questo rialzamento mo-derno è tutto uno scarico di calcinacci che non gli dà alcunrinforzo. Io spero però che il sullodato chiarissimo inge-gnere e l’attuale gonfaloniere, sig. conte Antonelli, fratellodell’odierno monsignor tesoriere generale dello Stato no-stro, i quali si danno tanta cura per abbellire la loro patria,si daranno pure ogni cura presso l’eminentissimo camer-lengo acciò il pavimento suddetto rimanga scoperto: e cosìsi potrà formare una più dolce declività, come dissi, alla ri-pidissima via che dal borgo alla marina conduce alla me-desima piazza.
In mezzo a questo pavimento si è trovato un piccolopiedistallo rovesciato, senza alcuna iscrizione, ornato solodi una gola rovescia e d’un listello. Si conosce poi chiara-mente che la moderna scala, la quale mette alla facciatadella cattedrale, era quella stessa che metteva all’anticotempio di Apollo Ansure, mentre si è trovata l’ossaturadegli altri scalini sotto questo scarico. È certissimo ancorache questo era il Foro attorniato di templi, vedendosenemolti avanzi di rincontro al fianco della cattedrale e in que’vicoli annessi: perciocché nel detto fianco a mano destratrovansi ancora tutte le sostruzioni grandissime ed intattedell’antico tempio summentovato, essendovi state fattemolte botteghe che servono per vendere generi mangiatizie che sono sotto all’attuale piano della cattedrale, costruttanei tempi costantiniani. E sovraposto alle medesime so-struzioni gira una bella cornice di questo gran basamento,sopra cui ergonsi bellissime colonne corintie, striate conbase attica, senza plinto, internate di un terzo nella sua pa-rete a bugne, come il tempio della Fortuna Virile in Roma:ed all’altezza del terzo del suo fusto gira orizzontalmentenell’intercolunnio una fascia con bellissimo fregio a fo-glia di acanto, ristretto fra due gole rovescie intagliate che
68
APPENDICI
lo chiudono, come nel di dietro della medesima, ove co-mincia l’abside, ammirasi altra parete del suddetto tempiodi Apollo, stata distrutta per costruire la nuova chiesa. An-nessi veggonsi grandi muri di opera reticolata, avanzi dialtri edifizi, come può vedersi nelle tavole 44 e 45 del mioViaggio pittoresco da Roma a Napoli che pubblicai nel1839: una delle quali tavole fu da Lei riportata nel suoAlbum50.
Incontro poi al suddetto fianco, entro al secondo vi-colo, si vede ancora l’angolo intatto del basamento finaledi altro tempio incassato nel muro moderno, essendovicollocata sopra un’altra colonna scannellata con sua base,in tutto e per tutto come le mentovate del tempio di Apollo.Questo basamento, o stilobate, ha un listello ed una grossagola rovescia; e così nel disotto, come si veggono in altritempli de’ Greci e degli Etruschi.
Nel primo vicolo si vede altro avanzo di altra colonnasimile alle descritte, la quale prescrive la larghezza di unaltro tempio simile a quello della Fortuna Virile di Romae della Dea Albunea di Tivoli: tutte opere di un’egualeepoca e stile in tutto e per tutto. Prima poi di entrare nellapiazza summentovata trovasi, entro alla seconda bottegaa mano dritta, altra bellissima colonna al suo sito, striata,con base e capitello: il tutto bellissimo alle già dette.
Sulla cima del monte, ove la visuale è sorprendente,sono gli avanzi del basamento del così detto ‘Palazzo diTeodorico’51, composto di otto arcate, che formano la lar-ghezza di circa 50 metri. Quivi vicino trovansi altri avanzi
69
APPENDICI
50 [P. E.] VISCONTI, Il tempio di Giove in Terracina, «Album. Gior-nale letterario e di belle arti», 8 (marzo 1841), 1a-2a.
51 TAV. LV.
da tutte le parti di altri edifici antichi e, poco più basso, vi-cino alla chiesa dei Dottrinari, si veggono resti di conservedi acqua con tutti i condotti ancora intatti di terra cotta econ lo stucco grossissimo ed intatto: ed avvi una di questea diverse arcate, somigliante alle così dette ‘Sette Sale’delle terme di Tito, che ancora è sempre ripiena di acqua,la quale, perduta, trafilerà nel terreno; e del pari ivi vedesiun pezzo di via antica. Certo la gran tazza di granito rosso,che trovasi sotto l’atrio della cattedrale, non fa dubitareche in Terracina esistessero delle terme, essendo stata que-sta città una delle più magnifiche e cospicue dei Volsci.
Nella parte della marina, ossia sotto alla città descrittaal presente, sorge un magnifico borgo, incominciato giàdall’immortale Pio VI, che fece il grand’edificio della Do-gana coll’altro annesso ed un altro grandissimo edificiodetto il ‘Palazzo del Papa’, oggi ingrandito per modo che,oltre l’appartamento pontificio, v’ha in esso una grande ca-serma, un ospedale ed altri comodi. Vicino alla Dogana èuna bella piazza con palazzi nuovi ed altri incominciati;poco distante è altra piazza semicircolare, attorniata di bot-teghe non ancora ultimate. Incontro ad essa si erge una granchiesa a forma basilicale, con magnifico prospetto ornatocon un portico, o pronao, di sei colonne tutte di pietra ditaglio di ordine ionico, con suo frontespizio. Il suo internoè a cinque navi compresevi le cappelle e con due file di co-lonne del medesimo ordine, terminando a croce latina consua cupola. Il che forma un bellissimo effetto ed è opera sìstudiata e ricercata ne’ suoi più minuti particolari, chetroppo ci vorrebbe a descriverla: talché credo che sia unadelle più belle fabbriche errette a’ nostri tempi e devesi almagistero del amico prof. cav. Antonio Sarti, architetto.Non molto lungi da essa, sul lido del mare, si veggono lerovine del grandissimo porto di Antonino Pio, di un peri-
70
APPENDICI
metro di più di tremila piedi, in oggi ostruito: ma vi si am-mirano ancora grandi avanzi di fornici e di molti menso-loni di pietra scorniciati con un gran foro in mezzo perfermare le funi delle navi. Ora annesso a questo sorge unaltro posto che si sta costruendo dall’illustre architetto in-gegnere prof. cav. Gaspare Salvi e che sperasi vedere ul-timato dalla munificenza del regnante sommo ponteficePio IX: il che produrrà grande utile per la città. Nella viapoi di là dal canale di navigazione, che internasi nel nuovoporto, e precisamente incontro al gran palazzo Braschi (nelluogo ove fu ritrovata la statua dell’Aristide52, che oraadorna il Museo Lateranense) si scorgono avanzi magni-fici di altre terme con muri di opera reticolata, e così puresotto al mentovato palazzo Braschi, nel fianco sulla se-conda salita; e d’altri muri antichi è segno nel didietro delpalazzo della bonificazione pontina. Diversi fusti di co-lonne di granito bigio sulla piazza: e quelle del porticodella cattedrale dello stesso granito. Qui è appoggiata lagrande iscrizione che, attesta Domenico Polo, essere statatrovata nella via Appia e viene riportata dal Nicolai nel-l’opera De’ bonificamenti delle terre pontine, iscrizioneche ci fa conoscere che nei tempi di Teodorico furono fattedelle bonificazioni e quindi donate a Decio.
L’interno della cattedrale è tutta barocca, salvo il pul-pito ed il pavimento, che è opera assai bella dei tempi co-stantiniani. Questa città veduta sulla marina si rappresentaassai pittoresca53 ed evvi un bel contrasto di tinte di que-gl’immensi monti rossastri colle tinte fredde delle frascheche investono gli edifici gotici e moderni; ed in generale
71
APPENDICI
52 Così a 227a della ‘lettera’ al de Angelis; mentre la medesima alBraun, 148, ha «Sofocle».
53 TAV. LVI.
il paese è assai bello per gli artisti. Dalla parte opposta allaDogana si veggono le immense Paludi Pontine, diseccatee bonificate dal sommo pontefice Pio VI, e si rappresen-tano tutte ridenti e fertili col gran bosco che reca tanto utilealla città; e vedesi pure il monte Circeo col porto di Ba-dino. Le Paludi sono di un’estensione in lunghezza di42000 metri e di larghezza 18000, secondo il sig. diProny54. L’inverno vi è come una primavera e vi allignanoassai gli alberi di palme55, di cedri, di portogalli e tanti altri:ma l’estate l’aria non è sana. La sua popolazione è di circa7 mila anime.
In questo momento mi scrive un amico le seguenti pa-role: «Scavando la strada che conduce al palazzo Braschi,si è rinvenuto in luogo recondito l’avanzo di un piccolotempio composto di dodici colonnette, nel cui mezzo unabase o piedistallo, sopra la quale doveva essere la statua diApollo, essendovi la seguente iscrizione: “ANSVRE .APOLLINI . DICATVM”»56.
Questa sarebbe la piccola edicola avanti al gran tem-pio di Apollo Ansure summentovato, edicola che pur sirinvenne avanti al tempio di Minerva in Assisi circa quat-tro anni sono e che fu ristaurata dall’architetto francese Ti-teux, in oggi morto in Atene.
72
APPENDICI
54 Des Marais Pontins [...], par M. DE PRONY [...], À Paris 1822;Description hydrographique et historique des Marais Pontins [...],par M. DE PRONY [...], À Paris 1818.
55 TAVV. LVII-LVIII.56 Riferimenti bibliografici in L. BOCCALI, Esempio di organizza-
zione delle fonti antiche per la ricostruzione del quadro della vita re-ligiosa di una città e del suo territorio in età preromana e romana:Terracina, «Cahiers du Centre Gustave Glotz», 8 (1997), 181-222: 217n° 1.
II57
Un antico teatro romano, risalente al primo secolo dopoCristo, sta tornando alla luce a Terracina. Gli scavi direttidal dott. Baldo Conticello58, per incarico del soprinten-dente prof. Luigi Pietrogrande, consentono ormai di indi-viduare le gradinate disposte a semicerchio59, la scena, unporticato a colonne alle spalle di quest’ultima. Dal teatro,che si leva a mezza costa sul mare, il pubblico di duemilaanni or sono poteva ammirare gli spettacoli sullo sfondodella costa tirrenica, oltre la quale il Circeo di delinea, perillusione visiva, quasi in forma di un’isola.
In questa parte della cittadina, che si chiama TerracinaVecchia o Alta, i turisti giungono di rado, attratti comesono dalla bellezza panoramica della zona costiera. Ma chiabbia il gusto dei paesaggi originali e inusuali deve salirefin qui, lungo la ripida via dell’Annunziata, che sboccasulla piazza del Municipio. Troverà, subito, una sorpresa:la pavimentazione della piazza è quella a lastre quadrate
57 S. MOSCATI, Il teatro di Terracina, in Archeologia mediterranea.Missioni e scoperte recenti in Asia, Africa, Europa, Milano 1966,231-34 (e Tav. 47).
58 Per le incertezze che, ancora all’inizio degli anni Sessanta, aleg-giavano sul sito del teatro, vd. Terracina. Guida a cura di B. CONTI-CELLO, Roma 1967, 40: «fra il palazzo Venditti e l’angolo nord-est dellapiazza, si stanno conducendo in questi ultimi anni scavi regolari; è giàvenuto in luce un vasto porticato colonnato, alle cui spalle di estendeuna costruzione ancora di incerta interpretazione allo stato attuale dei la-vori».
59 TAV. LIX.
che fu fatta eseguire, nell’età di Tiberio, dal magistratoAulo Emiliano. Un’iscrizione di quest’ultimo si legge an-cora, a grandi lettere incise, sulle pietre antiche.
La zona dei nuovi scavi è sulla destra di chi arriva. Equi lo spettacolo appare subito inusuale, perché i ruderiemergono tra agglomerati di case che i bombardamentidell’ultima guerra hanno parzialmente distrutto. Fette dipareti con intonaci a vivaci colori, muri diroccati e am-massi di pietre tra cui fiorisce qualche melograno, colonneantiche che s’inseriscono in costruzioni moderne, spiazziin cui gli edifici romani si enucleano in mezzo a cumuli dirifiuti: tale è l’ambiente sconvolto nel quale i diversi tempidella storia s’incontrano e si sovrappongono senza evolu-zione alcuna, mediante incroci caotici che pur hanno unloro fascino particolare.
Anche le case non diroccate, del resto, partecipano diquesti caratteri: perché non solo sorgono su quelle antichee medioevali, ma con esse s’integrano, spesso utilizzan-dole senza innovazioni di rilievo. Accade così che moltimuri siano nella parte inferiore romani, e che a più ripresecompaiano finestrelle bifore e trifore di tipico aspetto me-dioevale. Quanto agl’incroci, l’esempio più tipico è forsequello di un architrave romano che è venuto a trovarsiesattamente sotto il lavandino di una cucina moderna.
Nei vicoli stretti, sormontati da archi ora tondi ora ogi-vali che chiaramente svelano le loro remote origini, osterie,caffeucci, segherie, drogherie, frutterie s’annidano in am-bienti per lo più ricavati da gallerie romane. Botti, bidoni,catini, vecchi ombrelli si scorgono accatastati nella penom-bra. Sulle facciate delle case, file di panni stesi, coroncine dipomodori, mazzi di fiaschi s’inseriscono tra i fili della lucee gl’impianti televisivi, che svettano sui tetti a testimonianzadel progresso raggiunto. Ai lati delle porticine, i vecchi sie-
74
APPENDICI
dono a riposare al sole, mentre i fanciulli sciamano gridandoqua e là. Frotte di pulcini corrono ad annidarsi tra i restidelle colonne e i muri romani in opera reticolata60.
Procedendo verso la periferia esterna dell’agglomeratodi case, si raggiunge la cinta muraria, che può essere se-guita attraverso un cammino di ronda risalente all’età me-dioevale. Dalle feritoie delle fortificazioni si scorgono asquarci le fertili vallate dell’entroterra, ricche di melograni,pioppi e aranci. All’apice del cammino di ronda, un caval-cavia cinquecentesco emerge tra cespugli di bouganvilles.
Questo è l’ambiente singolarissimo nel quale s’inseri-sce l’opera degli archeologi. Ma qual è il motivo di un taleaffastellarsi di testimonianze diverse, dell’incrociarsi fittoe disorganico – ma perciò tanto significativo – dei restimonumentali? La parte alta di Terracina, fiorente nelprimo secolo della nostra èra, decadde in seguito per lospostarsi del centro commerciale verso la valle. Poi ancheil commercio venne meno e Terracina si ridusse a pochecentinaia di abitanti: il porto fu abbandonato, le acque sta-gnanti diffusero la malaria. Anche in età moderna, quandola bonifica ha fatto progressivamente rifiorire la zona, ilcentro cittadino si è sviluppato esclusivamente a valle,sulle rive del mare.
L’abbandono, così, ha favorito il conservarsi dei restiantichi e il diretto inserirsi in essi degli sviluppi medioe-vali e moderni. Si aggiungano i bombardamenti dell’ultimaguerra, che hanno sconvolto il terreno: la Soprintendenzaalle Antichità è allora intervenuta per vincolare la zona, im-pedendo le ricostruzioni moderne e impegnando l’ammi-nistrazione comunale a concedere ai proprietari il diritto dipermuta. Del resto, quand’anche non si fossero posti vin-
75
APPENDICI
60 TAV. LX.
coli, è assai dubbio, dato il prevalere della zona costiera,che vi sarebbero state molte ricostruzioni.
In uno stato di cose come quello ora descritto, è evidenteche gli archeologi non possono sperare di porre subito in lucetutti gli edifici antichi. Questo avverrà forse col tempo, a se-guito di una paziente opera di espropri e di demolizioni. Perl’inizio, quel che occorre è individuare la pianta e la strutturadelle costruzioni, fissarne i limiti tra quelle di altri tempi.Tale scopo, appunto, può dirsi realizzato per il teatro di re-cente scoperta: è chiaro l’arco formato dalle gradinate, ed èsuggestivo notare che le costruzioni più tarde ne hanno se-guíto, e con ciò segnato, il perimetro; sono chiare le dimen-sioni della scena, perché sono stati individuati i corridoi diaccesso che la delimitavano. Volendo, si potrebbe ormai cal-colare il numero degli spettatori che assistevano alle recite.
Un problema particolare è costituito dai resti del por-ticato a colonne che emergono alle spalle della scena, indirezione del mare. È possibile che tali resti, finora postiin luce per una striscia, facessero parte di una vera e pro-pria basilica; ma è possibile anche che si trattasse di unsemplice portico, nel quale si recassero a passeggiare, am-mirando il panorama, gli spettatori. Una specie, insomma,di foyer del teatro.
A questo punto, occorre avvertire che la vista dellaspiaggia e del mare, goduta dagli spettatori dell’antichità,non potrebbe essere ugualmente goduta dagli spettatorimoderni. Proprio di fronte all’antico teatro, infatti, è sortopochi anni or sono il nuovo palazzo comunale. Questo, pervero, imita volutamente nella facciata i muri a reticolato dietà romana; ma è assai dubbio che ciò possa costituire unaconsolazione.
L’edificio comunale, a sua volta, sorge su resti antichi,forse un porticato simmetrico a quello già descritto. Lo
76
APPENDICI
stesso si dica, come del resto è noto, per le costruzioni cheoccupano gli altri due lati della piazza: la Cattedrale è im-piantata esattamente su un tempio romano, del quale sonoancora visibili le colonne e le lastre marmoree decoratecon motivi floreali; l’edificio che ospita il Consorzio dellaBonificazione Pontina conserva nei suoi scantinati nume-rosi resti della basilica forense.
Il complesso degli edifici antichi, dunque, faceva co-rona alla piazza, rimasta intatta attraverso il tempo. Lapiazza stessa è il risultato di un’opera imponente: poiché ilterreno risultava in pendio, esso fu spianato e basato su unaserie di gallerie, ancor oggi chiaramente individuabili.L’opera poderosa sostenne il traffico antico e sostiene oraquello moderno, a prova efficace della sua perfetta solidità.
La scoperta del teatro, come si vede, completa il qua-dro della Terracina imperiale, confermandone il carattereormai pacifico e raffinato, dopo che la cittadina aveva co-stituito per secoli un centro militare di notevole impor-tanza, posto a controllo delle vie del meridione. Inclusanell’Impero, essa vide ridursi la sua funzione strategica,mentre si sviluppavano e fiorivano le attività della pace, inparticolare l’agricoltura e le viticoltura, che doveva ren-dere celebri queste terre.
Numerose iscrizioni di ricche famiglie romane, checontinuano a venire alla luce, indicano che qui esse co-struirono le loro ville, o comunque le loro tenute agricole.Del resto tutt’intorno, e specie lungo la costa in direzionedi Napoli, una serie di lussuose dimore era già nota; e nu-merose altre ne sono state individuate recentemente, a se-guito di una ricognizione per via di mare che il dott.Conticello ha eseguito in collaborazione con la Guardia diFinanza, la quale ha posto a disposizione i suoi mezzi nau-tici e l’esperienza dei suoi specialisti.
77
APPENDICI
Come oggi, dunque, anche duemila anni or sono que-sta costa fu sede di ricche ville. Alla più celebre, quella diTiberio a Sperlonga61, sempre nuove se ne aggiungono; evale la pena di cercarle, di ravvisarne i ruderi, di studiarei sistemi della pesca attraverso vivai62 in cui le acque ma-rine venivano sapientemente mischiate con quelle dolci.Ma questo è un altro itinerario, assai suggestivo e ben pococonosciuto, da effettuare in motobarca lungo la costa la-ziale; e poiché la stagione è inoltrata63, converrà pensarciun’altra volta64.
78
APPENDICI
61 TAV. LXI.62 TAV. LXII.63 Dell’anno 1965.64 TAVV. LXIII-LXV.
INDICE DELLE TAVOLE
TAV. I Arsoli, Castello Massimo, Salone principale:M. BENEFIAL, Roccasecca
TAV. II Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Dise-gni e delle Stampe: G. F. GROUTER, Il trionfo dell’amore
TAV. III M. GIUSTINIANI, Lettere memorabili, In Roma1669, C7v
TAV. IV a-b M. GIUSTINIANI, Lettere memorabili, In Roma1669, C8r-v
TAV. V N. TINDAL-P. RAPIN DE THOYRAS, carta nautica delMediterraneo
TAV. VI Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Dise-gni e delle Stampe: C. C. MASSIMO, Altare di Sant’Agata
TAV. VII Roma, Collezione privata Stefano Massimo: ve-duta di Roccasecca dalla collina di San Raffaele
TAV. VIII a-b Roccasecca dei Volsci, Tempietto di SanRaffaele
TAV. IX Roccasecca dei Volsci, Tempietto di Santa Mariadella Pace
TAV. X Roccasecca dei Volsci, Tempietto di San Raffaele:
TAV. XI Roccasecca dei Volsci, Tempietto di San Raffaele
TAV. XII Roccasecca dei Volsci, Tempietto di San Raf-faele
TAV. XIII Roma, Palazzo alle Quattro Fontane
TAV. XIV Palazzo Massimo a Roccasecca dei Volsci
TAV. XV Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Dise-gni e delle Stampe: C. C. MASSIMO, Gloria
TAV. XVI Roma, Archivio Capitolino: G. DELISLE (1675-1726), carta geografica della Campagna di Roma, del Pa-trimonio di San Pietro e del Ducato di Castro
TAV. XVII U. ALDOVRANDI, De piscibus et de cetis,Bononiae 1613, Ppp2v
TAV. XVIII Terracina, via della Palma, facciata di casamedievale con bifora
TAV. XIX Terracina, via Posterula
TAV. XX Terracina, via Anita Garibaldi, 98
TAV. XXI Terracina, via Anita Garibaldi, 98
TAV. XXII Terracina, Palazzo degli Azzi
82
INDICI
TAV. XXIII Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati-cana, Gabinetto delle Stampe, Ashby, Disegni, 252: E. S.PERCY (1782-1847), Villa a Terracina
TAV. XXIV Terracina, località Le Mole
TAV. XXV a-b Sagunto, pianta della città e strade
TAV. XXVI Sagunto, veduta del teatro romano e della città
TAV. XXVII Sagunto, veduta generale del teatro romano
TAV. XXVIII Sagunto, porta principale del teatro romano
TAV. XXIX Sagunto, vista sulla cavea e ingresso del teatroromano
TAV. XXX Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati-cana, Pal. Lat. 1564, 89r: miniatura della colonia romana
TAV. XXXI M. GIUSTINIANI, Della scelta delle lettere me-morabili [...], In Napoli 1683: L4r [= 247] (vd. p. 31)
TAV. XXXII M. GIUSTINIANI, Della scelta delle lettere me-morabili [...], In Napoli 1683: L4v-5r [= 248-49] (vd. p. 31)
TAV. XXXIII M. GIUSTINIANI, Della scelta delle letterememorabili [...], In Napoli 1683: L5v [= 250] (vd. p. 31)
TAV. XXXIV Roma, Archivio di Palazzo Massimo, Regi-stro 276, 471r
83
INDICI
TAV. XXXV Priverno, Archivio privato Silvio Barsi:rovine della cosiddetta ‘Villa di Seiano’ in località ColleSant’Ermo
TAV. XXXVI Terracina, sito del teatro romano
TAV. XXXVII Roma, Archivio di Stato, Catasto Grego-riano: pianta di Terracina
TAV. XXXVIII ‘Ricostruzione’ del tempio di Giove pro-posta alla fine dell’Ottocento dall’archeologo Pio Capponi
TAV. XXXIX L. ROSSINI, Viaggio pittoresco, illustrazionen° LXXII
TAV. XL Terracina, foto aerea scattata pochi anni dopo ilbombardamento del 1943
TAV. XLI Latina, Archivio di Stato, Imposte Dirette,Mappa n° 1574
TAV. XLII Terracina, sito del teatro romanosTAV. XLIII Terracina, sito del teatro romano
TAV. XLIV Terracina, sito del teatro romano
TAV. XLV Sagunto, teatro romano
TAV. XLVI Terracina, sito del teatro romano
84
INDICI
TAV. XLVII Terracina, sito del teatro romano
TAV. XLVIII Terracina, ruderi del teatro romano
TAV. XLIX Terracina, area del portico del teatro romano
TAV. L Terracina, ‘ricostruzione’ del teatro romano percura di Maurizio Marchetti
TAV. LI Sagunto, ricostruzione ipotetica del teatro romano
TAV. LII Terracina, area del teatro
TAV. LIII P. S. BARTOLI, ritratto del cardinale CarloCamillo Massimo (1620-1677)
TAV. LIV L. ROSSINI, Viaggio pittoresco, illustrazione n°XLII
TAV. LV Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati-cana, Gabinetto delle Stampe, Stampe II 3 (1, 61)
TAV. LVI Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati-cana, Gabinetto delle Stampe, Cicognara V 4095 (2)
TAV. LVII Terracina, veduta da San Francesco
TAV. LVIII Veduta di Terracina
TAV. LIX Terracina, sito del teatro romano: gradinate
85
INDICI
TAV. LX Terracina, incrocio vie Pertinace e Annunziata
TAV. LXI L. ROSSINI, Viaggio pittoresco, illustrazione n°XLVII
TAV. LXII Roma, Archivio Capitolino, Canale di Terracina
TAV. LXIII Terracina: area archeologica del teatro
Tav. LXIV a-b Terracina: area archeologica del teatro
Tav. LXV M. TRABUCCO, acquaforte
86
INDICI
INDICE DEI NOMI
Alberti L. 43, 56, 58Alessandro VII 21-22AMASENO 40-42Angelini E. 23Annibale 33, 43Antonino Pio 70Apollo 68-69APPIA 32, 40, 50Aquila P. 20Aristide 71ASSISI 72ATENE 72Augusto 49Aurigemma S. 47AVERNO 41
BADINO 72Barberini F. 17Beaven L. 16, 24Bellori G. P. 9, 23-24, 39, 60Bianchi R. 11Bianchini A. 32, 47Biondo Flavio 43, 56Boccali L. 72Bonato M. 17Buonocore M. 25
* L’indice è rigidamente selettivo.
Caligola 41Camilla 42CARTAGINE 33Cassieri N. 48, 50Castagnoli F. 37Cavi P. 67Circe 41CIRCEO 41, 72-73CIVITAVECCHIA 21Clemente X 27Clemente XI 12Colonna V. 17Contatore D. A. 11, 42, 56, 59Conticello B. 73, 77Corsini L. 12
Dea Bendata 53, 61De Angelis P. 31de la Blanchère M.-R. 56De Prony R. 72De Santis A. 48Di Capua C. 16di Carpegna Falconieri T. 17
Fagiolo M. 48FORO APPIO 40FOSSANOVA 56, 61
García Sanz F. 6, 59 GENOVA 20Germain M. 44GERUSALEMME 9, 15, 20Ghislieri F. M. 29
88
INDICI
Giacomo I 35Ginetti G. F. 28Ginetti L. 26Giustiniani C. 17-18Giustiniani M. 37Giustiniani V. 18Grossi V. 31
Hernández Hervás E. 34Huppert C. 48
Innocenzo X 5
Kircher A. 58, 61Klinger W. 29
Labruzzi C. 44LA LUCERNA 42LATINA 52Leo F. 42Livio 34Lorrain C. 9Lugli G. 44
Mabillon J. 44Madonna M. L. 48MADRID 5Mannino F. 13, 30, 62Mannino M. 16Maratta C. 9Marchetti M. 50Marocco G. 44Marzocchi R. 16, 24, 29, 40, 58
89
INDICI
Massimo C. 24Massimo G. L. 17Massimo L. 17Metabo 41-42Molinari M. C. 25Moroni G. 44Moscati S. 8, 45, 65, 73
NAPOLI 39-40, 44, 60, 69, 77Nerli F. 28Nicolai N. M. 71
Orazio 62
PADOVA 35Pagliaroli S. 8, 15, 17, 23-24, 31, 37-38, 42, 45, 62Palombini G. 36Palos y Navarro E. 35PALUDE PONTINA 32, 45, 72Papi G. 5-7, 12, 21, 55-57, 62Parisot J.-P. 40Peruzzi B. 12, 48Pietrogrande L. 73Pio VI 32, 70, 72Polo D. 71Pompeo 49Poussin N. 9, 18, 23PRIVERNO 40
Quinto Fabio Massimo 17, 43
Raggi O. 20Reni G. 27
INDICI
90
ROCCAGORGA 26ROCCASECCA DEI VOLSCI
Madonna della Pace 24Palazzo Massimo 23, 25San Raffaele 23, 27Santa Maria Assunta 18
Rocci G. L. 32Ronci S. 4Rossini L. 8, 43-44, 56, 65, 67
SAGUNTO (MORVIEDRO) 16, 33, 38, 46Salomone 39Salvi G. 71Sarti A. 70Seiano 40Serlupi G. 17Silio Italico 38Sofocle 71SPERLONGA 78Stratico S. 35
Teodorico 11, 69TERRACINA
Foro Emiliano 48, 50 Monte Sant’Angelo 11, 43, 58-59Rocca Traversa 51San Cesareo 30-31, 50-51San Domenico 31San Francesco 31
Terribile C. 17, 28Tessari C. 48Tiberio 49, 78Titeux P.-A. 72
INDICI
91
Tito 70TIVOLI 69Trivulzio G. G. 22
Vacani C. 36VALENCIA 21, 33Velázquez D. 5VELLETRI 26VINAROS 21, 38Virgilio 41Visconti P. E. 69
Zacinto 34, 38Zoilo 56
92
INDICI
INDICE GENERALE
Prefazione (F. GARCÍA SANZ) 5Introduzione (F. MANNINO) 7Premessa 15La vita 17Terracina, un ‘museo’ storico all’aperto 29Carlo Camillo Massimo e i teatri romani di Sagunto e di Terracina 33
Conclusione 47Postfazione (S. PAGLIAROLI) 55Appendici 63
INDICI
Indice delle tavole 81 Indice dei nomi 87