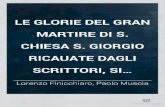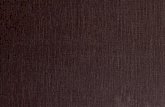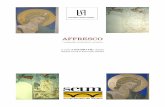martire di s. - chiesa s. giorgio - Fondazione Prospero Intorcetta
Santa Greca: la martire di Decimomannu, in C. Decampus, B. Manca e G. Serreli curr., Per una...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Santa Greca: la martire di Decimomannu, in C. Decampus, B. Manca e G. Serreli curr., Per una...
EditoreArci Bauhaus DecimomannuVia Cagliari 22Decimomannu - Tel./Fax [email protected]
Progetto grafico e impaginazioneil Graffio di Stefano SodduVia Mosca [email protected]
Stampa e allestimentoTiemme Officine GraficheLocalità Truncu Is FollasAssemini
Edizione 2008
© Copyright 2008
Tutti i diritti, nessuno escluso, concessi dagli autori, sono riservati all'Editore. È vietata per chiun-que la riproduzione di tutto o di parte del presente volume con qualsiasi mezzo, sia meccanico cheelettronico, senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.
Coordinamento scientificoGiovanni Serreli
Foto di copertina,controcopertine, pagine 4 e 366
Tonino Uscidda
Le prime manifestazioni della scrittura nel cagliaritanodi Maurizio Virdis
Mariu Pudhu
1- S’abbisòngiu nou de lingua sarda2- S’isperiéntzia istórica si fiat fendi sentza de língua3- Sa LSU (Limba Sarda Unificada)4- Sa LSM (Limba Sarda de Mesania)5- Sa cosa prus importanti
Passau e presenti de sa lingua sardadi Giovanni Casciu
Ricerca per una storia locale:Decimomannu dalla preistoria al feudalesimodi Cecilia Lilliu
La toponomastica del territorio di Decimomannudi Carlo Manca
I villaggi all’aperto dell’entroterra del golfo di Cagliarinel quadro della civiltà nuragicadi Vincenzo Santoni
I luoghi del sacroI diversi “filoni” di strutture funerarieBibliografiaReferenze documentali
L’espansione fenicia e punica nei campidanidi Paolo Bernardini
Decimo in età romana: le necropoli e l’acquedotto roma-no da Cabudacquas a Caralesdi Donatella Salvi
Sommario
16
232323242526
27
31
36
4451546270
71
79
Decimomannu e il suo ponte romano: un importantenodo stradale della Sardegna anticadi Fabrizio Fanari
Brevi cenni sulla Sardegna in epoca romanadi Marcella Bonello
ElmasAsseminiMonastirSan SperateUtaSestuVillaspeciosaDecimoputzuVillasorVallermosa Decimo è la Valeria ricordata da Tolomeo?Nelle carte l’ubicazione di Valeria varia notevolmenteI Documenti
L’antico quadro insediativo del Campidanoalto-meridionale e la questione di Valeriadi Giovanni Ugas
1 - L’enigmatica Valeria1.1 - status quaestionis
1.2- Le ragioni dell’esistenza di Valeria
2. Aspetti fisici, risorse e scarsa visibilità insediativadel Campidano 2.1. Le caratteristiche fisiche
2.2. L’edilizia dell’argilla e la falsa impressione della scarsa antropizzazione
campidanese
3. La situazione insediativa nel Campidano alto-meridionale3.1. I dati del territorio della curatoria di Gippi
3.2. La Curatoria di Nuraminis
3.3. La Curatoria di Decimo
3.4. La Curatoria di Dolia
3.5. I dati generali del Campidano alto meridionale
87
9798
101103104106107110112114115119120123
131
131132
135
136137138143149153158
4. Nuove considerazioni sull’identità di Valeria4.1. La gens Valeria nell’isola
4.2. Toponimi sardi legati alla base bar-/bal- e altri aspetti linguistici
4.3. L’identificazione di Oualeri: La risposta dell’archeologia
Archeologia nel Campidano di Cagliari.L’età tardo antica e l’altomedioevodi Donatella Salvi
Santa Greca: la martire di Decimomannudi Mauro Dadea
- L’epitattio- L’ipogeo- La chiesa- Il monastero- La martire
I fedeli sardi e Santa Grecadi Raimondo Podda
Decimo in età medievaledi Giovanni Serreli
Sul processo a Gherardo della Gherardesca,conte di Donoratico, feudatario di Dècimodi Valentina Grieco
- L’inchiesta- Le accuse- La sentenza
La villa di Decimo nel “Proceso contra los Arborea”di Maria Grazia Farris
Governo e amministrazione del regno di Sardegna in etàaragonese: la luogotenenza regiadi Fabio Cocco
- I titoli- L’assetto territoriale nel governo dello Stato
162163164
170
177178186189190191
203
210
229
230230
231
233
246247249
- Gli atti di nomina e i poteri delegati al luogotenente- Conclusioni
La presenza dei villaggi nel Parlamento sardo del 1355:Decimo e la sua curatoriadi Esther Martí Sentañes
Il Parlamento del 1355 nella storia parlamentare sardaLa presenza de Decimo nelle sessioni parlamentariConclusioni
Il sarcofago di Violante Carroçdi Donatella Salvi
La villa di Decimomannu in età moderna: appuntiper una storia politico-istituzionale ed economico-socialedi Giovanni Murgia
Le contese sui confini tra comuni contermini.I villaggi scomparsi ed il regime dei beni dall’usocivico al diritto di cussorgia alla proprietà perfettadi Aldo Cappai
- Ville despobladas nel sud est della Sardegna- Dall’esodo alle liti tra comunità contermini, e tra esse
e il feudatario, sull’uso dei territori despoblados- Isole amministrative- Il periodo piemontese- Diversi sistemi d’uso del territorio- Curadorìa di Decimo
Le vicende storiche di Villanova de Seruisdi Antonello Secci
- La controversia secolare fra tre comunie la suddivisione del salto di San Giovanni- La tradizione, la chiesa e le feste campestri- Appendice
Su alcune visite pastorali a Decimomannu (XVI-XVIII)di Simonetta Sitzia
250251
255255
261257
262
273
293294
295295296296
298
297
304
310307
312
Architettura religiosa medioevale a Decimomannue Decimoputzudi Roberto Coroneo - Anna Pistuddi
- Sch. 1. Decimoputzu/Villasor, chiesa di Santa Sofia- Sch. 2. Decimomannu, chiesa di Santa Greca- Sch. 3. Decimoputzu, chiesa di San Giorgio- Sch. 4. Decimoputzu, chiesa di San Basilio- Sch. 5. Decimomannu parrocchiale di Sant’Antonio Abate
Ordini equestri ed ospedalieri medievali nelle curadoriasdi Decimo e Gippidi Stefano Castello
- La precettoria di Santa Maria di Uta- Prima ipotesi- Seconda ipotesi- Conclusioni- San Michele di Searu e l’Ordine dei Cavalieri del Tau
I reperti rinvenuti nella Chiesa parrocchiale di Decimo,altare di Sant’Antoniodi Donatella Salvi
La chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate(Decimomannu)di Don Beniamino Tola
324326327328330331
332334335340344345
349
361
Santa Greca, la martire di Decimomannu, appartiene a quellavasta schiera di santi antichi dei quali, a ben vedere, si cono-scono con certezza soltanto il nome e il titolo1 (figura 1).
Nei difficili secoli dell’altomedioevo, alla quasi totale distruzionecui andarono soggetti perfino gli archivi centrali dell’impero nonpotevano certo sfuggire i documenti relativi alle piccole chieseparticolari.
1 La grande venerazione tributata a SantaGreca in tutta la Sardegna trova immediatoriscontro nella ricca bibliografia fiorita a suoriguardo. Limitatamente alle opere di genereagiografico, in ordine cronologico si vedano:Novena de sa Gloriosa Santa Arega Sardamartirisada in Deximu Mannu, Casteddu1788; Novena de sa Gloriosa Sant’AregaMartiri Sarda, Oristanis 1871; G. SPANO,Storia della chiesa di Santa Greca pressoDecimo Manno ed esercizio spirituale in linguavernacola che dai devoti si pratica in dettachiesa, Cagliari 1876; Ricordo della festa diSanta Greca a Decimomannu nel 24 e 25Settembre 1887, Cagliari 1887; N. FALCHI,Vita di Santa Greca Vergine e Martire,Sassari-Cagliari 1899; E. ARGIOLAS, SantaGreca Vergine e Martire, Cagliari 1911; A.CASU, Gemme sarde, Cagliari 1926, pp. 46-52; R. MAXIA, Vita di Santa Greca, Cagliari1930; A. SAILIS, Il devoto di Santa Greca.Novena e preghiere, inni, vita e goccius,Cagliari 1950; G. PIRAS, I santi venerati inSardegna nella storia e nella leggenda,Cagliari 1958, pp. 259-260; A. AMORE,Greca, santa, martire, venerata aDecimomannu, in Bibliotheca Sanctorum,VII, Roma 1966, coll. 164-165; R. BONU,“E a dir di Sardigna” (Uomini, Paesi, Santi),Cagliari 1969, pp. 138-140; F. COLLI,Decimomannu. Il paese e la sua storia. Il cultodi Santa Greca, Cagliari 1971; Dizionario deisanti venerati in Sardegna, Assemini 1993,pp. 108-109; A.F. SPADA, Storia dellaSardegna cristiana e dei suoi santi. Il primomillennio, Oristano 1994, pp. 190-192; E.LILLIU, Iconografia dei santi sardi veri o pre-sunti della pietà popolare, Cagliari 1995, p.121; R. PODDA, Santa Greca. Storia, tradizio-ne, leggenda e miracoli, Decimomannu19974; F. CIOMEI, Gli antichi martiri dellaSardegna, Alghero 20004, pp. 341-350; F.VIRDIS, Santa Greca da Decimomannu. Lanuova storia di un culto antichissimo,Monastir 2001; I. CHISESI, Dizionario icono-grafico dei patroni e dei santi della Sardegna,Cagliari 2004, p. 134; B. TOLA,Decimomannu: Il paese, Santa Greca, storia emiracoli, Monastir 2004.
177
Mauro Dadea
Santa Greca:la martire di Decimomannu
Fig. 1 - Santa Greca Vergine e Martire di Decimomannu in una stampadevozionale del XIX secolo
Così, in Sardegna come altrove, se la fede e la tradizione hannotenacemente conservato la memoria di tanti fedeli vissuti neiprimi secoli del cristianesimo, a suo tempo ritenuti degni di spe-cifica venerazione e quindi invocati come santi, oggi, in proposi-to, generalmente mancano quei documenti storici capaci di fardistinguere i personaggi leggendari, inseriti nei calendari locali enei vecchi martirologi ufficiali per i più svariati motivi, da quel-li realmente esistiti2.E in quanto a questi ultimi, generalmente il medioevo nonmancò di colmare le proprie lacune di conoscenza a loro riguar-do inventando di sana pianta biografie e miracoli, di solito in ter-mini tanto inverosimili da indurre gli studiosi moderni a porre indubbio la stessa consistenza storica dei “santi” ispiratori3.Santa Greca, compatrona di Decimomannu, si trova esattamen-te in una simile situazione, per cui, a propria volta, non è potu-ta sfuggire agli attacchi dei critici4. Le fonti informative a suoproposito, infatti, si riducono oggi a pochi elementi di naturaalquanto eterogenea.Non si possiede, cioè, nessun documento storico diretto, comesarebbero una sua biografia antica o gli atti del martirio, ma solouna congerie di fonti a carattere epigrafico, archeologico, monu-mentale ed archivistico che possono testimoniarne unicamentela remota antichità del culto.In ordine cronologico si hanno:1. l’epitaffio attribuito alla santa (V-VI secolo);2. la tomba a camera sotto il presbiterio della sua chiesa a
Decimomannu (V-VIII secolo);3. la chiesa ad corpus medievale (di cui oggi si conserva la sola
area absidale) sorta su questo sepolcro (fine XI secolo);4. vari documenti medievali relativi al monastero femminile
annesso a questa chiesa (XIV-XV secolo, con rimandi internianche ai due secoli precedenti);
5. la inventio seicentesca delle sue reliquie, con relativo corredodi osservazioni antiquarie tramandato dagli scavatori;
6. la chiesa ad corpus nella sua ristrutturazione sei/settecentesca.
- L’epitaffioIn questa occasione sarà necessario limitare l’analisi solo ai primiquattro punti, non essendo ancora disponibili moderne indagininé di scavo archeologico né di stratigrafia muraria che possanoutilmente permettere il riscontro scientifico anche degli ultimidue.Preliminare ad ogni altra possibile considerazione, naturalmen-te, dovrà essere l’esame dell’epigrafe funeraria, partendo dallenotizie più antiche ad essa riguardanti.Essa, secondo la testimonianza del padre Seraffin Esquirro, fuindividuata casualmente nella chiesetta rurale dedicata alla stes-sa Santa Greca, a Decimomannu, sotto l’episcopato di donAntonio Parragues del Castillejo (1558-1573), da alcuni mura-tori che cercavano di recuperare materiali edilizi all’interno del-l’edificio ormai semidiroccato, in vista del suo restauro: «En eltiempo que Don Antonio Parragues de Castilejo, (...) siendoArçobispo de Caller, hizo reedificar esta Iglesia (scil. di SantaGreca), la qual, por ser tan antigua, estava casi toda derribada, en
2 D. FILIA, La Sardegna cristiana, I, Sassari1909, pp. 49-50; R. TURTAS, Storia dellaChiesa in Sardegna dalle origini al 2000,Roma 1999, pp. 36-38.
3 D. FILIA, La Sardegna cristiana cit., pp. 60-61; R. TURTAS, Storia della Chiesa inSardegna cit., pp. 38-47.
4 Una prima messa a punto critica, e conse-guente proclamazione ufficiale della martireGreca a compatrona di Decimomannu, èvenuta dall’arcivescovo di CagliariOTTORINO PIETRO ALBERTI, Santa Greca.Omelia nella festa della santa martire,“Notiziario Diocesano”, XI, 3, 2001, pp.577-580.
178
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
este tiempo que se reedificava se hallò una losa de marmol, en laqual estava grabado un letrero, segun mas abaxo se veera. Estalosa, ignorantemente, fue levada a una otra iglesia muy cerca desta,la qual en esse mismo tiempo se edificava»5.Il primo a valorizzarla, ritenendola attinente al culto, fu a quan-to parrebbe l’arcivescovo don Francisco Del Vall (1587-1595):«Sucedio muchos años despues, en el Arçobispado, Don Franciscodel Vall. Vido este buen Prelado la dicha losa con el letrero, y pre-guntò de donde se havia quitado. Muchos de los que se hallaron pre-sentes quando se havia llevado de su lugar, a essa otra Iglesia quede nuevo se edificò, (...) dixeron que essa piedra la havian tomadade la Iglesia propria de Santa Greca: mandò luego su SeñoriaIllustrissima que la bolviessen alla, y en continiente la bolvierondonde agora està»6.Nonostante l’iniziale ottimismo del padre Esquirro, il quale nel1617 si diceva convinto «que antes que salga a luz la segundaparte desta obra se havra hallado su bendito cuerpo (di santaGreca)»7, le ricerche della sepoltura collegata all’epigrafe ebberoinizio solo molto più tardi, ai tempi dell’arcivescovo donAmbrosio Machin de Aquena, con felice esito conseguito il 18marzo 16338.A quest’ultimo episodio risalgono le più attendibili riproduzionidell’epigrafe, contenute in due diversi manoscritti dell’ArchivioArcivescovile di Cagliari. Una nel volume intitolato ActasOriginales9; l’altra in quello convenzionalmente denominatoCuerpos Santos10 (Fig. 2).
La più antica tra quelle finora conosciute, invece, è la trascrizio-ne che si trova in un manoscritto anonimo, oggi custodito pres-so l’Archivio Storico Comunale di Cagliari11 (figura 3). Di data-zione incerta, il codice deve comunque collocarsi tra la fine del
179
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
5 S. ESQUIRRO, Santuario de Caller y verdaderahistoria de la invencion le los Cuerpos Santoshallados en la dicha Ciudad y su Arçobispado,Caller 1624, p. 493.
6 IBIDEM, pp. 493-494.7 IBIDEM, p. 496.8 Archivio Arcivescovile di Cagliari, Actas ori-
ginales sobre la inbencion de las reliquias deSantos que se hallaron en la Basilica de SanSadorro y otras iglesias y lugares de la Ciudadde Caller y su Diocesis. Con indice de todo locontenido en estas Actas, ms. nr. 13, c. 247r.
9 Archivio Arcivescovile di Cagliari, Actas ori-ginales cit., c. 245r.
10 Archivio Arcivescovile di Cagliari, Copia deauthenticas de Cuerpos Santos que se hansacado del Reyno, y otras varias escrituras per-
contantes a la invencion de los mismosCuerpos Santos, que por duplicados se juntanen este legajo, ms. nr. 14, fasc. 25.
11 Archivio Storico Comunale di Cagliari,Manoscritti Sanjust, vol. nr. 55, c. 130v.
Fig. 2 - L’epitaffio di Greca in Cuerpos Santos (Archivio arcivescovile di Cagliari)
XVI e i primi anni del XVII secolo, perché nel riportare il testodella celebre iscrizione Aula micat12, allora visibile all’ingressodell’ipogeo funerario sotto la basilica di Sant’Antioco, nell’isolaomonima, il suo estensore anzitutto ne travisava lo incipit in Aviamicam, commentandone quindi il contenuto con queste parole:«clare p(ate)t corpus B(eati) Antiochi fuisse conditum in eo tem-plo»13. Se ne deduce che la scoperta delle reliquie del martire sul-citano, risalente il 16 marzo 1615, in quel momento non fosseancora avvenuta14.Presumibilmente contemporanee alla invención delle reliquie diSanta Greca, inoltre, devono essere ritenute le due raffigurazio-ni della relativa lapide inserite nelle Alabanças de los Santos deCerdeña, volume manoscritto di Juan Francisco Carmona con-servato presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari15 (figura 4).
12 CIL X, 7533.13 Archivio Storico Comunale di Cagliari,
Manoscritti Sanjust, vol. nr. 55, c. 133v.14 Archivio Arcivescovile di Cagliari, Actas
originales cit., c. 288v; F. DESQUIVEL,Relacion de la invencion de los Cuerpos Santosque en los años 1614, 1615, 1616 fueron hal-lados en varias Iglesias de la Ciudad de Callery su Arçobispado, Napoles 1617, p. 104.
15 J. F. CARMONA, Alabanças de los Santos deCerdeña, Caller 1631, ff. 36v, 135v(Biblioteca Universitaria di Cagliari, SP 6, 2,31, ms. autografo).
180
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
Fig. 4 - L’epitaffio di Greca nelle Alabanças di Juan Francisco Carmona, c. 36v(Biblioteca Universitaria di Cagliari)
Fig. 3 - L’epitaffio di Greca nel Ms. 55 del Fondo Sanjust dell’Archivio Storico Comunale di Cagliari
Di quegli stessi anni èanche la sua riproduzione astampa nel Triumpho de losSantos del Reyno deCerdeña, pubblicato nel1635 da DionisioBonfant16.L’aveva preceduta l’apogra-fo riportato nel Santuariode Caller del sacerdote cap-
puccino Seraffin Esquirro, che vide la luce nel 162417.A seguire varie trascrizioni più tarde, moltiplicatesi con maggio-re o minore utilità e precisione fino ad oggi, effettuate da JorgeAleo18, Michele Plazza19, Pietro Martini20, Giovanni Spano21,Theodor Mommsen (il quale, per il fatto che fosse tornato allaluce nel Seicento e riferito a una santa, a torto considerò falsol’epitaffio)22, Romualdo Loddo23, Hippolyte Delehaye24, AntonioSailis25, Gabriele Piras26, Agostino Amore27, Raimondo Bonu28,Francesco Colli29, Lorenzo Falanga30, i redattori dell’Année Épi-graphique31, Cecilia Lilliu32, Giovanna Sotgiu33, Antonio Ferrua34,il Dizionario dei santi venerati in Sardegna35, Antonio FrancescoSpada36, Eliseo Lilliu37, Raimondo Podda (solo fotografia della“seconda copia marmorea”)38, Antonio Maria Corda39 eFrancesco Virdis (solo riproduzioni di apografi antichi e fotogra-fie varie)40.Dell’iscrizione, tuttavia, esistono non soltanto riproduzioni car-tacee. Se ne conservano anche due incise sul marmo. La prima, seicentesca, è trascritta sotto una figura a bassorilievodella Santa gisant, cioè rappresentata sul letto di morte o com-posta all’interno della sua sepoltura, un tempo apposta sull’urnacontenente le reliquie, nell’altare maggiore della parrocchiale diDecimomannu (figura 5). Fu realizzata dai marmorari BernartSilva e Augusti Monsonat, come da regolare contratto stipulatoil 17 agosto 163341. Anche se in apparenza meno fedele paleo-graficamente, essa appare comunque più precisa, in alcuni parti-colari contenutistici, rispetto all’altra, di molto posteriore, anco-ra oggi visibile nella chiesa dedicata alla santa (figura 6).
16 D. BONFANT, Triumpho de los Santos delReyno de Cerdeña, Caller 1635, p. 409.
17 S. ESQUIRRO, Santuario de Caller cit., p. 494.18 J. ALEO, Sucessos generales de la Isla y Reyno
de Sardeña, I, Caller 1677, p. 220 (BibliotecaUniversitaria di Cagliari, SP 6, 3, 48, ms.autografo).
19 M. PLAZZA in R. LODDO, Note illustrative suun manoscritto del secolo XVIII con documen-ti epigrafici romani, bizantini e medievali del-l’agro cagliaritano, “Archivio Storico Sardo”,II, 1906, pp. 36-59, p. 50, nr. 23.
20 P. MARTINI, Iscrizione cristiana, “BullettinoArcheologico Sardo”, V, 1859, pp. 116-118,p. 117.
21 G. SPANO, Storia della chiesa di Santa Grecacit., p. 12.
22 CIL X, 1, 1225*. L’atteggiamento ipercriticodel Mommsen, nel caso specifico, è statoesplicitamente contestato da H. DELEHAYE,Recensione a R. Loddo, Note illustrative su unmanoscritto del secolo XVIII con documentiepigrafici romani, bizantini e medievali dell’a-gro Cagliaritano, dans l’ARCHIVIO STORICOSARDO, t. II (1906), p. 36-59, “AnalectaBollandiana”, XXVI, 1907, p. 318, nr. 70:«Mommsen, qui se défiait à bon droit desinscriptions chrétiennes de Sardaigne, dont il aété fait l’etrange abus que l’on sait, n’a pasaccueilli dans le Corpus l’épitaphe de Greca,dont il n’a pu voir l’original et q’il n’a connuevrainsemblablement que par une copie suspec-te. A s’en tenir au texte de l’inscription, celle-ci ne mérite en aucune façon d’être jugéeapocryphe». Forti dubbi sull’autenticità del-l’epigrafe, tuttavia, venivano ancora espressida C. LILLIU, Decimo e il suo territorio. Dalvillaggio preistorico, al latifondo, alla curato-ria, al feudo. Note attorno ai documenti del-l’insediamento umano, “Studi Sardi”, XXVII,1986-1987 (1987), pp. 55-131, p. 82.
23 R. LODDO, Note illustrative cit., pp. 50-51,nr. 23.
24 H. DELEHAYE, Recensione a R. Loddo cit., p.318.
25 A. SAILIS, Il devoto di Santa Greca cit., p. 27.26 G. PIRAS, I santi venerati in Sardegna cit., p.
260.27 A. AMORE, Greca cit., col. 164.28 R. BONU, “E a dir di Sardigna” cit., p. 138.29 F. COLLI, Decimomannu cit., p. 69.30 L. FALANGA, Albori del Cristianesimo in
Sardegna. Quando il cristianesimo è approda-to nell’Isola?, “Campania Sacra”, 13-14,1982-1983, pp. 17-56, p. 22.
31 AEp. 1984, 443.32 C. LILLIU, Decimo e il suo territorio cit., p.
82.33 G. SOTGIU, L’epigrafia latina in Sardegna
dopo il CIL X e l’EE VIII, “ANRW”, II, 11,I, Berlin-New York 1988, pp. 553-739, p.635, B108a.
34 A. FERRUA, Segnalazioni, “La CiviltàCattolica”, CXLV, 3, 1994, pp. 103-104 (produbia).
35 Dizionario dei santi venerati in Sardegna cit.,p. 108.
36 A.F. SPADA, Storia della Sardegna cristianacit., p. 190.
181
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
Fig. 6- Decimomannu - Santuario di Santa Greca.“Seconda copia marmorea” dell’epitaffio di Greca
Fig. 5 - Decimomannu - Santuario di Santa Greca. “Prima copia marmorea”dell’epitaffio di Greca
Quest’ultima parrebbe una copia (che si sarebbe voluta imita-zione precisa) di quella antica, la quale purtroppo deve conside-rarsi dispersa.Cosa rende certi che questa seconda lapide rappresenti unariproduzione moderna, e non invece l’originale, come pure variautori (Pietro Martini42, Giovanni Spano43, Arrigo Solmi44,Romualdo Loddo45, Hippolyte Delehaye46, Francesco Lanzoni47,Damiano Filia48, Agostino Amore49, Francesco Colli50 e LorenzoFalanga51) hanno sostenuto, anche recentemente?Innanzi tutto, è sufficiente osservare il supporto epigrafico dalpunto di vista tecnico. Il profilo della lastra marmorea risultatroppo regolare e i suoi stessi caratteri paleografici appaionoeccessivamente statici e pedissequamente imitati da un modelloormai lontano dalla sensibilità grafica dello scalpellino, che sideve quindi presumere attivo in età moderna52.Non si tratta però di un inganno ma di una copia, una sorta di“bella copia”, realizzata appositamente per impreziosire l’altarecon un oggetto che emanasse il fascino dell’antico e garantissel’autenticità del suo sacro deposito. Colui che materialmente laincise, con molta probabilità, dovette essere il marmoraroGiovanni Battista Franco, che nel 1820 innalzò l’altare in onore diSanta Greca nella cappella laterale che ne ospita il cenotafio, tut-tora visibile attraverso un oculo praticato al centro del paliotto53.Tra Sette e Ottocento, in tutto il mondo cattolico, furono innal-zati numerosi altari in onore di “corpi santi”, specie romani54, neiquali è molto comune trovare copie delle rispettive lapidi fune-rarie (sia incise, sia dipinte) i cui originali, magari, erano statideposti in qualche museo. Questo, ad esempio, fu il caso uni-versalmente celebre di Santa Filomena, “corpo santo” estrattodalle catacombe romane nel 1802 e traslato nella chiesa di SantaMaria delle Grazie a Mugnano del Cardinale nel 1805, il cui epi-taffio poté ricongiungersi alle relative reliquie solo nel 1828, perespressa volontà del pontefice Leone XII55.Che la lastra esposta nella chiesa di Decimo non sia l’originale,comunque, risulta soprattutto dal suo raffronto con gli apografipiù antichi. Ecco la trascrizione scientifica dell’epitaffio, condot-ta a partire dalle sue riproduzioni contenute negli Actas origina-les e in Cuerpos Santos. Si trattava di una lastra in marmo bian-co (mabre blanch56) della quale, purtroppo, i cronisti seicenteschinon hanno tramandato le misure, con iscrizione incisa in letterecapitali quadrate elegantemente apicate, la cui vocale A presen-tava la traversa spezzata:
1. ((cristogramma decussato)) ((alpha)) ((cristogramma decus-sato)) ((omega))
2. B(onae) ((fronda)) ((cristogramma astriforme)) ((fronda))m(emoriae) ((fronda)) Greca (!) ((cristogramma decussato))
3. quiescet (!) in pace,4. vixit annis ((fronda)) XX, ((palma))5. m(ensibus) ((fronda)) II, ((fronda)) d(iebus) ((fronda))
XVIIII, ((cristogramma decussato))6. deposita ((colomba a ds. con ramo d’ulivo nel becco))7. pridie Idus Ianuarias.
(12 gennaio)
37 E. LILLIU, Iconografia dei santi sardi cit., p.121.
38 R. PODDA, Santa Greca cit., p. 9.39 A.M. CORDA, Le iscrizioni cristiane della
Sardegna anteriori al VII secolo, Città delVaticano 1999, p. 145, DEC001.
40 F. VIRDIS, Santa Greca cit., pp. 49-54, 72,81, 83.
41 F. VIRDIS, Artisti e artigiani in Sardegna inetà spagnola, Serramanna 2006, pp. 71-72.
42 P. MARTINI, Iscrizione cristiana cit., p. 118.43 G. SPANO, Storia della chiesa di Santa Greca
cit., p. 12.44 A. SOLMI in R. LODDO, Note illustrative cit.,
p. 51.45 IBIDEM, pp. 50-51.46 H. DELEHAYE, Recensione a R. Loddo cit., p.
318.47 F. LANZONI, La prima introduzione dell’epi-
scopato e del cristianesimo nell’isola diSardegna, “Archivio Storico Sardo”, XI,1915 (1916), estratto, p. 12, nota 5.
48 D. FILIA, La Sardegna cristiana cit., pp. 51-52, nota 3.
49 A. AMORE, Greca cit., col. 166.50 F. COLLI, Decimomannu cit., pp. 69-70.51 L. FALANGA, Albori cit., p. 22.52 Di analogo avviso anche F. VIRDIS, Santa
Greca cit., p. 81, il quale osserva: «Si puòcredere che questa lapide cristiana del IVsecolo sia arrivata fino a noi senza un graffioné un frattura dopo essergli cascata la chiesasopra?».
53 IBIDEM, p. 152.54 Su tale problematica, limitatamente alla
Sardegna, cfr. M. DADEA, Le reliquie di SanValentino Martire venerate a Ozieri: prove-nienza e problematiche di natura storico-teolo-gica, in Duecento anni al servizio del territorio(1803-2003), Atti dei Convegni di Studi inpreparazione al Bicentenario della Diocesi diOzieri, a cura di T. Cabizzosu, Sassari 2003,pp. 125-145.
55 S. SANTUCCI, Sulla lapide sepolcrale di SantaFilomena Vergine e Martire, Roma 1837, pp.1-2: «La detta lapide, stanteché tenevasi inmolto pregio per la sua rarità, si volle con-servare nel tesoro delle sacre antichità; mapure nell’anno 1828 fu trasmessa alla dettachiesa, e collocata presso il corpo della SantaVergine e Martire».
56 Archivio Arcivescovile di Cagliari, Actasoriginales cit., c. 244r.
182
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
R. 1: Totalmente omessa da Ms. Sanjust, Piras, Amore, Bonu,Falanga, Année Épigraphique, Sotgiu e Corda; Spada riporta soloil cristogramma decussato semplice; Aleo colloca le lettere apo-calittiche non ai lati del secondo cristogramma ma entrambe allasua destra; E. Lilliu indica la sola alpha e omette la omega; nella“seconda copia marmorea”, in Martini, Spano, Plazza in Loddo,Colli, C. Lilliu e Dizionario dei santi, ai lati del secondo cristo-gramma mancano le lettere apocalittiche;R. 2: BEATA MARTYR Piras; Ms. Sanjust indica tutti gli elementivegetali stilizzati con funzione diacritica come piccole crocettedecussate; Aleo e Spada premettono al testo una crocetta;Esquirro, Bonfant e Aleo (seguiti più tardi da Martini, Spano,Mommsen, Plazza in Loddo, Sailis, Colli, Dizionario dei santi,Ferrua, E. Lilliu) trasformano in crocette tutti i segni di inter-punzione fitomorfi disseminati nel testo; Delehaye, Piras,Amore, Bonu, Falanga, Année Épigraphique, Sotgiu, Corda eSpada omettono tutti i segni diacritici e tutti i simboli; Esquirro,Bonfant, Aleo, “prima copia marmorea”, Mommsen, Sailis,Ferrua ed E. Lilliu normalizzano il cristogramma astriforme incristogramma decussato; Martini, Spano, Plazza in Loddo, Collie Dizionario dei santi non specificano il tipo di cristogramma;GRECA per GRAECA; CRECA Ms. Sanjust; R. 3: QVIESCET per QVIESCIT; Plazza in Loddo, Delehaye, Amore,Bonu, Falanga, Année Épigraphique, Sotgiu e Corda QVIESCIT;Sailis QVIEXIT; Piras QVIEX(V)IT;R. 4: ANIS Aleo; ANNOS Falanga, Année Épigraphique, Sotgiu eCorda; ANNIS 20 Piras; XXX Carmona e Corda;R. 5: MENSES Delehaye; M(ENSES) Année Épigraphique, Sotgiu eCorda; MENSIBVS DVOBVS Piras; DIEBVS 19 Piras; DIES Delehaye;D. VIIII Carmona c. 36v; D(IEBV)S “prima copia marmorea”; DVXVIII Plazza in Loddo; XVIII Aleo, Amore, Bonu, Colli, Falanga,C. Lilliu, Spada; D(IES) XVIII Année Épigraphique, Sotgiu e Corda;cristogramma astriforme in Ms. Sanjust; nella “seconda copiamarmorea”, in Martini, Spano e Dizionario dei santi dopo XVIIIInon viene riportato il cristogramma;R. 6: DIPOSITA Plazza in Loddo; gli apografi manoscritti di Actasoriginales, Cuerpos Santos, Carmona e Plazza in Loddo segnanoqui una colomba noetica, che però non compare né in Esquirroe Bonfant, né nella “seconda copia marmorea”, né in tutti glialtri autori successivi; Ms. Sanjust indica qui un cristogrammaastriforme, e la “prima copia marmorea” sostituisce la colombacon un segno sostanzialmente identico alla lettera alpha ivi acco-stata al secondo cristogramma della r. 1, seguito da un elementovegetale stilizzato;R. 7: tra le parole IDVS e IANVARIAS Bonfant, Aleo, Mommsen,Ferrua ed E. Lilliu inseriscono una crocetta; nella “seconda copiamarmorea” INNVARIAS, con nasale geminata in nesso; IANVVA-RIAS Martini, che legge un nesso -ANV-; IANVARIVS Sailis; JAN-VARIAS Piras; IANVARIAE Amore e Bonu.
Come mai tante imprecisioni, soprattutto da parte del marmistaottocentesco? Evidentemente si deve pensare che gli fosse statofornito un modello incompleto, reperito chissà dove.L’iscrizione originale era probabilmente scomparsa, chissà quan-do e chissà per quale motivo. Come la quasi totalità delle cin-quecento iscrizioni tornate alla luce durante gli scavi seicente-
183
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
schi alla ricerca dei Cuerpos Santos, conservate oggi solo in mini-ma parte57.Sembra comunque che verso il 1760 fosse ancora al suo posto.In quell’anno infatti Michele Plazza, un appassionato di antichi-tà che ricopriva la cattedra di chirurgia presso l’Università diCagliari, la vide «nel laterale della chiesa di Santa Greca aDecimomannu» e la trascrisse nei seguenti termini58:
(monogramma) (monogramma)B � (monogramma) � M � GRECA (monogramma)QVIESCIT IN PACEVIXIT ANNIS � XX �M � II � DV XVIII (monogramma)DIPOSITA (uccello)PRIDIE IDVS IANVARIAS
L’apparato iconografico, come prova soprattutto la presenza dellacolomba (definita genericamente uccello), non è quello dellacopia ora visibile ma appartiene senza dubbio all’archetipo, tra-mandato nelle trascrizioni manoscritte seicentesche.Nel dettaglio, tale corredo simbolico appare tra i più ricchi del-l’intero repertorio epigrafico cristiano della Sardegna59, annove-rando:
- cinque cristogrammi, dei quali uno astriforme e unoaffiancato dalle lettere apocalittiche αω;
- sette segni diacritici fitomorfi;- un ramo di palma;- la colomba noetica.
Tutto questo, ben più della famigerata abbreviatura B.M. impro-priamente interpretata b(eata/-us) m(artyr), convinse gli scavato-ri seicenteschi che si trattasse dell’epigrafe funeraria di una mar-tire antica60.I segni più importanti, al riguardo, in ambito erudito pre-archeo-logico erano considerati i rami di palma. La palma, sulla scortadel dettato scritturistico (2Macc. 14, 4; Gv. 12, 13; Ap. 7, 9),dagli scavatori seicenteschi sardi era ritenuta l’unico vero e pro-prio simbolo di trionfo e di martirio. Si legge ad esempio nellaRelación dell’arcivescovo Desquivel, a proposito di quei defuntisugli epitaffi dei quali compariva questo simbolo, che «las palmas(como nota Baronio) nos deven bastar para que sin ningun rezelolos tengamos por santos martyres»61. Lo stessa credenza, contem-poraneamente, era infatti condivisa dagli scavatori delleCatacombe romane62. Ludovico Antonio Muratori ne dimostròl’assoluta infondatezza63 ma nonostante ciò, ancora nel XIX seco-lo, taluni esperti di erudizione ecclesiastica rimanevano convintiche “la palma collocata presso la croce addita il martirio soffer-to per la religione: qualche volta questo segno sacro era espressocon il sangue stesso dei martiri”64.La colomba noetica invece, sempre sulla base della SacraScrittura, era considerata simbolo non solo di salvezza e di resur-rezione (Gn. 8, 10-12), ma anche di verginità e di purezza (Es.8, 8-12, Cant. 6, 9; Mt. 10, 16): rivelatore, in tal senso, un altropasso di don Francisco Desquivel riguardante i mattoni checoprivano le tombe di certi presunti vescovi, anonimi, tornatialla luce nel 1614 nella basilica di San Saturnino a Cagliari:«Sabemos que en los Cementerios y Cathacumbas Romanas la
57 M. DADEA, Alle origini di Cagliari cristiana,in M. DADEA - M.C. DI NATALE - G. LIOTTA,San Giusto Patrono di Misilmeri, Palermo2000, pp. 11-65, con precedente bibliografiasull’argomento a p. 38, nota 113.
58 M. PLAZZA in R. LODDO, Note illustrativecit., p. 50.
59 Riassuntivamente su questo tema cfr. A.M.CORDA, Il simbolismo nelle iscrizioni paleocri-stiane della Sardegna, in La Sardegna paleo-cristiana tra Eusebio e Gregorio Magno, Attidel Convegno Nazionale di Studi (Cagliari,10-12 Ottobre 1996), a cura di A. MASTINO,G. SOTGIU, N. SPACCAPELO con la collabora-zione di A. M. CORDA, Cagliari 1999, pp.49-64.
60 Per una valida sintesi della ben nota vicen-da storiografica cfr. R. TURTAS, Storia dellaChiesa in Sardegna cit., pp. 35-36.
61 F. DESQUIVEL, Relación cit., p. 50.62 G. FERRETTO, Note storico-bibliografiche di
Archeologia Cristiana, Roma 1942, pp. 249-250.
63 L.A. MURATORI, De Christianorum venera-tione erga Sanctos post declinationem romaniimperii, Dissertatio LVIII, in AntiquitatesItalicae Medii Aevi, Mediolani 1741, coll. 1-60, col. 33.
64 G. MORONI, s.v. Croce, crux, in Dizionario dierudizione ecclesiastica da San Pietro ai nostrigiorni, Venezia 1843, XVIII, pp. 226-234, p.229. Al segno della semplice palma furonoriconosciuti alcuni Corpi Santi “cemeteriali”ancora verso il 1850, come posto in eviden-za, sulla base di documenti ufficiali trattidalla Lipsanoteca del Vicariato, da A.FERRUA, Introduzione a G.B. DE ROSSI, Sullaquestione del Vaso di Sangue. Memoria inedi-ta con introduzione storica ed appendice didocumenti inediti, Città del Vaticano 1944,pp. VII-CII, p. XXVIII, nota 2.
184
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
palma es claro argumento de Martyr, y la paloma de Virgen, ybastales a los que andan en ellas para tener y venerar por reliquiasde Martyres y Virgines hallar esculpidas en sus sepulturas palmas,palomas o coronas, lo mesmo nos deve bastar a nosotros»65.Gli antichi scavatori delle Catacombe romane, inoltre, riteneva-no un vero e proprio simbolo martiriale anche il semplice mono-gramma costantiniano, che veniva letto P(ro) X(risto), intenden-do sottintesa la parola passa/-us66. Più sfumata, al riguardo, erainvece la posizione degli archeologi sardi. La presenza sull’epi-grafe della «cifra del sagrado nombre de Christo»67, ai loro occhi,dovette comunque rivestire un significato tutt’altro che generi-co, potendo con ogni verosimiglianza essere stata riferita allaconvinzione secondo cui, essa, avrebbe rappresentato un «gran-de indicio y señal particular de la santidad del cuerpo y personapara quien el tal letrero y losa se puso»68.Agli occhi degli studiosi moderni, al contrario, sono proprio i cri-stogrammi che dichiarano l’epigrafe databile almeno al IV seco-lo69. Cioè a un periodo comunque posteriore alle persecuzioni diDiocleziano, cui come al solito la tradizione popolare o semidot-ta, in mancanza di dati storici certi, ha voluto riportare anche ilmartirio di Santa Greca.La presunta vicenda biografica della martire decimese, per laprima volta, si trova sintetizzata in capo a un libriccino di pre-ghiere in lingua sarda, stampato a Cagliari nel 1788 in sa stam-peria de Bernardu Titard, dove si legge: «Sa gloriosa Virgini eMartiri Sant’Arega naxisidi in Deximu Mannu. No si podit dudaide is bonus costuminis de custa Santa Piccinna, essenduru istadadigna de cunsighiri sa corona de su martiriu. In tempus de suImperadori Dioclezianu, fudi stetida obbligada a negai sa ReligioniCristiana, qui professada. Però issa constanti in sa Fidi de GesuCristu suffrisit crudelissimus aciotus, di trapassesinti sa conca cuntres obilus: morgisit finalmenti cun animu intrepidu a filu de ispa-da. Is Cristianus arregollendu secretamenti su Corpus, d’hiantinterrada in unu logu, aundi esti sa Cresia. Custu tesoru esti isteti-du medas annus occultu, poxindi si funti incontradas is sagradasRelichias; e restanta in sa propria Bidda de Deximu Mannu. Pointercessioni de custa gloriosa Santa non lassat Deus nostu Segnoride cuncediri a is mortalis singularis favoris»70.Si tratta, evidentemente, del solito e innocuo assemblaggio diluoghi comuni agiografici, con l’intrepida giovinetta sottoposta avarie torture e poi decapitata sotto l’imperatore ritenuto il piùcrudele nemico dei cristiani. In un’altra edizione antica dellostesso libretto devozionale, stampata senza data né indicazionitipografiche e trascritta dallo Spano nel 187671, quale presuntoriferimento storico spicca anche il nome del preside Flaviano,qui diretto persecutore della martire, già conosciuto come emis-sario in Sardegna di Diocleziano grazie alla passio di Sant’Efisio72.Questa tradizione “dioclezianea” per il martirio di Santa Grecadeve considerarsi di origine piuttosto recente. Gli scavatori sei-centeschi, infatti, erano già perfettamente consapevoli di come lapresenza di cristogrammi, sulle iscrizioni, presupponesse unaloro datazione ad età postcostantiniana. Ad esempio l’arcivesco-vo di Sassari don Gavino Manca de Cedrells, commentando l’i-scrizione funeraria di Marcellus e Petronia scoperta nel 1614 aPorto Torres, faceva di loro due martiri della persecuzione van-dalica «por las notas de las Cruzes constantinianas, que contienen
65 F. DESQUIVEL, Relación cit., pp. 42-43.66 Ne trattò diffusamente, contestandone l’a-
busivo utilizzo ancora nel 1793, G. DICOSTANZO, Ragionamento sopra le tombedegli antichi cimiterii cristiani e sopra i segniche distinguono quelle dei martiri dalle altredei semplici fedeli, in Appendice a G.B. DEROSSI, Sulla questione del Vaso di Sangue cit.,pp. 130-150, pp. 142-143, facendo notareche perfino il papa Benedetto XIV (1740-1758) inizialmente ammise la validità di unasimile interpretazione. Si veda infattiBENEDICTI XIV olim P. DE LAMBERTINIS,Opus de Servorum Dei beatificatione etBeatorum canonizatione, I-VII, Prati 1842, l.4, p. 2, c. 27, n. 18.
67 J.F. CARMONA, Alabanças cit., c. 18r.68 F. BASTELGA, Relación sumaria y verdadera
de todo lo que ha sucedido y de la multitud decuerpos de Santos que se han hallado en laIglesia de San Gavino de Torres, que estásituada y plantada fuera de la Ciudad deSacer, distante della doze millas, junto al mary puerto de Torres de la dicha Ciudad, ázia laparte que el sol se pone, en el Reyno deCerdeña, Barcelona 1615, c. 17v.
69 D. MAZZOLENI, Origine e cronologia deimonogrammi: riflessi nelle iscrizioni dei MuseiVaticani, in Le iscrizioni dei cristiani inVaticano. Materiali e contributi per unamostra epigrafica, a cura di I. Di StefanoManzella, Città del Vaticano 1997, pp. 165-171.
70 Novena de sa gloriosa Santa Arega Sarda cit.,pp. 1-2. Testo integralmente trascritto ancheda F. COLLI, Decimomannu cit., pp. 102-103.
71 G. SPANO, Storia della chiesa di Santa Grecacit., p. 25.
72 P. MELONI, Sul valore storico di alcuni riferi-menti contenuti nelle passioni dei martirisardi, in Atti del Convegno di studi religiosisardi (Cagliari, 24-26 maggio 1962), Padova1963, pp. 56-66.
185
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
juntamiente el nombre de Christo abreviado, las quales tuvieronprincipio desde el tiempo del gran Constantino, a quien fue enseña-da del Cielo semejante señal, (...) como es de ver en Eusebio,Sozomeno y otros escritores de aquellos tiempos, y en el CardenalCesar Baronio, el qual trae una Cruz semejante, hallada en el cemi-terio de Priscillla, con el epitafio de Marciano, por testimonio deaquellos siglos»73.Essendo l’epigrafe della ventenne Greca successiva al periododelle persecuzioni romane, dunque, Hippolyte Delehaye perprimo ritenne che il culto nei suoi confronti avesse banalmentetratto origine dall’erroneo scioglimento, in B(eata) M(artyr),della formula elogistica abbreviata b(onae) m(emoriae) in apertu-ra di testo. Egli riteneva, cioè, che Santa Greca fosse una delletante presunte martiri sarde, identificate come tali nel Seicentosulla base di un’errata lettura della loro iscrizione funeraria74.Nonostante la sua opinione sia stata poi seguita da FrancescoLanzoni75, Agostino Amore76, Lorenzo Falanga77 e, ultimamente,da Réginald Grégoire78, il Delehaye in questo si ingannava.Infatti seppure questa epigrafe, agli occhi degli studiosi moderni,manchi di esplicite dichiarazioni circa la santità e il martirio dellaventenne Greca, il culto della compatrona di Decimomannu ècertamente più antico del XVII secolo. Lo provano svariati ele-menti archeologici e monumentali.
- L’ipogeoIl primo, in ordine di tempo, è costituito dall’ipogeo a cameracostruita sottostante il presbiterio della chiesa di Santa Greca aDecimomannu, il cosiddetto “carcere della santa”. Molto proba-bilmente si tratta, in realtà, di una tomba proto-bizantina, di V-VIII secolo, rispondente a una tipologia ben conosciuta in tuttala Sardegna79.La parola bizantina obbliga, a questo punto, l’apertura di almenouna parentesi circa una recente ipotesi, formulata già da CeciliaLilliu nel 1987, da Antonio Francesco Spada nel 1993 (ignoran-do la prima) e poi da Francesco Virdis (che mostra di non cono-scere i lavori dei due precedenti studiosi) nel 2001, secondo cuila santa Greca di Decimomannu non sarebbe stata una martirema una monaca bizantina80.Il supporto documentale, per i tre autori, consisterebbe nel sar-cofago di una Greca monastria, di scalpello romano ma recanteuna più tarda epigrafe in greco, relativa a un suo probabile riuti-lizzo, che viene generalmente datata tra il V e il VI secolo81.Il suo formulario, però, esclude assolutamente che la defuntafosse stata considerata degna di venerazione: ((croce))Μνησθητι Κ(υρι)ε της δουλης / <σ>ου Γρεκα µωναστρηααµ/η<ν>. Αναθεηα εσχουσην / τον αγηων τρηακοσηω/νεξηκοντα πεντε πατ/ερον ω/η εχσανυξη το λαρν/ακι τουτοωτη οδε ουδ/ε χρυσαϕη ουδε αρσηµη (Ricordati, o Signore,della tua serva Greca monaca, amen. Incorrerà nell’anatema deiSanti trecentosessantacinque Padri chiunque aprirà questa cassa,perché qui non c’è né oro né argento)82.Ben lungi dall’ammettere una simile eventualità, infatti, l’iscri-zione non soltanto tace positivamente sulla presunta santità eticadi questa religiosa, ma anzi la mette apertamente in dubbio
73 G. MANCA DE CEDRELLES, Relacion de lainvencion de los cuerpos de los IllustrissimosMartyres San Gavino, San Proto y SanJanuario, Patrones de la YglesiaMetropolitana Turritana, que se han halladocon otros Santos, por el mes de Junio 1614 enel templo dedicado a los mismos Santos de laCiudad antigua de Torres en el Reyno deSerdeña, Madrid 1615, c. 22r/v.
74 H. DELEHAYE, Recensione a R. Loddo cit., p.318.
75 F. LANZONI, La prima introduzione cit., p. 12,nota 5.
76 A. AMORE, Greca cit., col. 164, in terminipiuttosto contraddittori o quantomeno ana-cronistici, dopo aver riferito alcune dellefonti medievali relative al monastero dedica-to alla santa, sostiene che «molto probabil-mente il nome e il culto di Greca dipendonoda un’iscrizione del secolo IV o V, alla qualeaccennano documenti del secolo XVI, mache fu riscoperta solo all’inizio del secoloXVII».
77 L. FALANGA, Albori cit., pp. 23-24.78 R. GRÉGOIRE, Introduzione all’antica lettera-
tura agiografica sarda, in Oriens radiata ful-gore. La Sardegna nel contesto storico e cultu-rale bizantino, Atti del Convegno di Studi(Cagliari, 30 novembre - 1 dicembre 2007),a cura di L. Casula, A.M. Corda e A. Piras,Cagliari 2008, pp. 133-176, p. 160.
79 Su questi particolari monumenti funeraricfr. da ultimo P.B. SERRA, Documenti di etàalto-medievale: la tomba a camera in muratu-ra voltata a botte in località San Costantino,in Villa dei Greci. Una Villagreca inedita trastoria, archeologia ed arte, a cura di N. Rossie S. Meloni, Dolianova 2007, pp. 65-73, conbibliografia precedente.
80 C. LILLIU, Decimo e il suo territorio cit., pp.82-83; A.F. SPADA, Storia della Sardegna cri-stiana e dei suoi Santi. Il primo millennio,Oristano 1994, pp. 190-192; F. VIRDIS,Santa Greca cit., pp. 55-62.
81 G. SPANO, Sarcofago greco del Regio Museodi Cagliari, “Bullettino Archeologico Sardo”,V, 11, 1859, pp. 164-167; C. CAVEDONI,Annotazioni sopra l’iscrizione greca del RegioMuseo, “Bullettino Archeologico Sardo”, VI,4, 1860, pp. 51-56; A. TARAMELLI, Guida delMuseo Nazionale di Cagliari, Cagliari 1915,p. 102, nr. 42; A. FERRUA, Gli anatemi deipadri di Nicea, “La Civiltà Cattolica”, 107,1956, IV, pp. 378-387, ora anche in A.FERRUA, Scritti vari di epigrafia e antichitàcristiane, Bari 1991, pp. 274-283, in partico-lare pp. 279-281; A. FERRUA, Un’iscrizionegreca medioevale di Sardegna, “Epigraphica”,XVIII, 1956, pp. 94-103; G. PESCE,Sarcofagi romani di Sardegna, Roma 1957,pp. 43-44, nr. 14; M. VAVASSORI, Una lapidee un battistero paleocristiani a Noli, “Rivistadi Studi Liguri”, XXXIX, 1, 1973, pp. 45-63,p. 49; L. PANI ERMINI - M. MARINONE,Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.Materiali paleocristiani ed altomedioevali,Roma 1981, pp. 50-51, nr. 81; G. SOTGIU,L’epigrafia latina in Sardegna cit., pp. 648-649, B175; A.M. CORDA, Le iscrizioni cri-stiane della Sardegna cit., pp. 73-74,CAR034.
82 La definitiva interpretazione del notevol-mente sgrammaticato testo greco e la sua tra-duzione italiana sono di A. FERRUA, Gli ana-temi dei padri di Nicea in Scritti vari cit., p.281.
186
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
dichiarando la sua anima bisognosa di suffragi. Né sembra che,in subordine, l’epigrafe possa essere stata oggetto di un eventua-le equivoco interpretativo antico, non convenendo certamente,alla tomba di una santa, un simile formulario corredato diminacciosi anatemi contro i suoi eventuali violatori, cupidi d’ar-gento e d’oro83.Ma ancora non è tutto. La Lilliu, lo Spada e il Virdis, infatti,attribuiscono proprio a Decimomannu l’epitaffio di questaΓρεκα µωναστρηα che Giovanni Spano, suo primo editore,semplicemente vedeva «entrando a man sinistra nel gabinettolapidario del Regio Museo di Cagliari (...) incastrato in alto delmuro», dichiarando contestualmente che «non si sa dove ilmedesimo sia stato scoperto» e suggerendo pertanto, a mero tito-lo di ipotesi, che fosse stato «trasportato dalle catacombe cristia-ne verso Fangariu, dove pure fu rinvenuto il piccol cippo grecodi Metistria»84.L’esatta provenienza di questa iscrizione, dunque, rimane pur-troppo ignota. Il sarcofago, attualmente ridotto alla sola spondaanteriore, è uno dei primi reperti immessi nel MuseoArcheologico Nazionale di Cagliari, fin dai tempi della sua fon-dazione (1802)85. La sua origine, quindi, potrebbe essere stataperfino extrainsulare, come tra l’altro potrebbero indicare le dra-stiche mutilazioni cui esso fu sottoposto, per essere trasportatocon maggiore facilità86.Di conseguenza, quantomeno, allo stato attuale mancano deltutto le prove (e anche i semplici indizi) per fare della SantaGreca tradizionalmente venerata a Decimomannu una monacabizantina87.Tuttavia, ribaltando i termini della questione, sulla base di qualielementi si potrebbe affermare, al contrario, che si sia trattato diuna martire locale più antica?La presumibile tomba a camera ipogeica, vandalica o protobi-zantina, presente sotto la chiesa di Santa Greca a Decimomannu,a quanto parrebbe nel corso del medioevo fu ritenuta degna divenerazione, essendo munita di altare, inglobata proprio all’in-terno dell’area presbiteriale e resa accessibile tramite una rampadi scale interna88. Ecco la descrizione dell’intero complesso usci-ta dalla penna del padre Esquirro: «Antes de reedificarse, estaIglesia era mas grande porque tenia, a mano derecha entrando, unacapilla larga 30 palmos y ancha 24 palmos. Agora la que se ha ree-dificado en el mismo sitio y lugar, encima de los fundamientos anti-guos, y queda larga 42 palmos y ancha 10, tiene el Altar en altoque se sube con seys gradas, y de baxo del Altar una Capilla sotter-ranea, muy grande, tiene la puerta dentro de la misma Iglesia, a laparte de la Epistola, y se baxa a ella con nueve escalones. Es estaCapilla alta catorze palmos, es a saber del suelo hasta la boveda, eslarga 24 palmos y ancha catorze: tiene al derredor una moldura ocorniza. (...) Ay dentro de la misma Capilla un Altar»89.Per quanto se ne sappia, è anche probabile che l’edificio proto-romanico sia sorto in sostituzione di un altro più antico: la cer-tezza, tuttavia, potrà venire solo da specifiche indagini archeolo-giche, le quali ancora attendono di essere effettuate.Del fatto che l’ipogeo funerario fosse stato il sepolcro originariodi Santa Greca era convinto il padre Esquirro, il quale perento-riamente affermava: «Dentro desta Capilla esta el cuerpo de la bie-naventurada Santa Greca»90. Questo probabilmente perché, a suo
83 A.M. CORDA, Le iscrizioni cristiane dellaSardegna cit., p. 73, a proposito del formula-rio di questa iscrizione osserva: «L’incipit,molto sentito, contiene una preghiera direttaal Signore perché non dimentichi la propriaserva; una tale espressione, se non propriofrequente, è comunque un luogo abbastanzacomune all’epigrafia cristiana».
84 G. SPANO, Sarcofago greco del Regio Museodi Cagliari cit., p. 164 e nota 1.
85 G. LILLIU, Origine e storia del MuseoArcheologico Nazionale di Cagliari, in Ilmuseo archeologico nazionale di Cagliari, acura di V. Santoni, Sassari 1989, pp. 11-20,p. 20.
86 G. PESCE, Sarcofagi romani di Sardegna cit.,p. 43, così descrive il reperto: “Sono statesegate le parti estreme a destra e a sinistra ela zona superiore per tutta la sua lunghezza.Di essa è stata risparmiata la metà retrostan-te per un’altezza di m. 0,02 e per una lar-ghezza di m. 0,04. Il taglio alle estremità èineguale; in basso è ad angolo retto, in alto èa squadro. Nel resto il rilievo è discretamen-te conservato. Scalpellato è pure il listelloinferiore nella sua parte sinistra”.
87 M. DADEA, Recensione a FRANCESCO VIRDIS,Santa Greca da Decimomannu. La nuova sto-ria di un culto antichissimo, Decimomannu2001, “Biblioteca Francescana Sarda”, X,2002, pp. 431-437.
88 R. CORONEO. Storia dell’arte in Sardegna.Architettura romanica dalla metà del Mille alprimo ’300, Nuoro 1993, p. 39, sch. 4.
89 S. ESQUIRRO, Santuario de Caller cit., p. 494.90 IBIDEM, p. 494.
187
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
tempo, l’arcivescovo Del Vall vi aveva fatto collocare l’epigrafedella ventenne Greca (con cognizione di causa o per semplicimotivi contingenti?)91, come si apprende dall’anonimo mano-scritto agiografico cinque-seicentesco del Fondo Sanjust, giàricordato: «In Eccl(esi)a oppidi de Decimo Manno, quae vocaturSanta Rega, quae habet infra terram aliam Ecclesiam p(rae)tersuperiorem cum suo altari, aderat lapis q(ui) in altari alteri(us)novae Eccl(esi)ae postea translatus fuit»92. La notizia dell’avvenu-to trasferimento dell’epigrafe nella chiesa superiore trova confer-ma presso l’Esquirro, che negli anni iniziali del XVII secolo vede-va «la losa sobredicha en el primero escalon, que es el pavimientode la Iglesia, 6 palmos en alto en la misma pared»93.In alternativa a questa ipotesi, potrebbe anche darsi che il sot-terraneo abbia rappresentato la monumentalizzazione di un pre-cedente sepolcro, in origine di più semplice struttura; o addirit-tura che sia stato costruito a scopo rappresentativo (quindi uncenotafio). Anche in questo caso, tutta-via, finché l’area non sarà sottoposta aregolari indagini archeologiche, in pro-posito non potrà affermarsi niente disicuro.Un dato nuovo, comunque, risulta dedu-cibile dalla stratigrafia muraria della suaopera isodoma. Si tratta in questo caso diun elemento che finora non era mai statoposto nel giusto rilievo. Risulta evidente,infatti, come a un certo momento lavolta originale sia stata sfondata e note-volmente rialzata, senza dubbio per ren-dere più agevole la frequentazione dell’i-pogeo da parte dei devoti. Il particolarerisulta chiarissimo specie osservando laparete di fondo, in cui la ristrutturazionemedievale ha risparmiato la bassa centi-na d’appoggio della copertura più antica
91 Il dubbio è insinuato da F. VIRDIS, SantaGreca cit., pp. 78-79, secondo il quale «lariedificazione della chiesa superiore come eranell’antico non è stata realizzata né durantel’episcopato del Parragues né al tempo di DelVall. (...) Molto probabilmente, quando itesti dichiarano che si fa la festa della santaogni anno nella sua chiesa, si riferiscono auna celebrazione liturgica nella cripta».L’affermazione, però, sembra basarsi sullalettura imprecisa di un passo dell’Esquirro,che contrariamente a quanto ritenuto dalVirdis mostra di conoscere e descrive conprecisione sia la chiesa di Santa Greca rico-struita nel sopraterra, sia l’ambiente ipogeicoad essa sottostante.
92 Archivio Storico Comunale di Cagliari,Manoscritti Sanjust, vol. 55, c. 130v.
93 S. ESQUIRRO, Santuario de Caller cit., p. 494.Terminologicamente, l’Esquirro distinguevain modo netto quella da lui chiamata Iglesia,cioè l’edificio subdiale, dalla Capilla, cioè ilsotterraneo.
188
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
Fig. 7 - Santuario di Santa Greca. Le due centine sovrapposte sulla paretedi fondo della confessio
Fig. 8 - Decimomannu - Santuario di Santa Greca. Pavimentazionein cocciopesto della confessio
(figura 7). Al medesi-mo intervento potreb-be essere fatta risalireanche la pavimenta-zione in cocciopestotuttora esistente (figu-ra 8).I lavori dovrebberoessere stati eseguitinel corso dell’XI seco-lo, come parrebbeindicare la caratteri-stica sagoma a sezionepentagonale della cor-nice inserita allo spic-cato della nuova voltaa botte (figura 9), raf-frontabile ad esempioal listello marmoreocon sguscio ad ovolidel santuario di Sant’Antioco, nell’isola omonima, recante l’i-scrizione protogiudicale di Torchitorio, Salusio e Nispella94.Oppure, non volendo ammettere una semplice menda proget-tuale originaria, la modifica dell’ipogeo potrebbe essere interve-nuta subito dopo la costruzione dell’edificio nel sopraterra, col-locata alla fine dell’XI secolo, visto che il rialzo della coperturasotterranea ha notevolmente alterato le proporzioni interne delpresbiterio, oggi molto interrato95.
- La chiesaQuanto rimane della struttura protoromanica (figura 10) è statocompiutamente descritto da Roberto Coroneo: «Dell’edificio (...)pressoché integralmente ricostruito entro il 1792, si conservanol’abside e cantoni dei muri, individuabili nei tratti di fiancorisparmiati dalla moderna intonacatura in cemento. L’abside è dis-
94 R. CORONEO, Scultura mediobizantina inSardegna, Nuoro 2000, pp. 240-241, sch.13.8. Di analogo profilo anche un frammen-to di iscrizione dedicatoria dalla chiesa diSan Giovanni Battista ad Assemini, cronolo-gicamente affine: IBIDEM, pp. 208-209, sch.1.3.
95 La situazione appariva la stessa già ai tempidi S. ESQUIRRO, Santuario de Caller cit., p.494, che nella chiesa subdiale conobbe un«Altar en alto que se sube con seys gradas».
189
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
Fig. 10 - Decimomannu - Santuario di Santa Greca. Esterno dell’abside
Fig. 9 - Decimomannu - Santuario di Santa Greca.Cornice a profilo pentagonale sullospiccato della volta nella confessio
posta a sud est e descrive in pianta un arco parabolico assai pro-fondo. Sia all’esterno che all’interno, la muratura si presenta ete-rogenea, con prevalenza di grossi blocchi calcarei, sovrapposti infilari di approssimativa regolarità. L’unica stretta monofora, cen-trata, è priva di strombo; la centina ha un leggero rincasso. Lacopertura esterna del catino è data da un manto cementizio prein-dustriale, che non cancella il dettaglio strutturale dell’estradossorientrante sul filo dell’imposta. L’abside non segna spallette e sicollega senza soluzione di continuità a tratti di paramento ester-no, tecnicamente affini ma nel complesso incoerenti e forse messiin opera con riuso di materiali dei muri antichi. All’interno, l’ar-co frontale e il catino hanno sagoma non perfettamente semicir-colare; si conservano lacerti di antichi intonaci»96.Dovette esservi, quindi, una ripresa del culto a Santa Greca inpieno medioevo, che presuppose (o comportò) alcuni interventiedilizi sul santuario. La tradizione locale, in questo momentocosì antico, doveva essersi ancora conservata, anche se i suoiconnotati precisi rimangono purtroppo indefiniti.
- Il monasteroPromotrice del recupero potrebbe essere stata la famiglia giudi-cale cagliaritana. Un documento emanato nel 1355 dalla cancel-leria di re Pietro IV d’Aragona, infatti, parla di un monasterofemminile di San Giorgio a Decimomannu, detto anche di SantaGreca, ricordando tutta una serie di donazioni effettuate a suofavore: a cominciare da quella del giudice Torchitorio, contem-poraneo di papa Alessandro II († 1073), fino ai lasciti ricevutidalla sua badessa allora in carica, madonna Iohanna97.L’atto, evidentemente importantissimo anche per la storia delculto di Santa Greca, purtroppo non è stato ancora pubblicatonella sua integrità. Sulla base dei pochi elementi resi finora dis-ponibili, tuttavia, e alla luce di quanto già noto sull’evergetismogiudicale in Sardegna, sembrerebbe quantomeno lecito ipotizza-re che i regoli cagliaritani, a ulteriore conferma del loro specifi-co interesse per la valorizzazione degli antichi culti martiriali delgiudicato, abbiano voluto o economicamente favorito la ristrut-turazione del santuario98, affidandone poi la custodia a una fami-glia religiosa femminile99.Alla continuata presenza di queste monache a Decimomannu, inuna struttura che si può presumere annessa alla chiesa di SantaGreca, si riferiscono vari documenti del XIV e XV secolo100.Anzitutto, l’ordine trasmesso al governatore generale dellaSardegna dall’infante Alfonso, nel 1327, in accoglimento delleproteste che la medesima badessa Iohanna aveva inoltrato con-tro l’occupazione abusiva di beni e l’usurpazione di redditi delmonastero, da parte di elementi catalani101.Attorno alla metà del Trecento (1342-1347), quindi, si colloca-no le Rationes decimarum, che attestano la riscossione di tributipro monasterio S. Grege de Decimo102.Nel 1359 Raimondo, vescovo di Sulci, effettuò un lascito testa-mentario monialibus monasterii S. Greche situati in villa DecimiMaioris103.Al 1363, invece, risale la notizia di un pascolo affittato dallabadessa del mo(n)estir d(e) S(an)ta Grega (o anche Gregua) d(e)
96 R. CORONEO. Architettura romanica cit., p.39, sch. 4.
97 Archivo de la Corona de Aragón,Cancilleria, reg. 1024, c. 101v, citato daM.G. MELONI, Ordini religiosi e politica regianella Sardegna catalano-aragonese della primametà del XIV secolo, “Anuario de EstudiosMedievales”, 24, 1994, pp. 831-855, p. 849.Allo stesso documento, apparentemente, siriferiscono anche R. PINNA - C. ZEDDA, SanGiorgio, l’evangelizzazione dell’Ogliastra e lanascita dei giudicati, “Biblioteca FrancescanaSarda”, XII, 2008, pp. 161-182, p. 174, iquali tuttavia citano Archivo de la Coronade Aragón, Cancilleria, reg. 1030, cc. 102v-103.
98 Analoghe operazioni finanziarie, come bennoto, sempre nel corso dell’XI secolo furonocompiute dai giudici di Cagliari a vantaggiodei martyria di San Saturnino a Cagliari, diSant’Efisio a Nora, di Sant’Antioco nell’isolaomonima, poi donati con ricche pertinenzeai monaci benedettini di San Vittore diMarsiglia. Cfr. P.G. SPANU, MartyriaSardiniae. I santuari dei martiri sardi,Oristano 2000, pp. 51-95.
99 Un monasterium castarum, agli inizi dell’XIsecolo, era stato fondato a Cagliari dal giudi-ce Amanus: cfr. N. VOLPINI, Documenti nelSancta Sanctorum del Laterano. I restidell’“Archivio” di Gelasio II, “Lateranum”,n.s., LII, 1986, pp. 215-264, p. 262; R.TURTAS, Storia della Chiesa in Sardegna cit.,p. 213, nota 1.
100 G. SPANO, Storia della chiesa di Santa Grecacit. pp. 13-14; F. COLLI, Decimomannu cit.,pp. 83-84; F. VIRDIS, Santa Greca cit., pp.31-37.
101 Archivo de la Corona de Aragón,Cancilleria, reg. 403, cc. 199v-200r, citato daM.G. MELONI, Ordini religiosi e politica regiacit., pp. 848-849.
102 P. SELLA, Rationes decimarum Italiae neisecoli XIII e XIV. Sardinia, Città del Vaticano1945, pp. 56, 107, 156, 173.
103 D. SCANO, Codice diplomatico delle relazio-ni tra la Santa Sede e la Sardegna, I, Cagliari1940, doc. DLXXV, p. 401.
190
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
la vila d(e) Decimo al nobile Johan Carroz104.Il legittimo possesso di quello stesso territorio, detto salt - anchein questo caso - d(e) Sa(n)t Jordi (San Giorgio), era però conte-stato alle religiose da Mial(e) Orlando, luogotenente del vicariodelle curatorie di Gippi e Trexenta per conto del comune di Pisa.Sulla scorta di questa indicazione topografica, un’altra notiziadiretta del monastero di Santa Greca a Decimomannu potrebbeessere segnalata, ancora, per il 1345, se è corretto riconoscere inesso il misterioso monasterium sancte Girche il cui sindicus PietroMartini, katalanus, in quell’anno rivendicava a suo nome la villadi Aulis, nella curatoria di Trexenta, che invece secondo la con-troparte era «fuit semper Pisani communis»105.Per il secolo successivo, infine, risale al 1413 la lettera con cuiFerdinando I d’Aragona comunicò ai consiglieri della città diCagliari che l’arcivescovo Antonio Dexart aveva eletto «Isabella,figlia di Bernardo Rossellò di Valenza, badessa del monasterobenedettino e della chiesa di Santa Greca Martire fondato anti-camente in Decimo»106. In latino il passo suona: «in monasterio etecclesia Sancte Grece Martiris (…) in villa de Decimo»107.
- La martireDa quest’ultimo documento, dunque, si apprende che SantaGreca, almeno all’inizio del Quattrocento, era esplicitamenteritenuta martire. Quantomeno, questa è la più antica testimo-nianza scritta relativa alla particolare connotazione della sua san-tità108.All’arcivescovo di Cagliari Dexart, che la comunicò al reFerdinando I d’Aragona, da dove poteva essere venuta una simi-le contezza? Da qualche sconosciuto documento storico nonarrivato fino ai giorni nostri? Si potrebbe pensare, ad esempio, aipiù antichi calendari ecclesiastici della archidiocesi cagliaritana,che molto probabilmente dovettero esistere benché non se ne siaconservata alcuna traccia.In questo periodo, tuttavia, potrebbe anche essere stato com-messo l’errore ipotizzato da Hippolyte Delehaye. Dando per sta-bilita, cioè, la nozione relativa alla pura e semplice santità diGreca, di cui si aveva un evidente e incontestabile possesso alme-no dall’XI secolo, come prova la già considerata trasformazionedella sua (presumibile o presunta) tomba a camera in una vera epropria confessio, essa potrebbe essere stata creduta martire leg-gendo b(eata) m(artyr), anziché b(onae) m(emoriae), su una lapi-de funeraria a lei arbitrariamente attribuita. Casi analoghi sisono registrati anche in altri ambiti geografici. Sullo scadere delmedioevo, un identico equivoco si verificò ad esempio aBergamo, dove nel 1401 gli scopritori dell’epitaffio di un B. M.Domnio, e dei suoi nipoti Eusebia e Domnon, scambiarono que-sti personaggi per b(eati) m(artyres), benché dei presunti santi,fino a quel momento, nessuno avesse mai sentito parlare109. Essi,successivamente, furono perfino inseriti nel MartyrologiumRomanum del Baronio110.Una simile eventualità, però, nello stesso periodo appare assaiimprobabile in Sardegna, ancora lontanissima dal poter risentiredei benefici influssi del rinascente umanesimo (al contrario delleregioni centro-settentrionali del continente italiano). Sembra
104 Archivio di Stato di Cagliari, AnticoArchivio Regio, vol. K1, c. 74v (84v dellanuova numerazione).
105 M. TANGHERONI, Due documenti sullaSardegna non aragonese del Trecento,“Medioevo. Saggi e Rassegne”, 2, 1976, pp.27-64, p. 49. Ora anche in IDEM, SardegnaMediterranea, Roma 1983, p. 267.
106 F. ARTIZZU, Registri e carte reali diFerdinando I d’Aragona, “Archivio StoricoSardo”, XXV, 1-2, 1957, pp. 261-318, n. 49,p. 278.
107 Archivo de la Corona de Aragón,Cancilleria, reg. 2398, Sardinia, c. 42-42v.
108 O.P. ALBERTI, Santa Greca cit., pp. 577-580.
109 CIL V, 5187: Hic requiescunt in pa[ce]b[onae] m[emoriae] Domnio cum nepotibussuis Eusebia et Domnon[e]. Dep[ositus]Domno avus XVI k[alendas] Augus[tas],Eusebia III k[alendas] Novemb[res], Domnionon[is] Ian[uariis]; cfr. P. BERTOCCHI,Domno, Eusebia e Domnione, santi, martiri diBergamo, in Bibliotheca Sanctorum, IV,Roma 1964, coll. 768-769.
110 Martyrologium Romanum ad novamKalendarii rationem et ecclesiasticae historiaeveritatem restitutum. Gregorii XIII PontificisMaximi iussu editum, Romae 1584, pp. 210(“16 Iulii: Bergomi sancti Domnionis marty-ris”), 334 (“29 Octobris: Bergomi sanctaeEusebiae virginis et martyris”).
191
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
perfino superfluo, a tale proposito, ricordare le tragiche condi-zioni di arretratezza culturale in cui clero e classi egemoni dell’i-sola versarono fino alla metà del XVI secolo, quando finalmentesi procedette a riformarne il sistema scolastico e a creare il primoembrione di quello universitario111.Per tale motivo, appare tanto più da respingere l’opinione diFrancesco Virdis il quale, ponendo l’accento sul fatto che l’epi-taffio della ventenne Greca, nelle relazioni seicentesche, venissedefinita in letras goticas, ritiene «necessario datarla al XIV-XVsecolo, periodo nel quale può essersi riscritta la Vita della mona-ca Greca, ma non ricordando chi fosse, hanno scritto quella lapi-de esemplandola a una delle tante martiri riportate negli ActaMartyrum, che sicuramente circolavano tra i nostri predicato-ri»112. Sembrerebbe potersi intuire, insomma, che a giudizio delVirdis l’epigrafe tradizionalmente attribuita alla tomba di SantaGreca fosse stata addirittura fabbricata fra Trecento eQuattrocento, allo scopo di assegnare un’identità qualsiasi a unafigura, dai tratti ormai evanescenti, che si voleva comunquerecuperare al culto.Il Virdis, tuttavia, sembrerebbe ignorare come nel XVII secolo,con l’espressione letras goticas, non si intendesse quella partico-lare scrittura medievale oggi comunemente definita “gotica”,bensì «una scrittura maiuscola che si allontani dal modello esem-plare della capitale antica, cioè in particolare quell’alfabeto mistodi lettere capitali o onciali che gli umanisti vedevano usato neititoli e nelle iniziali dei codici medievali e a cui essi sostituironomaiuscole di tipo epigrafico esemplate su modelli romani»113. Sitratta, evidentemente, proprio del tipo di caratteri più ricorrentinell’epigrafia tardoantica e altomedievale, anche in Sardegna114.Le più antiche falsificazioni epigrafiche di cui si abbia sicuranotizia, per l’isola, non certo a caso risalgono entrambe al terzoquarto del XVI secolo. La prima, esclusivamente documentale, èil sunto in versi latini di un celebre enigma umanistico, l’epitaf-fio di Aelia Laelia Cripis, che all’arcivescovo di Cagliari AntonioParragues del Castillejo, nel 1559, fu fatto credere «sacado deuna sepultura que aun se halla en esta ysla»115. La seconda, incisasu supporto lapideo, è l’epigrafe cosiddetta della Civitas Jole,fatta ritrovare a Cagliari nel 1562116.Oltre un secolo prima quindi, nel secondo decennio delQuattrocento, un’eventuale travisazione dell’epigrafe decimesedi Greca, volontaria o meno, sarebbe stata impossibile: il conte-sto culturale non l’avrebbe permesso.Si potrebbe pertanto pensare, lasciando da parte l’epigrafia, chela fonte informativa dell’arcivescovo Dexart, nel 1413, diretta-mente o meno fosse stata la tradizione. Essa avrebbe davveropotuto conservare, fin dal V-VI secolo, memoria della specificasantità personale di questa giovane martire, non strettamentericavabile dal solo epitaffio.È bene insistere sul concetto di tradizione locale, perché i marti-rologi storici e lo stesso Martyrologium Romanum non ricordanomai il nome di una santa Graeca117, che quindi deve verosimil-mente ritenersi un personaggio locale, vissuto nell’antica statioromana di Ad Decimum, e non magari il banale duplicato di qual-che altro martire famoso, la cui testimonianza di fede debbainvece collocarsi altrove118.Ma in quest’ultimo caso, cioè di un’antica memoria orale fedel-
111 R. TURTAS, Storia della Chiesa in Sardegnacit., pp. 390-393.
112 F. VIRDIS, Santa Greca cit., p. 80.113 S. RIZZO, Il lessico filologico degli umanisti,
Roma 1984, p. 126114 A.M. CORDA, Le iscrizioni cristiane della
Sardegna cit., p. 252.115 A. DEROMA, Anton Parragues de Castillejo
e la circolazione di un enigma umanistico nellaSardegna del ’500, “Sandalion”, 23-25,2000-2002 (2003), pp. 123-145.
116 M. DADEA, I primi passi dell’archeologia inSardegna. Esperienze di scavo e ritrovamentiepigrafici a Cagliari nel XVI secolo,“Archeologia Postmedievale”, 5, 2001, pp.263-310, pp. 267-278.
117 Su tale cognomen di origine etnica, cfr. H.SOLIN - O. SALOMIES, Repertorium nominumgentilium et cognominum Latinorum,Hildesheim - Zürich - New York 1994, p.340.
118 S. ESQUIRRO, Santuario de Caller cit., p.495: «Esta bienaventurada Santa Greca esSarda, y Martyrizada en Sardeña. ElMartyrologio Romano no haze mencion deninguna Santa deste nombre: se haran las dili-gencias que convienen para hallar su sagradoCuerpo».
192
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
mente tramandata dalla comunità cristiana decimese, se Grecanon fosse stata martire è davvero credibile che una simile notiziapotesse essere stata omessa o dimenticata, e non riportata assie-me al titolo di santità?La risposta più plausibile parrebbe negativa. Se i decimesi del-l’altomedioevo sapevano che Greca era santa, molto probabil-mente avrebbero anche saputo se fosse stata martire o no. La tra-dizione ecclesiastica più antica sosteneva che fu martire, per cuimartire effettivamente dovrebbe essere stata.A questo punto, però, sorge il problema del suo inquadramentostorico.Infatti, se si intendesse continuare a riferirla ai tempi della per-secuzione di Diocleziano, sarà del pari necessario ammettereanche che l’iscrizione funeraria a lei comunemente attribuita,più tarda, sia in realtà quella di una semplice omonima, sepoltaa scopo devozionale presso la sua tomba a noi, però, tuttoraconosciuta: si tratterebbe, in pratica, di una semplice depositio adcorpus119.Se invece si volesse continuare a ritenere, come parrebbe piùlogico, che quello sia il suo epitaffio originale, tanto questo quan-to la presumibile tomba a camera posta sotto il presbiterio dellasua chiesa protoromanica costringerebbero a escludereDiocleziano, e il suo preside Flaviano, per riportare il martiriodella santa decimese al V-VI secolo.Rimandano nello specifico all’arco di questi due secoli, infatti, glielementi cronologici deducibili dagli aspetti testuali dell’epigrafe,già analizzati da Antonio Maria Corda120, e la particolare forma
delle hederae distinguentes che costellano il testo, strettamenteconfrontabili, ad esempio, con quelle di un’iscrizione dei MuseiVaticani datata agli anni 530-533 (figura 11)121.Le persecuzioni pagane, in questo momento, erano già cessate dacirca due secoli. Se Santa Greca fu martire, allora, ad opera di
119 Su tale fenomeno cultuale, relativamentealla Sardegna, cfr. S. CISCI, Il culto dei marti-ri sardi in Sardegna in età tardoantica e alto-medioevale attraverso le testimonianze storicheed archeologiche, “Rivista di ArcheologiaCristiana”, LXXVII, 2003, pp. 371-406.
120 A.M. CORDA, Le iscrizioni cristiane dellaSardegna cit., DEC001, p. 145.
121 D. MAZZOLENI, Origine e cronologia deimonogrammi cit., nr. 26, p. 169.
193
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
Fig. 11 - Musei Vaticani - Calco di hedera distinguens incisa sull’iscrizione 2125, inv. 6709, databile agli anni 530-533 (da M AZZOLENI 1997)
chi avrebbe versato il suo sangue per la fede?La risposta sembrerebbe venire proprio dall’iscrizione funeraria alei attribuita. Infatti, benché il testo non dichiari in modo espli-cito né la santità né il martirio della defunta ivi nominata, è age-vole poter immediatamente osservare come questa iscrizione, nelquadro dell’antica epigrafia cristiana della Sardegna, presentialcune particolarità assolute.Anzitutto il sovrabbondante numero di cristogrammi, addirittu-ra cinque. Il cinque, come noto, agli occhi dei primi cristianipossedeva una valenza anzitutto soteriologica, corrispondendo alnumero delle lettere che compongono la parola greca Σωτηρ,Salvatore, principale attributo di Cristo e motivo stesso della suaincarnazione122: replicare cinque volte il nome di Cristo, dunque,specie in ambito funerario, potrebbe aver voluto significare, sem-plicemente, una professione di fede nella missione redentrice dilui, e un augurio di vita eterna per la persona defunta.Si deve subito osservare, tuttavia, che i cristogrammi sull’epitaf-fio decimese di Greca appaiono non tutti uguali, ma di tre diver-si tipi. Pur tenendo presente la possibilità di un banale gustodella variatio da parte dello ordinator o del lapicida, e senza vole-re escludere anche l’eventuale valenza escatologica dell’iterazio-ne, una simile scelta parrebbe doversi considerare non casuale,ma dettata un intento preciso che, nel particolare contesto stori-co in cui l’iscrizione deve essere inquadrata, potrebbe ipotetica-mente individuarsi in una volontà polemica antiariana.La Sardegna, dal 456 circa al 534, fu occupata dai Vandali, popo-lazione di stirpe germanica che professava un’eresia cristologicaparticolarmente insidiosa, l’arianesimo123. Essa, in pratica, nega-va il patrimonio di fede fondamentale per i cattolici, ponendo«una divisione profonda nella santissima Trinità, riservando ilcarattere di divinità solo alla prima persona e facendo delle altredue delle sue creature: prima creatura era il Figlio e secondacreatura lo Spirito Santo: con la necessaria conseguenza cheanche in Gesù non si era incarnato un dio, ma una creatura»124.Specie per motivazioni politiche e di ordine interno, i Vandalicercavano di costringere i cattolici ad apostatare e ad abbraccia-re la loro fede125.La fortissima resistenza incontrata tra le popolazioni autoctoneindusse gli invasori a scatenare una crudelissima persecuzione cheprodusse numerose vittime, specialmente in Africa settentrionaledove si trovava la capitale del loro regno, Cartagine. In particola-re Possidio, nella sua Vita Augustini, Vittore Vitense, nella suaHistoria persecutionis Africanae provinciae, e lo Pseudo Ferrando diCartagine, nella Vita Fulgentii, hanno descritto questa grave tribo-lazione della Chiesa in qualità di testimoni oculari126.Non furono risparmiati neppure gli altri territori dominati daiVandali, tra i quali appunto la Sardegna127.Le vittime preferite della persecuzione erano i vescovi e gli altrimembri del clero128, ma in realtà alla violenza ariana non sfuggi-va nessun cattolico praticante: neppure i vecchi129, le donne130 o ibambini131, né tantomeno le stesse vergini consacrate132.Addirittura, per non fare delle loro vittime altrettanti martiridegni di culto pubblico, i Vandali torturavano le persone perfarle abiurare, cercando però di non ucciderle133. Per molti, però,i duri maltrattamenti subiti risultavano comunque fatali134.Nonostante taluni studiosi, in tempi recenti, abbiano tentato di
122 E. TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristiani,Gerusalemme 1962, p. 227.
123 L. PANI ERMINI, La Sardegna e l’Africa nelperiodo vandalico, “L’Africa Romana”, II, 1984(1985), pp. 105-122; L. PANI ERMINI, LaSardegna nel periodo vandalico, in Storia deiSardi e della Sardegna. Dalle origini all’età bizan-tina, a cura di M. Guidetti, Milano 1988, pp.297-327; G. ARTIZZU, La Sardegna e la politicareligiosa dei re vandali, “Studi Sardi”, XXX,1992-1993 (1996), pp. 497-512; P.G. SPANU,L’età vandalica, in Storia della Sardegna antica, acura di A. Mastino, Nuoro 2005, pp. 499-509.
124 A. FERRUA, La polemica antiariana nei monu-menti paleocristiani, Città del Vaticano 1991, p.11.
125 CH. COURTOIS, Les Vandales et l’Afrique, Paris1955, pp. 301-304; A. ISOLA, I cristianidell’Africa vandalica nei sermones del tempo(429-534), Milano 1990, p. 3; A. PLACANICA,La Cristianità africana tra Arrianus furor e sub-reptiones Acephalorum, in Le invasioni barbari-che nel meridione dell’impero: Visigoti, Vandali,Ostrogoti, Atti del Convegno (Cosenza, 24-26luglio 1998), a cura di P. Delogu, SoveriaMannelli 2001, pp. 181-241, p. 209.
126 Un recente riesame complessivo delle fonticattoliche relative alla conquista vandalicadell’Africa è in A. PLACANICA, La Cristianitàafricana cit., in particolare pp. 196-199.
127 VICT. VIT., Hist. pers. Afr. prov., I, 17 (ed. it.VITTORE DI VITA, Storia della persecuzione van-dalica in Africa, Traduzione, introduzione e notea cura di S. Costanza, Roma 1981, pp. 53-54).
128 VICT. VIT., Hist. pers. Afr. prov., II, 9-12(trad. it. cit., pp. 65-69 e passim)
129 IBID., I, 2 (IBID., p. 31); I, 9 (p. 43); I, 13 (pp.48-49).
130 IBID., I, 2 (IBID., p. 31); V, 1 (pp. 114-115);V, 4 (pp. 117-121).
131 IBID., I, 2 (IBID., pp. 31-32); II, 9 (p. 66) V, 1(p. 115).
132 IBID., I, 10 (IBID., pp. 44-46); II, 7 (p. 64).133 IBID., I, 14 (IBID., pp. 50-51); V, 6 (p. 119).134 Ad es. Maioricus, IBID., V, 1 (IBID., pp. 115-
116); Servus, V, 2 (p. 116); Victorianus, V, 4(pp. 117-118). Gli esempi potrebbero molti-plicarsi ancora numerosi.
194
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
negare attendibilità storica agli stessi protagonisti dei fatti, e cosìdi ridimensionare notevolmente la gravità e la portata della per-secuzione vandalica ariana135, proprio di essa potrebbe esserestata vittima la Greca martir che il vescovo Dexart, più di milleanni dopo, attestava ancora venerata a Decimomannu136.L’iscrizione sepolcrale a lei tradizionalmente attribuita rispondein tutto agli schemi formulari più consolidati dell’antica epigra-fia cristiana della Sardegna, con nome proprio della personadefunta al nominativo, preceduto dal generico elogio b(onae)m(emoriae) in forma abbreviata e seguito dall’espressione quiescitin pace, dai dati biometrici e dalla data della depositio137.Quest’ultima indicazione, relativamente poco usata nell’isola,testimonia la fede nell’immortalità dell’anima perché i cristiani,convenendo a celebrare i defunti nei giorni anniversari delrispettivo decesso, che corrispondeva quasi sempre a quello disepoltura, ne festeggiavano in realtà il dies natalis alla vera vita inDio138. La fede, naturalmente, non poteva estinguere del tutto gliumani sentimenti di dolore e di rimpianto nei confronti dei cariscomparsi, a espressione dei quali, talvolta, gli epitaffi si soffer-mavano a indicarne con grande precisione gli anni, i mesi e igiorni della vita terrena139. Impulsi profondi che, però, la dottri-na escatologica cristiana consentiva di sublimare in un vincolod’amore ancora più saldo: l’uso del verbo quiescere, infatti, docu-menta la credenza nel dogma della resurrezione finale, quando icorpi che ora semplicemente vi riposano saranno fatti risorgeredalle tombe140. Particolarmente diffusa l’espressione in pace, conoltre 120 attestazioni anche in Sardegna dove risulta quindi unasorta di stereotipo141. Da parte dei sopravvissuti, attesta l’integri-tà morale e spirituale delle persone defunte cui viene riferita,ritenute pertanto degne di gioire eternamente nella pace delSignore142.Tutto insomma, in questa epigrafe, sembrerebbe escludere l’uc-cisione di Greca in odio alla fede e di conseguenza la sua even-tuale identificabilità con una martire, giusto il reciso giudizioespresso a suo riguardo da Hippolyte Delehaye: «C’est la pierretombale d’une jeune chrétienne morte en la paix du Seigneur, danssa vingt et unième anée. Greca n’a certainement pas subi le marty-re»143.A tale conclusione del celebre bollandista, tuttavia, si potrebbeanzitutto opporre che proprio la formula funeraria in pace, perquanto comprensibilmente rara, non manca di sicure attestazio-ni nell’epigrafia martiriale ad esempio dell’Africa144.Comunque, come giova ripetere, ciò che nell’epitaffio decimesedi Greca si annuncia fuori dal comune, invitando così ad inda-garne singolari particolarità e conseguenti motivazioni ideologi-che, non è il formulario ma il suo complesso apparato figurativo,la cui ricchezza non mancò di colpire gli stessi studiosi seicente-schi. Così Juan Francisco Carmona: «Su letrero es de los sump-tuosos y nobles que se han hallado»145.Il cristogramma è l’abbreviatura in nesso del nome di Cristo, ingreco, e in questo epitaffio ne compaiono cinque: tre decussati,cioè del tipo in genere più comune, e due particolari. Il primo,affiancato dalle lettere apocalittiche alpha e omega, e l’altro diforma stellata, dato dall’intersezione non delle solite lettere Χ(chi) e P (rho), iniziali dell’aggettivo Χρ(ιστος), ma delle lettere
135 In particolare contro Christian Courtois, chenel suo Les Vandales et l’Afrique cit., fu il prin-cipale alfiere di questa “rivalutazione”, A.ISOLA, I cristiani dell’Africa vandalica cit., pp.3-4, testualmente scrive: «Il modo con il qualehanno perseguito il preciso disegno di annien-tare o di rendere comunque inoffensiva l’op-posizione cattolica e la ferocia mostrata duran-te le “normali” azioni di guerra sono tali, dagiustificare ampiamente la fama sinistra cheaccompagna da sempre il nome dei Vandali.(...) La via della cattività è una delle più fre-quentate dalla persecuzione, insieme con quel-la dell’esilio; e può condurre al martirio. (...)Per altro, nel periodo vandalico il martirio nonpassa necessariamente per la cattività, (...) epossiamo affermare con certezza che esso èmeno singolare di quanto qualcuno vorrebbefar credere».
136 Circa gli esiti della persecuzione vandalica inSardegna, in mancanza di documentazione sto-rica diretta, l’opinione prevalente tra gli studio-si rimane comunque ancora quella a suo tempoespressa da L. PANI ERMINI, La Sardegna nelperiodo vandalico cit., p. 299: «Il dominio van-dalo fu caratterizzato dalle lotte di natura reli-giosa, dei seguaci dell’eresia di Ario nei riguardidel clero e della popolazione cattolica: VittoreVitense ne descrive le sofferenze luttuose, ma èopinione comune che il suo racconto si riferiscaunicamente agli eventi africani e che, al contra-rio, la politica di Genserico verso la Sardegna siastata prudente e avveduta, volta piuttosto adassicurarsi una pace nell’isola che a controllar-ne il credo religioso». Si vedano anche G.ARTIZZU, La Sardegna e la politica religiosa dei revandali cit., p. 502; e da ultimo P.G. SPANU,L’età vandalica cit., p. 501.
137 A.M. CORDA, Le iscrizioni cristiane dellaSardegna cit., pp. 235-242.
138 F. GROSSI GONDI, Trattato di epigrafia cri-stiana latina e greca del mondo romano occi-dentale, Roma 1920, pp. 185-187.
139 IBIDEM, p. 185.140 IBIDEM, pp. 192-195.141 A.M. CORDA, Le iscrizioni cristiane della
Sardegna cit., p. 241.142 F. GROSSI GONDI, Trattato di epigrafia cri-
stiana cit., pp. 221-223.143 H. DELEHAYE, Recensione a R. Loddo cit., p.
318.144 Y. DUVAL, Loca Sanctorum Africae. Le culte
des martyrs en Afrique du IV au VII siècle,Rome 1982, pp. 467-468.
145 J.F. CARMONA, Alabanças cit., c. 135v.
195
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
I (iota) e Χ (chi), iniziali dei nomi I(ησους) Χρ(ιστος) 146.Il cristogramma con le lettere apocalittiche αω, alla r. 1, esprimela fede nella divinità di Cristo, inizio e fine, come si legge in tredistinti passi del libro dell’Apocalisse: «Io sono l’Alpha el’Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene,l’Onnipotente!» (Ap. 1, 8); «Io sono l’Alpha e l’Omega, ilPrincipio e la Fine.» (Ap. 21, 6); «Io sono l’Alpha e l’Omega, ilPrimo e l’Ultimo, il primo e l’ultimo» (Ap. 22, 13). Come spie-ga Antonio Ferrua, le prime due volte «è Dio stesso che parla, laterza è Gesù. Ciò vuol dire che a Gesù sono dati gli attributi stes-si di Dio ed in particolare l’eternità. I cristiani nelle loro epigra-fi hanno scelto definitivamente quest’ultimo uso»147.Subito dopo, alla r. 2, nell’epitaffio decimese di Greca segue ilmonogramma astriforme, con il nome, I(ησους), imposto alFiglio di Dio al momento della circoncisione: «Quando furonopassati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messonome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima di essereconcepito nel grembo della madre» (Lc. 2, 21).Nell’interpretazione dei Padri della Chiesa, Gesù sarebbe statosottoposto a questo antico rito della legge mosaica a testimo-nianza della sua umanità, cioè della piena realtà della sua incar-nazione148. Al nome I(ησους), sempre su base scritturistica,erano strettamente collegati anche i caratteri di eternità e filia-zione divina: «Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lochiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; ilSignore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà persempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine» (Lc.1, 31-33). In questo particolare monogramma, infatti, il nomeproprio I(ησους) risulta congiunto al titolo di Χρ(ιστος), a riba-dire simbolicamente la fede nella piena identificazione dell’uomoGesù con il Cristo, il Figlio di Dio (Mt. 16,16; 26, 63; Mc. 8,29;14, 61; Lc. 9, 20; 22, 67-70; Gv. 10, 25-38; 20, 31) che era statoannunciato dai profeti (Gv. 1, 41; 4, 25)149.Ecco quindi, si direbbe, che l’epitaffio di Greca proclama aperta-mente il dogma cattolico della doppia natura divina e umana diCristo in un’unica persona, in un contesto storico-politico chepotrebbe far presupporre non una semplice professione di fede asé stante, ma una voluta presa di posizione polemica contro l’e-resia ariana.Ario, infatti, partiva dal presupposto che uno solo fosse il prin-cipio ingenerato, Dio. E siccome il Verbo è detto dalla SacraScrittura generato (γεννητος), a suo giudizio non poteva essereDio. Essere generato, infatti, importa mutazione (γεννασθαι =γιγνεσται), per cui genito si sarebbe dovuto ritenere equivalentea creato (γεννητος = γενητος). Di conseguenza il Verbo, essen-do creato, per il pensatore alessandrino non poteva ritenersiimmutabile né coeterno al Padre, cioè a lui consustanziale(οµοουσιος), essendo impossibile la scissione della monadeassoluta. Conseguentemente al mistero trinitario, Ario distrug-geva anche quello dell’incarnazione, per cui Gesù, nel quale inVerbo si è fatto uomo, in realtà sarebbe stato privo dell’animaumana, sostituita dal Verbo stesso: non sarebbe stato, perciò,vero uomo150.Un esempio delle contro argomentazioni cattoliche può leggersinel Liber fidei catholicae presentato dai vescovi africani, sardi ebalearici fedeli al dogma niceno nel Concilio di Cartagine del
146 Su introduzione e uso del cristogrammadecussato, dello stesso affiancato dalle lette-re apocalittiche e di quello astriforme cfr. D.MAZZOLENI, Origine e cronologia dei mono-grammi cit., rispettivamente alle pp. 165,166, 167.
147 A. FERRUA, La polemica antiariana cit., p.48.
148 E. TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristianicit., p. 362.
149 A. FERRUA, La polemica antiariana cit., pp.43-44.
150 M. SIMONETTI, Ario-Arianesimo, inDizionario patristico e di antichità cristiane,diretto da A. Di Berardino, I, Genova 1983,coll. 337-345, coll. 337-338.
196
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
484, che Vittore Vitense riporta integralmente nella propriaopera: «Poiché professiamo che nel Figlio vi sono due nature,cioè che egli è vero Dio e vero uomo, dotato di corpo e di anima,tutto quello dunque che le Scritture dicono di lui con eminentee sublime efficacia, noi riteniamo che si debba riferire alla suaammirevole divinità; tutto ciò che invece è detto di lui stesso inmaniera più dimessa e inferiore all’onore dovuto alla sua dignitàceleste, noi lo riferiamo non a Dio Verbo, ma all’umanità da luiassunta»151.Tornando alle teorie di Ario, essendo il Figlio una creatura, trat-ta dal nulla come tutte le altre creature, egli non sarebbe statocoeterno e quindi neppure uguale al Padre. Di conseguenza nep-pure lo Spirito Santo poteva ritenersi persona divina, ma creatu-ra che procede per creazione dal Verbo, come il Verbo procedeper creazione dal Padre in reciproca subordinazione152. Totale,quindi il contrasto col dogma cattolico, per il quale invece le trepersone della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo,sono uguali e distinte. Come risposta alle dottrine ariane, infat-ti, nel Liber fidei catholicae tra l’altro si legge: «L’evangelistaGiovanni dice: Per questo i Giudei cercavano di ucciderlo, perchénon solo violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosiuguale a Dio (cfr. Gv. 5, 18). Questo poi non deve essere riferi-to ai Giudei, perché è l’evangelista che ha veramente dettoriguardo al Figlio che si faceva uguale a Dio. Ancora nel Vangelosta scritto: Tutto quello che fa il Padre, lo stesso ugualmente lo faanche il Figlio (cfr. Gv. 5, 19). E ancora: (...) Affinché tutti ren-dano onore al Figlio, come rendono onore al Padre (cfr. Gv. 5, 23);uguale onore infatti non si tributa che a persone uguali»153.Specie alla luce di quest’ultima affermazione, quindi, potrebbeessere spiegata la presenza, alle rr. 1, 2 e 5 dell’epitaffio di Greca,degli altri tre cristogrammi decussati semplici, raffigurati perl’appunto uguali e distinti.Antonio Ferrua tende ad escludere, in mancanza di più concretiriscontri letterari, il valore probatorio antiariano di questi solisimboli più volte ripetuti, che potrebbero essere stati incisi anchea semplice scopo ornamentale154.Tuttavia l’epigrafe di Greca sembrerebbe poter fare eccezionerispetto a questa opportuna regola prudenziale, perché oltre all’i-terazione dei cristogrammi si rende necessario considerare anchela loro posizione specifica.Il cristogramma astriforme, infatti, sullo specchio epigraficorisulta costituire il vertice di un triangolo equilatero (standoalmeno all’apografo seicentesco), con base parallela al lato supe-riore della lapide. Gli altri due vertici sono formati da un cristo-gramma decussato cui si affiancano le lettere apocalittiche e daun terzo cristogramma decussato semplice. Quest’ultimo, a suavolta, in possibile rapporto geometrico con altri due cristogram-mi identici, del quale verrebbe a formare il vertice di un secon-do triangolo.Il valore simbolico trinitario delle figure triangolari, in ambitopolemico antiariano, è generalmente ammesso in letteratura155,per cui il programma figurativo recondito dell’epitaffio decimesedi Greca potrebbe essere delineato in questi termini:1. il monogramma astriforme dichiarerebbe che Gesù, vero
uomo nato da Maria, circonciso secondo la legge mosaica, èil Cristo;
151 VICT. VIT., Hist. pers. Afr. prov., III, 4(trad. it. cit. p. 83).
152 M. SIMONETTI, Ario-Arianesimo cit., col.338.
153 VICT. VIT., Hist. pers. Afr. prov., III, 3(trad. it. cit. p. 82).
154 A. FERRUA, La polemica antiariana cit., pp.52-54.
155 IBIDEM, pp. 68-69.
197
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
2. del Cristo, il cristogramma affiancato dalla lettere apocalitti-che αω proclamerebbe l’eternità, e quindi la natura divina;
3. il terzo cristogramma quindi, in quanto disposto, con gli altridue, a completare la figura di un triangolo, inserirebbe Cristonel sistema trinitario riconoscendolo, come Figlio di Dio, a luicoeterno e consustanziale;
4. triangolo equilatero, quest’ultimo, il cui valore simbolico,quale proclamazione dell’uguaglianza e pari dignità delle tredistinte persone divine, verrebbe ribadito dal secondo trian-golo formato dai cristogrammi decussati semplici, incisi l’unoidentico all’altro.
Riguardo allo Spirito Santo, terza persona della SantissimaTrinità, i vescovi cattolici convocati al Concilio di Cartaginedichiaravano: «Noi crediamo (lo Spirito Santo) consustanziale alPadre e al Figlio, coevo e coeterno a loro. Per quanto, infatti,questa veneranda Trinità sia distinta nelle persone e nei nomi,tuttavia non per questo bisogna credere che essa sia differente dase stessa e dalla sua eternità: ma crediamo realmente e ferma-mente che la natura divina sia immanente da prima dei secoli nelPadre, nel Figlio e nello Spirito Santo»156.A riprova del loro assunto, essi allegavano vari testimonia biblicie tra questi, anzitutto, le stesse parole iniziali della SacraScrittura: «Dai libri dell’Antico Testamento, e poi anche da quel-li del Nuovo, ci verrà insegnato che il Padre, il Figlio e lo SpiritoSanto sono di una sola sostanza. Già il libro della Genesi comin-cia così: In principio Dio creò il cielo e la terra; ora la terra erainvisibile e informe, e le tenebre erano sopra l’abisso, e lo Spirito diDio si portava sulle acque (Gn. 1, 1-2). (...) Lo Spirito di Dio siportava sulle acque in quanto creatore, sostenendo con la virtùdella sua potenza la creazione, sicché, producendo da esse tuttele specie viventi, dava ai rozzi elementi il calore del propriofuoco, e la natura dell’acqua, balenando già da allora il misterodel battesimo, riceveva la potenza santificatrice, e produceva perprima alla vita i corpi inanimati»157.Di questa dottrina, forse, conserva eco anche l’epitaffio decime-se di Greca. Oltre al triangolo trinitario, infatti, vi compare lacolomba con un ramo nel becco.Si è già riferito il simbolo, di eminente valore escatologico, all’e-pisodio biblico del diluvio: «Attese altri sette giorni e di nuovofece uscire la colomba dall’arca, e la colomba tornò a lui sul fardella sera; ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo. Noècomprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altrisette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più dalui» (Gn. 8, 10-12). La colomba, però, nei Vangeli è soprattuttosimbolo dello Spirito Santo, con esplicito legame al mistero bat-tesimale: «Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, siaprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come unacolomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse:Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto»(Mt. 3, 16-17; Mc. 10-11; Lc. 4, 21-22). Nella tradizione patri-stica, in questo passo è sempre stata vista l’attuazione della pro-fezia che, proprio tramite il racconto del diluvio, si ricolleghe-rebbe direttamente all’atto creatore di Dio, nel quale sarebbe giàstata annunciata la salvezza portata da Cristo tramite l’acqua e loSpirito (Gv. 3, 5). Nello specifico, siccome sia sulle acque delfiume Giordano sia su quelle del diluvio, che del battesimo sono
156 VICT. VIT., Hist. pers. Afr. prov., III, 9(trad. it. cit. p. 89).
157 IBIDEM, III, 10 (IBIDEM, p. 90).
198
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
figura (1Pt. 3, 20-21), vola una colomba che nel primo caso è loSpirito, risulterebbe immediato il collegamento al passo inizialedella Genesi in cui lo Spirito di Dio, analogamente, «si portavasulle acque» primordiali all’atto della creazione.Alla luce di tale dottrina, sull’epitaffio decimese di Greca, adom-brata sotto l’innocuo aspetto di quella noetica non soltantopotrebbe essere stata rappresentata la colomba dello SpiritoSanto, terza persona della Santissima Trinità, ma di questa sareb-bero anche state contestualmente affermate la coeternità conDio Padre e la funzione creatrice, cioè la piena divinità.Se questa lettura è corretta, quindi, davvero Greca fu molto pro-babilmente persona coinvolta nella polemica trinitaria antiaria-na, all’epoca in cui la Sardegna era dominata dai Vandali, segua-ci di tale eresia. E questo potrebbe esserle costata la vita.L’analisi iconografica fin qui condotta, è ovvio, potrebbe essereinficiata alla base dal legittimo sospetto circa l’effettiva fedeltàcon cui gli scavatori barocchi avrebbero riportato graficamentel’epitaffio decimese di Greca. In tutti quei casi nei quali le iscri-zioni da loro segnalate siano giunte fino ai giorni nostri, però, siè potuta sistematicamente constatare una fedeltà assoluta degliapografi rispetto ai modelli dati, ivi comprese le più complesseparticolarità paleografiche. Un caso davvero emblematico, a tito-lo di esempio, può considerarsi quello relativo all’epitaffio paga-no di Sp(urius) Pomp(---) Entimus, tornato alla luce presso labasilica di San Saturnino a Cagliari nel 1649158.A tale riguardo, sull’iscrizione decimese di Greca si nota in par-ticolare la cura con cui il segretario della Curia arcivescovile diCagliari tenne a riprodurre la speciale forma della lettera alpha asinistra del secondo cristogramma della r. 1. Nonostante l’evi-dente impaccio arrecatogli dal doversi cimentare con forme gra-fiche a lui totalmente estranee, è facile intuire come la letteracapitata sotto i suoi occhi si caratterizzasse per «la sbarra tra-sversale che muove in senso ascendente dalla punta estremadella linea di sinistra», tipica della cosiddetta “maiuscola biblica”greca in uso dalla metà del IV al VI secolo dopo Cristo159.Dando quindi per assodata la piena affidabilità dell’apograforispetto all’archetipo (grazie anche alla testimonianza settecente-sca del Plazza rispetto al contenuto, e a quella primo ottocente-sca della “seconda copia marmorea” rispetto alla forma delle let-tere), parrebbe non disutile né vacuo voler sperimentare la let-tura crittografica di questa iscrizione fino alle sue estreme con-seguenze.La critica archeologica ha lungamente discusso sulla correttainterpretazione del monogramma astriforme, che taluni studiosipreferirebbero considerare un semplice emblema siderale stiliz-zato160.Sull’epitaffio decimese di Greca, esso potrebbe avere assolto auna duplice funzione: alfabetica e figurativa.È da notarsi, infatti, come nel Liber fidei catholicae presentato alConcilio di Cartagine, a evidente commento del Symbolum nice-no, si insista in più luoghi sulla definizione di Cristo quale Deumde Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero: «Poiché ilPadre ingenerato ha generato il Figlio da se stesso, cioè da ciòche egli è, (...) è chiaro che è una sola la sostanza del generantee del generato, giacché noi veracemente professiamo che il Figlioè Dio da Dio, lume da lume. Infatti, che il Padre sia luce lo atte-
158 G. SOTGIU, Iscrizioni latine della Sardegna,Padova 1961, nr. 132, pp. 92-93; M. DADEA,Alle origini di Cagliari cristiana cit., pp. 34-39.
159 E. MIONI, Introduzione alla paleografiagreca, Padova 1973, p. 52. In ambito locale,un valido raffronto paleografico può adesempio istituirsi con l’epitaffio caralitano inlingua greca di Αµµια, datato generalmenteal V secolo; cfr. A.M. CORDA, Le iscrizionicristiane della Sardegna cit., CAR005, pp.49-50, tav. II.
160 A. FERRUA, La polemica antiariana cit., p.43.
199
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
sta l’apostolo Giovanni dicendo: Perché Dio è luce e in lui nonsono tenebre (1Gv. 1, 5). Similmente del Figlio dice: E la vita erala luce degli uomini, e la luce splende tra le tenebre, ma le tenebrenon l’hanno accolta (Gv. 1, 4-5). E più sotto: Era il lume vero, cheillumina ogni uomo che viene in questo mondo (Gv. 1, 9). Da ciòè chiaro che il Padre e il Figlio sono di una sola sostanza, giacchénon può essere diversa la sostanza della luce e del lume, cioè dichi genera da sé e di chi trae esistenza da chi genera»161.Tale figura cristologica, come noto, ebbe origine dal fatto cheGesù fosse stato preannunciato nell’Antico Testamento sotto lametafora dell’astro, secondo l’esplicita interpretazione che di taliprofezie fu data nel Nuovo. Nel libro dei Numeri infatti si leggeche «una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge daIsraele» (Nm. 24, 17), i quali nell’Apocalisse furono senz’altroidentificati con Cristo: «Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, pertestimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono laradice della stirpe di David, la stella radiosa del mattino» (Ap.22, 16).Potrebbe darsi, perciò, che chi fece incidere l’epitaffio della ven-tenne Greca, inserendovi il cristogramma astriforme, avesseanche voluto proclamare Gesù Cristo lumen de lumine e quindiDeum verum de Deo vero, sempre in chiave polemica antiariana.A possibile supporto di una simile interpretazione, si noti comeil cristogramma astriforme, in questa epigrafe, appaia affiancatoda elementi vegetali in forma di rametto, che potrebbero allude-re proprio allo scettro e al virgulto dei due passi biblici appenacitati, identificabili con il germoglio di cui parlano vari altri luo-ghi dell’Antico Testamento (Is. 11, 1; Ger. 23, 5; Zc. 3, 8; 6,12)162.Tali segni d’interpunzione, tutti tra loro abbastanza simili (rr. 2,4, 5) tranne uno, dall’evidente aspetto di un ramo di palma (r.4), risultano esattamente otto, che nell’interpretazione degliantichi Padri era il numero cristologico per eccellenza163.Secondo i Vangeli, infatti, passati otto giorni dalla nascita Gesùè stato circonciso, a testimonianza della sua umanità (Lc. 2, 21);e nell’ottavo giorno della settimana, «il primo giorno dopo ilsabato», è resuscitato dai morti, a testimonianza della sua divini-tà (Mt. 28, 1; Mc. 16, 2; Lc. 24, 1; Gv. 20, 1, 19). Oltre che svol-gere l’evidente funzione di segni diacritici, dunque, gli otto race-mi incisi sull’epitaffio decimese di Greca avrebbero anche potu-to alludere all’inizio della vera vita in Cristo, rappresentato dalvirgulto, e al trionfo sulla morte con lo stesso Cristo risorto, rap-presentato dalla palma antico simbolo delle vittorie agonali.Per lo stesso motivo, il ramo di palma fu anche assunto ad attri-buto biblico del martirio (1Mac. 13, 37, 51; 2Mac. 14, 4; Ap. 7,9), già esplicitamente inteso come tale anche dai cattolici africa-ni perseguitati dai Vandali164.D’altra parte, stando al suo epitaffio, Greca risulta essere mortaa un’età che potrebbe farla annoverare tra le vittime privilegiatedell’odiosa violenza ariana, cioè tra quelle virgines violatae cosìtanto numerose da spingere il pontefice Leone Magno, dopo laliberazione dell’Africa, a preoccuparsi personalmente della loroincerta sorte165.Ma allora perché, nella sua iscrizione funeraria, Greca non fuesplicitamente dichiarata martire?In parte è stato già detto. I Vandali cercavano di evitare di fare
161 VICT. VIT., Hist. pers. Afr. prov., III, 7(trad. it. cit. pp. 86-87). Cfr. anche IBIDEM,III, 8 (IBIDEM, pp. 88-89).
162 E. TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristianicit., p. 286.
163 IBIDEM, pp. 9, 47, 55, 63, 227, 374, 406,438.
164 VICT. VIT., Hist. pers. Afr. prov., V, 1 (trad.it. cit., p. 115, Maioricus).
165 LEO M., Epist., 12, 8 e 11 in PL 54, 653 e655; A. ISOLA, I cristiani dell’Africa vandali-ca cit., pp. 32, 84.
200
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
201
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
martiri166, e se capitava si sforzavano di impedirne il culto, dis-perdendone i corpi e distruggendone le sepolture167, come spiegamolto bene Antonino Isola: «Quanto alla penuria di monumen-ti funerari posti a memoria delle vittime vandaliche, bisogneràtenere ben presente che gli stessi cristiani potevano aver cura dicustodire con discrezione le memorie dei loro martiri, preser-vandole da eventuali rappresaglie disposte dal potere secolare»168.Questo potrebbe aver consigliato di tacere un’esplicita dichiara-zione di martirio e santità sull’epitaffio della giovane donna, cheavrebbe potuto mettere a repentaglio la conservazione delle suespoglie; senza rinunciare, tuttavia, a inserirvela quantomeno informa crittografica.Greca sarebbe stata quindi deposta nell’area cimiteriale cristianadell’antico centro punico-romano di Ad Decimum169, la quale, perla doppia intitolazione di cui alla metà del XIV secolo faceva fedela surriferita carta del re Pietro IV d’Aragona170, si potrebbe rite-nere originariamente dedicata a San Giorgio Megalomartire171.Proprio quest’ultimo particolare, alla luce di almeno un altrocaso, del tutto analogo, relativo alla parte centro settentrionaledell’isola, pur con tutte le cautele del caso parrebbe consigliareun serio riesame critico della possibilità che Greca, davvero, siastata martire di un evento persecutorio verificatosi nellaSardegna vandalica (e che tale persecuzione sia stata sistematicao sporadica qui poco importa), rimasto finora ignoto alle fontistoriche.I paralleli istituibili tra caratteristiche e modalità del culto diSanta Greca e di Santa Inbenia, venerata ab immemorabili comemartire a Cuglieri (OR), alle pendici del Montiferru172, sonoinfatti tanto stringenti da farle apparire addirittura gemelle.Come S(an)ta Grega anche S(an)c(t)a Inbenia, cui nel Condaghedi San Pietro di Silki risulta intitolata una chiesa o monastero,gode di un’incontestabile attestazione cultuale fin dal XII secoloalmeno173.Il nome di Inbenia costituisce un apax nell’intero mondo roma-no, e la sua venerazione, come quella di Greca, è circoscritta allasola Sardegna, per cui risulta impossibile ipotizzare per loro uneventuale sdoppiamento di figure agiografiche riferibili all’ester-no dell’isola174.La memoria di entrambe le martiri è sempre rimasta radicatapresso due antiche comunità di origine punico-romana, AdDecimum e Gurulis Nova, che l’hanno tradizionalmente custodi-ta fino al momento del risveglio umanistico della Sardegna, nelXVI-XVII secolo175.Di entrambe, nel Seicento, sono stati ritrovati gli epitaffi proprionegli incontestati epicentri del rispettivo culto: di Greca, lo si èvisto, a Decimomannu; di Inbenia a Cuglieri nel 1628176.Anche se, in progresso di tempo e con lo sviluppo del culto, illoro nome aveva poi finito per prevalere, entrambe erano statesepolte nell’ambito di aree funerarie o chiese originariamenteintitolate ad altri santi più antichi, martiri delle persecuzioniimperiali romane: nel caso di Greca San Giorgio, in quello diInbenia San Lussorio martire di Forum Traiani177.Le rispettive iscrizioni funebri, recentemente riesaminate in ori-ginale o in copia conforme con gli strumenti della moderna cri-tica epigrafica, ad onta della condanna a suo tempo espressa neiloro confronti dal Mommsen178 si sono rivelate autentiche e data-
166 Cfr. supra, note 133-134.167 VICT. VIT., Hist. pers. Afr. prov., I, 1; V, 1
(trad. it. cit., pp. 30; 116).168 A. ISOLA, I cristiani dell’Africa vandalica
cit., p. 43.169 C. LILLIU, Decimo e il suo territorio cit., pp.
60-83.170 Cfr. supra, nota 97.171 Sull’antichità assoluta del culto di San
Giorgio Megalomartire in Sardegna manca-no ancora studi specifici. Generalmente, lasua introduzione viene fatta risalire ad etàbizantina (cfr. A.F. SPADA, Storia dellaSardegna cristiana cit., pp. 242-243), maniente vieterebbe di collocarla anche in unperiodo anteriore. La devozione al celebremartire di Lydda, infatti, si era prepotente-mente diffusa in ambito latino già nel Vsecolo, nei cui anni iniziali il vescovo Severo(† 409) gli dedicava a Napoli una basilica(cfr. D. BALBONI, Giorgio, santo, martire, inBibliotheca Sanctorum, VI, Roma 1965, coll.512-525, col. 519) e il cosiddetto DecretumGelasianum, nel 496 circa, pur confermandola storicità del santo annoverava la spettaco-lare Passio Georgii nella propria Notitia libro-rum apocryphorum (cfr. H. DELEHAYE, Leslégends greques des saints militaires, Paris1909, pp. 45-76; E. PERETTO, DecretoGelasiano, in Dizionario patristico e di anti-chità cristiane, diretto da A. Di Berardino,Genova 1983, coll. 901-902). Nell’isola, alquarto miglio da Tharros, in corrispondenzadel punto in cui la strada per la città si bifor-cava verso Cornus e Othoca sorgeva un cen-tro abitato di origine romana, chiamato inetà tardo antica Oppidum Sancti Georgii (cfr.P.G. SPANU - R. ZUCCA, I sigilli bizantini dellaΣΑΡ∆ΗΝΙΑ, Roma 2004, pp. 77-86). Viesisteva una chiesa con annesso archivum evasto cimitero, che il ritrovamento di untipario fittile per la confezione di eulogieattesta dedicata a San Giorgio almeno dalVII secolo (cfr. M. DADEA, Due reperti epi-grafici bizantini dell’Antiquarium Arborensedi Oristano, in La ceramica racconta la storia.La ceramica nel Sinis dal Neolitico ai giorninostri, Atti del II Convegno di Studi(Oristano - Cabras, 25-26 ottobre 1996),Cagliari 1997, pp. 403-435, pp. 403-408).
172 Limitando la rassegna bibliografica all’ulti-mo cinquantennio cfr. G. PIRAS, I santi vene-rati in Sardegna cit., pp. 258-259; Dizionariodei santi venerati in Sardegna cit., pp. 115-117; A.F. SPADA, Storia della Sardegna cri-stiana cit., pp. 192-194; E. LILLIU,Iconografia dei santi sardi cit., p. 122; F.CIOMEI, Gli antichi martiri della Sardegnacit., pp. 295-297, I. CHISESI, Dizionario ico-nografico cit., p. 141.
173 G. BONAZZI, Il Condaghe di San Pietro diSilki. Testo logudorese inedito dei secoli XI-XIII, Sassari-Cagliari 1900, sch. 316, pp. 75-76.
174 H. SOLIN, Analecta epigraphica CLIV.Inbenia. Zu einer Sardischen Inschrift,“Arctos”, 27, 1993, pp. 130-131, suggeriscedi normalizzare questo nome in Inventa (nelsenso di “Esposta”, “Trovatella”) ipotizzandoche, nell’epigrafe in esame, al betacismodello ordinator si fosse malauguratamenteunita anche la disattenzione dello scriptor, ilquale avrebbe dimenticato di incidere il trat-to orizzontale della T. Tale proposta, cheanche A.M. CORDA, Le iscrizioni cristianedella Sardegna, p. 158, ritiene probabilmentefondata, presupporrebbe tuttavia che il cultodi tale ipotetica Inventa > Inbenta, sbadata-mente trascritta Inbenia e in quest’ultimaspecifica forma conosciuta e venerata già nelXII secolo, proprio da Cuglieri si fosse diffu-so nel resto della Sardegna (Codrongianus,Porto Conte d’Alghero e Padria) traendo ori-gine da un’ulteriormente erronea letturadella sua iscrizione funeraria: qui infattisarebbe stata vista la parola martyr, laddoveinvece essa non sarebbe mai esistita.Ricostruzione forse un po’ troppo macchino-sa (oltre che affatto originale: cfr. ad es. M.SERRA, Mal di Sardegna, Firenze 19563, p.233), e perciò verosimilmente accantonabi-le.
175 Su Gurulis Nova cfr. R. ZUCCA, Gurulis Nova- Cuglieri. Storia di una città dalle origini alsecolo XVII, Oristano 2006, pp. 109-125.
176 A.G. ANGOTZI, Traduzione italiana dalle lin-gue spagnola e portoghese degli atti originali
202
Santa Greca: la martire di Decimomannu di Mauro Dadea
riguardanti l’invenzione delle reliquie ed il cultodi Santa Imbenia Vergine e Martire, Cagliari-Sassari 1895, pp. 17-18.
177 IBIDEM, p. 27; R. ZUCCA, Gurulis Nova cit.,pp. 148-152.
178 L’epitaffio di Inbenia fu da lui registrato inCIL X, 1, 1248*.
179 M.G. CAMPUS, Il titulus funerario diInbenia (Cuglieri). Contributo alla riletturadel materiale epigrafico cristiano dellaSardegna, “L’Africa Romana”, VIII, 1990(1991), pp. 1063-1072 = AEp. 1991, 910.
180 Nel caso di Inbenia, i dubbi si incentranosul segno che apre la terza riga dell’epigrafe.Si tratta di una M le cui sbarrette trasversali,a differenza di quanto si osserva sulle altretre stesse consonanti ricorrenti nel testo, siprolungano, incrociandosi, fino a toccare labase di quelle verticali, formando apparente-mente un nesso MA- (da escludere, nel con-testo specifico, la possibile alternativa AM-).Dell’epitaffio, dunque, tradizionalmenteveniva data questa lettura: Hic req(ui)escet(!) fa/mula D(e)i Inbenia / ma(rtyr), Ianuariid(ie) III / migravit a sec(ulo). (!) Vivat inD(omi)no. / Amen. Ne ammette la possibili-tà, pur ritenendola personalmente improba-bile, A. MASTINO, La romanità della societàgiudicale in Sardegna: il Condaghe di SanPietro di Silki, in La civiltà giudicale inSardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documen-ti scritti, Atti del convegno (Sassari, 16-17marzo 2001 - Usini, 18 marzo 2001), a curadell’Associazione “Condaghe San Pietro inSilki”, Sassari 2002, pp. 23-61, p. 61. Alcontrario secondo R. ZUCCA, Gurulis Novacit., p. 151, «il dato fondamentale dell’au-topsia (scil. quella effettuata sull’epitaffio il 5dicembre 1986) è costituito dalla insussi-stenza del nesso MA alla linea tre, che avevaconsentito nel XVII secolo la soluzionema(rtyr)». Analogamente a M.G. CAMPUS, Iltitolo funerario di Inbenia cit., pp. 1068-1069, e ad A.M. CORDA, Le iscrizioni cristia-ne della Sardegna cit., pp. 157-158, perciò,ignorando la presenza del presumibile nessopreferisce leggere m(ensis) Ianuarii d(ie) III.
181 A. MASTINO, La Sardegna cristiana in etàtardo-antica, in La Sardegna paleocristianatra Eusebio e Gregorio Magno, Atti delConvegno Nazionale di Studi (Cagliari, 10-12 ottobre 1996), a cura di A. Mastino, G.Sotgiu, N. Spaccapelo, con la collaborazionedi A.M. Corda, Cagliari 1999, pp. 263-307,p. 300.
182 Come quella, ad esempio, del beatissimusmartyr Luxurius, apposta nel VI secolo sulluogo del suo martirio a Forum Traiani, l’o-dierna Fordongianus (cfr. R. ZUCCA, Le iscri-zioni latine del martyrium di Luxurius(Forum Traiani - Sardinia), Oristano 1988,p. 21 = AEp. 1990, 459).
bili all’età vandalica179.Entrambi gli epitaffi offrono la possibilità di un’interpretazionecrittografica che avrebbe potuto voler rivelare ai soli iniziati, permotivi di sicurezza, come nonostante il loro aspetto esteriore deltutto ordinario essi, in realtà, fossero stati incisi per contrassegna-re le sepolture di altrettante martiri della persecuzione ariana180.Le coincidenze, come si vede, sembrerebbero davvero tropponumerose per poterne semplicisticamente sostenere la puracasualità.Di lì a poco poi, nel 534, la Sardegna fu riconquistata dalle arma-te dell’imperatore Giustiniano e il cattolicesimo fu ovunqueristabilito181.In questo momento, con quella di Inbenia, dovette aver inizio lavenerazione pubblica di Greca, in quanto a tutti gli effetti marti-re della sua fedeltà a Cristo Dio. Alla sua iscrizione funeraria ori-ginale, ovviamente conservata, nel corso del tempo potrebbeesserne aggiunta anche un’altra, di carattere cultuale, con unadichiarazione esplicita della sua santità e del suo martirio182: forsela vera fonte d’informazione a suo riguardo conosciuta nel corsodel medioevo, della quale però, per il momento, sembrerebbenon essere rimasta alcuna traccia.