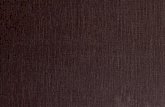Fra Antichità e Storia
Transcript of Fra Antichità e Storia
FRA ANTICHITÀ E STORIA 3
MARIANO MALAVOLTA
Fra Antichità e Storia
(conferenze 2006-2012)
UniversItalia
4 MARIANO MALAVOLTA PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA Copyright 2013 - UniversItalia - Roma ISBN 978-88-6507-405-3 A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registratori o altro. Le fotocopie per uso personale del lettore possono tuttavia essere effettuate, ma solo nei limiti del 15% del volume e dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art.68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633. Ogni riproduzione per finalità diverse da quelle per uso personale deve essere autorizzata specificatamente dagli autori o dall’editore. In copertina: Il vaso Portland (Londra, British Museum).
FRA ANTICHITÀ E STORIA 5
Sommario Storia, historia, (h)istorìa, serendipity: le connessioni
originarie fra indagine storica e “metodo” scientifico (2011), pp. 9-32. - Re del bosco, re della città. Alle origini dei sacra nominis Latini (2006), pp. 33-60. - In caelo Romulus (2011), pp. 61-76. - Ventisette secoli (e mezzo) di “Roma ladrona” (2012), pp. 77-92. - Il concetto di tutela dell’ambiente nell’antica Roma tra religione, filosofia e diritto (2009), pp. 93-116. - Costantino in Campidoglio (2012), pp. 117-130. - Cassero, qasr, castrum: destrutturazione del limes e medioevo nostrano (2011), 131-147. - Per un archivio dell’effimero (2012), pp. 149-155.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 7
Premessa Gli scritti che ho raccolto in questo libretto, che non vorrei
chiamare libercolo, sono con ogni evidenza “scritti d’occasione”, pensati ed elaborati per essere letti in pubblico, e dunque apparterrebbero, secondo la communis opinio, ad un genere per definizione subalterno, di limitato valore scientifico. Io sono convinto del contrario, per l’esperienza di una ormai lunga pratica d’insegnamento (le prime lezioni, anzi “esercitazioni”, le ho fatte a Siena nell’ormai lontano 1974) che a tutti noi che facciamo questo mestiere ha mostrato la notevole differenza che corre fra lo scrivere un testo destinato alla pubblicazione e l’elaborare un discorso diretto a un uditorio presente e, magari, reattivo. Ho ritenuto, inoltre, che proprio per questo motivo gli scritti qui radunati possano fornire ai miei studenti non frequentanti uno specimen di come possa essere affrontato un percorso di approfondimento, al di là delle linee canonizzate nei manuali, di singoli argomenti o di motivi d’interesse specifico in una materia di studio - la Storia romana - considerata per lo più propedeutica all’antichistica in generale e che proprio per la sua caratteristica di immenso ed insostituibile contenitore di cultura “condivisa” ha sempre goduto, almeno fino a qualche decennio fa, di una posizione privilegiata nell’avvio delle giovani generazioni agli studi umanistici.
La stesura di questa premessa mi offre inoltre una occasione, di cui approfitto, per consegnare alle stampe (sia pure nel numero limitatissimo degli esemplari di questo libretto che vedranno la luce) una mia personalissima quanto inutile (me ne
8 MARIANO MALAVOLTA rendo ben conto) protesta contro la peste della delirante idiozia che sta travolgendo il mondo accademico, il nostro ineffabile Ministero, gli organi collegiali di tutte le facoltà di questo martoriato Paese, divenuti vittime ben consapevoli, e spesso compiacenti, di una schizofrenia che da ultimo si è manifestata senza pudore nelle inutili quanto inconcludenti maratone della Valutazione della Qualità della Ricerca, del Tirocinio Formativo Attivo, e di altre amenità del genere. Non altro voglio dire rivolgendomi a chi queste cose ben conosce, e quello che con più disgusto mi limito a denunziare è il silenzio acquiescente di tutti quelli che invece avrebbero dovuto far saltare a calci i tavoli sui quali la stoltezza dei più sta (non scientemente, si badi bene) pianificando la distruzione dei talenti per sostituirvi la più gigantesca rete di minuto quanto squallido malaffare che abbia mai afflitto il mondo degli studi.
Roma, 8 gennaio 2013.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 9
Storia, historia, iJstoriva, serendipity: le connessioni originarie fra indagine storica e
“metodo” scientifico1 Ho accolto con piacere l’invito, che mi è stato rivolto dal
professor Tito Pasqualetti, mio antico Maestro, a partecipare a questa giornata rievocativa del cinquantenario del liceo che per cinque anni ho frequentato come allievo, uscendone dopo la maturità nell’ormai lontano 1967 (dunque quarantacinque anni fa) e non nascondo la mia emozione di parlare in questa sala dell’allora cinema Pomponi, dove per tante volte sono stato seduto in platea, arrivando qui dalla mia lontanissima Cossignano: anche questa è “storia”, la mia storia, che interessa soprattutto me, mentre l’argomento che ho scelto per annoiare voi, giovanissimi amici, riguarda il significato più generale della parola “storia”: una di quelle parole che usiamo con grande frequenza e disinvoltura, ma spesso senza troppo riflettere sul loro più autentico significato.
Il concetto di storia possiamo incominciare a chiarirlo osservando che questo vocabolo anche nella nostra lingua italiana si presenta in contesti diversi, anche di linguaggio corrente, con più di un significato: di una qualsiasi banale vicenda da raccontare si può dire che è “una lunga storia”, con allusione alla concatenazione di fatti correlati fra loro in 1 Testo (in parte rielaborato) della relazione svolta il 30 maggio 2012 nel Teatro “Concordia” di San Benedetto del Tronto, in occasione delle celebrazioni per il Cinquantenario del Liceo classico “G. Leopardi”.
10 MARIANO MALAVOLTA maniera complessa, e allo stesso modo una relazione di qualsiasi tipo (non necessariamente amorosa) può essere definita “una storia”, mentre l’espressione “fare storie” può alludere a reticenze, spiegazioni o motivazioni complicate, per lo più pretestuosamente addotte. La storia insomma è una cosa da spiegare e da capire, con un prima, un dopo, azioni e reazioni dei protagonisti e, magari, rivelazioni illuminanti di retroscena ignoti agli stessi protagonisti.
C’è poi la storia che si studia sui libri, che è quella che qui ci interessa, e che è stata anch’essa accomunata nel giudizio di personaggi anche importanti, ancorché non specialisti, al significato corrente, illustrato sopra, di “insieme di frottole” o “chiacchiere”: così nello spicciativo giudizio di Henry Ford, il re americano dell’automobile “la storia è - più o meno - un fuorviante sproloquio2 (bunk). Essa è tradizione. Noi non abbiamo bisogno di tradizione: noi vogliamo vivere nel presente, e la sola storia che valga qualcosa è la storia che noi costruiamo giorno per giorno”3. D’altra parte, qualche anno dopo aver detto quest’idiozia, lo stesso Ford si riscattò, almeno in parte, promuovendo la fondazione di un museo dell’automobile, nel quale il visitatore potesse seguire le linee evolutive della “storia” della produzione dei veicoli a quattro ruote, documentata dai modelli realizzati nei pochi decenni precedenti. Non meno interessante l’etimologia della voce
2 Questa traduzione di bunk - forse un po’ lambiccata - cerca di rendere il valore pregnante dello slang : la vuota chiacchiera della storia, insomma, non è solo inutile, ma anche disonesta e imbastita con l’intento di imbrogliare chi ascolta. 3 History is more or less bunk. It's tradition. We don't want tradition. We want to live in the present and the only history that is worth a tinker's damn is the history we make today.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 11 gergale bunk usata da Ford (abbreviazione di bunkum), che nello slang americano indica appunto una fandonia, e trae la sua origine dal discorso che tal Felix Walker, delegato della contea di Buncombe (North Carolina) volle fare a tutti i costi il 25 febbraio del 1820 nella House of Representatives a Washington (nel corso di una lunga ed estenuante sessione), sol perché il testo ne fosse pubblicato dai giornali e mostrasse agli elettori della sua contea che egli era membro attivo del Congresso: “I shall not be speaking to the House - egli avrebbe dichiarato - but to Buncombe” e da quel momento la voce bunkum, ossia il nome della suddetta contea, così storpiato dall’uso, divenne sinonimo di ogni “nonsensical language”, e si diffuse al punto di produrre una forma abbreviata bunk , di uso comune.
Assai più complessa e di ben altro spessore si presenta, ovviamente, l’indagine che possiamo imbastire sul vocabolo “storia”, che così si denomina dal derivato di una parola latina (historia) imprestata alla lingua volgare (‘istòria’, poi ‘storia’), nella quale l’accento cade sulla o perché la i dell’iato ia è una vocale breve, e dunque la legge della prosodia latina fa ritrarre l’accento sulla terzultima. A sua volta il latino historia è trascrizione o, meglio, traslitterazione (nelle lettere dell’alfabeto latino) di una parola greca, iJstoriva, nella quale si deve notare lo spirito aspro sullo iota iniziale, che indica l’aspirata, e che si conserva nella h iniziale del latino historia.
Intanto è significativo (si devono notare questi particolari apparentemente ovvii, visto che la storia è fatta di queste cose, e con questo metodo) che i Romani o Latini che dir si voglia, per dare un nome alla storia siano stati costretti a scegliere una parola greca, ossia straniera: è evidente che la
12 MARIANO MALAVOLTA cultura romana, allorché nel terzo secolo a.C. i Romani cominciarono a parlare di storia, non aveva ancora elaborato un vocabolo adatto a definire nella lingua latina un’attività teoretica così complessa.
Tornando al greco iJstoriva, che correntemente significa “indagine”, “ricerca”, è da ricordare che l’origine di questo vocabolo è assai antica, e si riconnette al vocabolo i{stor (= colui che sa, che conosce le leggi), che è presente già nel nucleo originario dei poemi omerici, nel libro 18° dell’Iliade; i glottologi lo fanno derivare dal tema vid di oida e orao [“vedo”]: dunque è histor “colui che sa” e che sa “per aver visto” o, come vedremo, “per aver investigato su ciò che non ha visto”, dal momento che il significato corrente di historeo è “indago”.
Il luogo omerico di cui abbiamo parlato è la descrizione (che poi diventerà archetipo di un genere letterario, l’èkphrasis) delle scene istoriate4, ossia incise col bulino o a sbalzo dal dio Efesto (il Vulcano dei Romani), che è un bravissimo fabbro, sullo scudo che lo stesso Efesto fabbrica per volere della divina Teti, che dello scudo fa dono al figlio Achille (nato da Peleo e da Teti), che ne è rimasto sprovvisto per avere imprestato le sue armi all’amico Patroclo, ucciso in combattimento da Ettore.
Omero, come per comodità chiameremo l’anonimo o gli anonimi poeti dell’Iliade, si mostra in questo caso orgoglioso del grado di civiltà raggiunto dal suo popolo e coglie il pretesto di questa descrizione dello scudo per immaginare
4 Questo è un altro significato del vocabolo storia, derivato anch’esso dal latino volgare (i)storia, che significa “raffigurazione di un fatto”: dunque ‘istoriare’ = ‘decorare con una scena figurata’.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 13 rappresentate, in un contesto figurato, le occasioni più caratteristiche della vita civile della immaginaria comunità: una delle situazioni che meglio si prestano ad essere scelte per comporre questa specie di sintesi figurata della civiltà coeva è una questione giudiziaria: un processo, si direbbe oggi, che si svolge presso un tribunale, dinanzi al quale i cittadini della immaginaria città assistono ad una lite per il mancato pagamento di una somma che è dovuta, come risarcimento ai familiari di un ucciso, da un omicida, ciò che sta ad indicare l’avvenuto superamento del primitivo istituto della vendetta personale secondo la legge dell’occhio per occhio, dente per dente, superstite ancora ai nostri giorni, come abbiamo potuto constatare dal reportage televisivo andato in onda nell’autunno 2001, che ha mostrato lo sgozzamento in diretta di un omicida, operato direttamente dalla madre dell’ucciso sul colpevole, consegnatole legato mani e piedi dal tribunale islamico dello stato dei Talebani. Anche ai tempi della città immaginaria descritta nello scudo, in effetti, è ben verosimile che l’omicida non cadesse ancora sotto sanzioni di stato, ma fosse soggetto soltanto alla vendetta “privata” dei parenti del morto: ma nel contesto culturale presentato da Omero, già irrimediabilmente “contaminato” da fermenti evolutivi anticipatori della futura “civiltà”, poteva altresì accadere che i danneggiati dall’omicidio avessero convenienza a sanare la controversia mediante un compenso di beni, che offriva un’alternativa incruenta al primitivo quanto feroce rituale della faida o legge del taglione, che in ambiente romano è documentata ancora (talio) nella lex duodecim tabularum del 451-450 a.C.
Ma vediamo cos’è esattamente questa ‘storia’ raffigurata
14 MARIANO MALAVOLTA sullo scudo, leggendo la bella traduzione italiana del Monti:
D’altra parte nel foro una gran turba convenir si vedea. Quivi contesa era insorta fra due che d’un ucciso piativano la multa. Un la mercède già pagata asserìa; l’altro negava. Finir davanti a un arbitro la lite chiedeano entrambi, e i testimon produrre. In due parti diviso era il favore del popolo fremente, e i banditori sedavano il tumulto. In sacro circo sedeansi i padri su polìte pietre, e dalla mano degli araldi preso il suo scettro ciascun, con questo in pugno sorgeano, e l’uno dopo l’altro in piedi lor sentenza dicean. Doppio talento d’auro è nel mezzo da largirsi a quello che più diritta sua ragion dimostri. [vv. 690-706] Dunque, di fronte alle pretese di uno dei familiari
dell’ucciso, che reclama il risarcimento, l’omicida (a sua volta attorniato dai suoi familiari) oppone di aver già provveduto al pagamento della multa, e dunque si origina la lite fra due partiti i quali alla fine decidono di rivolgersi ad un “arbitro” che dirima la controversa questione, ossia, nel testo greco (S501): ejpi; i{stori pei'rar ejlevsqai [epì hìstori pèirar elèsthai]; ed ecco entrare in ballo questa primigenia quanto enigmatica figura di histor.
Il discorso che abbiamo in mente di fare sulla “storia” di
FRA ANTICHITÀ E STORIA 15 questo vocabolo non può ovviamente prescindere da una accurata analisi delle sue occorrenze nella più antica letteratura del popolo greco5. Oltre che nel diciottesimo libro dell’Iliade il vocabolo histor ricorre anche nel libro ventitreesimo del poema, nella rapsodia sui giochi funebri in onore del defunto Patroclo. Anche in questi versi vediamo delinearsi una disputa - rinforzata da una scommessa - fra due “tifosi” di opposte fazioni che assistono alla gara delle bighe:
Nel circo assisi intanto i prenci achei stavansi attenti ad osservar da lungi i volanti cavalli che nel campo sollevavan la polve. Idomeneo re de’ Cretesi gli avvisò primiero, che fuor del circo si sedea sublime a una vedetta. E di lontano audita del primo auriga, che venìa, la voce, lo conobbe, e distinse il precorrente destrier che tutto sauro in fronte avea bianca una macchia, tonda come luna. Rizzossi in piedi e disse: O degli Achei prenci amici, m’inganno, o ravvisate quei cavalli voi pure? Altri mi sembrano da quei di prima, ed altro il condottiero. Le puledre che dianzi eran davanti
5 L’indagine è stata affrontata più d’una volta, ma basterà qui rinviare alle pagine scritte su questo argomento da C. DEL GRANDE, Nascita della i[storiva. Prolusione al corso di Letteratura greca pronunciata nell’Università di Bologna il 16 febbraio 1949. Napoli [Ricciardi] 1952, pp. 5-22, lavoro del quale citeremo ampi stralci.
16 MARIANO MALAVOLTA
forse sofferto han qualche sconcio. Al certo girar primiere le vid’io la meta; or come che pel campo il guardo io volga, più non le scorgo. O che scappar di mano all’auriga le briglie, o ch’ei non seppe rattenerne la foga, e non fe’ netto il giro della meta. Ei forse quivi cadde, e infranse la biga e le cavalle devïar furïose. Or voi pur anco alzatevi e guardate: io non discerno abbastanza, ma parmi esser quel primo l’ètolo prence argivo Dïomède. Che vai tu vaneggiando? Aspro riprese Aiace d’Oïleo. Quelle che miri da lungi a noi volar son le puledre. Più non sei giovinetto, o Idomenèo: la vista hai corta, e ciance assai, né il farne molte t’è bello ov’altri è più prestante. Quelle davanti son, qual pria, d’Eumèlo le puledre, e ne regge esso le briglie. E a lui cruccioso de’ Cretesi il sire: Malèdico rissoso, in questo solo fra noi valente; ed ultimo nel resto, villano Aiace, deponiam su via un tripode e un lebète, e Agamennòne giudichi e dica che corsier sian primi, e pagando il saprai. [vv. 583-625]
FRA ANTICHITÀ E STORIA 17
Il signore di Creta, Idomeneo, è in disaccordo con un altro dei capi, Aiace Oileo, su chi è in testa, ed è da costui schernito e chiede quindi che fra loro due sia Agamennone, anche per la sua autorevolezza di comandante in capo degli Achei, a fare da histor (v. 486).
Dunque, già in Omero le valenze del vocabolo si presentano con sfumature diverse (come mostra un elementare confronto fra i due contesti narrativi) per le quali nel seguito della sua evoluzione la lingua greca principiò a distinguere, dentro il generico concetto di “giudice”, fra il significato di “uomo capace di indagine” (kritès) e quello di “custode e conoscitore delle leggi” (dikastès o thesmothetès). Per l’histor omerico i più autorevoli lessici giudicano unanimemente che esso sia formato dalla radice »Ûid [leggi: vid] di orào e di òida (= “ho visto”, e quindi, “so”), radice indoeuropea conservata nel verbo latino video (= “io vedo”); quanto al significato si registra - negli stessi lessici - una oscillazione fra “colui che sa” (perché ha visto: una traduzione che aderisce all’etimologia) e “giudice” (traduzione desunta dai contesti dei luoghi citati). Agamennone, nel secondo dei due contesti, può fare da histor fra Idomemeo e Aiace “perché conosce meglio degli altri i cavalli dei concorrenti, perché ha una buona vista a scorgere i segni a distanza, e soprattutto perché, moderatore supremo dell’esercito, è l’unico ad avere posizione preminente tra due eroi, capi di schiere anch’essi”. Nella scena dello scudo di Achille, invece, histor è colui che sa di costumanze e leggi e contemporaneamente è capace di inquisire sulla verità di un fatto tra versioni contraddittorie e diverse, e dunque uno che sa un mestiere, una disciplina di
18 MARIANO MALAVOLTA cui altri discute, e la sa al punto da essere buon giudice di quello che sia il vero, anche se questo vero è da individuare fra pareri e testimonianze contrastanti.
Giudice e conoscitore è anche l’histor menzionato da Esiodo6, che istruendo i suoi sceltissimi lettori sulle qualità dei singoli giorni del mese dice che ogni “grande ventesima” nasce un uomo che possa essere histor, ossia un giudice fornito di tutti i requisiti: saggio, prudente, accorto, equilibrato, onesto; in un verso di Sofocle, invece, a proposito della morte di suo padre, Elettra (v. 850) afferma di essere histor, anzi, yperhistor, ossia una che ha visto con i propri occhi come sono andate le cose, e dunque il termine scende al significato più umile di testimone oculare, che sa perché ha visto: una accezione che resta anche nel linguaggio giuridico di età storica, come mostra un’iscrizione di Tespie nella quale, per giunta, il vocabolo è attestato nella presumibile forma originaria Ûivstwr 7.
Ma il confronto più illuminante ai fini del nostro discorso sul nesso originario fra indagine storica e metodo scientifico è offerto da un frammento di Eraclito (avremo modo di parlare di lui ancora più avanti), nel quale il vocabolo appare mostrando per intero la “pregnanza” del suo valore, allorché si afferma che “di ben molte cose conviene che siano indagatori (historas) gli uomini che professano filosofia”. Si è
6 In ESIODO, Le opere e i giorni, (composto fra VIII e VII secolo), al v. 792 sg. leggiamo: Eijkavdi d''!ejn mega;lh/, plevw/ h[mati, i{stora fw'ta É geivnesqai (= “Grande è il ventesimo [scil. giorno del mese]! Al suo culmine potrai generare un bel maschio, ed esso sarà di mente molto accorta”. Curioso il riscontro con il 21 maggio, sacro a Giano agonio nel calendario romano. 7 I.G. VII 1779, 1780 cfr. SCHWYTZER 492.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 19 notato, a questo riguardo, che “chi conosce la dizione di Eraclito e sa come egli ritenesse che la polumaqiva, ossia l’avere imparato molte cose, non fa nou'" (ossia non fa “mente”, non fa “intelletto”, non fa vera scienza, insomma), comprende bene come egli intendesse qui histor, oltre che con il significato spicciolo di “colui che sa”, anche con quello più specifico di “ricercatore”, e non tanto di leggi umane, come era per l’histor di Omero e di Esiodo, quanto delle forme e delle leggi della vita fenomenica, per giungere ad un assoluto da mirare come verità: histor è dunque, per Eraclito, chi ricerca, chi indaga ciò di cui si può giungere alla scienza. Ed è questa infatti, nella maggioranza dei casi, la valenza semantica originaria dei derivati di histor, ossia del verbo iJstorei'n e del sostantivo iJstoriva; il verbo si presenta con il significato di cercare di sapere, indagare, inquisire, e nella forma ajnistorei'n è documentato nel Prometeo di Eschilo (v. 956) con il significato di “chiedere per sapere”, analogo a quello del latino quaero, per il quale è da confrontare il quaistor o quaestor paricidas della lingua latina arcaica, che designa il magistrato che indaga sull’omicidio di un cittadino (il paricidium, e non semplice homicidium, che non sempre è considerato reato). Il vocabolo iJstoriva, al suo primo apparire, significa dunque “ricerca per giungere a qualcosa” che sia possibile conoscere, a vantaggio e a frutto di patrimonio comune del sapere, e anche in questa forma di sostantivo ricorre in un frammento dello stesso Eraclito, conservato da una citazione di Diogene Laerzio8: “Pitagora (figlio) di Mnesarco più di tutti gli uomini curò l’ iJstoriva, e avendo fatto una scelta di queste esposizioni (cioè delle 8 Vita dei filosofi VIII 6 = fr. 129 D.
20 MARIANO MALAVOLTA suggrafaiv, gli scritti composti prima di lui) creò la propria sapienza, erudizione, possesso di mezzi a fini malvagi”. Dal momento che la tradizione è concorde nel non attribuire a Pitagora interessi che noi oggi diremmo “storici”, è chiaro che il fisico Eraclito intendeva riferirsi ad una ricerca nel campo dei medesimi problemi che assillavano le menti degli altri “presocratici”, con la stessa accezione che, del resto, ritroviamo nel Fedone platonico, dove Socrate ne parla in modo negativo, quasi come di una malattia infantile di quel genio che poi si sarebbe evoluto verso la vera speculazione filosofica: “Vedi, Cebete, quand’ero giovane io mi sentivo trasportato in modo straordinario verso quella scienza che indaga sui misteri della natura, quella che chiamano storia naturale (peri; fuvsew" iJstorivan). Oh! Sapere le cause di ciascuna cosa! Sapere il perché ciascuna cosa viene alla vita, perché si dissolve, perché esiste. Quante volte mi sentivo tutto sconvolto, quando cercavo la risoluzione di problemi come questi: non è forse vero che quando un misterioso processo, che par di putrefazione, interviene nel caldo e nel freddo, taluni affermano che allora appunto i viventi prendono tutti insieme consistenza e forma? Oppure è forse il sangue l’elemento che consente il pensiero all’uomo? L’aria, forse? Il fuoco? Oppure nessuno di questi elementi, e invece il cervello è suscettivo di produrre le sensazioni dell’udito, della vista, dell’odorato? Da queste sensazioni proviene il ricordo (mnhvmh), l’opinione (dovxa)a; e a sua volta dal ricordo e dall’opinione, resi tranquilli e profondi, si viene formando, appunto con questo processo, la scienza (ejpisthvmh)9”.
9 96b, p.332 FOWLER; trad. di E. TUROLLA.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 21
Da questo significato originario di storia come “storia naturale”, quale doveva essere magistralmente illustrato nell’opera di Anassagora (che infatti è citato subito dopo da Socrate nel prosieguo delle sue argomentazioni in risposta a Cebete) e ancora superstite nella locuzione italiana a motivo della fortuna del titolo della Naturalis historia di Plinio, si passò poi al significato divenuto predominante di “storia” quale oggi l’intendiamo, attestato già nel proemio delle Storie di Erodoto: “Questa è la esposizione della historìa di Erodoto di Turi, perché di quanto è avvenuto da parte degli uomini il ricordo col tempo non svanisca, né rimangano senza gloria le opere grandi e meravigliose compiute dai Greci e dai barbari”. In questa “esposizione di ciò che si sa” fatta da Erodoto la materia è chiaramente storica (le gesta dei Greci e dei barbari), ma il metodo d’indagine è quello già affinato e sperimentato nelle scuole filosofiche della Ionia ed in quelle italiche della Magna Grecia: un metodo maturato in un contesto di grecità di frontiera che, senza negare il divino, sceglieva però di non fermarsi al racconto tradizionale e indiscriminato del mito e lo sottoponeva al vaglio della ragione.
Da tutto quel che abbiamo detto risulta chiaro che historìa fu in un primo momento ricerca razionale pertinente ai problemi dell’essere e del divenire, e solo in un secondo momento ricerca, fatta con un siffatto metodo, portata sui fatti che più propriamente chiamiamo storici; mentre la notizia secondo cui ancor prima di Erodoto fu Ecateo di Mileto a comporre in prosa una historìa induce a ritenere non usurpata la fama di “padre della storia” che egli contese ad Erodoto già nell’antica letteratura dossografica: come
22 MARIANO MALAVOLTA Pitagora, portando un suo metodo di ricerca e di discriminazione intuitiva sulle syngraphài esistenti di argomento religioso e filosofico (non necessariamente tutte in lingua greca), aveva formato una sua scienza (chiamata filosofia, e non semplicemente sophia), così Ecateo, applicando alle syngraphài di materia narrativa il medesimo metodo, o un altro più o meno simile, aveva stabilito una sua versione personale della storia primitiva dell’Ellade, e questo suo metodo si era a tal punto sposato a quella materia che il vocabolo historìa (che ancora in Eraclito, come abbiamo visto, designava il metodo, e non la materia) in breve passò a significare quel che noi diciamo racconto storico o anche storia nell’accezione comune. Quello che in seguito distinguerà la storia dalla scienza sarà “l’emergere di un paradigma scientifico imperniato sulla fisica galileiana” e sul rigore “nell’impiego della matematica e del metodo sperimentale, che implicavano rispettivamente la quantificazione e la reiterabilità dei fenomeni”, mentre la prospettiva individualizzante delle discipline basate sul paradigma indiziario (tali, oltre alla storia, la medicina) “escludeva per definizione la reiterabilità del fenomeno ed ammetteva la quantificazione solo con funzioni ausiliarie”. Si presenta di particolare interesse, a questo riguardo, l’osservazione di Carlo Ginzburg10 (l’autore del contributo che stiamo citando) che una conferma di questa divergenza si ebbe nel corso del XVII secolo, allorché “l’innesto dei metodi dell’antiquaria sul tronco della storiografia portò
10 C. GINZBURG, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in “Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce” a cura di UMBERO ECO e THOMAS A. SEBEOK. Milano [Bompiani] 1983, p. 111.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 23 indirettamente alla luce le lontane origini indiziarie di quest’ultima”: origini, possiamo aggiungere, delle quali l’uomo antico fu ben consapevole, individuando come precipua funzione della storia la trattazione della “materia non sottoposta a regole metodiche”11.
Dunque, nella funzione specifica (non ancora scissa dal complesso articolarsi della teoresi) che abbiamo vista affidata all’histor omerico, che deve ricostruire dopo attente ricerche un frammento del passato noto solo ai protagonisti (uno dei quali, con ogni evidenza, mente) e che egli deve in qualche modo “vedere” (ossia ricreare, ricostruire) servendosi degli indizi di cui può venire a conoscenza (per il mezzo della escussione dei testi e di indagini su altre fonti): in questa funzione, si diceva, viene in qualche modo definito in nuce, in un testo antichissimo, il compito che sarebbe stato dello storico, al quale si richiede, ora come ai tempi di Tucidide o Tacito o Machiavelli, una facoltà che è almeno in parte divinatoria, come ribadito dalla teoria humboldtiana del “dono degli annodamenti” (di Verknupfungsgabe parlò infatti Karl Wilhelm von Humboldt [1767-1835]), e, più di recente, nelle citate pagine di Carlo Ginzburg, alle quali si rinvia, e nelle quali si parla di “abduzione”, “intuizione bassa” (facoltà posseduta per eccellenza dal sesso femminile), il lavoro dello storico si trova ad essere sempre più accostato a
11 Così affermava TAURISCO (discepolo di CRATETE DI MALLO) citato da Sesto Empirico, medico e filosofo scettico, appartenente alla scuola medica empirica, nel trattato Contro i matematici 1, 249:iJstorikovn de; to; peri; thvn proceirovthta th'" ajmeqovdou u{lh". Poco più avanti, si ribadisce la concordia dei teorici: a[tecnon ei\nai kai ; ejk th'" ajmeqovdou u{lh" tugcavnein. Cfr. S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, I, Bari 1965, p. 485.
24 MARIANO MALAVOLTA quello di un giudice, o di un poliziotto indagatore (un detective come Holmes), che cercano il colpevole, o di un medico che cerca la causa, a volte nascostissima, di uno stato di infermità distinto da particolari sintomi, o viene accostato a quello dello scienziato che fa una importante scoperta scientifica (si pensi alle leggi gravitazionali intuite da Isaac Newton o all’esistenza delle onde radio, svelata dal nostro Marconi), o di un cacciatore che insegue una preda sulla base dei segni che questa lascia sul terreno. Anche qui l’intuizione “bassa” gioca un ruolo predominante: per tutte queste situazioni è infatti indispensabile una buona dose di ‘sensitività’ che si potrebbe dire animalesca (si pensi, nell’ambito dell’analogia del cacciatore, all’abitudine degli animali di occultare i propri escrementi a scopo difensivo, già prima che contro i cacciatori, contro altri animali predatori); una facoltà insomma che affonda le sue radici, così come la distinzione fra i sessi, ad un’epoca assai antecedente all’evoluzione dell’homo sapiens e all’elaborazione della logica deduttiva aristotelica.
Questa primordiale attitudine all’indagine riscontrata
dagli esegeti nell’histor omerico, e che appare incentrata sulla capacità, ritenuta non comune, di “scorgere”, anzi, per meglio dire, di “vedere” gli indizi rivelatori non è del tutto priva di interessanti riscontri: pensiamo alla riscoperta, verso la fine del XVIII secolo, di quella che Horace Walpole chiamò “serendipity”, in una lettera scritta a Horace Mann, un suo amico che viveva a Firenze, il 28 gennaio del 1754, con riferimento ad un fenomeno che peraltro era già ben presente nella pubblicistica dell’epoca, come può desumersi
FRA ANTICHITÀ E STORIA 25 dalla lettura di Zadig, novella scritta da Voltaire fra il 1745 e il 1747, la cui pubblicazione definitiva risale al 174812. Nella novella di Voltaire si narra una storia non dissimile da quella nota a Walpole, e lo stesso Walpole, come sicuramente anche il grande Voltaire, si rifaceva ad uno schema narrativo di origine orientale che in Italia è già presente in una novella del Sercambi (vissuto fra il 1348 e il 1424)13, ma che si diffuse in tutta Europa soprattutto per merito di tal Cristoforo Armeno. Costui, originario di Tabriz (nell’Azerbaigiàn) aveva intrapreso nella seconda metà del Cinquecento il suo viaggio verso l’Occidente, spinto, come leggiamo nella sua biografia curata da Eduardo Melfi14, “dal desiderio, che egli stesso collega all’educazione cristiana ricevuta in patria, di conoscere il mondo culturale e religioso della Franchia”; nel 1554 egli giungeva a Venezia, allora alleata della Persia dei Şafawidi, e dopo qualche anno dava alle stampe, per i tipi dell’editore Michele Tramezzino, il Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, dalla persiana nell’italiana lingua trapportato15. Il Peregrinaggio, secondo uno schema non insolito nelle letterature orientali, inserisce una serie di novelle all’interno di una novella che fa da cornice e che è quella dei tre figli di Giaffèr, re di
12 La prima edizione, col titolo Memnon, histoire orientale, è del 1747; dell’anno successivo, 1748, l’edizione definitiva col titolo Zadig ou la destinée. Histoire orientale, che dunque precede di almeno 6 anni la lettera di Walpole. 13 Si veda l’edizione delle Novelle a cura di GIOVANNI SINICROPI, I, Bari [Laterza] 1972, p. 11 sgg. 14 Per il Dizionario biografico degli Italiani, vol. 31 (1985), p. 71 sg., che qui pedissequamente seguiremo. 15 Se ne veda l’edizione curata da R. BRAGANTINI, Roma [Salerno ed.] 2000.
26 MARIANO MALAVOLTA Serendippo (cioè Sarandib, nome persiano di Ceylon): costui, volendo mettere alla prova la validità dell’educazione che ha fatto impartire ai figli, li spinge a intraprendere un viaggio nel corso del quale essi entrano al servizio del re Beramo, leggendario sovrano di Persia, dopo però aver affrontato vari casi che costituiscono l’oggetto di altrettante novelle, fino al pieno successo dei tre principi, dei quali il primo, tornato in patria, diventerà re di Serendippo, mentre il secondo diventerà re dell’India e il terzo, sposata la figlia di Beramo, succederà infine a quest’ultimo sul trono di Persia. Il motivo delle prove superate dai tre fratelli si ritrova di frequente nella letteratura araba, specie nella saga di Beramo, eroe dell’epica persiana trattata da Firdusi (e dunque risalente al X secolo) nel Libro dei Re e poi rielaborata da Nezami (vissuto nel XII secolo), che vi inglobò varie novelle di disparata origine, entrate poi a far parte stabilmente della letteratura araba popolare, e il nostro Peregrinaggio è, fino ad ora, “l’unica testimonianza di questa redazione arricchita come doveva essere presente, nella sua integrità, nella letteratura popolare persiana del secolo XVI. Cade così - scrive sempre E. Melfi - l’ipotesi formulata da Th. Benfey in base ai limitati dati disponibili nella seconda metà del secolo scorso, che il Peregrinaggio non abbia che pretestuosi legami con le letterature orientali, ma sia opera di un letterato veneziano, forse lo Straparola, che si sarebbe celato dietro la figura fittizia di Cristoforo”. Rinviando - per ogni critico approfondimento della questione - al citato dotto lavoro del Melfi, vediamo ora brevemente quale fosse la magia di questi racconti, che affascinò scrittori come Voltaire e Walpole, dopo aver influenzato già fra XIV e XV secolo (non
FRA ANTICHITÀ E STORIA 27 sappiamo per qual tramite) il nostro Sercambi. I tre prìncipi di cui si diceva, da poco giunti nel paese di Beramo, s’imbattono in un cammelliere disperato per aver perduto il proprio animale, sua unica fonte di guadagno. I tre non hanno visto il cammello, ma per burlarsi del buon uomo e dilettarsi del proprio intelletto dicono al poveretto che il suo animale l’hanno incontrato sul loro cammino, buon pezzo addietro, e per rendere credibili le loro indicazioni gli forniscono tre indizi convincenti: il cammello perduto è cieco da un occhio, gli manca un dente in bocca, ed è zoppo. Il cammelliere, rincuorato, ripercorre a ritroso la strada fatta dai tre principi, ma non riesce a ritrovare l’animale. Il giorno seguente, tornato sui suoi passi, incrocia di nuovo i tre giovani e si lamenta con loro di averlo ingannato. Per mostrargli di aver detto il vero i tre principi aggiungono altri tre indizi: il cammello aveva una soma, carica da un lato di miele e dall’altro di burro; portava una donna; questa donna era gravida. Di fronte a questi particolari il cammelliere dà per certo che i tre abbiano veramente visto l’animale, ma è convinto che proprio loro siano i ladri che glielo hanno sottratto, e dunque li accusa del furto. Imprigionati nelle segrete del castello di Beramo i tre invano si scusano, asserendo di non aver mai visto il cammello e di aver parlato solamente per burlarsi del cammelliere, e vengono condannati a morte come ladri. A scongiurare l’imminente esecuzione della sentenza di condanna interviene la provvidenziale testimonianza di un altro cammelliere il quale ha trovato il cammello e, avendolo riconosciuto, lo riconduce al legittimo proprietario. I tre giovani, dei quali è stata dimostrata l’innocenza, vengono così liberati, a patto di
28 MARIANO MALAVOLTA dare una spiegazione sul come abbiano fatto a descrivere nel dettaglio l’animale, senza averlo mai visto. In effetti, spiegano i giovani, ciascun particolare del cammello è stato immaginato ed è poi risultato vero grazie alla loro capacità di osservazione e alla loro sagacia: che fosse cieco da un occhio era dimostrato dal fatto che, pur essendo l’erba migliore da un lato della strada, essa era stata brucata dal lato opposto, a indicare che il cammello vedeva solo da un occhio, quello che dava sul lato della strada con l’erba mangiata. Che fosse privo di un dente lo mostrava l’erba mal tagliata che poteva osservarsi lungo la via. Che fosse zoppo lo svelavano senza ombra di dubbio le impronte lasciate dall’animale sulla sabbia. Ancora più stupefacenti i dettagli “divinati” nella descrizione del carico: il cammello portava da un lato miele e dall’altro burro, perché lungo la strada da una parte i giovani avevano notato l’accalcarsi di formiche (amanti del grasso), dall’altra di mosche (amanti del miele); il cammello doveva avere sul dorso una donna, perché in una sosta costei aveva approfittato per urinare, e quell’urina aveva attirato l’attenzione di uno dei principi che, chinatosi per osservarla, aveva visto vicino orme di piede umano molto piccolo, che poteva essere di donna o di ragazzo; per sciogliere la sua curiosità aveva messo un dito nell’urina (cosa non strana per i tempi, e che i medici facevano comunemente al letto del malato) e poi annusato il dito, era assalito da concupiscenza carnale, che può venire solo dalle urine di donna; infine, la donna doveva essere gravida, perché poco innanzi alle orme dei piedi c’erano quelle lasciate dalle mani, usate dalla donna per rialzarsi a fatica, dato il carico del corpo. Per farla breve, la sagacia dei tre principi stupisce Beramo, che decide di
FRA ANTICHITÀ E STORIA 29 farne i propri consiglieri, avviandoli al luminoso destino che degnamente compenserà la loro intelligenza, oltre che render giustizia alla nobiltà dei natali.
L’analogia fra l’histor omerico e le più recenti storie di serendipity, qui sopra illustrate, è insomma evidente, come si è detto, in quella capacità particolare di “vedere” ciò che sfugge ai più. In Omero questa capacità viene appena accennata, ed è stata enucleata da una sofisticata esegesi, mentre lo schema narrativo confluito nell’opera di Cristoforo Armeno contiene, a nostro avviso, una “volgarizzazione” dello stesso primordiale metodo, che egregiamente si prestava a vivacizzare spunti novellistici capaci di catturare l’attenzione di un più vasto pubblico, ed è evidente - come leggiamo in un sito web - che la serendipity non pretende di essere metodo scientifico, che possa sostituire il modo di procedere ortodosso (galileiano) dei ricercatori, ma è l’applicazione particolare di un processo logico detto “abduzione” che caratterizza l’esperienza degli scienziati: un’eccezione, che può sembrare a prima vista un’eresia, ma che va guardata, come ogni fenomeno, da una mente elastica e sgombra da ogni preconcetto, e che sappia ricondurre il dato discordante e inatteso ad una possibile novità invece che ad una deviazione fastidiosa perché non facente parte del percorso logico di una ipotesi di lavoro non correttamente impostata.
Vale la pena di aggiungere, a chiusura delle poche pagine
che abbiamo dedicato ad un tema così affascinante e complesso (la nascita del sapere critico) che quella originaria fiducia che il popolo dello scudo di Achille accordava alla
30 MARIANO MALAVOLTA maestosa persona dell’histor venne a poco a poco scemando, insieme con l’autorevolezza del personaggio e col dissolversi dei valori aristocratici dell’antica società. La sicurezza di giudizio del venerando veggente fu ben presto inficiata da calcoli di giurie corrotte da denaro o divenne sicurezza impunita ed arrogante del potere, naturalmente nemica e diffidente nei confronti di ogni occhio scrutatore, paragonabile a quello del sopra citato personaggio (Zadig) del grande Voltaire. Così già Platone esprimeva la convinzione che nei processi “retori e avvocati fanno credere ciò che vogliono” ai membri delle giurie, ed aggiunge ironicamente (quasi a commento dell’ingenuità di quell’antica fiducia): “oppure pensi che esistano maestri così abili che mentre un po’ d’acqua scorre giù dalla clessidra, riescano ad insegnare il vero svolgimento dei fatti a chi non ha visto con i suoi occhi la persona che è stata derubata [ = mentre è stata derubata] di denaro o ha subito qualche altra violenza?”16. Allo stesso modo il nostro secolo non ha mancato di ridicolizzare il metodo abduttivo, stigmatizzando il paradigma indiziario utilizzato nel popolarissimo genere della letteratura poliziesca. La straordinaria capacità di osservazione attribuita al detective Sherlock Holmes da sir Arthur Conan Doyle trova la sua feroce parodia nell’episodio immaginato per l’adolescenza del detective, che all’età di 11 anni, durante una vacanza in campagna con i genitori, osservando attentamente con un binocolo il villino
16 Teeteto, 201 a-c.; considerazioni su questo metodo dell’historia anche nell’esperienza di AULO GELLIO, iudex ex quinque decuriis in Noct. Att. 14, 2 (p. 995 dell’ed. curata da C.M. CALCANTE, con la traduzione di L. RUSCA).
FRA ANTICHITÀ E STORIA 31 dei vicini, avrebbe scoperto che i bambini non vengono portati dalla cicogna, ma dalla levatrice in una valigetta17. Qualche volta l’atteggiamento di chi guarda con scettica superiorità a queste cose è ampiamente giustificato. Viene in mente la memorabile battuta del film Anni di piombo della von Trotta: la protagonista, redattrice di un settimanale di grande diffusione, vive traumaticamente la morte recente di sua sorella, una terrorista affiliata alla Rote Armee Fraktion arrestata dalla polizia e, secondo la versione ufficiale, impiccatasi in carcere. Dopo una appassionata quanto minuziosa indagine la giornalista giunge alla conclusione, documentata da un insieme di indizi, che sua sorella non si è suicidata, ma è stata strangolata in cella, e si rivolge al capo redattore del settimanale, chiedendogli di pubblicare quel corposo dossier diligentemente elaborato, proponendolo come uno scoop. Ma l’idea viene bocciata dal direttore della rivista, che bonariamente rimprovera la giovane per la fatica che ha sprecato a mettere insieme quel lavoro dedicato ad un fatto accaduto qualche anno prima, in un passato che egli considera, dal suo punto di vista, remoto. Queste cose, egli osserva, non hanno lo smalto dell’attualità, non vanno bene per un settimanale che vende centinaia di migliaia di copie, e inoltre lo scritto ha una estensione spropositata (più di 60 cartelle, se ben ricordo) e può andar bene tutt’al più per “la
17 “Dopo aver eliminato l’impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, dev’essere la verità” (come leggiamo in A. CONAN DOYLE, Gli aforismi di Sherlock Holmes, a cura di MASSIMO BALDINI, Roma [Newton-Compton] 1995, p 40. La parodia è nel delizioso film di BILLY WILDER, The private life of Sherlock Holmes (1970), dalla cui sceneggiatura fu ricavato l’omonimo romanzo satirico scritto da MICHAEL e MOLLY HARDWICK.
32 MARIANO MALAVOLTA pattumiera della storia”18.
Cosa è diventata la storia? Una pattumiera in cui chiunque può buttar via tutto ciò che vuole? La durezza di una così spietata sentenza mi sentirei quasi di condividerla, e certamente questa società in cui viviamo può misurare con esattezza l’avanzamento del suo stato di sfacelo dando una semplice occhiata al valore che viene comunemente assegnato alla ricerca della verità, oltre che alla scadente qualità (tale da meritare la pattumiera) del prodotto elaborato, per fini il più delle volte inconfessabili, nel nome di quella ricerca. D’altra parte la magica veggenza dell’histor, mitizzata già dall’umanità omerica, deve pur sempre essere annoverata fra quei preziosi “istinti di base” ai quali si spera che la ‘nostra’ umanità sappia ancora far ricorso utilmente nelle imminenti emergenze del suo non immaginabile futuro.
18 MARGARETHE VON TROTTA, Anni di piombo [Die bleierne Zeit], del 1980, Leone d’oro alla mostra di Venezia del 1981.
Re del bosco, re della città. Alle origini dei sacra nominis Latini1.
A Maria Cristina Vincenti, colpevole di avermi rivolto
l’invito, sono personalmente grato dell’occasione che mi è stata offerta di conversare con un uditorio così selezionato ed attento: occasione rara, ormai, per chi è assuefatto alla sempre più distratta condiscendenza della maggior parte degli studenti delle nostre università. L’impegno che l’Archeoclub di Ariccia (per il tramite del suo Presidente Alberto Silvestri) ha profuso nell’organizzare questo ciclo di conferenze in onore di Renato Lefevre dimostra in ogni caso, e questo deve rincuorarci, che anche al di fuori degli ambiti istituzionali è ancor viva e diffusa la voglia di assicurare la sopravvivenza dei più autentici valori dell’identità culturale delle nostre piccole o grandi patrie, in netta controtendenza rispetto alla deriva analfabetizzante di un corpo sociale che di parole come identità si serve per lo più a sproposito, ma quasi sempre con le più inconfessabili
1 Letta il 17 maggio 2006 nella Sala Bariatinski del Palazzo Chigi di Ariccia nell’ambito di un ciclo di conferenze in onore di Renato Lefevre), pubblicata in “Annali. Archeoclub d’Italia. Aricino-Nemorense” 1, 2006, pp. 39-51; nella stesura di queste pagine ho utilizzato in gran parte materiale già pubblicato in un mio lavoro intitolato I ludi delle feriae Latinae a Roma, in “Alba Longa. Mito, storia, archeologia”. Atti dell’Incontro di studio (Roma – Albano Laziale, 27-29 gennaio 1994), a cura di ANNA PASQUALINI, Roma 1996, pp. 255-273.
34 MARIANO MALAVOLTA intenzioni strumentali.
Ho ascoltato con grande attenzione, insieme con molti di Voi, la relazione svolta in questa sala da Anna Pasqualini, che ha magistralmente illustrato, nell’ambito di una sostanziale dicotomia fra la “latinità” di Ariccia e la “grecità” di Nemi, l’importanza dell’influsso culturale di tradizioni greco-orientali attive nell’antichissimo Lazio e sicuramente determinanti nella definizione – quale ci è documentata in età storica – della suggestiva liturgia del rito di uccisione del rex Nemorensis. Ho apprezzato in particolare il richiamo – che condivido pienamente – al contesto teatrale nel quale deve essere collocato quel rito, che corregge una ormai vulgata communis opinio della letteratura più recente, incline a stemperare l’uccisione rituale del rex Nemorensis mescolandola con le “banali” (si fa per dire) uccisioni elargite a piene mani a sempre più nutrite masse di spettatori nei munera2. Allo stesso modo, non posso non condividere le parole finali della relazione di Anna Pasqualini, secondo cui quegli influssi greco-orientali “assumono un rilievo di splendido isolamento rispetto alla cultura politica e religiosa del nomen Latinum”, a patto che questa notazione vada riferita, come io credo, alle caratteristiche “importate” nella liturgia del rito, che nel suo nucleo più antico,
2 Così ad esempio, nel recente contributo di B. SCARDIGLI, Rex Nemorensis – servus fugitivus, in “L’Italia centromeridionale tra repubblica e primo impero. Alcuni aspetti culturali e istituzionali. Giornate di studio” (Roma, 13 dicembre 2002), a cura di M.L. LAZZARINI e P. LOMBARDI, Roma 2003 [= Opuscula epigraphica, 11], pp. 93-100, dove peraltro a p. 96 viene impropriamente usata, per indicare i munera, l’espressione “ludi gladiatorii”.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 35 concretamente sopravvissuto all’evoluzione della sua veste esteriore, ha invece un evidente parallelo nell’uccisione rituale della vittima umana che in qualche modo solennizzava, annualmente, la celebrazione urbana delle feriae Latinae.
È dunque evidente, già dal titolo del mio intervento, che ora vi chiederò di lasciare il sacro bosco di Diana e di seguirmi nel tentativo di esplorare una selva non meno intricata, sia perché dopo la relazione di Anna Pasqualini ben poco resterebbe da dire sul pur fitto bosco del lago, sia per la serie impressionante di analogie che possono riscontrarsi fra i singoli elementi caratteristici dei due riti: presenza di più o meno ambigui simulacri di regalità; coincidenza del momento agonale (duello o corsa); morte cruenta e sua valenza sacrificale; contesto teatrale spettacolare della celebrazione; presenza parallela di un simbolo vegetale (il vischio del ramo d’oro aricino e l’assenzio romano, come vedremo); radicamento dei due riti nei rispettivi territori d’origine, che entrambi si propongono, sia pur alternativamente, quali centri federali dell’originario embrione statale (mai giunto a vita autonoma) del popolo latino.
L’accostamento fra i due riti di uccisione, apparso già per tempo nella letteratura antiquaria ottocentesca e divenuto tema quasi centrale dell’opera di James George Frazer3, è stato recentemente richiamato da Andrea Carandini come “mitema incardinato nella conquista della regalità
3 J. G. FRAZER, Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione, Torino 1965 (traduzione italiana dell’edizione ridotta del 1922) p. 194, 685 e v. infra.
36 MARIANO MALAVOLTA aborigeno-latina”4: ed è questa la chiave di lettura che ho cercato di utilizzare nel riesame, che qui di seguito vi propongo, delle testimonianze superstiti sulla celebrazione urbana delle feriae Latinae, condotto con l’intento di verificare se anche nella liturgia del sacrificio attestato a Roma sia da ravvisare la reliquia di uno dei tratti distintivi delle fisionomia originaria del più antico stato latino, conservata da una “memoria culturale” di cui sempre più si va recuperando il prezioso valore5.
La documentazione di cui stiamo parlando si presenta,
almeno a prima vista, piuttosto frammentaria e ipotecata da severi giudizi sulla sua autenticità, ma sicuramente contiene tutti gli ingredienti necessari perché si possa parlare di una vera e propria celebrazione urbana delle feriae Latinae, che autonomamente si svolgeva in città nei giorni in cui le più alte cariche dello stato, insieme con la piccola folla dei 4 A. CARANDINI, La nascita di Roma. Dèi, Lari, eroi e uomini all’alba di una civiltà. Torino 2003, p. 183: “Fauno appare come il prototipo del rex Nemorensis. Fauno viene infatti ucciso (da Ercole, che potrebbe aver sostituito una figura mitica indigena: Latino?). Viene poi ucciso Amulio (per riportare sul trono Numitore) e infine viene ucciso anche Remo (da Romolo). L’uccisione del parente, del fratello e del gemello è dunque un mitema incardinato nella conquista della regalità aborigeno-latina. La successione del rex Nemorensis, astratta da qualsiasi ambito parentelare, non è che l’ultimo ricordo di ben più antichi rituali di clan gerarchici (più che tribali) ridotti a fossile. La predominanza del tema dei fratelli e lo stesso meccanismo della successione nemorense basato sul duello fanno sospettare che ad Alba vigesse originariamente un tipo di successione non verticale, cui potevano accedere i membri di uno o più lignaggi egemoni, ritenuti più prossimi all’antenato comune divinizzato”. 5 Per questa metodologia cfr. da ultimo lo stesso CARANDINI, Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani (775/750 – 700/675 a.C.), Torino 2006, p. 15 sgg.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 37 sacerdoti e, a quel che pare, una parte del popolo, partecipavano o assistevano ai sacri riti “federali” celebrati sul monte Albano. Vere e proprie feriae, dunque, che gli antichi intendevano come tempora dis sacrata, solennizzate da sacrifcia, epulae, ludi6. Con la comprensibile eccezione delle epulae, che non sono esplicitamente attestate per il momento cittadino della festa, questi elementi costitutivi sono presenti e documentati7: nei giorni delle feriae si osservava in città l’astensione dal lavoro; il momento ludico della festa era rappresentato da una corsa di quadrighe sul Campidoglio, e al vincitore di questa gara veniva dato a bere dell’assenzio; alla divinità festeggiata (Giove Laziare) veniva offerto il sangue di un condannato a morte, espressamente ucciso per quella occasione. Va inoltre notato, per completare questo quadro, che i due giorni successivi a quelli delle feriae Latinae erano considerati dies religiosi8, e che ai sacra e ai ludi di questa festa, caso unico per una ricorrenza che non era stata mai annoverata fra i ciuilia uocabula dierum nel calendario ufficiale dello stato romano, si applicava l’obbligo della instauratio, ossia della ripetizione della cerimonia inficiata da irregolarità9, prescritta soltanto
6 Così MACROB., Sat. 1, 16, 3: festis insunt feriae, sacrificia, epulae, ludi. Sulla testimonianza di Macrobio è da vedere il commento di G. WISSOWA, s.v. Feriae, in “P.W.” VI 2 (1909) col. 2211, che spiega come feriae debba essere considerato sinonimo di dies festi. 7 Come risulta dalla lettura della efficace sintesi (venti righe in tutto) data da E. SAMTER nella voce Feriae Latinae, in “P.W.” VI 2 (1909) col. 2215. 8 Sull’astensione dal lavoro cfr. CIC., De re publ. 1, 9, 14. Sui dies religiosi è preziosa la testimonianza dello stesso CIC., Ad Q. fr. 2, 4, 2. 9 L. POLVERINI, s.v. Ludi, in “Diz. Epigr.” IV (1975) p. 2016; G. PICCALUGA, Elementi spettacolari nei rituali festivi romani, Roma 1977, p.
38 MARIANO MALAVOLTA per i ludi Romani e per i ludi plebeii (ossia per le più antiche e le più importanti fra le pubbliche solennità). Questa circostanza, combinata con la constatazione fatta già da Gaetano De Sanctis ed in seguito costantemente ribadita: che cioè i ludi Romani così si denominavano per caratterizzarsi rispetto alle preesistenti feriae Latinae10, permette di riconoscere in queste ultime una specie di arcaico prototipo di tutte quelle importanti festività che in età storica vediamo incluse nel calendario e solennizzate con lo svolgimento di ludi. Di più: le feriae Latinae, come si è già detto, non furono mai incluse nel calendario – non divennero cioè mai statiuae – ma conservarono sempre, pur continuando ad essere regolarmente concepite di anno in anno per più di un millennio, questo che va considerato un ulteriore loro carattere di arcaicità.
Altro aspetto da indagare, per ricavarne un apporto almeno in termini di cronologia relativa, è costituito dalla dualità nella celebrazione della festa, che regolarmente si svolgeva in due ambiti spaziali ben distinti. A questo riguardo già il Marquardt notava che a un simile iato (giochi a Roma e sacra sul monte Albano) corrisponde il vario atteggiarsi della denominazione della festa, ad esempio nei luoghi di Livio in cui vengono distinti ludi Latinaeque11, o
52 con nota 92. Elenco delle instaurationes delle feriae Latinae in G. DE SANCTIS, Storia dei Romani IV 2, 1, Firenze 1953, p. 335 sg con nt. 950. 10 G. DE SANCTIS, o.c., p. 326 con nota 889; A. PIGANIOL, Recherches sur les jeux romains, Strasbourg 1923, p. 90; H.S. VERSNEL, Triumphus. An inquiry into the origin, development and meaning of the Roman triumph, Leiden 1970, p. 115. 11 J. MARQUARDT, Röm. Staatsverwaltung, III 2, Leipzig 1885, p, 297 con nota 3; cfr. Ch. WERNER, De feriis Latinis, Diss. Lipsiae 1888, p. 6.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 39 nell’alternanza Latiar / feriae Latinae, in cui è evidente una stratificazione nella quale la denominazione feriae Latinae sembra rifarsi al momento istitutivo della celebrazione così come noi la conosciamo per l’età storica, nella forma nelle modalità con cui essa si svolse a partire dal decisivo intervento dei re etruschi, mentre Latiar si presenta come traccia superstite di un rito sacrificale assai più antico, specie se si tiene nel debito conto l’analogia, notata già dal Preller, con il nome dell’antico sacrificio detto Palatuar, che apre la serie delle festività localizzate sulle cime del Septimontium descritto da Antistio Labeone12. Così come il Palatuar designava il sacrificio dovuto sul monte Palatino, è assai probabile che il Latiar sia stato un rito sacrificale insistente su quella cima del Quirinale detta collis Latiaris13, che di fatto non era inserita nel Septimontium di Antistio Labeone, e che anzi per la sua vicinanza al Capitolium uetus del Quirinale evoca una scansione dello spazio urbano che ben si collocherebbe entro l’idea, che fu già del Niebuhr, delle due città (di Romolo e di Tito Tazio) in contesa per la rocca capitolina14. 12 FEST., p. 47 L.: Septimontio, ut ait Antistius Labeo, hisce montibus feriae: Palatio, cui sacrificium quod fit Palatuar dicitur etc; cfr. il commento di A. FRASCHETTI, Roma e il principe, Roma-Bari 1990, p. 142 con nota 14. Sull’assonanza Palatuar-Latiar è da vedere L. PRELLER, Röm. Mythologie, I (a cura di H. JORDAN), Berlin 1881, p, 212 nota 1; cfr. E. AUST, s.v. Iuppiter, in W.H. ROSCHER, Ausfürliches Lexikon der griech. und röm. Mythologie, II, 1, Leipzig 1890-1894, col. 688. 13 Sulla quale si veda H. JORDAN, Topographie der Stadt Rom im Altertum, I, 3 (bearb. Von CH. HÜLSEN), Berlin 1907, p. 399 sg.; ibid., p 411 sul Capitolium uetus. 14 Sulla fortuna dell’ipotesi delle due città, elaborata nella Römische Geschichte da B.G. NIEBUHR e ripresa dallo SCHWEGLER e dal MOMMSEN, si veda J. POUCET, Les Sabines aux origines de Rome.
40 MARIANO MALAVOLTA
Verso questa stessa direzione sembra sospingerci quella che si presenta come l’unica sicura informazione sul momento spettacolare della festa urbana (se si eccettuano i cenni fugaci a non meglio identificati ludi che troviamo in Livio, Tertulliano e Novaziano)15 e che è fornita da Plinio, con riguardo ad una gara di quadrighe disputata in Capitolio16, indizio evidente, anche questo, della arcaicità dell’istituzione, riferibile ad un’epoca in cui probabilmente non poteva essere utilizzato per queste occasioni agonistiche lo spazio della uallis Murcia, futura sede del Circo Massimo.
La notizia di Plinio, così laconicamente riferita senza ulteriori precisazioni topografiche, presenta non lievi difficoltà di interpretazione, ma è chiaramente riferita allo spiazzo antistante il tempio di Giove, mentre sembra difficile Orientations et problèmes, in “A. N. R. W.” I, 1, 1972, pp. 48-51. Sul Capitolium uetus, oltre al JORDAN citato nella nota precedente, si veda CH. HÜLSEN, s.v. Capitolium uetus, in “P.W.” III 2 (1899) col. 1540; “Th. l. Lat. Onomasticon” II, Lipsiae 1907-1913, col. 1909; F. COARELLI, s.v. Capitolium vetus, in “Lexicon topographicum urbis Romae” I (A-C), Roma 1993, p. 234. Va ricordata, in questo contesto, la testimonianza relativa al rito (conservato da TZETZE, citato infra, alla nota 17) della corsa del trionfatore giunto in Campidoglio al termine della pompa triumphalis. 15 Liv. 5, 19, 1: ludi Latinaeque; TERT., Apolog. 9, 5: ludis suis; NOVATIAN., De spectaculis, 5, 1: sacrificiorum in ludis genera monstruosa. Vale la pena di ricordare che si deve tener conto della accertata proprietà di linguaggio dei testi citati, che induce ad escludere nel modo più assoluto che i rispettivi autori si riferiscano a munera gladiatoria. Può trattarsi, nei casi sopra citati, soltanto di ludi circenses o scaenici. 16 PLIN., Nat hist. 27, 28, 45: …Latinarum feriis quadrigae certant in Capitolio (l’intero paragrafo pliniano è riportato infra, alla nota 19); sulle gare in questione si veda G. WISSOWA, Rel. Und Kultus der Römer, München 1912, p. 451 con nota 4 e p. 40 con nota 6; si vedano anche i dubbi espressi da K. LATTE, Röm. Religionsgeschichte, München 1960, p. 146 con nota 3.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 41 ipotizzare una gara su un percorso più lungo, in salita, che ripercorresse lo stesso itinerario seguito in età più antica dalla pompa circensis o dalla pompa triumphalis che transitavano entrambe, scendendo dal cliuus Capitolinus o imboccandolo17, proprio nel punto in cui più tardi sorse l’arco di Settimio Severo e dove probabilmente la sacra uia si biforcava, dirigendosi a destra verso l’arx (questo doveva essere il percorso più antico), a sinistra verso il Capitolium vero e proprio (un percorso più recente, successivo alla fondazione della triade capitolina)18. Va infine notata, in questo contesto storico e topografico della gara delle quadrighe citata da Plinio, un oggettivo riscontro costituito dalla presenza della quadriga bronzea (con il simulacro di Romolo coronato dalla Vittoria) nel Vòlcanal, ossia nel santuario all’aria aperta, di
17 La composizione della pompa circensis è nota dal resoconto di FABIO PITTORE conservato da DION. HAL. 7, 1-2 (specie per ciò che riguarda la partecipazione di cavalli, bighe e quadrighe). Per la presenza di carri (plostra) che trasportavano le Vestali, il rex sacrorum e i flamines va ricordata in primo luogo la c.d. tabula Heracleensis (C.I.L. I2 593 e add. a p. 916 = I.L.S. 6085 = F.I.R.A. I p. 140 sg., nr. 13, ll. 62-65; cfr. M. MALAVOLTA, s.v. Ludi, in “Diz. Epigr.” IV, 1977, p. 2025). Sull’analogia fra la pompa circensis e la pompa triumphalis VERSNEL, Triumphus citato alla nota 10, col. 94-98. Al riguardo del percorso seguito dalla pompa triumphalis lungo la sacra uia, l’unico percorso che immetteva nel cliuus Capitolinus cfr. CIC. In Verr. 2, 5, 77: cum de foro in Capitolio currus flectere incipiunt, illlos duci in carcere iubent, idemque dies et uictoribus imperii et uictis uitae finem facit. Una descrizione parallela è in ZONARA 7, 21 e TZETZE (per i quali si veda la p. 72 sg. dell’ed. BOISSEVAIN, I, Berolini 1895, che ricorda un rito di corsa per il trionfatore). 18 Sulla topografia in generale si veda F. COARELLI, Il Foro romano. I. Periodo arcaico, Roma 1983, pp. 53 sg.; T.P. WISEMAN, s.v. Clivus Capitolinus, in “Lexicon topographicum urbis Romae” I (A-C), Roma 1993, p. 280 sg. Sul significato della locuzione in Capitolio negli scrittori antichi si veda C. REUSSER, s.v. Area Capitolina, ibid., pp. 114-117.
42 MARIANO MALAVOLTA poco sollevato rispetto all’area del Comitium (e dunque lungo il percorso della ipotetica gara), che per di più era – secondo una tradizione riferita da Plutarco – il luogo in cui si riunivano i senatori e dove lo stesso Romolo era stato da costoro ucciso e smembrato19.
È fuor di dubbio, in ogni caso, che il certamen quadrigarum avvenisse nel contesto della sacra celebrazione delle feriae, come del resto accadeva per tutti i ludi che solennizzavano pubbliche festività e come conferma lo stesso Plinio, che di questa gara parla casualmente descrivendo le varie specie e le proprietà dell’assenzio: un’erba medicamentosa che, stando a quanto egli ci dice, godeva di particolare considerazione nel sacro cerimoniale (sacris populi Romani celebrata peculiariter sono le sue parole), visto che era tradizione che il vincitore della corsa delle quadrighe per le feriae Latinae bevesse dell’assenzio, che gli veniva offerto come premio, secondo la spiegazione ipoteticamente allegata da Plinio, giusto per le proprietà medicamentose che già in tempi antichissimi erano
19 Sulla quadriga bronzea con il simulacro di Romolo coronato dalla Vittoria (ricordato da DION. HAL. 2, 54, 3; PLUT., Vita Rom. 24, 5) e la sua collocazione nel Volcanal, ossia nell’area sacra sottostante il niger lapis, si veda F. COARELLI, o.c. nella nota precedente, pp. 167, 174-176, 191 sg.; F. ZEVI, Il Foro e il Campidoglio: l’area pubblica e la rocca sacra, in “La grande Roma dei Tarquini. Catalogo della mostra”, a cura di M. CRISTOFANI, Roma 1990, p. 50; per la tradizione dell’uccisione e dello sbranamento di Romolo nel sito del Volcanal ad opera dei senatori cfr. PLUTARCO. Le vite di Teseo e di Romolo. A cura di C. AMPOLO e M. MANFREDINI, Milano 1988, p. 336 con note 30 e sgg.; A. BRELICH, Quirinus, una divinità romana alla luce della comparazione storica, in “Studi e materiali di storia delle religioni” 31, 1960, pp. 63-119; ID., Tre variazioni sul tema delle origini, Roma 1975, pp. 133-135; B. LIOU-GILLE, Cultes “héroïques” romains. Les fondateurs, Paris 1980, p. 176 sg.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 43 riconosciute a questa essenza20.
Assai più articolato e variopinto si presenta il panorama delle fonti sull’uccisione rituale del condannato a morte o del bestiarius21, che vale la pena di rileggere correggendo il perentorio giudizio di alcuni pur autorevolissimi studiosi moderni, per lo più concordi nel negare validità a queste notizie ritenute inventate e tralaticiamente ripetute fino al
20 PLIN., Nat. hist. 27, 28, 45: De usu eius [ossia dell’assenzio] conuenit, herbae facillimae atque inter paucas utilissimae, praeterea sacris populi Romani celebratae peculiariter, siquidem Latinarum feriis quadrigae certant in Capitolio uictorque absinthium bibit, credo, sanitatem praemio dari honorifice arbitratis maioribus. I commenti a Plinio notano che questo è l’unico luogo in cui si parla della tradizione di far bere dell’assenzio ai vincitori, e che probabilmente la bevanda offerta a costoro non era vero e proprio assenzio, ma ul liquore aromatizzato all’assenzio, o absinthites, ritenuto tonificante, preparato secondo ricette analoghe a quelle fornite dallo stesso PLINIO (14, 19, 109) e da COLUMELLA (De agri cult. 12, 35); all’assenzio veniva altresì attribuita la magica proprietà di allontanare il pericolo delle escoriazioni: intertrigini remedium: in uiam cum ibis, absinthi Pontici sarculum sub anulo habeto afferma CATONE nel De agri cult. 159 (p. 108 dell’edizione curata da F. GOUJARD, Paris 1975, con commento a p. 318 sg.). Sul valore “indiziario” dell’assenzio nella definizione della fisionomia originaria del Latiar v. infra. 21 Che la vittima sacrificata a Iuppiter Latiaris fosse scelta fra i bestiarii risulta soltanto dalla esplicita testimonianza di TERT., Apologet. 9, 5 (sulla quale v. infra la nota 32). Va notato che con il vocabolo bestiarius venivano indicati sia il uenator professionista (detto anche grecamente qhriomavco", la cui performance era assai meno apprezzata rispetto a quella del gladiatore), sia il condannato a morte che veniva offerto alla furia delle belve. Rispetto a quanto avevo avuto occasione di affermare qualche anno fa [alla nota 21 di p. 262 della prima edizione di questo lavoro, citata nella nota 1] ritengo invece, oggi, più che giustificata la cautela di G. VILLE, La gladiature en occident des origines à la mort de Domitien, Roma 1981, p. 465, dove si annota che non è ben chiaro se nel passo di Tertulliano sopra citato si alluda a un uenator o a un condannato a morte.
44 MARIANO MALAVOLTA logorio, come luogo comune della pubblicistica apologetica di parte cristiana.
La testimonianza di Minucio Felice, che probabilmente è fra le più antiche, va esaminata con un minimo di attenzione al contesto della polemica che già da tempo opponeva alla crescente insofferenza della cultura pagana i primi tentativi di reazione da parte dei seguaci della nuova religione. Costoro, come è noto, avevano goduto di un regime di larga tolleranza durante il regno di Antonino Pio, che per questo aspetto aveva continuato l’indirizzo inaugurato da Adriano, prestando anzi attenzione ad impedire quegli episodi di giustizia sommaria di cui talvolta i Cristiani erano stati vittime per aver provocato il furore popolare. Tuttavia episodi di intolleranza non erano certo mancati, come nel caso (assai discusso) di S. Policarpo, martirizzato nella provincia d’Asia, a Smirne, nel 155, in una occasione in cui il proconsole (o chi per lui) si era lasciato prendere la mano dalla folla inferocita22. Agli ultimi anni del regno di Antonino, e quindi a poco prima del 161, può essere datata la cosiddetta seconda Apologia del greco palestinese Giustino, indirizzata al senato (dopo che una prima Apologia era stata presentata all’imperatore e ai suoi figli Marco
22 A. GARZETTI, L’impero da Tiberio agli Antonini, Bologna 1960, p. 488 sg. Sul discusso martirio di Policarpo si veda H. GRÉGOIRE, Les persécutions dans l’empire romain, Bruxelles 19642 pp. 108-114 e 177 sg. Dell’atmosfera di larga tolleranza di cui potevano godere Giudei e Cristiani è prova non ultima il riconoscimento della validità in giudizio del giuramento prestato da ciascuno propria superstitione, attestata da Dig. 12, 2, 5, 1.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 45 Aurelio e Lucio Vero)23. In questo scritto compare per la prima volta la constatazione, enunciata con socratico candore da un uomo nutrito di dottrina stoica, del fatto che i Cristiani erano spesso costretti con la forza e anche con la tortura o con la minaccia della tortura ad ammettere colpe inesistenti e inventate, e che per di più si configuravano come azioni non dissimili dalle pratiche di culto che i pagani officiavano pubblicamente, aspergendo di sangue umano un idolo, in un rito celebrato dalle più eminenti personalità che provvedevano personalmente alla provscusi" del sangue delle vittime uccise24. Il nome di Iuppiter Latiaris non è esplicitamente pronunciato da Giustino, che anzi parla di musthvria Crovnou, ma l’allusione a quella divinità è evidente, così come è comprensibile che il greco Giustino abbia denominato Crono un Giove ritenuto per antonomasia il più antico25.
Il martirio di Giustino, che ebbe luogo in Roma non più tardi del 167, dopo il processo messo in atto dalla denuncia del filosofo stoico Crescente e la sentenza pronunciata dal praefectus urbi Quinto Giunio Rustico, motivata con la
23 Sulle due Apologie di Giustino cfr. H. LIETZMANN, s.v. Iustinus, in “P.W.” X 2 (1919) col. 1332 sg; H. GRÉGOIRE, o.c. alla nota precedente, p. 158. 24 IUSTIN., Apol. 2, 12, 4-5 p. 70 dell’edizione curata da D.G. KRÜGER, Die Apologieen Justins des Märtyrers, Freiburg-Leipzig 1896.; cfr. le pp. 204-205 della recente edizione (con traduzione) curata da G. GIRGENTI, Milano 1995. 25 SERV. ad Aen. 12, 132: Iuppiter Latiaris antiquissimus est; anche del santuario di Giove Laziare sul Quirinale MARZIALE (5, 22, 4) dice: qua uidet antiquum rustica Flora Iouem; cfr. G. PUCCI, Saturno: il lato oscuro, in “Lares” 58, 1992, pp. 5-17, specialmente p. 7, sull’assimilazione a Crono di Iuppiter Latiaris.
46 MARIANO MALAVOLTA disubbidienza all’imperatore per il rifiuto di sacrificare agli dei26, mostra che quella ritorsione delle accuse pagane, osata da Giustino, aveva colpito nel segno suscitando aspre reazioni. Fra l’altro, una vera e propria risposta alla seconda Apologia di Giustino, sollecitata forse da Marco Aurelio e più o meno anticipatrice o giustificativa di quel martirio, deve considerarsi il discorso del retore Marco Cornelio Frontone27, che non si peritava di imputare ai Cristiani, colorandole con il lenocinio della sua parola, le nefandezze che il popolino attribuiva ai seguaci della nuova religione. Anche questo era un segno evidente del mutato atteggiamento del principe: la preoccupazione politica per l’esempio di disubbidienza e per un’ostinazione che in questo come in altri episodi poté essere considerata provocatoria, e insieme il filosofico disprezzo per l’agire irrazionale di chi si offriva alla morte con un ardore innaturale si trovarono a coincidere in “uno di quei casi di coscienza nei quali il dovere di essere inesorabile si imponeva sulla soddisfazione di esser mite”28.
È proprio a questo punto che si colloca la testimonianza di Minucio Felice, che espressamente si riferisce a Frontone e alle sue calunnie, alle quali viene opposta una ferma, anche se pacata, riproposizione dell’argomentare del martire 26 Sul martirio di Giustino, databile fra il 163 e il 167, oltre al GARZETTI, o.c., p. 547, si veda anche L. PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, V, Torino 1960, p. 550. 27 Così A. ROSTAGNI, Storia della letteratura latina, III 2 (terza edizione riveduta ed ampliata, a cura di I. LANA), Torino 1964, p. 302 sg.; P. FRASSINETTI, L’orazione di Frontone contro i cristiani, in “Giornale di filologia” 2, 1949, pp. 238-254; B. BALDWIN, Fronto and the Christians, in “Illinois classical studies” 15, 1990, pp. 177-181. 28 A. GARZETTI, o.c., p. 547.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 47 Giustino: le colpe che i Cristiani devono ammettere di aver commesso sono né più né meno che le pratiche lecite della religione pagana, che comportano realmente l’uccisione di vittime anche umane, prescritta dal rituale e pubblicamente celebrata. A suffragio di questa asserzione, che era stata già di Giustino, Minucio Felice, che vive a Roma, dove esercita la professione di avvocato, cita l’uccisione mediante interramento della coppia di Galli e di Greci (un rito della cui storicità non si dubita) e, di seguito, l’homicidium che ancora ai suoi giorni (hodie dice Minucio, quasi in contrapposizione a quelle uccisioni citate precedentemente e documentate solo sui libri di storia) i Romani praticavano nell’ambito del culto prestato a Iuppiter Latiaris, che stavolta viene esplicitamente ed inequivocabilmente nominato quale degno figlio di Saturno, ingrassato dal sangue di un criminale da punire (mali et noxii hominis sanguine), degno idolo di una cultura che attribuiva al sangue umano la proprietà di curare l’epilessia, nonché emulo del comportamento della feccia dell’anfiteatro, che aggrediva o saccheggiava le carcasse delle belve uccise e rimosse dall’arena29. Si tratta di fatti, anche stavolta, che non escono soltanto dalla penna di Minucio Felice, ma che sono attestati anche da fonti
29 MIN. FEL., Oct. 30, 3; ad un’epoca ancora più antica risale la testimonianza del retore TATIANO (allievo di Giustino, dal quale era stato convertito al cristianesimo), di tendenze vegetariane: La sua Oratio ad Graecos fu verosimilmente scritta durante il soggiorno a Roma, e quindi prima del 172, e contiene anch’essa un riferimento esplicito all’uccisione di vittime umane per Iuppiter Latiaris (cap. 29):eujrw;n de; para; men JRwmaivoi" to;n kat!aujtou;" Latiavrion Diva luvqroi" ajnqrwvpwn kai; toi'" ajpo; tw'n ajndroktasiw'n a]ima terpovmenon etc.(p. 52 sg. dell’ed. curata da M. WHITTAKER, Tatian. Oratio ad Graecos and fragments, Oxford 1982).
48 MARIANO MALAVOLTA insospettabili, come mostra il passo di Plinio dal quale apprendiamo che qualcuno fra gli spettatori si precipitava a bere il sangue caldo dal corpo ancora palpitante dei gladiatori caduti, ritenuto rimedio efficace contro l’epilessia30; ed è appena il caso di notare che anche il cenno di Minucio Felice, pur nella sua brevità, è estremamente chiaro e si riferisce inequivocabilmente ad una uccisione appositamente eseguita per irrorare il simulacro della divinità. La stessa precisione nella descrizione del rito abbiamo riscontrato, del resto, nel citato luogo di Giustino e in un passo del più tardo De spectaculis pseudociprianeo (opera per lo più attribuita a Novaziano), nel quale si dice che l’uccisione avvaeniva durante la celebrazione di ludi, nel corso dei quali un essere umano diveniva vittima latrocinio sacerdotis31.
30 PLIN., Nat. hist. 27, 2, 4: sanguinem quoque gladiatorum bibunt ut viventibus poculis, comitiales morbi, quod spectare facientis in eadem harena feras quoque horror est. At, Hercule, illi ex homine ipso sorbere efficacissimum putant calidum spirantemque et uiuam ipsam animam ex osculo volnerum, cum plagis omnino ne ferarum quidem admoveri ora mos sit humanus. Questo sangue, va notato, veniva considerato sangue di una vittima, cioè di una persona ritualmente uccisa (A. BRELICH, Presupposti del sacrificio umano, Roma 1967, p. 111). 31 NOVATIAN., De spectaculis 5, 1: Plura prosequi quid est necesse vel sacrificiorum in ludis genera monstruosa describere? Inter quae nonnumquam et homo fit hostia latrocinio sacerdotis, dum cruor etiam de iugulo calidus exceptus spumanti patera, dum adhuc feruet, et quasi sitienti idolo in faciem iactatus crudeliter propinatur, et inter uoluptates spectantium quorundam mors erogatur, ut per cruentum spectaculum saevire discatur, quasi parum sit homini priuata sua rabies, nisi illum et publice discat (p. 172 dell’edizione curata da G.F. DIERCKS, Nouatiani opera quae supersunt, Turnholti 1972 [Corpus Christianorum. Series Latina IV]). Sull’attribuzione a Novaziano del De spectaculis pseudociprianeo si veda H. KOCH, s.v. Novatianus, in “P.W.” XVII 1 (1936) coll. 1148-1150.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 49
Altre informazioni si ricavano da un luogo dell’Apologeticum di Tertulliano, pubblicato nel 197: anche qui si dice che l’uccisione avveniva in città (in illa religiosissima urbe Aeneadarum) per offrire sangue umano ad una personificazione di Giove, in occasione di ludi che si svolgevano in suo onore, e che la vittima era un bestiarius: una precisazione, quest’ultima, che l’autore fa pronunciare agli immaginari interlocutori, con i quali polemizza, còlti nel tentativo di invocare un’attenuante, che al contrario va considerata un’aggravante32. Altrove, nello Scorpìace, lo stesso Tertulliano precisa il nome della divinità (Latio Iovi) e accenna, anche se molto vagamente, al luogo nel quale si faceva il sacrificio (media in urbe humanus sanguis ingustatur)33 riproponendo un argomento destinato a divenire un tovpo" frequentatissimo dalla pubblicistica cristiana e che come tale ricorre ancora, ad esempio, nel
Ricordiamo inoltre in questa nota, fra le testimonianze antiche sui sacrifici umani, anche quella fornita da TEOFILO, vescovo di Antiochia nel 169, nell’operetta intitolata Ad Autolycum (3, 6), pubblicata dopo la morte di Marco Aurelio, e dunque dopo il 180. 32 TERT., Apologet. 9, 5: Ecce in illa religiosissima urbe Aeneadarum piorum est Iuppiter quidam, quem ludis suis homano sanguine proluunt. Sed bestiarii, inquitis. Hoc, opinor, minus quam hominis? Certe tamen de homicidio funditur. Su questo passo si veda T.D. BARNES, Tertullian. A historical and litterary study, Oxford 1971, p. 219. 33 TERT., Scorp. 7, 6: sed enim Scytharum Dianam aut Gallorum Mercurium aut Afrorum Saturnum hominum victima placari apud saeculum licuit, et Latio ad hodiernum Iovi media in urbe humanus sanguis ingustatur, nec quisquam retractat aut non rationem praesumit aliquam aut inaestimabilem dei sui voluntatem (pp. 106-109 dell’edizione curata da G. AZZALI BERNARDELLI, Firenze 1990). Si badi bene che in questo luogo il sacrificio a Giove Laziare non viene citato a disdoro della religione pagana, ma anzi come esempio per esortare i Cristiani al martirio, la cui necessità era negata dalla montante gnosi valentiniana.
50 MARIANO MALAVOLTA Contra gentes del vescovo di Alessandria Atanasio (composto nel 335 o 336)34, nel Liber de errore profanarum religionum, scritto intorno alla metà del IV secolo da Fìrmico Materno35, in uno dei carmi di Paolino da Nola, databile alla fine del IV secolo36, e ancora nel primo dei due libri Contra Symmachum di Prudenzio, di poco posteriore37.
Un posto a parte in questa rassegna merita la citazione del filosofo neoplatonico Porfirio di Tiro, noto soprattutto per essere stato curatore degli scritti del suo maestro Plotino. Uno dei primi lavori ispirati ai dettami delle dottrine neoplatoniche (nelle quali Porfirio, subito dopo essere giunto a Roma, nel 263, era stato erudito da Plotino) è il trattato De abstinentia ab esu animalium (Peri; ajpoch'" ejmyuvcwn), opera in quattro libri di esortazione alla dieta vegetariana, che contiene, fra l’altro, la stessa esecrazione del sanguinario rito per Giove Laziare e mostra come questo motivo polemico non fosse monopolio esclusivo della letteratura apologetica cristiana, che pure Porfirio conosceva e anzi aspramente controbatteva, anche con argomenti violentemente polemici (ad esempio nei 15 libri dell’invettiva Kata; Cristianw'n); è difficile, anche se
34ATHAN., Contra gentes,25: kai; oij pavlai de; JRwmai'oi to;n kalouvmenon Latia;rion Diva ajnqrwpoqusivai" ejqrhvskeuon (p. 68 sg. dell’edizione curata da R.W. THOMPSON, Oxford 1971). 35 FIRM. MAT., Liber de errore profanarum religionum, pubblicato nel 347 d.C. (26, 2): humanarum victimarum frequenter sanguine cruentasti et Latiaris templi cruore etc. (p. 119 dell’edizione di CAROLUS HALM, Vindobonae 1867). 36 PAUL. NOL., Poem. ult. adv. pagan., 108 sg.: hinc Latiare malum prisci statuere Quirites / ut mactatus homo nomen satiaret inane. 37 PRUDENT., Contra Symm. 1, 396: funditur humanus Latiari in munere sanguis.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 51 non impossibile, pensare che egli abbia intenzionalmente utilizzato, desumendolo da autori cristiani (e non da una ben nota realtà contemporanea, come da lui asserito) un argomento polemico che si sapeva inconsistente e calunnioso. L’uccisione della vittima umana per Giove Laziare, della quale si parla come di un fatto universalmente noto ed attuale, viene catalogata da Porfirio fra gli spargimenti di sangue che, oltre ad essere di per sé esecrabili, sono del tutto inutili, nemmeno giustificati da uno stato di necessità, come quella che si poteva invocare, ad esempio, per gli episodi di cannibalismo verificatisi nel corso di lunghi assedi, trattati nella rubrica successiva38.
Va infine notato, a chiusura di questa rassegna, che il silenzio delle altre fonti su questo antichissimo rito sacrificale non deve essere riguardato, da chi voglia attribuire un qualche valore alle testimonianze sopra esaminate, come un’ipoteca sulla loro storicità, e anzi può essere spiegato in vario modo, specie se si accetta l’idea della continuità del rito fin dall’età più remota: ciò ne avrebbe reso ovviamente inutile la registrazione annalistica, che invece puntualmente troviamo per altre uccisioni rituali eccezionalmente celebrate. Non occorre dunque pensare che quel rito sacrificale sia stato una restitutio di un cerimoniale ripescato
38PORPH.,Deabstin.,2,56: ajll! e[ti ge nu'n ti;" ajgnoei' kata; th;n megavlhn povlin th/' tou' Latiarivou Dio;" ejorth/' sfazovmenon ajnqrwpon_ (p. 181 della edizione curata da A. NAUCK, Porphirii philosophi Platonici opuscula selecta, Lipsiae 1886, e si veda HÖFER, s.v. Latiaris, in ROSCHER, Ausfürliches Lexicon II, 2 [1894-1897] col. 1903 sg.; sulla violenta polemica anticristiana di Porfirio, che qualche tempo dopo avrebbe avuto esito nella distruzione dei suoi scritti, condannati al rogo come quelli di un nemico della fede, cfr. SOCR., Hist eccl. 1, 9 e vedi A. COLONNA, La letteratura greca, Torino 1967, p. 704 sg.
52 MARIANO MALAVOLTA da erudite tradizioni antiquarie, volta a recuperare il contenuto spettacolare della sua esecuzione ed escogitata in età imperiale, ad esempio da un Caligola, che si era mostrato particolarmente devoto a Iuppiter Latiaris39, o da un Claudio, di cui è ben documentata la morbosa propensione per antichi e truculenti istituti40.
Anche la testimonianza liviana del minime Romano sacro41, che viene quasi ritualmente invocata dagli scettici ad ogni costo, deve essere riletta con attenzione, specie per ciò che attiene a quel minime, e proprio per quel suo affrettarsi a dichiarare l’estraneità al costume romano di un uso aborrìto come primitivo ed incivile e quasi richiamando quella che viene presentata come una presa di posizione ufficiale, universalmente nota ed ovvia, del diritto pontificale. Un principio, dunque, enunciato forse proprio tenendo conto dell’esistenza di un’eccezione che tale doveva restare, circoscritta alla sopravvivenza di un antico rituale formalmente richiamato in vita di anno in anno dai supremi magistrati dello stato, di fatto (si badi bene) non mai stabilmente accolto nel calendario ufficiale.
39 SUET., Cal. 22: … et quidam eum Latiarem Iovem consalutarunt; cfr. CASS. DIO 59, 28 e vedi Ch. WERNER, De feriis Latinis, Diss. Lipsiae 1888, p. 25. 40 SUET., Claud. 34: Saevum et sanguinarium natura fuisse, magnis minimisque apparuit rebus… cum spectare antiqui moris supplicium Tiburi concupisset, et deligatis ad palum noxiis carnifex deesset, accitum ab urbe vesperum usque opperiri perseveravit. 41 LIV. 22, 57, 6 relativo all’indomani della rovinaosa battaglia di Canne: interim ex fatalibus libris sacrificia aliquot extraordinaria facta, inter quae Gallus ete Galla, Graecus et Graeca in foro Boario sub terram uiui demissi sunt in locum saxo consaeptum, iam ante hostiis humanis, minime Romano sacro, inbutum.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 53
A conferma di quanto detto sopra va considerata, per quel che può valere, la circostanza che proprio a questo carattere di vetustà del rito e della sua persistenza ad hodiernum si appellano gli apologisti cristiani (ai quali fa eco l’ejti ge nu'n del neoplatonico Porfirio), rilevando – dal loro particolarissimo punto di vista – la partigiana tolleranza su quel peculiare carattere di superstitio che qualificava il culto di Iuppiter Latiaris (specie in questa caratteristica sua celebrazione urbana) e che contribuiva a far sentire, in certo modo, ancor più pretestuosa e contraddittoria l’accusa di superstitio illicita che incombeva sulla nuova religione.
Era dunque per il tramite di questa falla che l’acuminato argomento socratico del martire Giustino giungeva direttamente al cuore della religio dei pagani, con l’immediatezza di una replica tanto polemica quanto efficace, che sicuramente sembrò in particolar modo irritante, oltre che imbarazzante e temibile, a un principe filosofo come Marco Aurelio, al punto da indurlo a recidere ogni residuo di indulgenza, per trincerarsi dietro ad una ragion di stato sorda a qualsiasi filosofica preghiera.
Non meno significativa si presenta, dopo questa pur
veloce rilettura delle testimonianze antiche, la vicenda del valore ad esse attribuito dalla moderna storiografia: i testi che abbiamo esaminato, e che abbiamo ragione di ritenere documentino la persistenza in età storica del rito di uccisione del bestiarius fino all’età imperiale avanzata, furono ritenuti fededegni dalla storiografia ottocentesca, raccolti diligentemente in una dotta dissertazione del Roeper42 e 42 Th. ROEPER, Lucubrationum pontificalium primitiae, Gedani 1848, p. 38 sg.
54 MARIANO MALAVOLTA riproposti nella loro integrità dal Preller43 e dal Marquardt44. Esse trovarono poi, come si è accennato, un convinto assertore della loro validità in James George Frazer, che della comparazione fra i due riti sacrificali (quello di Ariccia e quello di Roma) fece uno dei punti di forza della sua suggestiva visione: “possiamo dunque concludere - scriveva il Frazer nell’edizione ridotta apparsa nel 192245 - e con molta probabilità, che se il re del bosco ad Aricia viveva e moriva come l’incarnazione di una divinità silvana, egli abbia in tempi antichi un parallelo a Roma negli uomini che, ogni anno, venivano uccisi come rappresentanti del re Saturno, il dio del grano seminato e risorgente”. E ancora, in altro luogo della sua opera, egli annotava: “le leggende della morte violenta dei re romani suggeriscono che la gara con cui avevano guadagnato il trono poteva essere più spesso un duello a morte che non una corsa. Se così fosse, l’analogia che abbiamo trovato tra Roma e Nemi sarebbe anche più stretta. In ambo i luoghi i re sacri, rappresentanti viventi della divinità, sarebbero stati soggetti a soffrire la deposizione e la morte per mano di un uomo risoluto che potesse provare i suoi divini diritti al santo ufficio con il suo braccio forte e la sua spada affilata. Né vi sarebbe da meravigliarsi se tra i Latini primitivi si decidesse del diritto al trono con un duello, perché fino ai tempi storici gli Umbri sottoponevano regolarmente le loro dispute private alla prova di un combattimento, e chi tagliava la gola all’avversario si stimava che avesse dimostrato la giustezza 43 L. P. PRELLER, Römische Mythol. I, Berlin 1881, p. 215. 44 J. MARQUARDT, Röm. Staatsverw. III 2, Leipzig 1885, p. 297 con nota 4. 45 J. G. FRAZER, Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione, Torino 1965, p. 685.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 55 della sua causa al di sopra della portata di ogni cavillo”46. Questa asserzione del Frazer va vista, ovviamente, dentro il contesto della sua teoria generale, secondo cui “tutte le religioni tendono a deificare i re e, quindi, a far morire i propri dèi come vittime sacrificali”. Secondo questa concezione “tutto sta ad indicare che il mondo sarà rinnovato dall’atto rituale dell’uccisione del re”. Allo stesso modo, come ognuno può constatare, “la dottrina centrale del Cristianesimo è che il Dio incarnato fu mandato a morte come re” (come ci ha efficacemente ricordato anche la relazione di Anna Pasqualini) e che lo stesso Dio viene considerato dalla dottrina come vittima sacrificale”, mentre “sono attribuiti poteri di rinnovamento al rito del sacrificio. L’analogia con il Cristianesimo, a questo punto, è perfetta e si impone”. Ora, è vero che il Frazer “aveva troppo rispetto per l’aspetto poetico della religione per insistervi a fondo in un modo che poteva risultare oltraggioso”, e che “egli non tracciò mai esplicitamente il parallelo tra il Cristianesimo e le antiche credenze che esso riorganizzava”47, ma è altrettanto vero che lo straordinario successo del libro di Frazer ebbe per effetto di strappare quelle pagine polverose (che abbiamo letto sopra) dalle mani dei pochi eruditi depositari della tradizione e di conferire ad esse una nuova diffusione ed una invadente attualità, che finì per provocare, da parte della più accreditata scienza antichistica, un giudizio di non attendibilità (che non può non ricordarci quello uscito già in antico dalla penna di Livio) autorevolmante pronunciato e 46 Ibid., p. 194. 47 Queste osservazioni sintetiche sulla teoria generale del Frazer si possono leggere nella ampia prefazione di MARY DOUGLAS, alla p. XVII dell’edizione citata nelle note precedenti.
56 MARIANO MALAVOLTA puntualmente riconfermato48, secondo una tendenza interpretativa che ammette tutt’al più la derivazione di questa “favola” del sacrificio umano da una circostanza molto più banale, che cioè in occasione del Latiar si sarebbero elargiti al popolo, a partire da una certa epoca, dei munera gladiatoria: per questo motivo gli apologisti cristiani si sarebbero sentiti autorizzati a scrivere che la statua di Giove Laziare veniva bagnata con sangue umano49. 48 Si veda specialmente G. WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, München 19122, p. 124 con nota 8; K. LATTE, Römische Religionsgeschichte, München 1960, p. 144 con nota 3. 49 Così F. SCHWENN, Die Menschenopfer bei den Griechen und Römern, Giessen 1915, p. 180 sg.; ID., s.v. Menschenopfer, in “P.W.” XVI, 1 (1931) col. 945 sg.; I. OPELT, Die Polemik in der christlichen lateinischen Literatur von Tertullian bis Augustin, Heidelberg 1980, p. 18 con nota 40. Anche G. PICCALUGA, La colpa di perfidia sullo sfondo della prima secessione della plebe, in “Le délit religieux dans la cité antique” (Table ronde, Rome 6-7 avril 1978), Roma 1981, pp. 21-25, sembra adombrare una analoga spiegazione, scrivendo che nel 493 agli edili della plebe “venne affidato un ruolo sacrale di notevole importanza nella festa di cui sopra [ossia delle ferie latine]: la direzione del munus nel cui ambito – e forse non solo da epoca tarda, come finora si è stati propensi a credere – aveva luogo il sacrificio di un essere umano”. Di questa posizione della Piccaluga va senz’altro apprezzata la tendenza a rivalutare i dati della tradizione sull’uccisione rituale del bestiarius nel senso di una ininterrotta continuità del rito, che concorda con quanto sosteniamo in queste pagine: d’altra parte si deve notare che i giochi affidati nel 493 agli edili plebei, che Dionigi di Alicarnasso identifica con le ferie Latinae, sono in realtà sicuramente i ludi Romani o ludi magni ; la imprecisione di Dionigi è notata già dallo SCHWEGLER (Röm. Gesch. II p. 232 con nota 5) e dal Mommsen (Staatsr. II p. 519; cfr. Ch. WERNER, De feriis Latinis, Diss. Lipsiae 1888, p. 23) ed è stata unanimemente ribadita anche negli studi più recenti, ad esempio da O. DE CAZENOVE, Le sanctuaire de Cérès jusqu’à la deuxième sécession de la plèbe. Remarques sur l’évolution d’un culte public, in “Crise et trasformation des sociétés archaiques de l’Italie antique au Ve siècle av. J. C.” [Actes de la table ronde, Rome, 19-21 nov. 1987], Roma 1990, p. 387. Tuttavia l’interpretazione, a nostro giudizio
FRA ANTICHITÀ E STORIA 57
Che questo giudizio di condanna, per quanto autorevole, non possa in alcun modo essere considerato inappellabile non spetta a me di dirlo, ma è chiaro che in ogni caso vale la pena di riaprire la discussione per correggere un eccesso di sistematicità e di rigore di metodo che in qualche caso sembra aver determinato una vera e propria rimozione50 di un nucleo di documenti che indubbiamente sono difficili da conciliare con la ben nota avversione della religione romana non soltanto per i “sacrifici umani”, ma anche per le cosiddette “uccisioni rituali” (ritenute per lo più assai meno gravi dagli studiosi moderni), e che sono anche in contrasto con la realtà inoppugnabile della legislazione elaborata in quella direzione, che aveva portato ad estendere la nozione di homicidium alla pratica dei sacrifici umani ammessa da
errata, che tende a inquadrare l’uccisione del bestiarius fra i munera, piuttosto che fra i ludi (scaenici) è condivisa da C. VISMARA, Il supplizio come spettacolo, Roma 1990, p. 73, dove leggiamo che la “difesa dei munera gladiatorii e delle condanne cruente dell’arena viene elaborata dall’aristocrazia pagana, che ripropone appunto la loro interpretazione religiosa come la sostituzione dei sacrifici umani, che venivano anticamente offerti ad alcune divinità: Nemesi, Saturno, Giove Laziare etc.”. Non è ancora stata studiata in modo soddisfacente l’iscrizione del Latiarius attestato da una iscrizione di Mileu in Numidia, che sembra riferirsi a un gladiatore (C.I.L. III 19994 e cfr. “Diz. Epigr.” IV 1947, p. 424). 50 Così nei lavori di C. CICHORIUS, Staatliche Menschenopfer, in Römische Studien, Leipzig-Berlin 1922, p. 7 sgg.; V. GROH, Sacrifizi umani nell’antica religione romana, in “Athenaeum” 21, n.s. XI, 1933, pp. 240-249; E. CANTARELLA, I supplizi capitali in Grecia e a Roma, Milano 1991; K.M.COLEMAN, Fatal charades. Roman execution staged as mythological enactments, in “J.R.S.” LXXX, 1990, pp. 44-73, che pure cita la documentazione figurata di un bestiarius, che sarebbe rappresentato in un mosaico africano (p. 54).
58 MARIANO MALAVOLTA alcuni diritti locali51. Senza negare la sostanza di quella realtà, sembra tuttavia, nei limiti di questa specifica questione, che proprio il carattere di eccezionalità e anzi di unicità del Latiar, inteso come sacrificio consistente nella uccisione di una vittima umana, estraneo agli usi sacrali degli abitatori del primo nucleo della città, ma in seguito inglobato nel suo processo di espansione, culminato nella formazione della grande Roma dei Tarquinii e conservato da una superstitio che ne garantì l’incolumità con una pratica più che millenaria, vada riletto e riconsiderato non come una anomalia inesplicabile che conviene espungere senza troppi rimpianti, ma come spia rivelatrice di un interessante nodo, che vuole essere sciolto da più accurate indagini.
Qualche parola ancora vale la pena di spendere su uno
degli ingredienti a nostra disposizione, di cui non è ben chiara la funzione e per il quale non può bastare la spiegazione allegata da Plinio. Nel Lessico universale italiano leggiamo che l’assenzio propriamente detto, o assenzio romano, o assenzio maggiore (Artemisia absinthium) è spontaneo in Italia, e dunque facilmente reperibile o coltivabile; dalle foglie e dai fiori si ottiene uno 0,3 o 0,4 per cento di olio essenziale, usato per preparare liquori di gusto amarognolo (che viene chiamato vèrmoda già in un glossario del V secolo, dove si fornisce questo equivalente per il vocabolo greco ajyivnqion)52, ma questo impiego è proibito in alcuni paesi per via della tossicità di alcoli contenuti
51 PLIN., Nat. hist., 30, 1, 13; SUET., Claud. 25 e cfr. Th. MOMMSEN, Röm Strafrecht, Leipzig 1899, p. 120 con nota 2. 52 Th. ling. Lat. II col. 321.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 59 nell’essenza: questa, peraltro, assunta in piccole dosi, risulta avere un’azione tonica dello stomaco e può considerarsi stimolante energetico. Quello che sobriamente il Lessico non dice, e che ho dovuto accertare nella vecchia Enciclopedia, è che la parte più attiva dell’essenza ricavata dall’Artemisia possiede proprietà convulsivanti e produce dapprima un’eccitazione disordinata più o meno violenta a cui, se la dose è sufficiente, segue una crisi motoria dimile a quella provocata dall’epilessia53. Sembra sicuro che l’auriga vincitore della gara di cui parla Plinio ricevesse, dopo la vittoria, un assaggio di liquore dal gusto amarognolo, detto absinthites. Nella stessa giornata, in un luogo non ben precisabile, ma che potrebbe essere il sacrario di Iuppiter Latiaris sul Quirinale o un vicino teatro nel quale venivano rappresentati ludi scaenici in occasione delle feriae Latinae, un flamen Latiaris procedeva, magari in presenza del praefectus urbi feriarum Latinarum, al sommario rito di uccisione di una vittima umana (un condannato a morte, o addirittura qualche povero reietto preso per strada): due momenti celebrativi apparentemente non collegati fra loro, meccanicamente riproposti di anno in anno da una plurisecolare liturgia di una festa “mobile” per eccellenza. Non è escluso, se le proprietà dell’assenzio hanno qualcosa a che vedere con la funzione originaria che quel farmaco doveva svolgere nella consumazione del rito, che in età molto più antica quei due momenti celebrativi della festa,
53 Oltre alle voci Assenzio dell’Enciclopedia italiana e del Lessico universale italiano si veda anche G. N. OLCOTT, Thesaurus linguae Latinae epigraphicae, I, Rome 1904, p. 378 e la bibliografia fornita da S. LAUFFER, Diokletians Preisedikt, Berlin 1971, p. 219.
60 MARIANO MALAVOLTA come ogni cosa lascia credere, fossero un tutt’uno e che il vincitore della corsa venisse costretto a ingoiare una bevanda molto più amara54.
54 Questa mia ipotesi sulla vittima del sacrificio, preventivamente drogata con l’assenzio, è stata recentemente presa in coinsiderazione anche da CARANDINI, o.c. a nota 4, p. 198 con nota 53. La possibilità che il Campidoglio, o anche il Capitolium uetus del Quirinale, siano stati in età arcaica luoghi deputati allo svolgimento di riti “autonomi” di uccisione è adombrato anche da M. LEMOSSE, Les éléments techniques de l’ancien triomphe romain, in “A.N.R.W.” I, 2, Berlin 1972, p. 447 con nota 25. Potrebbe trattarsi, in questo come in altri casi, di una di quelle “sequenze storiche” illustrate da A. BRELICH, Presupposti del sacrificio umano, Roma 1967, p. 13 sg., rilevabili allorché “una religione politeistica ha adattato alle sue esigenze un rito autonomo di uccisione, originariamente non sacrificale, trasformandolo in elemento liturgico della festa dedicata a una divinità”. Si veda, a questo riguardo, l’interpretazione (anticipata già da TERT., De spectaculis 9, 5) della corsa con la quadriga intesa come la trasposizione della lotta fra estate e inverno (H. VERSNEL, o.c. alla nota 10, pp. 267-269), che renderebbe possibile ricondurre sia il rito della pompa triumphalis (ibid., p. 355 sgg.) sia il certamen quadrigarum, sia il conseguente sacrificio per le feriae Latinae ad una cerimonia di capodanno legata al rinnovamento del tempo e connaturata al potere regale (F. COARELLI, Il Foro Boario. Dalle origini alla fine della Repubblica, Roma 1987, p. 427), nel cui ambito potevano ben essere elaborate leggende simili a quella dell’uccisione di Romolo.
In caelo Romulus1. Dopo tutto quello che abbiamo sentito (e “visto”) sulla
fondazione di Roma, consentitemi di dedicare gli ultimi minuti di quest’incontro alla persona del fondatore, a quel Romolo che si porta dietro la croce di un nome inventato di sana pianta, estratto da quello della Città da lui fondata: e vorrei farlo facendovi riflettere sulla doppia lettura di quel nome che ancora oggi salta agli occhi: perché ancora nello stesso nome convivono, in qualche modo, il Romolo ragazzo del Tufello degli stornelli, e il Romulus che è un eurocity Roma-Vienna, o un motel sulla Salaria, o un costoso orologio: non dobbiamo dimenticare che è da quest’altezza vertiginosa che ci sporgiamo per guardare nell’abisso dei millenni.
Il nome Romolo era tornato di gran moda, almeno in Occidente, nei secoli del tardo impero, se solo pensiamo al Valerio Romolo figlio di Massenzio, morto giovanissimo nel 3092, o al Romolo Augustolo, l’ultimo Augusto, deposto da Odoacre nel 476: che un imperatore romano portasse il nome fatale del fondatore della città si rivelò fatale per i destini dell’impero, che con la deposizione di quell’imperatore concluse la sua vita in quell’anno fatidico, e forse fu già disegno del fato che il Romolo figlio di
1 Testo della relazione svolta nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, il 16 aprile 2011, in occasione dell’Incontro culturale organizzato dal Gruppo Storico Romano sul tema “La fondazione di Roma. Un viaggio fra storia e leggenda”; pubblicata in “Acta bimestria” a. 1, nr. 6 (marzo-aprile 2011), pp. XIV-XVIII. 2 È il nr. 6 alla p. 772 della P.L.R.E.
62 MARIANO MALAVOLTA Massenzio sia mancato sulle soglie della fanciullezza, senza poter giungere alla promessa porpora imperiale.
Ma andiamo ancor più indietro, nella Roma del nostro “contemporaneo” Livio: contemporaneo perché (come noi) visse a secoli di distanza dai tempi eroici delle origini, in un’epoca che per molti aspetti fu di splendida civiltà, ma che egli considerava tutt’altro che eroica, e anzi ormai condannata (né più né meno della nostra) da quel suo esser giunta al punto cruciale del non più sopportare quei mali che l’affliggevano, ma tanto meno disposta (ne sappiamo qualcosa anche noi) a sottoporsi ai troppo severi rimedi, cioè alla cure necessarie a correggerli.
Sulla leggenda dell’assunzione in cielo di Romolo Livio, come oggi noi suoi contemporanei, non poteva che mostrarsi scettico: “I racconti tradizionali – egli ci spiega – che si riferiscono ai tempi precedenti la fondazione o la futura fondazione dell’Urbe, simili più alle favole dei poeti che a una rigorosa documentazione storica, io non intendo né confermarli né confutarli. Possiamo ben accordare agli antichi questa licenza di nobilitare le origini della città mescolando l’umano col divino. E se vi è un popolo cui si deve consentire di divinizzare le proprie origini e di attribuirne la causa prima agli dei, il popolo romano ha una tale gloria militare che, quando esso vanta soprattutto Marte come padre suo, e del suo fondatore, le genti accettano di buon animo questa sua debolezza, così come ne accettano il dominio”3. Lo stesso scetticismo traspare, dopo poche pagine del primo libro, a proposito della misteriosa scomparsa di Romolo, avvolto da una nube e rapito in cielo
3 Praef. 6.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 63 mentre è intento a sacrificare nel Campo Marzio: è evidente per Livio che l’assunzione in cielo è tutt’al più una favola, buona per ammansire il popolo, che accusava i senatori di aver fatto sparire il cadavere del re, e che proprio a questo scopo la favola fu suffragata dalla testimonianza di Proculo Giulio, che giurò di aver incontrato “il padre di questa città” sceso improvvisamente dal cielo e latore di una profezia secondo cui “nessuna potenza umana avrebbe potuto resistere alle armi dei Romani”, per poi vederlo di nuovo sparire verso l’alto (sublimis abiit sono le sue parole): “è davvero sorprendente – conclude Livio – che si sia prestata tanta fede a un uomo che dava una simile notizia, e che tanto si sia mitigato nella plebe e nell’esercito il rimpianto di Romolo, una volta creatasi la convinzione della sua immortalità”4.
L’ovvio scetticismo di Livio rappresenta, in questa formulazione canonizzata dalla storiografia ufficiale, la naturale continuazione di un atteggiamento largamente condiviso già nell’ultima età repubblicana, ed esplicitamente dichiarato anche dagli elementi più lealisti nei confronti della religione di stato, e che si professano di fede “stoica”. Mi limito a citare Cicerone, che nel De legibus fa cenno all’episodio di Proculo Giulio come ad un “esempio eclatante di favolosità della storia antica”5, mentre in più
4 1, 16, 5-8. 5 De legibus 1, 3 dove, rivolto ad Attico, Cicerone risponde alla notazione ironica dell’amico: “Ma non prima che tu abbia risposto a me, se sia vero che Romolo, dopo la sua morte, passeggiando non discosto dalla tua abitazione, abbia detto a Proculo Giulio di essere un dio e di chiamarsi Quirino, e ingiunto che ivi gli si dedicasse un tempio”. La citazione fra virgolette è dall’edizione curata da CANCELLI, p. 256.
64 MARIANO MALAVOLTA luoghi del De re publica si sofferma a lungo sulla questione della non verosimiglianza portando argomenti scientifici, quasi democritei (“… ma i loro corpi – egli osserva – non furono elevati in cielo, poiché la loro natura non ammetterebbe che ciò che deriva dalla terra dimori altrove che sulla terra”)6, e insiste a più riprese e rimarca il suo stupore di fronte alla divinizzazione di Romolo avvenuta non nei tempi eroici dei poemi omerici, ma “meno di 600 anni fa, quando la scrittura e l’educazione erano già radicate nella nostra gente”7.
Il soggiorno in cielo di Romolo/Quirino è nondimeno ‘dogma’ della religione ufficiale, e lo è probabilmente da età assai antica, visto che ne abbiamo un’attestazione sicura già per l’età del poeta Ennio, morto settantenne nel 169 a.C. Nel primo libro degli Annali leggiamo che Romulus in caelo, cum dis genitalibus aevom degit8, e sappiamo che l’assunzione in cielo di Romolo restò a lungo un fatto isolato, almeno fino alla divinizzazione di Cesare (l’unico inserito come caelicola, dopo Romolo, nelle Metamorfosi di Ovidio9): e non è per caso che nella Farsaglia di Lucano il futuro divo Giulio, nel momento cruciale della sua vita, sul punto di gettare il dado passando il Rubicone, invochi (con altri dei) i rapti secreta Quirini, ossia Romolo/Quirino10(1, 197); e ancora quattro
6 De re publica 3, 28, 40. 7 Ibid. 2, 17-18. 8 Fr. 119 VAHLEN = 54 VALMAGGI, p. 29. Ennio visse fra il 239 e il 169 a.C. Dii genitales sta qui per indigites, o originarii, ai quali è dovuta la nascita di tutte le cose. 9 Per l’apoteosi di Romolo, condotto in cielo da Marte, Met. 14, 805-828; per quella di Cesare, raccolto e trasportato da Venere, ibid. 15, 843 sgg. 10 LUC., Phars. 1, 197.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 65 secoli più tardi, nell’operetta satirica che va sotto il titolo I Cesari dell’imperatore Giuliano, Romolo la fa addirittuta da padrone di casa, quando decide di festeggiare i Saturnali dando in Olimpo un party al quale invita tutti gli dei, quasi nell’imminenza del definitivo tramonto del paganesimo.
Lo scetticismo che era stato già dei pagani viene ampiamente utilizzato, al solito, nella letteratura apologetica dei primi scrittori cristiani, che dal nuovo Olimpo, ossia dal loro Paradiso, vogliono invece sfrattare il povero Romolo, anche perché, fra l’altro, si sentono sfidati da un aspetto non secondario del suo mito: la scomparsa del corpo. Così Tertulliano, nell’Apologeticum (pubblicato negli ultimi mesi del 197) dopo aver riferito che anche i notabili dei Giudei dopo il miracolo della scomparsa del corpo dal sepolcro, “sparsero la voce che il corpo di Cristo era stato trafugato dai discepoli” (come quello di Romolo dai senatori), riafferma la verità della fede cristiana, secondo la quale, dopo aver affidato ai suoi apostoli il compito di predicare per il mondo, “avvolto da una nube – ancora una volta come Romolo – salì in cielo, con molto maggior verità di quanto i vostri Proculi vadano raccontando dei vostri Romoli”11. E ancora sant’Agostino, nel De ciuitate Dei, pubblicato nel 426, pochi anni prima della morte (avvenuta nel 430), e scritto all’indomani dell’epocale sacco di Alarico (410), dedica molte pagine al paragone fra Cristo e Romolo, affermando ovviamente la incommensurabile superiorità del Cristo, ma – è curioso quest’aspetto – giungendo addirittura a polemizzare con lo scetticismo democriteo di Cicerone, allorché annota che i Romani dei tempi più antichi (quando 11 TERT., Apol. 21, 23.
66 MARIANO MALAVOLTA Roma era ancora un villaggio di pastori) poterono ben credere alla trasfigurazione di Romolo, cui aderirono istintivamente, con un atto di fede che egli sembra addirittura apprezzare, quando gli sfugge di dire che esso avvenne “non per amor d’errore, ma per error d’amore” (non amore erroris sed errore amoris: 22, 6; cfr. 18, 24 e 22, 4).
Il lungo soggiorno di Romolo in caelo, che varrebbe sicuramente la pena di indagare con qualche attenzione in più di quanto io abbia fatto in questa rapidissima rassegna, riceve ulteriore conferma da quello che leggiamo nell’Apocolocintosi di Seneca: si tratta però di un’apparizione tutt’altro che lusinghiera per il nostro “padre della patria”, che ha destato il mio interesse e mi ha suggerito una più accurata indagine su una rappresentazione di cui non mi pare siano state fino ad ora considerate tutte le implicazioni.
L’operetta di Seneca, che nella letteratura latina rappresenta un esempio quasi unico di pamphlet satirico conservato dalla tradizione, narra le peripezie che l’imperatore Claudio avrebbe affrontato al momento della sua morte, avvenuta per avvelenamento il 13 ottobre del 54, fra mezzogiorno e l’una: in un contesto compositivo tipico della satira menippea, che alternava prosa e versi, veniva messo in scena un concilio degli dei nel corso del quale i diui del consesso vengono interrogati, seguendo il protocollo delle adunanze del senato romano, sulla opportunità o meno di accogliere nel proprio seno la new entry proposta dai mortali. Claudio viene fatto allontanare (anche nei consigli di facoltà, l’interessato non può assistere mentre si delibera sulla sua “chiamata”) e Giove, che presiede l’assemblea, dà la parola ai consoli designati Giano e Diespiter, che in effetti in
FRA ANTICHITÀ E STORIA 67 quest’ordine intervengono, e mentre sembra tutto sommato negativo il parere di Giano (il notarius non è stato in grado di stenografare le parole del suo articolato discorso e dunque se ne riferisce un sunto), di quello di Diespiter (un’antica divinità locale, dio del giorno e della luce e figlio di Vica Pota) viene riportato addirittura un estratto del verbale, che così recita: “dal momento che il divino Claudio è consanguineo del divino Augusto e ugualmente della divina Augusta, sua nonna12 (che egli stesso volle che fosse dea) e poiché egli supera di gran lunga tutti i mortali in saggezza, ed inoltre è nell’interesse dello stato che vi sia qualcuno che possa “divorare le rape bollenti” con Romolo13, propongo che da oggi il divino Claudio sia divo, così come ognuno che prima di lui sia stato fatto divo a pieni diritti, e che questo avvenimento si debba aggiungere alle Metamorfosi di Ovidio”. La proposta desta le ire del divo Augusto, che si sente personalmente offeso dall’eventualità che Claudio diventi un suo pari, e che quindi dà un parere fortemente contrario alla divinizzazione; la mozione di Augusto viene votata all’unanimità, e di conseguenza Claudio viene trascinato negl’inferi da Mercurio, e vi sconta un’adeguata condanna.
Della morte di Claudio, avvelenato da Agrippina per affrettare la successione del diciassettenne Domizio
12 La madre di Claudio, Antonia minore, era figlia di Ottavia (sorella di Augusto e moglie di Marco Antonio il triumviro). 13 SEN., Apocol. 9, 5 (p. 87 dell’edizione curata da LUCA CANALI e MARCO FUCECCHI, Milano 2006): … sitque e re publica esse aliquem qui cum Romulo possit ‘feruentia rapa uorare’, censeo uti diuus Claudius ex hac die deus sit, uti ante eum quisque optimo iure factus sit eamque rem ad Metamorphosin Ouidi adiciendam.
68 MARIANO MALAVOLTA Enobarbo, Seneca doveva aver goduto in maniera a dir poco spropositata, per un evento che lo ripagava dei lunghi anni d’esilio in Corsica (dal 41 al 49), inflittigli proprio da Claudio per il sospetto di adulterio con Giulia Livilla, la figlia di Germanico14. Uno dei capolavori del nostro retore – che purtroppo non possediamo – fu indubbiamente la laudatio che egli scrisse al giovane Nerone, perché costui la recitasse in occasione dei funerali di stato del defunto imperatore: ai primi passaggi del discorso Nerone era riuscito a imporsi il tono che la circostanza richiedeva, ma con lo scorrere dei fogli la lettura dell’orazione di Seneca aveva indotto sbuffi di riso del principe che alla fine avevano avuto il sopravvento, trasmettendosi all’uditorio delle più alte cariche dello stato e trasformando l’elogio funebre in una irrefrenabile esplosione di ilarità generale. Ora non è il caso di trattenerci sui motivi dell’odio di Seneca per Claudio, o sulla connotazione da assegnare al Diespiter o – come qualcuno preferirebbe leggere – Dis pater (il padre Dite), che avrebbe a che fare con lo squallido commercio dei diritti di cittadinanza romana che l’entourage di Claudio aveva organizzato con la più o meno consapevole connivenza dell’imperatore. Ci interessa invece soffermare la nostra attenzione su quest’Olimpo descritto da Seneca, e sul flash che per un attimo ne ha illuminato il fondale, mostrandoci l’inedita immagine di un Romolo quasi curvo sul piatto (o addirittura sul truogolo?), intento a divorare “rape bollenti” o, se si vuole, “rape lesse”, piuttosto che nettare e ambrosia, come a un dio si converrebbe; e non basta: qualcuno può pensare di fornirgli un “compagno” nella persona del nuovo divo Claudio, ben 14 Dunque, sorella di Caligola e nipote di Claudio.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 69 noto per il suo essere “impresentabile”, malfermo, bavoso e con la voce di un mostro marino. E ancora: il Romolo “mangiarape” celeste non compare soltanto nel libello di Seneca, ma è noto anche a Marziale, che vi allude nel suo libro di Xènia, una specie di raccolta (pubblicata nell’84) di epigrammi in distici elegiaci da utilizzare come etichette dei doni sorteggiati nei conviti o inviati ai clienti delle famiglie ragguardevoli: Haec tibi brumali gaudentia frigore rapa / quae damus, in caelo Romulus esse solet 15, quasi a far notare scherzosamente al destinatario del cesto di rape che non dev’essere deluso di quel dono, visto che si tratta del cibo preferito da Romolo in cielo. I commentatori di Seneca osservano concordemente, a questo proposito, che il feruentia rapa uorare conserva sicuramente un emistichio (ossia un mezzo esametro) di Lucilio, autore satirico vissuto nel II secolo a.C., che con ogni probabilità fu autore di un componimento16, poi divenuto molto popolare, nel quale Romolo era in certo senso ridicolizzato (non diversamente da quanto è frequentemente attestato per altre figure di eroi divinizzati, come l’Eracle dei drammi satireschi). La popolarità dell’icona del Romolo celeste, del resto, è indirettamente attestata dalla curiosa circostanza che sui muri di Pompei (sommersa dalla cenere e dai lapilli 15 MART. 13, 16: “queste rape che godono del freddo brumale, e che io ti dono, sono cibo abituale di Romolo lassù in cielo”. Il libro degli Xènia (il 13° nella raccolta tramandata dai codici) era stato pubblicato autonomamente nell’84, dunque una trentina d’anni dopo la morte di Claudio. 16 Si veda LUCILIUS, Satires, Tome III, livres XXIX, XXX et fragments divers. Texte établi et traduit par F. CHARPIN, Paris 1991, p. 163, [fr.] 15+ (1357 M), e cfr. ibid. p. 313.
70 MARIANO MALAVOLTA dell’eruzione del Vesuvio del 24 agosto del 79) ben tre graffiti, e addirittura un’iscrizione incisa su una tessera lapidea di cm 12 x 7, recano la enigmatica scritta Romulus in caelo, riferita forse al soggetto di un monumento figurato (nel caso della tessera), o di un mimo (una farsa, un exodium) rappresentato di recente con quel titolo17. Ovvio che il Romulus di qualcuno dei graffiti di Pompei può essere stato anche un omonimo per noi anonimo (ancorché noto ai lettori pompeiani), o uno che portava quel nomignolo per esserselo scelto e che magari aveva qualcosa di romuleo da vantare. Noi storici non lo sapremo mai, a meno che non ci aiuti qualche archeologo, ma in ogni caso i documenti che abbiamo frettolosamente citato mostrano con evidenza che sulla vita ultraterrena del nostro eroe la fantasia degli antichi si esercitò non meno che sulle imprese compiute in vita, in contesti che, ovviamente, furono di volta in volta definiti nella direzione richiesta da utilizzazioni strumentali del mito, una volta che questo era più o meno spontaneamente fiorito. La voglia di rape (bollite, come nel caso di Romolo e dell’imperatore Claudio, o anche grigliate – così pare piacessero a Manio Curio Dentato e a Gaio Fabricio, vincitori dei Sanniti e di Pirro18) qualificava campioni di
17 C.I.L. IV 3135, 7353, 8568, 8995; da Pompei proviene anche l’unico elogium di Romolo, con i dati salienti della sua figura: Romulus Martis filius. Urbem Romam condidit et regnauit annos duodequadraginta. Isque primus dux duce hostium Acrone rege Caeninensium interfecto spolia opima Ioui Feretrio consecrauit, receptusque in deorum numero Quirinus appellatus est (C.I.L. X 809 = I.L.S. 64). 18 G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, I, Firenze 19743, p. 472, su Manio Curio Dentato cita VAL. MAX. 4, 3, 5; PLIN., N.h. 19, 87; 36, 111; FLOR. 1, 13, 22; lo stesso aneddoto viene narrato di Gaio Fabricio in FRONTIN.,
FRA ANTICHITÀ E STORIA 71 rudezza delle più antiche virtù repubblicane, ma poteva essere utilizzato, nella sua connotazione negativa, anche in complicati contesti letterari di sfida al potere. Della “dissacrazione” che si rileva nel passo di Seneca può forse aversi qualche primo sentore già nei versi dei Fasti ovidiani dedicati (in un contesto ovviamente assai diverso) alla ricorrenza delle none quintane del 2 a.C., di quel 5 febbraio, cioè, in cui ad Augusto era stato conferito il titolo di pater patriae, nell’anno del suo 13° consolato. Il confronto fra Romolo, padre fondatore del villaggio di pastori, e il nuovo padre di Roma, ora metropoli e ombelico del mondo, viene proposto enumerando i meriti civili dei due, il che alla fine rende scontata la vittoria di Augusto: a questo proposito, dicono i commentatori, Ovidio sceglie come interlocutore ideale il perdente del confronto, sia “per attenuare l’enfasi dell’elogio diretto, sia per fornire un esempio di quella clemenza consolatoria con i vinti che è elemento importante nella costellazione dei valori promossa dal regime”19. Ma qualche perplessità ci assale se ascoltiamo con attenzione le parole con le quali il poeta si rivolge direttamente a Romolo: “Romolo, riconoscilo: questi rende forti le tue mura, vegliando su di esse, tu le desti a Remo da saltare; sentirono la tua forza Tàzio, Cenìna e la piccola Curi, ma sotto la sua guida il mondo è romano a oriente e a occidente; tu possedevi non so qual piccolo spazio di terra, Cesare ha in
Strat. 4, 3, 2; HYGIN fr. 3 PETER. Moltissimi altri accenni si trovano nelle fonti classiche. 19 Per tutto questo si veda la citata edizione curata da CANALI e FUCECCHI, p. 138, e ancora L. Annaei Senecae Diui Claudii Apocolocyntosis, a cura di CARLO FERDINANDO RUSSO, Firenze 1948, pp. 92-95 e 145.
72 MARIANO MALAVOLTA suo potere tutto ciò che è sotto l’alto Giove; tu rapisci le spose, questi le vuole nel suo regno pudìche; tu accogli il crimine nel tuo bosco sacro, questi lo scaccia; a te fu gradita la violenza, sotto Cesare fioriscono le leggi; tu porti il nome di dominus, questi di princeps; te Remo accusa, questi ha perdonato i nemici; te il padre rese divino, questi ha reso divino suo padre”. Nel ritrarre Romolo come il guerriero poco attraente e retrogrado che doveva essere stato, è chiaro che Ovidio chiama neanche tanto velatamente in causa le qualità di Augusto. “La strategia – è stato scritto – è di quelle coperte, come devono necessariamente essere certe strategie, tanto più negli ultimissimi anni, i più segnati dall’autoritarismo, del principato di Augusto” ma qui “essa diviene esplicita, all’interno di un’estesa e sistematica comparazione che Ovidio istituisce tra il principe e il suo arcaico prototipo romano. È in questo passo, così brillante per il suo candore smaliziato, che la riscrittura ovidiana di Romolo sembra più vicina che mai a rivelare un piano nascosto <di feroce critica>. Un panegirista animato da slancio sincero avrebbe colto al volo l’opportunità di salutare Augusto come il nuovo Romolo, il degno successore del primo ‘padre della patria’. Nella variazione sovversiva di Ovidio, non per questo meno avara di elogi ad Augusto, i meriti del secondo pater patriae inducono a formulare qualche riflessione sui meriti del primo. Tutto questo significa propriamente dare con una mano e riprendere con l’altra. Quanto vale la lode del princeps, una volta affiancata dalla denigrazione del prototipo ideologico del principe stesso? Ad ogni distico la figura di Augusto cresce in maestà, e a ogni distico viene reciso un altro pezzo della base su cui
FRA ANTICHITÀ E STORIA 73 quella si erge”20. L’esilio di Ovidio a Tomi ci induce a pensare che il destinatario dell’elogio abbia ben compreso la minaccia del ridicolo nell’ostentazione d’ipocrisia che avvolgeva gli elogi del poeta, che in parecchie delle manchevolezze del padre fondatore della città alludevano scopertamente ad altrettanti scheletri nell’armadio dell’Augusto: la moglie Livia “scippata” (quasi come le Sabine del ratto) al marito Tiberio Claudio Nerone, la vendetta spietata contro i nemici, il tradimento degli amici (come Cicerone) di cui si era strumentalmente servito, la crudeltà riservata ai superstiti dell’assedio di Perugia, il voltafaccia che lo aveva portato dal lealismo nei confronti del senato all’accordo scellerato con Antonio e Lepido, i loschi figuri di cui si circondava, come Vedio Pollione o Pompeio Mena, per non parlare del contrasto stridente fra le pudìche spose dell’elogio e lo scandaloso comportamento di Giulia21, dei cui amori lo stesso Ovidio era stato, se non altro, esperto consigliere.
Ma a questo punto qualcuno di voi chiederà: ma insomma, perché proprio le rape? Ed è la stessa domanda che io mi sono posto nel corso di queste settimane, da quando cioè ho pensato a questo argomento di conversazione per l’incontro di questa sera. Sarò onesto: non ho trovato nella documentazione una risposta soddisfacente, e anzi l’unica risposta soddisfacente è venuta da un responso oracolare del motore di ricerca che mi ha risparmiato qualche pomeriggio di biblioteca. In un libro pubblicato lo 20 S. HINDS, Arma in Ovid’s Fasti. Part 2: Genre, Romulean Rome and Augustan ideology, in “Arethusa” 25, 1992, 113-153, spec. p. 132 ss. 21 Culminato con il suo arresto, avvenuto proprio in quell’anno 2 a.C. in cui suo padre riceveva l’appellativo di padre della patria.
74 MARIANO MALAVOLTA scorso anno da Anthony Di Renzo, uno studioso dell’Ithaca College (dunque Stato di N.Y.), con il titolo Bitter greens (“verdure amare”), nel quale – ve la faccio breve – si legge, a p. 92, che “Romolo, diventato re, dava banchetti a base di rape per rafforzare il suo rapporto con la plebe, con il popolino, insomma, e che l’imperatore Claudio, ghiotto di rape (e autore di un elogio della rapa) avrebbe restaurato questa antichissima cerimonia, invitando a quei banchetti il popolo e il senato. Una spiegazione che non fa una grinza, e anzi sembra proprio la soluzione più soddisfacente dei quesiti posti dalla documentazione. Il fatto è che il prof. Di Renzo, da me interpellato via mail, mi ha confessato che la “suggestione” gli era venuta dalla lettura dei ben noti romanzi storici di Robert Graves.
Robert Graves, avido lettore del Ramo d’oro di Frazer, non è certo l’ultimo venuto, e anzi forse ha visto bene: un frammento dello storico bizantino Màlala racconta, a proposito dei Brumalia di Costantinopoli (la nuova Roma fondata da Costantino sul Bosforo) che Romolo, dopo esser divenuto re, istituì la festa dei Brumalia (la bruma è il giorno più corto dell’anno, quello del solstizio, e i Brumalia coprirebbero l’intero periodo fra il 24 novembre e il 25 dicembre), che consisteva nel nutrire il senato e il popolo in riparazione del fatto che i gemelli non erano stati nutriti dai genitori, ma da una lupa o dalla moglie del pastore Faustolo. Inoltre, leggiamo sempre in Malala, i Romani “essendogli nemici, odiandolo e ingiuriandolo, dicevano che non bisognava che quello regnasse, e lo rendevano oggetto di scherno”. La festa, che di fatto fu solennizzata a Costantinopoli fino al IX secolo, cadeva proprio nel colmo
FRA ANTICHITÀ E STORIA 75 della stagione delle rape, e, inoltre, Malalas cita per l’istituzione dei Brumalia una fonte autorevole, quale l’annalista Gaio Licinio Macro, un contemporaneo di Cicerone che in effetti fu autore di Annali che coprivano il periodo iniziale della storia romana, da Romolo alla guerra contro Pirro22. La parabola celeste di Romolo si può ben concludere, per quello che ci riguarda, sulle rive del Bosforo, dove nel momento della fondazione della nuova Roma non poteva certo mancare la figura del mitico fondatore della prima Roma. Anche e soprattutto qui, come ha notato Augusto Fraschetti in un suo apprezzato lavoro di quasi dieci anni fa23, la morale cristiana di Costantinopoli fece prevalere la sua visione etica sugli aspetti eroici della vita del fondatore, e su di lui si addensarono quelle ombre, quegli apetti oscuri, che la tradizione dell’antica Roma attribuiva solo all’ultima fase della sua vita, quando da buon re si era tasformato in tiranno. Ancor più di Augusto, Costantino poté atteggiarsi a sovrano migliore rispetto al leggendario fondatore della antica città sulle rive del Tevere.
Consentitemi, in fine, di aggiungere a queste righe una noticina a proposito delle feste e ricorrenze che abbiamo celebrato o a cui siamo prossimi, proprio perché non è stato privo di effetto ascoltare pochi minuti fa, in questa splendida Sala, il nostro Inno Nazionale: il 21 aprile vedrà compiersi il 2763° anno dalla fondazione di questa Città, la cui vita entrerà così nel suo 2764° anno – fidatevi, questo è il conto esatto – ed è il momento, per questa come per molte altre 22 Per il frammento di Gaio Licinio Macro e il passo di Malala che lo riferisce si veda H. PETER, HRR. fr. 2, p. 298, cfr. pp. CCCL sg.; il passo di MALALA 7, 228 è anche in CSHB, pp. 177-179 23 A. FRASCHETTI, Romolo il fondatore, Roma-Bari 2002, pp. 130-132.
76 MARIANO MALAVOLTA ricorrenze, che molti scelgono per aggredire non soltanto i Padri della Patria, ma anche i nostri più sacri miti. Ne sappiamo qualcosa per aver festeggiato, poche settimane fa, i primi 150 anni dell’Italia unita: una piccola parte di una lunghissima e plurimillenaria storia che, a ben vedere, ebbe inizio proprio con il nostro Romolo, ossia con quel dio (tale divenuto per suoi meriti indiscussi) che fin dall’inizio aveva profetizzato che di Roma avrebbe reso schiava la Vittoria. Quest’anno insieme con i padri fondatori dell’Italia moderna (Vittorio Emanuele, Cavour, Mazzini e Garibaldi) è stato in qualche modo aggredito anche Romolo, da chi è venuto a Roma a spiegare, con arguzia, che S.P.Q.R. deve intendersi come acronimo di s(ono) p(orci) q(uesti) R(omani). Possiamo scommettere che in caelo, in quel preciso istante, sollevando la bocca dal suo fiero pasto di rape, Romolo abbia socchiuso gli occhi per sussurrargli la sua lettura: s(orcio), p(erché) q(ui) r(osichi)?
Ventisette secoli (e mezzo) di “Roma ladrona”1.
Visti gli argomenti delle nostre relazioni qualcuno potrà
obbiettare che forse non era questo il miglior modo di celebrare, proprio alla vigilia del suo giorno natale, l’immagine di Roma come culla della civiltà. D’altra parte la convergenza della scelta effettuata in piena autonomia da ciascuno di noi tre relatori attesta la serietà scientifica dell’iniziativa del Gruppo storico romano, che non ha fatto concessioni alla retorica celebrativa d’occasione, mentre il convergere delle nostre attenzioni su aspetti sicuramente deteriori dei comportamenti dei nostri progenitori romani si è rivelato intuizione felice di quanto questi temi fossero destinati, proprio nel corso delle ultime settimane, ad assumere i caratteri della più stringente attualità: leggi elettorali addomesticate per favorire l’elezione dei “nominati”, scandali politici che coinvolgono eminenti personaggi, invettive contro “Roma ladrona” o addirittura, come abbiamo recentemente sentito, “Roma farabutta”, mai come ora sono stati pane quotidiano di stampa e televisione, ma quasi nessuno ha colto l’ironia della sorte per cui proprio i più convinti detrattori di Roma, in un momento di
1 Testo della relazione svolta il 20 aprile 2012 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, nell’occasione dell’Incontro culturale “Caput mundi, umbilicus mundi. Gli archetipi dell’attualità quotidiana”, organizzato dal Gruppo Storico Romano. Pubblicata in “Acta bimestria” 2012, nr. 10, pp. 5-12.
78 MARIANO MALAVOLTA smarrimento, sono arrivati a rispolverare la formula magica di un romanissimo “triumvirato”.
Il titolo del mio contributo, Ventisette secoli (e mezzo) di “Roma ladrona”, allude scherzosamente ad un’espressione cara al cavalier Benito Mussolini (si veda, ad esempio, il discorso pronunciato a Milano nel decennale del 1932), e quel mezzo secolo che ho aggiunto fra parentesi ai ventisette secoli vantati dal Duce vuol essere di proposito un maldestro tentativo di aggiornamento, ad accentuare i risvolti tutto sommato esilaranti delle situazioni che ora stiamo vivendo, se confrontati con un tragico passato. Circa la qualifica di “ladrona”, invece, il discorso può cominciare ad articolarsi richiamando le analogie fra la “Roma ladrona” dell’ultimo decennio e il “governo ladro” evocato (con la frase “governo ladro, piove”) da una vignetta satirica del “Pasquino” in occasione di una pioggia che nel 1861 a Torino guastò una manifestazione antigovernativa di Mazziniani. Ora, non è questo il luogo per attardarci a spiegare a un uditorio così selezionato la differenza fra ‘ladro’ e ‘ladrone’. Il ladro è l’autore di un furto con destrezza, e i Romani lo chiamavano fur, da cui furtum. ‘Ladrone’ è invece chi rapina con la violenza, ed è l’esito nella nostra lingua del vocabolo latino latro (genitivo latronis), usato appunto per indicare il brigante di strada, il predone o il pirata. Altrettanto ovvio che mentre il ‘governo ladro’ di ottocentesca memoria dà voce a più che legittimi sentimenti antigovernativi, contro qualsivoglia governo, la ‘Roma ladrona’ di cui stiamo parlando si è caratterizzata, specie negli ultimi decenni, come invettiva regionale e ‘nordista’, ancorché non esclusiva delle genti padane, escogitata peraltro, come qualcuno mi
FRA ANTICHITÀ E STORIA 79 dice, alla vigilia della marcia su Roma dalla componente futurista e milanocentrica del fascismo della prima ora2.
I lessici ci dicono che il significato originario del vocabolo latino latro è “mercenario”, derivato dalla stessa radice dei vocaboli greci latreiva (che significa servitù) e latreuv" (che indica appunto il servo come il mercenario che combatte per soldi), ma che ben presto la parola era divenuta sinonimo di masnadiero, brigante di strada, rapinatore, riferita a chi strappa via con la violenza un bene su cui non avrebbe alcun diritto; con questo significato essa fu utilizzata già nella lingua latina3, soprattutto per significare
2 Me lo suggerisce Federica Guidi, cui sono grato della segnalazione. Non sono riuscito, a dire il vero, a trovare negli scritti dei Futuristi lo slogan “Roma ladrona”, ma certo un archetipo può considerarsene, tanto per fare un esempio, quel che disse Giovanni Papini (1881-1956) al teatro Costanzi (l’attuale Teatro dell’Opera di Roma) il 21 febbraio 1913, definendo Roma “città brigantesca e saccheggiatrice che attira come una puttana e attacca ai suoi amanti la sifilide dell’archeologismo cronico... simbolo sfacciato e pericoloso di tutto quello che ostacola in Italia il sorgere di mentalità nuove”. Per i sentimenti antiromani del Marinetti si può confrontare l’auspicio, espresso già nel manifesto del 1911, di cancellare “il fastidioso ricordo della grandezza romana con una grandezza italiana cento volte maggiore”, mentre - venendo a tempi assai più recenti - vale la pena annotare che la paternità dello slogan “Roma ladrona” è rivendicata dal deputato leghista Alessandro Cè, poi passato all’IDV, che proprio per questa circostanza meritò la qualifica di “europirla” dalla Gialappa’s. Ma non mancherebbero precedenti risalenti alla metà degli anni Cinquanta: tale il Lucio Marcarino “marpista”, ossia militante del MARP (Movimento per l’autonomia regionale piemontese), di cui leggiamo in P. STEFANINI, Avanti Po: la Lega alla riscossa nelle regioni rosse, Milano 2010, p. 119. 3 Si veda a questo riguardo, oltre a P.G. VAN WEES – W. BUCHWALD, in Th.l.L. VII col. 2016 s.v. latro, la voce latro redatta da M. SCARSI per l’Enc. virg. III (1987) p. 136 sg., che registra l’anomalo uso virgiliano di latro nel significato di uenator.
80 MARIANO MALAVOLTA la sopraffazione di tutti i popoli dell’ecumene antica operata progressivamente dal dilagare dell’occupazione militare romana, le cui prime vittime furono le stirpi latine, seguite dall’Italia intera, e poi, inesorabilmente, dal resto del mondo conosciuto. Della sterminata letteratura pubblicistica che nel secolo scorso aggredì il cosiddetto “imperialismo romano” mi limito a citare il pamphlet violentemente antinazista di Simone Weil (filosofa e mistica ebrea, 1909-1943), divulgato nel 1939, alla vigilia del secondo conflitto mondiale4, intitolato Réflexions sur l’origine de l’Hitlerisme, nel quale Roma e il suo impero venivano polemicamente additati non come culla della civiltà occidentale, ma anzi come il modello dell’impero del male, al quale Hitler si proponeva di aderire, ricreando quella stessa diabolica capacità di aggregare il consenso di massa5.
Da questa lettura di una Roma ‘predona del mondo’, che potremmo definire totalizzante (e che in seguito sarebbe stata utilizzata anche contro gli effetti nefasti del cosiddetto imperialismo americano), va ovviamente distinta un’altra lettura che, con obbiettivo più molto più modesto, senza coinvolgere la dialettica storica e il destino degli umani, si limita ad elencare i singoli numerosissimi episodi di corruzione e di ladroneria, di volta in volta messi in opera dai responsabili del governo centrale o dai governatori provinciali, come dagli appaltatori o dagli esattori di imposte, dai procuratori imperiali, e insomma da quei funzionari che furono più o meno direttamente responsabili 4 La versione integrale fu pubblicata a Parigi solo nel 1960. 5 Su questa problematica in generale si veda il recentissimo contributo di S. RODA, Il modello della repubblica imperiale romana fra mondo antico e mondo moderno, Noceto 2011.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 81 della gestione amministrativa delle province. Anche in questa categoria (che a noi è ben nota, e che qualcuno potrebbe anche spingersi ad accettare con rassegnazione, come dato fisiologico del viver civile di tutti i tempi, specie in questo nostro Bel Paese) possiamo comprendere una ricchissima documentazione, relativa soprattutto al periodo della cosiddetta crisi della repubblica, che viene bene illustrato da Plutarco a proposito – tanto per fare un esempio – delle vessazioni imposte alla ricca provincia d’Asia dopo l’intervento di Silla contro la sollevazione antiromana di Mitridate, fino a che il nuovo governatore, Lucullo, non intervenne per porre fine a quello scempio. “Lucullo rivolse poi la sua attenzione – siamo nel 71 a.C. – alle città d’Asia, intendendo ristabilirvi la giustizia e la legalità, finché era libero da impegni militari. La carenza delle leggi, che durava ormai da molti anni, causava infatti alla provincia danni incalcolabili e incredibili. Gli abitanti venivano spogliati dei loro beni e ridotti in schiavitù dai gabellieri e dagli usurai; i genitori erano costretti a vendere i figli più graziosi e le figlie giovani, le collettività ad alienare offerte votive, quadri e statue conservati nei templi; quand’erano ridotti all’estremo i cittadini stessi si consegnavano schiavi ai creditori. Ma più atroce ancora era la loro condizione prima di arrivare a tal punto; i creditori li tormentavano con tratti di corda, con gli aculei, col cavalletto, li esponevano sotto il cielo aperto ai raggi infuocati del sole, li immergevano nel fango o nel ghiaccio durante l’inverno. Tutto sommato la schiavitù appariva a quei poveri infelici un sollievo e una pace beata. Simili obbrobri Lucullo trovò nelle città, e in breve tempo ne liberò totalmente le vittime. Per prima cosa fissò il tasso
82 MARIANO MALAVOLTA d’interesse all’uno per cento al mese e non più (dunque il 12 % annuo); in secondo luogo decurtò gli interessi maggiori del capitale; per terzo, e fu la misura più importante, dispose che il prestatore non potesse ricevere più della quarta parte del reddito del debitore [noi oggi limitiamo alla quinta parte i contratti di cessione dello stipendio]; chi poi aggiungeva gli interessi al capitale [rendendosi colpevole di anatocismo], veniva privato degli uni e dell’altro. Con questo sistema in meno di quattro anni tutti i debiti risultarono pagati e le proprietà tornarono ai padroni libere da ipoteche. In Asia tutti erano indebitati in questo modo a cagione della multa di ventimila talenti, che Sulla aveva imposto alla provincia. Essa fu pagata almeno due volte nelle mani degli usurai, che a forza di interessi l’avevano fatta salire a centoventimila talenti”6. Non diversa, anzi per certi aspetti peggiore, la condizione di spietato sfruttamento che emerge dalle orazioni pronunciate da Cicerone nel 70 contro Gaio Verre, governatore della provincia di Sicilia fra il 73 e il 71, che non provo nemmeno a riassumere, ma che sono universalmente note come il documento più noto e ricco di particolari sugli abusi degli amministratori romani: Verre fu condannato per aver estorto ai Siciliani oltre 40 milioni di sesterzi (grosso modo equivalenti a un centinaio di milioni di euro), ne restituì nemmeno la decima parte in forza della sentenza, e poté godere in esilio delle ricchezze che aveva predato, e pensate che il fulcro della sua difesa consisté nel dire che quei denari non li aveva sottratti al popolo romano, ossia allo stato, ma ai Siciliani, e che gli storici ritengono per lo più che la condotta di Verre non sia stata in sostanza peggiore di
6 PLUT., Lucull. 20.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 83 quella solitamente seguita dai suoi pari.
A questo stato di cose, come ci fa notare Tacito nel primo libro degli Annali, la rivoluzione “borghese” di Augusto pose efficacemente riparo, tanto che “nemmeno alle province dispiaceva del tutto questa nuova amministrazione, per la totale mancanza di fiducia nel governo del senato e del popolo, a motivo delle contese fra i potenti e l’avidità dei governatori, contro la quale a nulla valeva la garanzia della legge, schiacciata ora con la violenza, ora col raggiro, e infine con la corruzione”7. A parte le parole di Tacito, o l’Elogio a Roma di Elio Aristìde, non meno evidente il dato, concordemente suffragato dai documenti epigrafici come dai papiri, dalle monete e dai resti archeologici, secondo cui subito dopo l’avvio del nuovo regime imperiale la maggior parte delle province dell’impero conobbe una prosperità e una floridezza che le portò in molti casi a superare il livello di benessere che fino ad allora aveva distinto la condizione privilegiata dell’Italia, che pure non era gravata dai tributi, decime o stipendia imposti ai provinciali. Indizio, questo, del fatto che l’osmosi in atto fra Italia e province dell’impero funzionò nei due sensi, con immissione verso la periferia di risorse finanziarie che alla fine si risolveva a favore delle province. E c’è anche un certo consenso fra gli studiosi dell’economia antica sul fatto che, eccettuati i casi di proteste che in taluni casi essa suscitò, l’imposta fondiaria richiesta ai provinciali non dovette risultare particolarmente
7 TAC., Ann. 1, 2, 2: neque prouinciae illum rerum statum abnuebant, suspecto senatus populique imperio ob certamina potentium et auaritiam magistratuum, inualido legum auxilio quae ui ambitu postremo pecunia turbabantur.
84 MARIANO MALAVOLTA gravosa, visto che la stima dell’aliquota di prodotto sottratta viene valutata alla stregua di una low tax, e in ogni caso entro un massimo del 10 per cento8. Una condizione delle province dell’impero, dunque, tutto sommato ben diversa dalle devastazioni operate nel continente africano, tanto per fare un esempio, da due secoli di colonizzazione dei più o meno etici stati moderni. Va anche riveduta, per quel che riguarda il preteso saccheggio millenario dell’Italia annonaria, che per tutta l’età imperiale, e ancora dopo la costituzione della diocesi Italiciana, alla quale Diocleziano aveva esteso il regime fiscale delle province, il rifornimento dell’Urbe non fu garantito dalle esazioni del vicarius Italiae, ma bensì da quelle del vicarius Urbis, che gravavano sulla sola Italia peninsulare.
Pronunciata questa difesa d’ufficio in risposta alle accuse contro “Roma ladruncola” (ad opera di alcuni, non pochi, governatori dell’ultima età repubblicana), ci resta di prendere in esame l’altra accusa, che sembrerebbe ben più grave, contro Roma per eccellenza ladrona, per aver sottomesso con la forza, l’una dopo l’altra, tutte le genti, chiudendole dentro un unico impero. Accusa grave, certo, se adottiamo il punto di vista sopra illustrato di Simone Weil, ma è anche un’accusa cui si può rispondere abbastanza sbrigativamente opponendo l’esito storico della fatale conquista, che fu la reductio ad unum del mondo antico, conseguita mediante la progressiva inclusione delle culture e delle etnie più disparate e distanti fra loro, senza distinzioni
8 Si vedano, da ultimo, F. CARLÀ – A. MARCONE, Economia e finanza a Roma, Bologna 2011, p. 225, dove si citano noti e documentatissimi lavori di E. LO CASCIO (del 2000) e K. HOPKINS (2002).
FRA ANTICHITÀ E STORIA 85 di religione o di razza e, in genere, nel segno della meritocrazia. La constitutio Antoniniana del 212, nota anche come editto di Caracalla (il cui diciottesimo centenario è stato magistralmente celebrato proprio in questa sala da Andrea Giardina il 23 febbraio scorso) con l’estensione della cittadinanza romana optimo iure a tutti i nati liberi nell’impero, realizzava nella concretezza dell’ordinamento giuridico un’antica e congenita aspirazione del genio romano all’uguaglianza dei diritti comuni (si pensi alla politica, favorevolissima all’inclusione, di imperatori come Claudio) che oggi non sembra realisticamente proponibile neppure come utopistico sogno. Di fronte ad un simile risultato di unità raggiunto dall’impero romano non può che rivelarsi anacronistica la proiezione verso un passato così lontano di una categoria quale quella dei cosiddetti imperialismi dell’età contemporanea.
Una sia pur breve rassegna delle testimonianze più significative a questo riguardo mostrerà – fra l’altro – come l’icona dei Romani latrones fu in qualche modo autoctona, generata dalla compiaciuta consapevolezza del ruolo “fatale” di conquistatori e dominatori delle genti, apertamente vantato, ad esempio, nel poema virgiliano9, del che si ha un immediato riscontro nella più vulgata tradizione manualistica confluita nel Breviario di Eutropio10. Dall’indice lessicale dell’opera risulta che la voce latro ricorre
9 Mi limito a ricordare le parole pronunciate da Giove a 1, 279: imperium sine fine dedi, o quelle notissime della profezia di Anchise a 6, 851: tu regere imperio populos Romane memento. 10 Pubblicato nel 367, durante il regno di Valente.
86 MARIANO MALAVOLTA due sole volte: per il ribelle spagnolo Viriato11, e per i più antichi cittadini dell’Urbe, allorché si osserva – proprio all’inizio di questo manuale di storia romana (usato nelle scuole medie, oggi diremmo) – che Numa, il successore di Romolo, “pur non avendo fatto alcuna conquista, fu non meno utile di Romolo, perché dotò di leggi e di costumi quei suoi sudditi che in precedenza, per la loro abitudine a fare la guerra, avevano fama di latrones e di semibarbari”12. Né si può dire che questa primigenia propensione dei Romani al latrocinium sia una elaborazione tarda della storiografia sulle origini, come si vede da una citazione autorevolissima che troviamo nella vita plutarchea di Romolo, ove si registra un’annotazione di Fabio Pittore (il primo e il più antico degli annalisti romani, autore di annali in lingua greca) secondo cui il ratto delle Sabine fu osato da Romolo nel quarto mese dopo la fondazione della città (dunque il 21 agosto del 753), proprio perché Romolo “per sua natura era bellicoso, e fu convinto da alcuni oracoli come fosse destino che Roma diventasse potentissima alimentandosi e crescendo con le guerre. In effetti – continua Plutarco citando Fabio – le ragazze rapite non furono molte, ma solo trenta, appunto perché lui (Romolo) aveva più bisogno di guerre che di
11 Capo della rivolta antiromana del 151 a.C., in EUTR. 4, 16, 2: pastor primum fuit, mox latronum dux, postremo tantos ad bellum populos concitauit, ut adsertor contra Romanos Hispaniae putaretur. 12 EUTR. 1, 3: postea Numa Pompilius rex creatus est, qui nullum bellum gessit, sed non minus ciuitati quam Romulus profuit. Nam et leges Romanis moresque constituit, qui consuetudine proeliorum latrones et semibarbari putabantur.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 87 matrimoni”13.
Con sistemi analoghi a questi usati contro i Sabini dunque Romolo si era mostrato campione dell’imperium predatorio, strappando il Trastevere e altri territori ai rivali Veienti (il significato originario di rivalis è proprio questo, di indicare il proprietario della terra al di là del Tevere), e questo carattere, rilevato da Fabio Pittore, era stato poi dissimulato da Livio e Dionigi. Tutto induce a ritenere, insomma, che questa ostentazione del latrocinium, questo vanto bullesco, destinato poi a rimanere fissato in un certo cliché popolaresco di ruberie spavaldamente perpetrate, fosse una specie di leggenda autoctona, proiettata nella costruzione della mitica figura del fondatore: un tòpos retorico che poi si prestò ad essere adattato alle circostanze della irresistibile crescita del dominio romano, fornendo agli storici romani materiale da utilizzare. Vedremo così che raptores Italicae libertatis lupi, come leggiamo in Velleio (che forse conserva una pagina sallustiana o liviana) sono i Romani nelle parole di Ponzio Telesino, capo sannita che arringa i suoi prima dello scontro con Silla a Porta Collina (presso il tempio di Venere Ericina): “ripetendo che era giunto per Roma l’ultimo giorno – riferisce Velleio – gridava che quella città doveva essere abbattuta e distrutta, aggiungendo che non sarebbero mai mancati i lupi pronti a strappare la libertà all’Italia se non si tagliava la selva nella quale essi trovavano rifugio”14. Qui i Romani sono 13 PLUT. Rom. 14, 1, confluito in Fr. Gr. Hist. 809 F 54 JACOBY = H.R.R. I2 7 e cfr. la nota a p. 306 dell’edizione della Vita Romuli curata da C. AMPOLO 14 VELL. 2, 27, 2. La battaglia avvenne il primo novembre dell’82, e l’odio di Ponzio fu scatenato dalla vista dei resti dell’accampamento di
88 MARIANO MALAVOLTA naturalmente accostati ai lupi, perché una lupa aveva allattato Romolo e Remo, e perché la lupa era simbolo della città (cui veniva contrapposto il toro, che infatti calpesta la lupa in un conio monetale dei ribelli). Si trattò di una battaglia durissima, protrattasi fino a notte inoltrata, vinta dai Romani per il sopraggiungere di Crasso, che rimediò alla disfatta, già profilantesi, dell’esercito sillano, e dunque è chiaro che Sallustio o Livio (fonti di Velleio) ne curassero in particolar modo la rielaborazione retorica.
I risultati migliori della rielaborazione di questo tema dei Romani latrones lo troviamo, ovviamente, nei più importanti rappresentanti della storiografia senatoria, Sallustio e Tacito, entrambi profondamente imbevuti del metodo tucidideo della ricerca dell’obbiettività, e che “appaiono a noi – osserva Santo Mazzarino15 - più obbiettivi nell’interpretazione del punto di vista degli avversari esterni”. Questa dev’essere la chiave di lettura della lettera di Mitridate ad Arsace, considerata già dagli antichi un piccolo capolavoro, come mostra il fatto che essa sia stata conservata come excerptum: il pretesto di questo pezzo di bravura dello storico è la richiesta (probabilmente fittizia, finta da Sallustio), fatta da Mitridate VI Eupàtor al re dei Parti Ársace XII (i Greci dicevano Arsàce), di un valido intervento che consentisse alle forze unite dei due regni di schiacciare i Romani, definiti latrones gentium (rapinatori del mondo): “Ignori forse che i
Annibale, allorché egli iniziò l’arringa alle sue truppe: circumuolans ordines exercitus sui… dictitansque adesse Romanis ultimum diem, uociferabatur eruendam delendamque urbem, adiicens numquam defuturos raptores Italicae libertatis lupos, nisi silva, in quam refugere solerent, esset excisa. 15 Il pensiero storico classico II, 1, Bari 1968, p. 469 sg.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 89 Romani, arrestati dall’Oceano nella loro avanzata verso Occidente, hanno qua volto le loro armi? Che essi, fin da principio nulla possiedono, casa, mogli, terre, impero, se non quello che hanno arraffato come frutto di rapina? Profughi senza patria, senza genitori, si organizzarono in stato per la rovina del mondo, e non c’è legge umana né divina che li trattenga dal depredare e dal fare a brani gli alleati, gli amici, vicini o lontani, deboli o potenti, e chi non hanno ridotto in schiavitù, soprattutto i regni, considerano loro nemico”16. Qui c’è la novità, o meglio l’aggiornamento del tòpos all’epoca successiva alle grandi conquiste, con l’Oceano che impedisce l’avanzata dei Romani verso Occidente e li spinge a invadere l’Oriente, ma il tòpos è riconoscibile dall’evidente allusione all’icona del predone Romolo e del ratto delle Sabine. Gli stessi artifici sono utilizzati da Tacito nella finzione del discorso fatto ai suoi soldati da Calgàco, il duce dei Britanni che resistono alla conquista romana in Caledonia, alle falde del mons Graupius, nell’84 d.C., durante il regno di Domiziano17. Lo schema retorico della composizione vi è ancora più evidente, perché l’operetta in 16 Epistula Mithridatis, in Hist. IV fr. 17: an ignoras Romanos, postquam ad Occidentem pergentibus finem Oceanus fecit, arma huc conuortisse? Neque quicquam a principio nisi raptum habere, domum coniuges agros imperium? Conuenas olimsine patria, parentibus, peste conditos orbis terrarum; quibus non humana ulla neque diuina obstant quin socios, amicos, procul, iuxta sitos, inopes potentisque trahant, exscindant omniaque non serua et maxume regna hostilia ducant? Da notare che Mitridate aveva avuto al suo seguito uno storico di fama, Metrodoro di Scepsi, il misoromano, che a sua volta insisteva sulle rapine compiute dai Romani in tutta la loro antica storia, per esempio sull’etrusca Volsinii (MAZZARINO, o.c. II 1, Bari 1968, p 208 sgg.). 17 Il lungo discorso di Calgaco occupa ben tre capitoli (30-32) dell’operetta tacitiana.
90 MARIANO MALAVOLTA cui esso è inserito (De uita et moribus Iulii Agricolae) è conservata integralmente, e sappiamo che si trattò di una laudatio pronunciata nel 97, al ritorno di Tacito da un governo provinciale che lo aveva tenuto lontano da Roma per diversi anni, e dunque assente nel 93, anno della morte del suocero. Al discorso di Calgaco rivolto ai barbari britanni, che è una controuersia, segue quello di Agricola ai soldati romani, che rappresenta la corrispondente suasoria, ma ben poco vi è di scolastico nel contenuto dei discorsi, specie di quello di Calgaco, che hanno affascinato – oltre a Simone Weil – folle di giovani, finendo anche sugli striscioni delle manifestazioni contro la guerra in Vietnam, specie là dove Calgàco sembra quasi dare per scontato, pur agitandolo come esito da scongiurare, il destino di schiavitù che attende quei pochi Britanni liberi sfuggiti fino a quel momento al giogo dell’oppressore romano e ora sospinti loro malgrado, egli dice, “agli estremi margini del mondo e della libertà” dai “rapinatori del mondo, che dopo aver tutto devastato, non avendo più terre da saccheggiare, scrutano il mare; avidi se il nemico è ricco, smaniosi di dominio se è povero, tali da non essere saziati dall’Oriente né dall’Occidente, gli unici che bramano con pari veemenza di possedere tutto, e ricchezze e miseria. Auferre, trucidare, rapere [ossia] rubare, massacrare, rapinare, questo essi con falso nome chiamano impero e dove hanno fatto il deserto lo chiamano pace”. Questa non è retorica, è intuizione poetica. Rivivendo mentalmente un atroce episodio di guerra e rivedendolo attraverso gli occhi di suo suocero, di cui sta pronunciando l’elogio, Tacito percepisce l’odio dell’orda barbarica che gli sta di fronte, misto al terrore per la
FRA ANTICHITÀ E STORIA 91 inevitabile strage che seguirà e, almeno per qualche momento, vede vacillare la fede sua e della sua razza di padroni del mondo nella ineluttabilità del processo di forzata civilizzazione imposto dall’impero: in linea, tutto sommato, con la contraddizione già presente nei più convinti teorizzatori (come Posidonio di Apamea) della legittimità del dominio dell’oligarchia senatoria romana, quasi fosse un’incarnazione del lovgo", e la profonda simpatia per la selvaggia energia delle genti barbare18. Ed è evidente, tutto questo, nel tono di fondo dell’appassionata arringa di Calgaco, che esorta sì i suoi barbari ad opporre l’ultima resistenza contro i Romani, ma è ben consapevole che quel suo manipolo di irriducibili, votati al sacrificio, altro non è se non una sparuta frazione “di questo grande ergastolo che è il mondo”, ormai ridotto a area di reclutamento dell’instrumentum uocale indispensabile al buon funzionamento della gigantesca macchina costruita dai dominatori.
Ecco: vi avevo promesso 27 secoli (e mezzo) di Roma ladrona, ma noi antichisti siamo responsabili soltanto dei primi 12, e dunque questa rapida rassegna può finire qui. La conclusione è evidente: “Roma ladrona” è l’invettiva dei vinti, inventata o meglio abbellita e cesellata dai vincitori, e al gatto romano non fa più effetto dello squittire del sorcio che sta per essere artigliato. Il risultato di 27 secoli e mezzo di latrocinio possiamo vederlo già guardandoci intorno in questa sala, e soprattutto nell’immensa quantità dei tesori che questa città ha custodito, investendo oculatamente i frutti delle sue rapine, che via via sono stati restituiti al mondo dai Cesari, dai Papi, e
18 ALMAGIÀ, s.v. Posidonio, in “Enc. It”.
92 MARIANO MALAVOLTA pure dai nostri governi ladri (non ladroni, che come abbiamo visto è un titolo nobiliare). Alla dea Roma, come a nume presente, non possiamo che augurare, a vantaggio non soltanto suo, ma del mondo intero, i prossimi ventisette secoli (almeno) di felice e impunita rapina.
Il concetto di tutela dell’ambiente nell’antica Roma tra religione,
filosofia e diritto1. “Quando Tin(ia) fece sua la terra dei Rasna stabilì e volle
che le terre fossero misurate e i campi segnati. Conoscendo l’ingordigia degli uomini e la terrena avidità, ordinò che tutto da termini fosse distinto. Tempo verrà che per l’ingordigia dell’ottavo secolo, l’ultimo del mondo, gli uomini con frode violeranno la proprietà, metteranno le mani sui termini e li rimuoveranno. Ma chi vi metterà le mani e li rimuoverà, per ingrandire il suo podere, per scemare l’altrui, per questo delitto sarà dagli dei condannato. Se lo commetteranno servi, essi cambieranno padrone in peggio. Se il padrone sarà complice, tosto sarà sradicata la sua casa e perirà tutta la sua discendenza. E i violatori da orrende malattie e piaghe saranno colpiti e paralizzati nelle loro membra. Allora anche la terra da bufere, e cicloni, e frequenti frane sarà scrollata. E i raccolti spesso saranno guasti e atterrati dalle piogge e dalla grandine, arsi dalla canicola e distrutti dalla ruggine. E molte le discordie civili. Sappi che questo accade quando tali delitti si commettono. Perciò non essere ingannatore e la tua lingua non sia biforcuta. Riponi questo insegnamento nel tuo cuore”.
1 Intervento in margine alla conferenza di Grazia Sommariva, svoltasi il 22 aprile 2009 nella sede della Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei (Aula “Giuseppe Dalla Vedova”) in Villa Celimontana. Pubblicato anche sul sito web IMAGOROMAE.
94 MARIANO MALAVOLTA
Così il celebre oracolo (qui riprodotto nella traduzione ormai patinata di Giovan Battista Pighi2) noto con il nome di “profezia di Vegoia”, che ancora in una raccolta di scritti di agrimensura compilata nel V secolo d.C., nel clima plumbeo della imminente dissoluzione del ben ordinato cosmo dell’Impero, veniva conservato nella memoria storica della casta dei gromatici e riproposto come spiegazione cosmologica dei tragici tempi che allora all’umanità toccava di vivere. La ninfa Vegoia nella sua profezia (che di fatto esprime – è bene ricordarlo – angosce insorte nell’età graccana) lamenta soprattutto che la scellerata rimozione dei termini avvenga non già e non soltanto per uno spregevole vizio di serui uillici, ma addirittura con la complicità di uomini liberi (domini) che hanno ormai dimenticato le norme dell’onesto vivere, accecati dai più sordidi personali interessi, e pronostica – fra le punizioni che affliggeranno gli empi trasgressori – il contrappasso della paralisi delle membra, geometrica sanzione dell’indebito e fraudolento “avanzare” dei cippi confinarii, individuando proprio in questo disordine dei catasti, con l’inqualificabile complicità delle autorità, la radice del male profondo che affliggeva quel secolo crudele.
Indubbiamente – e passiamo dalla profezia alla storia – fu proprio la casta dei gromatici ad essere colpita per prima dal nuovo caos, svilita dal dilagare di una fiera destrutturazione che di lì a poco avrebbe avviato il processo di trasformazione profonda seguito alla fine del mondo antico, destinato a segnare per lungo ordine d’anni gli interminabili secoli del Medio Evo: possiamo dunque ben comprendere l’interesse
2 G.B. PIGHI, La poesia religiosa romana, Bologna 1958, p. 23.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 95 che gli esperti di agrimensura autori della raccolta (più o meno contemporanei di Agostino) provarono per l’antica profezia: ma è altrettanto fuor di dubbio che del precetto finale contenuto nella profezia, di “riporre questo insegnamento nel cuore” (disciplinam pone in corde tuo), l’umanità abbia effettivamente continuato a far tesoro, proprio per l’intrinseco interesse alla conservazione di un valore considerato fondante in ogni patto sociale basato sul reciproco rispetto dei contraenti e, in primo luogo, sulla sacralità della proprietà privata, specie della proprietà fondiaria. Ecco così che gli echi dell’antico oracolo ispirato all’Etrusca disciplina, e la sacralità della proprietà privata, considerata dai giuristi classici estensione quasi corporea dei civium capita, riaffiorano, insieme con i germi della rinascita della civiltà e con un’aderenza a dir poco sorprendente agli antichi concetti pagani, nella cultura popolare e nell’iconografia degli edifici del culto cristiano, dove la fraudolenta rimozione dei cippi confinarii viene bollata come “peccato” ed additata alla pubblica esecrazione in alcune raffigurazioni del Giudizio Universale (quella che ho presente porta la data 1410) illustrate da scritte che bollano “chi caccia3 li termini” ossia chi sposta i cippi confinarii, macchiandosi di un reato che del resto viene già contemplato in norme statutarie più o meno coeve con
3 Nella lingua regionale il verbo “cacciare” (sinonimo di “estrarre”) indica tecnicamente l’atto della rimozione dalla sede originaria, come, ad esempio, nell’uso vernacolare dell’espressione “cacciare un dente”; la scritta può leggersi nella chiesa dei santi Pietro e Paolo di Castignano: ANTONIO SALVI, Iscrizioni medievali nel territorio ascolano, Ascoli 2010, p. 66, nr. 47.
96 MARIANO MALAVOLTA irrogazione di pena per “chi trahesse overo mutasse term(in)i et de chi guastasse li limite”4.
È il primo germogliare dei semi della rinascita dello stato di diritto, e dunque della fede nella trasparenza dei rapporti di proprietà, garantita da una superiore autorità, oltre che dall’esistenza di adeguate documentazioni d’archivio.
Non è certo il caso, a questo punto, di arzigogolare troppo sui buoni fondamenti teoretici del rispetto della sacralità dei termini o cippi confinari, né di richiamare la circostanza di come l’inosservanza di quella sacralità sia un aspetto non di poco conto dell’attuale disastro globale, prodotto dalla dilagante inosservanza della norma generale pacta sunt seruanda, che gli studiosi di filosofia del diritto da tempo denunciano come sintomo di un’entropia dell’autodistruzione della civiltà. Mi limito a constatare quanta parte della nostra “memoria culturale” sia rimasta collegata all’ambiente e contenuta nel persistere di quelle antichissime linee tracciate addirittura nel momento del primigenio imporsi della vita civile, consentendoci ancor oggi di leggere nel tessuto del nostro territorio la sua millenaria storia e di riconoscere, tanto per fare qualche esempio, l’originario impianto urbanistico ippodameo nel nucleo centrale dell’abitato di Napoli, o il disegno dei gromatici nelle tracce delle centuriazioni romane lungo la via Emilia o nei reticoli degl’isolati dei centri storici di tante città dell’Italia centrale e settentrionale. Lo schema urbanistico della maggior parte dei nostri centri urbani ha spesso preso forma aderendo con tenace pervicacia ad antichissime
4 Statuti di Ascoli Piceno. A cura di G. BRESCHI e U. VIGNUZZI. I, Ascoli Piceno 1999, p. 329.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 97 infrastrutture “originarie” che in molti contesti, anche se non sempre, hanno quasi naturalmente usufruito della buona sorte d’essere risparmiate dalla peggiore libidine speculativa, conservando intatta – anche nella topografia – quella identità primigenia che è il vero plusvalore, accumulato in quasi tre millenni di storia e di cultura, di tanta parte del nostro paesaggio.
Ho ascoltato qui, insieme con la maggior parte di voi – poco meno di un mese fa5 – la prolusione di Salvatore Settis (Il paesaggio tra cultura e territorio) e ho scoperto su quale tenuissimo contesto normativo (prodotto o, per meglio dire, appena germogliato nei decenni successivi all’Unità e soprattutto nel periodo fra le due guerre del ventesimo secolo) si sia innestata la vigente legislazione di tutela dell’ambiente, che per di più si riduce ad ottimistiche dichiarazioni d’intenti, quotidianamente smentiti dagli scempi dei quali tutti noi siamo testimoni più o meno sofferenti. Se tanto possiamo dire del nostro presente, sul quale siamo fin troppo documentati, è facile immaginare quali potranno essere i risultati di una ricerca indirizzata alla definizione del concetto di tutela “operante” nel mondo antico in generale e nel mondo romano in particolare, ossia in quell’ambiente per tanti aspetti ignoto, oltre che vastissimo, dell’ecumene antica, e dentro una documentazione che, all’opposto, si caratterizza proprio per la sua frammentarietà casuale e le sue sterminate lacune. Il rischio più probabile, giusto per evocarne uno solo, è quello di sovrastimare, a tutto vantaggio dei nostri antichi progenitori, la consistenza effettiva dei più che labili indizi
5 Il 27 marzo 2009, in questa stessa sala.
98 MARIANO MALAVOLTA dell’esistenza stessa di un simile concetto di tutela.
Eppure questo doveroso appello al metodo non esclude – la mia citazione dell’antica profezia lo dimostra – che si possa pur sempre risalire, proprio sulla scorta delle persistenze e delle sopravvivenze, e in una prospettiva di lunga durata dei millenni, all’individuazione di radici della moderna coscienza ambientalistica, ritrovandone gli archetipi più lontani nel tempo e dunque accettando la sfida che il tema di questo dibattito ha audacemente lanciato.
Non per caso, nella storiografia recente, si è tanto parlato dell’antica profezia: in essa i limiti “geografici” del territorio, come osserva Giusto Traina6 (io direi quasi “catastali”), “coincidono con quelli dell’ordine politico, e dunque con l’immagine cosmologica legata all’ideologia egemone”, e come tali essi vengono riproposti invano, in un disperato estremo tentativo di recupero di valori fondanti, in un momento di crisi epocale del mondo tardo antico, per tornare d’attualità in un secolo che, come il nostro, vede a sua volta seriamente minacciata la sua preziosa “civiltà occidentale” da un processo vorticoso di globalizzazione che sembra caratterizzarsi per tratti vieppiù catastrofici oltre che per esiti imprevedibili. D’altra parte, se nemmeno l’inarrestabile flusso migratorio che quindici secoli fa travolse la pars Occidentis riuscì – come si è notato – a cancellare dalla memoria culturale dell’Occidente quell’imperativo categorico fondato sul vincolo sacrale originario del rispetto dei confini catastali, è altrettanto vero che quel principio ordinatore era considerato in crisi già parecchi secoli prima, in pieno saeculum Augustum, stravolto
6 O.c. in BIBL., p. 79.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 99 dai tumultuosi processi di crescita e di espansione della città antica: già Livio lamentava la violazione sistematica dello spazio sacro del pomerio dell’Urbe e la costruzione di edifici abusivi addossati alla cinta serviana (1, 44, 4) richiamando il concetto (etrusco) originario del divieto di costruire al di là di quella linea che divideva il sacro dal profano7. Già ai tempi di Livio, dunque, si considerava ormai perduta – con funesto presagio – quell’antica sapienza che il poeta Orazio considerava base fondante dell’edificio della civiltà, di cui delineava puntualmente i tratti: fuit haec sapientia quondam / publica priuatis secernere, sacra profanis, / concubitu prohibère vago, dare iura maritis / oppida moliri, leges incidere ligno (Ars 396-399). Chi invadeva l’area sacra e pubblica del pomerio con costruzione abusiva poteva dunque ben essere considerato sovvertitore dell’ordine cosmico di quei confini fra sacro e profano, pubblico e privato che erano stati devastati dal tempestoso saeculum male inaugurato dall’età graccana, e che anche dopo l’avvento del saeculum Augustum, nonostante la propaganda di regime, apparivano ai prudentes non meno costantemente minacciati da un’empietà ormai endemica e tutto sommato tollerata, che traspare dalle parole di Tacito, quando lamenta lo stato della rete viaria italica mal ridotta fraude mancipum et incuria magistratuum8 (ossia per le frodi delle ditte appaltatrici e l’incuria delle autorità): una frase che stigmatizza quella stessa più o meno
7 OGILVIE, o.c. in BIBL., p. 180: dividing the hallowed from the profane. 8 Ann. 3, 31, 5: Idem Corbulo, plurima per Italiam itinera fraude mancipum et incuria magistratuum interrupta et imperuia clamitando, exsecutionem eius negotii libens suscepit; quoid haud perinde publice usui habitum quam exitiosum multis, quorum in pecuniam atque famam damnationibus et hasta saeuiebat.
100 MARIANO MALAVOLTA concertata complicità fra serui e domini aborrita dalla ninfa Vegoia, e che potremmo anche leggere come un’istantanea efficacissima della attuale “deriva” italiana, posto che non la si riferisca alle sole strade.
L’ordine originario, sancito dall’avvento della ciuitas, era stato canonizzato dal collegio dei pontefici, depositari del fas e delle formule rituali che avevano regolato i criteri di quelle separazioni, l’individuazione degli spazi sacri e dei confini da rispettare e, inoltre, le situazioni e le cerimonie che, di volta in volta, consigliavano o consentivano il superamento di quei confini. Il pomerio è senza dubbio il più evidente e il più funzionale di queste linee di confine, ma ad esso andavano aggiunti le aree templari, la curia, il comizio, i luoghi consacrati (inaugurati) in funzione delle sue necessità, dalla civitas. In tutti questi casi, a ben vedere, la questione della tutela si poneva prima di tutto come tutela dei confini dell’area sottoposta al vincolo sacrale, e dunque tutela della “proprietà” di questo o quel Nume. Interessa, a questo riguardo, il parallelo che Ettore De Ruggiero magistralmente delineava fra consecratio e mancipatio, entrambi percepiti, nella loro essenza, come riti solenni di trasferimento della proprietà: la mancipatio regolava la vendita solenne per aes et libram, fra privati, di una res mancipi (tale era il dominium ex iure Quiritium, ossia la proprietà terriera in Italico solo), mentre la consecratio permetteva un analogo passaggio nel quale il bene veniva stabilmente alienato alla divinità, secondo un rito che, anch’esso, era ammissibile soltanto in Italico solo.
Il vincolo sacrale – dislocato o fondato dai pontefici (come nel caso del pomerio, della curia, del comizio, delle
FRA ANTICHITÀ E STORIA 101 aree templari) o da essi semplicemente riconosciuto come tale (pensiamo alle cime dei monti, sedi per così dire “naturali” di sacrifici dovuti, come il Latiar o il Palatuar) – poteva riguardare un’infinità di luoghi: “nella concezione religiosa romana si riteneva infatti che ogni luogo, di ogni tipo, ospitasse la propria divinità immanente, il proprio genius loci (locuzione che non per caso è tornata attuale in architettura): Servio ci rammenta che nullus enim locus sine genio (ad Aen. 5, 85), e aggiunge poi che per lo più esso si manifesta sotto la specie di un serpente (per anguem plerumque ostenditur). Il genius è vera e propria divinità presente nel luogo che protegge, custodisce, santifica, e dove esercita un’azione speciale ed attiva su coloro che vi giungono o vi dimorano e lo sentono presente. Il genius loci è soprattutto là dove il luogo appare notevole o per bellezza di panorama o per ubertà, per ricordi mitologici, storici, o è difficile per il transito, ai confini di un paese esposto ai pericoli di vicini inospitali, oppure ha assunto una speciale importanza, effimera o duratura, per chi vi ha soggiornato più o meno a lungo. Allora l’essenza divina, la divinità che il Romano nel suo panteismo sentiva ovunque presente, si impersonava nel genius loci, che nel luogo aveva culto. Ovunque fosse un credente, là primo spirito protettore ed amico a lui più vicino era il genius loci che la sua fede evocava ad animare e a santificare il luogo stesso”9.
Un consistente insieme di documenti di indubbio interesse ai fini dell’individuazione del concetto antico di tutela è quello relativo ai boschi sacri, i luci, per i quali una amplissima documentazione, arricchita da una puntuale 9 CESANO, o.c. in BIBL., p. 462.
102 MARIANO MALAVOLTA esegesi, è stata fornita da Anna Pasqualini in una voce del Dizionario epigrafico di Antichità romane, con speciale riguardo ai contenuti delle leggi sacre che regolavano il divieto di scaricarvi rifiuti, seppellirvi cadaveri, celebrarvi cerimonie funebri, o di utilizzare il ricavato (dal taglio del legname o da altro: il lucar) che invece doveva essere impiegato soltanto nel circuito dell’economia che potremmo definire “santuariale”, ad esempio come contributo alle spese per le cerimonie cultuali, fra le quali c’era anche il più o meno modesto compenso per gli attori che si esibivano nella celebrazione di ludi scaenici. Una conferma indiretta dell’assunto iniziale di questo mio contributo, che cioè la radice del concetto di tutela sia da ricercare in un originario imperativo categorico di protezione dei confini, del più o meno immaginario “solco” tracciato secondo il rituale dell’Etrusca disciplina, viene poprio da una suggestione evidenziata dalla rassegna dei boschi sacri, che riferisce sull’ipotesi del Palmer, secondo cui il vetustissimo cippo del foro conserverebbe il testo di una lex luci, analoga a quelle documentate per età più recenti a Lucera e a Spoleto, spiegabile con il carattere sacro del comitium: la primitiva area di adunata dei cittadini, presso la curia Hostilia, sarebbe stata in tempi remoti coperta da un bosco sacro, e questa – nota la Pasqualini – è circostanza di notevole interesse se pensiamo agli altri luoghi in cui tali boschi assunsero carattere pubblico, ossia all’analogia tra il bosco del foro romano, il lucus Dianius di Aricia e il lucus Ferentinus presso il lago di Albano, visto che questi due ultimi furono centri federali della lega latina. Spazi, a ben vedere, che finiscono con l’essere destinati ad una funzione pubblica voluta dalla
FRA ANTICHITÀ E STORIA 103 ciuitas, mentre la tutela originariamente imposta dal vincolo sacrale si trasforma in tutela dei confini dello spazio di rappresentanza, ossia affermazione della proprietà collettiva di un’area concretamente occupata e posseduta dall’insieme dei singoli ciues, ossia dal populus, che rappresenta in quei casi la parte attiva della ciuitas, non soltanto quando va in guerra sotto il comando del magister populi, ma anche quando, come comitium curiato o calato, conferisce l’imperium al rex o ai magistrati, vota leggi, pronuncia verdetti emananti dalla sua sovranità, ratifica testamenti e adozioni. Il regime di condominio che rende ogni singolo cittadino un po’ proprietario (pro quota) dello spazio consacrato autorizza il singolo a esigere la piena disponibilità, per il transito o la sosta, di ogni spazio pubblico, piazza o strada che sia, sorvegliando che esso non sia abusivamente occupato, così come autorizza la moderna sensibilità degli appartenenti ad uno stato democratico e dunque proprietari, pro quota, del bene ambiente. Segnalo anche, a questo riguardo, un più recente contributo di Giuseppe Ragone, dedicato espressamente all’economia e alla tutela del bosco sacro nell’antichità, che ha riconosciuto l’importanza storica della continuità di alcuni “aggregati vegetali sottoposti a tutela” (così li definisce l’autore) quali il roseto della Porziuncola assisana, il bosco del Clitunno, l’orto degli ulivi al Getsemani, che incarnano uno sviluppo del concetto di tutela in qualche modo successivo rispetto a quello appena descritto.
Fra i numerosi altri contesti di particolare attinenza al
nostro tema, non può mancare la grande attenzione del
104 MARIANO MALAVOLTA mondo romano nei confronti di quello che oggi si chiamerebbe patrimonio idrogeologico, comprendendovi sia la particolare venerazione di fonti e sorgenti sedi di culti (ben esplorata nel volume degli atti di un convegno recente, curato da L. Gasperini), sia lo sterminato lavoro di sistemazione dei terreni messi per la prima volta a coltura nel periodo a ridosso dell’inarrestabile dilagare dell’ager Romanus nell’Italia centrale – dopo la battaglia di Sentinum e la costituzione della tribù Velina nel 241, con la sistematica “occupazione” delle enormi porzioni di ager publicus guadagnate dalla conquista. Un lavoro per certi aspetti tutt’altro che rispettoso dell’ambiente, che comportò la costruzione di strade e soprattutto, un fiero disboscamento eseguito con il massiccio intervento della manodopera schiavile, ma che fu generalmente accompagnato dalla messa in opera di capillari opere di drenaggio dei terreni agricoli, nonché dalla costruzione di infrastrutture utili alla captazione e alla distribuzione delle acque e alla formazione di riserve idriche destinate a vita più che millenaria, e che molto potrebbero ancora insegnarci qualcosa in materia di prevenzione dei dissesti10.
Se ora passiamo al tema dei soggetti preposti alla tutela,
ossia ai magistrati e ai sacerdoti che furono parte attiva della costituzione dell’antico stato romano, e dunque i motori di ogni iniziativa di legislazione e attività di controllo, anche 10 Un esempio di opera di drenaggio realizzata mediante lo scavo di profondi incili è documentata dai mattoni del formato cosiddetto “lidio” rinvenuti in uno scavo nei pressi di Cossignano (AP): M. MALAVOLTA, Lydium laterum genus (nota a Vitruv. II 3, 1), in «Archeologia classica» 1977, a. 29, fasc. 1, pp. 184-187, tavv. XLVIII-XLIX.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 105 una semplice rassegna dei numerosissimi contesti in cui istituzionalmente si configuravano azioni di tutela comporterebbe un discorso assai più complesso, che in questa sede dobbiamo semplificare, limitandoci per il momento a constatare che se da un lato la tutela della memoria culturale delle distinzioni fra sacro e profano, pubblico e privato, spettava in primo luogo ai pontefici, poi agli altri collegi sacerdotali, dall’altro la concreta tutela dell’integrità dei confini stabiliti del sacro e del pubblico rientrava nel complesso della cura urbis, affidata ab immemorabili agli edili, nati come magistrati plebei (coadiutori dei tribuni) alle cui dipendenze erano i quattuoruiri viarum curandarum (uno per ciascuna delle quattro regioni serviane dell’Urbe), ai quali in seguito si affiancarono i duouiri uiis extra propiusue Romam passus mille purgandis: un organigramma che denota già una divisione di incarichi per le strade situate o dentro la città o nel suburbio, ossia nelle sue immediate vicinanze. L’esistenza di una magistratura apposita (creata a quel che pare da Cesare) per la viabilità del suburbio sembra evidenziare esigenze insorte in età piuttosto tarda, con il dilagare della città e del suburbio nell’ultimo secolo dell’età repubblicana, così come la scomparsa dei duoviri e la ristrutturazione del vigintisexvirato operata da Augusto, che affidò (per l’intero loro percorso) la cura uiarum a personaggi di rango pretorio o consolare mostrano il dilagare delle competenze di magistrati urbani cum imperio (oltre che del pretore urbano) per tutto il territorio dell’Italia: un fenomeno che in qualche misura possiamo dire prefigurato dalle particolari competenze attestate, ad esempio, nei decreti del senato
106 MARIANO MALAVOLTA sulle “province” dei due consoli del 59 (Cesare e Bibulo) inizialmente incaricati di una speciale curatela su silvae callesque (ossia, a quel che pare, delle foreste con picariae [industrie di produzione della pece da resine vegetali]11 del Bruttium e dei tratturi apulo-lucani). Nella stessa direzione importantissime funzioni di controllo dell’assetto urbano di Roma vennero in età imperiale stabilmente affidate ad appositi magistrati (pensiamo, solo per fare un esempio, ai curatores alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis istituiti da Tiberio, se non già dallo stesso Augusto).
Rivolgendo quindi la nostra attenzione alla Città e alle città in generale, è importante, intanto, notare come una originaria distinzione fra città e campagna, urbs e rus, ambiente urbano e ambiente rurale (sancito nella mitica ripartizione serviana del territorio fra tribù urbane e tribù rustiche) si riveli forse più persistente negli ordinamenti municipali, che sempre distinguevano nettamente coloro che avevano il domicilio entro le mura della città e coloro che lo avevano fuori, nel senso che i primi erano considerati come veri municipes o coloni e i secondi come incolae; gli uni ammessi al decurionato e alle magistrature, gli altri esclusi. Questa differenza, che appare già nel cap. 91 della lex Ursonensis, è confermata da un luogo di Ulpiano, dove peraltro si lamenta l’espediente escogitato dai maggiorenti delle comunità, di trasferirsi nella loro campagna, con lo
11 F. GRELLE – G. VOLPE, Aspetti della geografia amministrativa ed economica della Calabria in età tardoantica, in “Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di antichità romane, Bari 1996, p 118 sg. con note 28 e 29.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 107 scopo di sottrarsi ai più onerosi munera curiali12, mentre un testo di età traianea attesta – per un momento in cui la negazione delle cariche pubbliche agli incolae era ancora sentita come un’esclusione – una precisa concessione, fatta dall’imperatore nel 105 o qualche tempo prima, ut incolae, quibus fere censemur, muneri[bus nobiscum fungantur]13. Da qui l’uso non infrequente, nelle epigrafi, di chiamare i cittadini con pieni diritti municipes intramurani (CIL XI 3797 da Veii), e municipes extramurani i semplici incolae (ibid. 3798). Ancor più netta la distinzione che troviamo in un’iscrizione di Sicca (in Numidia, CIL VIII 1641) nella quale si prescrive che siano ammessi ad una elargizione i municipes item incolae, dumtaxat incolae, qui intra continentia coloniae nostrae aedificia murabantur. I domiciliati entro le mura della città vengono più comunemente chiamati urbani (V 7696; IX 2568, 2855, 6257; X 5059) o, talvolta, oppidani (IX 2473).
La nozione di città intesa come adiacenza della cinta muraria ricorre in numerosi contesti normativi documentati dalle leggi epigrafiche, a cominciare dalla tabula Heracleensis, la c.d. lex Iulia municipalis (CIL I2 593, del 45 a.C.), la quale, oltre a prescrivere ai frontisti gli obblighi di pulizia della pubblica via (ivi compresa l’eliminazione di eventuali
12 Dig. 50, 5, 1, 2: qui in fraudem ordinis in honoribus gerendis, cum inter eos ad primos honores creari possint, qui in ciuitate munerabantur [che il MOMMSEN legge: cum inter eos ad primos honores qui creari possent in ciuitate numerabantur; ma vedi anche il murabantur dell’iscrizione di Sicca], evitandorum maiorum onerum gratia ad colonos praediorum se transtulerunt, ut minoribus subiciantur, hanc excusationem sibi non parauerunt. 13 CIL V 875 = ILS 1374.
108 MARIANO MALAVOLTA ristagni d’acqua che ne impedissero l’uso), affida la sorveglianza su questa norma ai suddetti duoviri, definendo lo spazio urbano con la locuzione quae uiae in urbem Rom(am) propiusue u(rbem) R(omam) p(assus) m(ille) ubei continente habitabitur (alla l. 20, ripetuta quasi alla lettera alla l. 56: quae uiae in urbe Roma sunt erunt intra ea loca, ubi continenti habitabitur (con il divieto di transito dei plostra nelle ore diurne). Una definizione analoga troviamo nella lex Quinctia de aquaeductibus del 9 a.C., dove leggiamo: in urbe Roma et qua aedificia urbi continentia sunt erunt o ancora: circa riuos qui sub terra essent et specus intra ubem et urbi continentia aedificia con evidente allusione a parti della città che si estendevano oltre il limite pomeriale dell’urbs propriamente detta, secondo uno schema che giunge a contrapporre la nozione di urbs a quella di Roma: la prima in quanto è rinchiusa dal pomerio, la seconda in quanto fuori della prima ne abbraccia i sobborghi, come spiegano Paolo, nel commento ad edictum in Dig. 50, 16, 2: ‘urbis’ appellatio muris, ‘Roma’ autem continentibus aedificiis finitur, quod latius patet, e Marcello che cita Alfeno in Dig. 50, 16, 87: ut Alfenus ait ‘urbs’ est Roma, quae muro cingeretur, Roma est etiam qua continentia aedificia essent: nam Romam non muro tenus existimari ex consuetudine cotidiana posse intellegi, cum diceremus Romam nos ire, etiamsi extra urbem habitaremus14).
Di notevole interesse le formule utilizzate negli statuti municipali per indicare la delimitazione degli abitati di municipi o colonie, considerate – secondo la definizione di Aulo Gellio – effigies paruae simulacraque quaedam della
14 Cfr. le testimonianze raccolte dal DE RUGGIERO in “Diz. epigr.” II p. 1185 s.v. continentia (urbis).
FRA ANTICHITÀ E STORIA 109 grande Roma. Nella rubrica 62 dello statuto di Malaca (databile agli anni 82-84) possiamo leggere la disposizione relativa al divieto di demolizione di edifici che sorgevano dentro l’abitato: ne quis in oppido municipii Malacitani quaeque ei oppido continentia aedificia erunt, aedificium detegito destruito demoliundumue curato, che la Lamberti15 così traduce: “che nessuno, entro le mura del municipio Flavio Malacitano, e in ordine agli edifici adiacenti le mura, scoperchi, abbatta o demolisca un edificio”. Ed è appena il caso di notare che quasi le stesse parole (ne quis in oppido… detegito neue demolito) possiamo leggere nella lex municipii Tarentini (anteriore al 62 a.C.), nella lex Ursonensis (del 44 a.C., cap. 62), mentre lo stesso divieto di demolizione a fini di lucro è ribadito nel testo epigrafico dei senatusconsulta de aedificiis non diruendis (CIL X 1401 = ILS 6043 = RICCOBONO, p. 288). Nel s.c. Hosidianum, del 44 d.C., si legge della prouidentia optimi principis (ossia di Claudio) interessata tectis quoque urbis nostrae et totius Italiae aeternitati. Nel Volusianum, datato all’anno 56, nello stile precipuo del quinquennium Neronis, si rinnovano le sanzioni dell’Hosidianum nel nome della felicitas di un saeculum che non può ulteriormente tollerare che, anche se solo in una sua parte, l’Italia sia deturpata (ruinis aedificiorum ullam partem deformari Italiae), assecondando cioè la trascuratezza che, almeno fino al momento di quel provvidenziale provvedimento, avrebbe potuto far dire a qualcuno che lo stato romano “era sotto le macerie” (ita ut diceretur senectute
15 A p. 319, osservando in nota: “sarei più propensa a considerare oppidum come riferito alla cinta muraria che delimita il perimetro urbano, piuttosto che nel senso di città”.
110 MARIANO MALAVOLTA ac tum[ulo iam rem Romanam perire]). Questa deformitas denunciata nel testo del Volusiano è rievocata nella sentenza di Ulpiano riportata nel Digesto fra quelle che illustrano le mansioni del praeses prouinciae, il quale è tenuto, fra l’altro, a costringere i rispettivi domini a ricostruire gli edifici demoliti, irrogando, se necessario, adeguate sanzioni (Dig. 1, 18, 7: et aduersus detractantem competenti remedio deformitati auxilium ferat). Non meno interessante, in queste prescrizioni, la circostanza, enfatizzata specie nel testo dell’età neroniana, della salvaguardia dell’integrità dell’assetto urbano visto nel suo insieme, postulata dalla condanna della deformitas, che – pur nella ovvia distanza dei contesti – non può non farci pensare alla c.d. “carta di Gubbio” con la quale veniva affermata nel 1960, contro eventuali disinvolti progetti di demolizione di interi contesti urbani (come quelli avvenuti a Roma durante il Ventennio), l’esigenza di tutela e protezione dei centri storici nel loro complesso.
Un’ultima riflessione, dentro questa ricerca di archetipi delle odierne sensibilità ambientaliste, riguarda un tratto modernissimo di autori antichi ben noti al pubblico colto: pensiamo al Seneca delle Consolazioni e delle Lettere a Lucilio, che da questo punto di vista costituisce una vera e propria miniera, ma limitiamoci in questa occasione a Plinio, l’autore della Naturalis historia (opera enciclopedica diffusissima nel mondo romano, come mostra la sua ricchissima anche se complessa tradizione manoscritta). Plinio è l’autore che, a proposito del papiro, e dunque della carta, notando l’opportunità di spendere qualche parola su questo tipo di manufatto, che egli considera
FRA ANTICHITÀ E STORIA 111 importantissimo, cum chartae usu maxime – egli osserva – humanitas uitae constet, certe memoria (13, 21): egli invita così il lettore a riflettere su come ai suoi tempi (dentro quel saeculum che includeva il felicissimo quinquennium Neronis) l’humanitas uitae, ossia la civiltà, il progresso, la qualità della vita, fossero fatte “essenzialmente (maxime) di carta” e pensando, come poteva pensare un nostro contemporaneo fino a qualche anno fa, a libri, giornali, documenti d’archivio, lettere, fogli di appunti (prima dell’avvento delle memorie elettroniche: oggi lo stesso Plinio ne avrebbe dovuto trattare parlando del silicone). L’attualità dei toni della sua denuncia della natura violata è evidente, ad esempio, là dove si rivolge con tono accorato ad un’umanità che, non paga dei veleni presenti in natura – oggetto della sua trattazione – ne produce artificialmente e con essi “avvelena i fiumi e gli elementi naturali, e la stessa aria, che ci è indispensabile per vivere”16. L’oltraggio alla terra – stavolta meccanico più che chimico – è descritto a tinte fosche nella rappresentazione delle cave minerarie in Spagna, dove alla fine dei lavori di perforazione mirata “la montagna si squarciava con un fragore che l’immaginazione umana non può concepire e, insieme, con un soffio d’aria di incredibile veemenza: i minatori osservarono, vittoriosi, il crollo della natura”17. Questo oltraggio, egli nota ancora altrove, fu risparmiato all’Italia appena lo si poté vietare: “quanto a miniere d’oro, d’argento, di rame e di ferro, finché fu permesso di tenerle,
16 N.h. 18, 3: nos et flumina inficimus et rerum naturae elementa, ipsumque quo uiuitur in perniciem uertimus. 17 Ibid. 33, 72 nella traduzione del ROSATI.
112 MARIANO MALAVOLTA l’Italia non fu seconda a nessun’altra regione18 e ora, gravida com’è nelle sue viscere di queste ricchezze, in luogo di esse profonde diversi umori, nonché cereali e frutti pieni di sapore”. Questo tema della felicitas Italiae (che in età augustea sarà sancito con l’enucleazione dell’istituto giuridico del ius Italicum, da concedere eccezionalmente a territori posti oltre i confini d’Italia) e del privilegio assicurato da una norma che ne impediva lo strazio, è ripetuto nel terzo libro (haec est Italia dis sacra… metallorum omnium fertilitate nullis cedit terris) con in aggiunta l’informazione del divieto votato dal senato a tutela dell’integrità del suo volto (sed interdictum id uetere consulto patrum Italiae parci iubentium)19, e ancora nel trentatreesimo libro, dove il discorso è più articolato: vi leggiamo che “l’Asturia, la Gallaecia e la Lusitania assicurano in questo modo – ossia con le miniere e le cave a cielo aperto – ogni anno ventimila libbre d’oro” e ancora, come c’era da aspettarsi, che “in nessun’altra parte del mondo [è di là da venire, notiamo noi, il sistematico sfruttameno delle miniere daciche] una tale fertilità si è conservata per tanti secoli”. Subito dopo, quasi a rassicurare di non avere con questa notizia tolto un primato alla felicissima Italia, egli aggiunge: “Abbiamo già detto che l’Italia è risparmiata dallo sfruttamento in virtù di un antico decreto di interdizione del senato (Italiae parci uetere interdicto patrum diximus [è un rinvio interno al già citato 3, 183]), altrimenti nessun’altra terra sarebbe stata più feconda di questa, anche nei metalli.
18 37, 202: metallis auri, argenti, aeris, ferri quamdiu licuit exercere, nullis cessit terris. 19 3, 138.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 113 Si conserva il testo della legge censoria sulla miniera d’oro di Victimulae nel territorio di Vercelli, con cui si proibiva agli appaltatori pubblici di impiegare per lo sfruttamento più di cinquemila uomini”20. Nel commento dello Zehnhacker21 si legge che lo sfruttamento delle miniere della Cisalpina fu limitato non per il nobile motivo addotto da Plinio (parci Italiae), ma semplicemente perché, come si evincerebbe da un confronto con un luogo di Strabone, le miniere della Transalpina e della Spagna erano più vantaggiose22: “ecco una singolare smentita – conclude lo Zehnacker, ingaggiando con Plinio una gara di sciovinismo dall’esito piuttosto scontato – del mito della fertilità dell’Italia”. Ricordo inoltre, a questo riguardo, un mio breve scambio di idee con Jean Andreau che mi fece notare come, secondo qualcuno, il vero scopo del decreto del senato sarebbe stato una ovvia volontà, da parte dell’oligarchia senatoria, di ostacolare gli affari dei publicani. Io trovo invece che quel parci Italiae conservi la sua valenza indiziaria della presenza – nel testo a noi sconosciuto di quel decreto – dell’enunciazione di un principio di rispetto per l’ambiente, come diremmo noi, o, come avrebbe detto Plinio, per il sacro suolo italico: il fatto che poi quel principio sia stato pretestuosamente usato, come sempre, per inconfessabili scopi politici o affaristici, nulla toglie al suo “ideologico”
20 33, 78: extat lex censoria Victimularum aurifodinae in Vercellensi agro, qua cauebatur, ne plus quinque milia hominum in opere publicani haberent, dove la lex censoria è probabilmente il capitolato d’appalto concesso ad una societas publicanorum, documento non diverso – nella sostanza – dalla lex metalli Vipascensis, che invece è conservata (I.L.S. 6891 ). 21 Pubblicato nella collezione delle “Belles Lettres”, Paris 1989, p. 178. 22 STRAB., Geogr. 5, 1, 12 p. 218 C.
114 MARIANO MALAVOLTA valore.
Non per caso ho indugiato nell’esegesi di questi passi pliniani, per i quali un puntuale riscontro è fornito da dati scientifici acquisiti e ampiamente divulgati in tempi relativamente recenti che dimostrano, a dispetto di ogni certezza “primitivista” sul potenziale industriale del mondo antico, che quelle di Plinio non erano esagerazioni di maniera. Carotaggi eseguiti nel ghiaccio della calotta polare artica e in Groenlandia da un’équipe dell’Università di Grénoble diretta da Claude Boutron hanno potuto accertare, con metodo in certo modo analogo a quello della dendrocronologia, l’entità dell’inquinamento causato nelle varie epoche dalle attività estrattive e siderurgiche. Le emissioni inquinanti, dopo aver raggiunto la troposfera, sono state infatti regolarmente depositate dalle nevi nel corso dei millenni e annualmente “sigillate” dalla sovrapposizione di successivi strati di ghiaccio. L’analisi dei prelievi ha rivelato, per il periodo compreso fra I secolo a.C. e III d.C., che in quei secoli furono estratti dai 6 agli 8 milioni di tonnellate di piombo, con record annuali di 80.000 tonnellate. Il procedimento più inquinante in assoluto sembra sia stato quello della coppellazione della galena, ossia del riscaldamento in forno di minerale grezzo (ricco di solfuro di piombo), mediante un getto di aria calda che ossidava il piombo, facilitandone la separazione dall’argento. Il diagramma ricavato dai carotaggi ha mostrato, in corrispondenza dei primi due secoli dell’era volgare, un picco notevole, seguito da una curva progressivamente discendente in corrispondenza dell’età di mezzo, e che poi viene di nuovo eguagliato nel pieno degli anni della
FRA ANTICHITÀ E STORIA 115 rivoluzione industriale. Il pulviscolo associato con gli agenti inquinanti mostra inoltre con evidenza che la stragrande maggioranza delle scorie proveniva dalle miniere spagnole, mentre per i secoli successivi i fumi inquinanti risultano di provenienza cinese (epoca, questa, della costruzione della Grande Muraglia). Impressionante, infine, il dato che l’antico inquinamento “romano” da piombo sarebbe pari al 15% di quello attualmente prodotto dalla carburazione, ossia dai gas di scarico delle nostre automobili23.
Non stiamo certo svelando – ad un così scelto ed avvertito uditorio – il valore esemplare della fine del mondo antico, da leggere ed interpretare come sentenza di oracolo e da utilizzare nella costruzione dell’avvenire: ci limitiamo ancora una volta a constatare che, come già nella “profezia sul passato” dell’occhiuta ninfa Vegoia, uirgo prudentissima, il futuro è storia, così come l’indagine sul passato è chiave ineludibile per la comprensione del futuro che incalza. La risposta ai dubbi e alle incertezze, indotte da metodi di indagine sempre più sofisticati, su tanti aspetti della vita dell’uomo antico, dobbiamo cercarla nelle quotidiane angosce prodotte dal nostro ostinarci a vivere – a ogni costo – calpestando la nostra umanità.
23 Breve resoconto su “Science” 272, 1996, pp. 246-249.
116 MARIANO MALAVOLTA
BIBLIOGRAFIA. – E. DE RUGGIERO, s.v. continentia (urbis), in “Diz. epigr.” II [1910], p. 1185; S.L. CESANO, s.v. genius, in “Diz. epigr.” II [1922] p. 462 sgg.; A. PASQUALINI, s.v. lucus, in “Diz. epigr.” IV [1975], pp. 1973-1975; R.M. OGILVIE, A commentary on Livy (books 1-5), Oxford 19783;
G. TRAINA, Ambiente e paesaggi di Roma antica, Roma 1990; G. RAGONE, Dentro l’àlsos. Economia e tutela del bosco sacro nell’antichità, in “Il sistema uomo-ambiente tra passato e presente” (Ravello, 3-6 giugno 1994), a cura di C. A. LIVADIE E F. ORTOLANI, Bari 1998, pp. 11-25 [fonti del Clitunno, roseto della Porziuncola, orto degli ulivi al Getsemani]; A. RICCI, Attorno alla nuda pietra. Archeologia e città tra identità e progetto, Roma 2006; Usus veneratioque fontium. Fruizione e culto delle acque salutari nell’Italia romana, a cura di L. GASPERINI, Tivoli 2006.
Costantino in Campidoglio1
Il titolo di questo mio breve intervento allude - si
potrebbe aggiungere che allude un po’ maliziosamente - al rapporto, non sempre facile e felice, fra il grande imperatore, Costantino, e questa fatidica rocca capitolina o, se si vuole, più in generale, fra Costantino e la città di Roma. Avrei potuto concepire un titolo come “La Roma di Costantino”, che però sarebbe suonato ancora più ambiguo e addirittura fuorviante, in quanto più propriamente riferibile alla vera Roma di Costantino, da Costantino fondata, ossia a Costantinopoli, la seconda Roma. Vedremo, nel corso di questa conversazione, che si trattò in ogni caso di un rapporto ineludibile quanto intenso, e tutt’altro che improduttivo, come era inevitabile che fosse fra una città il cui destino da ben più di due millenni è intrecciato con il destino del mondo e un uomo che come pochi altri nella storia ha avuto nelle sue mani le sorti del mondo e dei millenni futuri.
Intanto, questo richiamo ad un rapporto non sempre facile va in qualche modo contestualizzato come esito scontato, e non certo dovuto alla persona di Costantino, quanto piuttosto postulato dai caratteri congeniti dell’età del dominato: già prima di Costantino, ai tempi di Aureliano e Probo, si parlava di restitutores Illyrici, ossia di quegli
1 Testo della relazione svolta a Roma il 6 dicembre 2012, nella Sala Pietro da Cortona (Palazzo dei Conservatori) nell’ambito dell’incontro sul tema “Itinerari costantiniani. Tra passato e presente”.
118 MARIANO MALAVOLTA imperatori nativi dell’Illirico (così i Romani chiamavano la grande regione compresa fra l’Adriatico e il Danubio), e che in quella terra avevano con sforzo sovrumano contenuto l’avanzare della barbarie gotica: “tutti costoro ebbero come patria l’Illirico” osserva l’autore di un manuale di storia romana, ravvisando in Aureliano e Probo gli anticipatori dei tetrarchi2 e in armonia con una consapevolezza (assai diffusa nella pubblicistica dell’epoca) del fatto che ormai il cuore dell’impero batteva non più in Italia e nella vecchia Roma, ma a ridosso delle sponde del Danubio3. A questo si deve aggiungere la circostanza che lo schema di governo della tetrarchia, nella sua più intrinseca natura, era ispirato al principio del decentramento, che imponeva agli imperatori una vigile presenza nelle aree esposte al rischio delle pressioni esercitate sul limes dell’impero da incontenibili movimenti migratorii: Diocleziano fu a Roma una sola volta o due, Massimiano un paio di volte, Costanzo, Massimino Daia e Licinio non la visitarono mai, come Galerio e Severo, che si accostarono alla città soltanto in occasione dei rispettivi tentativi di assediarla e conquistarla. Non è priva
2 AUR. VICT., Liber de Caesaribus 39, 26-28: His sane omnibus (ossia a Diocleziano e ai tetrarchi) Illyricum patria fuit: qui, quamquam humanitati parum, ruris tamen ac militiae miseriis imbuti satis optimi rei publicae fuere. Quare constat sanctos prudentesque sensu mali promptius fieri, contraque expertes aerumnarum, dum opibus suis cunctos aestimant, minus consulere. Sed horum concordia maxime edocuit uirtuti ingenium usumque bonae militiae, quanta his Aureliani Probique instituto fuit, paene sat esse. 3 D. LASSANDRO, L’Illirico nella visione dei panegiristi gallici di età tardoantica, in “Dall'Adriatico al Danubio. L'Illirico nell'età greca e romana” (Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003), Pisa 2004, pp. 395-401.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 119 d’interesse, a questo riguardo, la trovata retorica del panegirista Claudio Mamertino a proposito dell’incontro di Milano nel 291, dove sembra di cogliere (dissimulatissimo fra le righe) l’intento di dare voce alla delusione del popolo romano di Roma, “snobbata” dai due Augusti convenuti a Milano: “Anche Roma, signora dei popoli, esaltata dalla gioia straordinaria della vostra prossimità, tentando di scorgervi dalle vette dei suoi colli per appagarsi più da vicino dei vostri volti, si sporse il più possibile per potervi contemplare da presso [ossia: guardando verso Milano]. Certo essa inviò le glorie del suo senato, rendendo volentieri come partecipe della sua maestà quella città di Milano così felice in quei giorni, così che allora la sede dell’impero sembrava essere là dove erano venuti entrambi gli imperatori”4.
Da questo punto di vista, dunque, Costantino (anch’egli di origine illirica, in quanto nativo di Naissus città della Moesia superior, oggi Niş) può vantare un maggior numero di presenze (tre in tutto) e anche, da un punto di vista concretamente urbanistico, una più che apprezzabile cura che durante il suo regno fu rivolta alla città, evidente nell’impulso da lui dato a terminare i lavori di costruzione della mastodontica basilica di Massenzio (l’avversario da lui annientato), delle terme sul Quirinale, meno grandiose di altre ma sicuramente più eleganti, del portico della regione settima, dell’arco trionfale presso il Colosseo e, forse, dell’arco quadrifronte del Velabro, al punto che, secondo le adulazioni di un panegirista5, si poté dire che “ogni luogo
4 Paneg. Lat. III 12 5 Paneg. Lat. X 35, p. 241 B. (è il panegirico di Nazario).
120 MARIANO MALAVOLTA importante della città splendeva di nuove opere e l’oro fulgente faceva risaltare al confronto la indecorosa parsimonia degli antichi”6. Certo, dirà qualcuno, si tratta di un’osservazione scontata in un contesto elogiativo, ma la realtà monumentale non lo smentisce, come del resto ha potuto personalmente constatare chi è venuto qui stasera, e ha sicuramente notato i frammenti (specie la famosa testa) della statua colossale dell’imperatore nell’atrio del Palazzo dei Conservatori, che possiamo annoverare fra le testimonianze concrete di una presenza di Costantino in Campidoglio.
Eppure, anche nella brevissima rassegna delle tre presenze romane di Costantino risulta evidente quella problematicità del rapporto che sopra abbiamo segnalato, che ha fatto parlare di un “abbandono del Campidoglio” da parte di Costantino7, e che si è venuta articolando - specie nel corso degli ultimi decenni - come una fra le più dibattute e tormentate questioni storiografiche, ormai del tutto inaccessibile ai non iniziati.
La prima volta di Costantino a Roma è quella del 29
ottobre del 312 (il giorno successivo a quello della battaglia dei Saxa Rubra o di Ponte Milvio): un ingresso trionfale in una città che lo accoglieva come liberatore dal “tiranno” Massenzio, in un clima di publica laetitia, che però fa registrare (nel IX panegirico) una qualche delusione da parte del popolo che si accalca per “vedere” il liberatore: 6 Su tutto ciò cfr. F. CASTAGNOLI, Topografia e urbanistica di Roma antica, Roma 1958, p. 38. 7 Questo è il titolo del lavoro di A. FRASCHETTI, citato nella nota bibliografica.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 121 qualcuno arriva - nel racconto del panegirista - all’audacia di chiedere all’Augusto di resistere, ossia di fermarsi un attimo per concedersi alla folla, o a lamentare che egli affretti di andarsi a rinchiudere nella residenza imperiale (ossia nella domus del Palatino), che alla fine viene circondata da quel popolo che sembra quasi assediare colui che ha liberato la città dall’assedio8. Non si parla assolutamente di una salita al Campidoglio, con un silenzio che qualcuno ha addirittura imputato ad una censura, concludendo sbrigativamente che la salita al Campidoglio, e dunque al tempio di Giove Ottimo Massimo, senz’altro ci fu, perché era impossibile che il vincitore si sottraesse, in una simile circostanza, al rito millenario postulato dalla configurazione stessa dello spazio urbano. Sappiamo con certezza, in ogni caso, che questo primo soggiorno fu il più lungo dei tre, una vera e propria luna di miele, e si protrasse dal 29 ottobre del 312 almeno alla fine di gennaio dell’anno successivo (tre mesi in tutto), allorché l’imperatore lasciò Roma per recarsi a Milano, dove sarebbero state celebrate, in febbraio, le nozze fra sua sorella Costanza9 e l’Augusto Licinio.
Il secondo adventus dell’imperatore a Roma si ebbe nel 315, a distanza relativamente breve dal primo, nel compimento dei decennalia del regno, come attesta Eusebio, che precisa anche che in quella occasione l’imperatore “nel
8 Paneg. IX 19: ausi etiam quidem ut resisteres poscere et quasi tam cito accessisse Palatium et, cum ingressus esses, non solum oculis sequi, sed paene etiam sacrum limen inrumpere. Inde omnibus circumfusi viis, dum excederes, opperiri, prospicere, optare, sperare, ut viderentur eum a quo obsidione liberati fuerant, obsidere... 9 Flavia Giulia Costanza in realtà era una sua sorellastra, nata da Costanzo Cloro e Teodora (a sua volta figliastra di Massimiano).
122 MARIANO MALAVOLTA corso di pubbliche celebrazioni, rivolse preghiere di ringraziamento al Dio dell’universo, quali sacrifici senza fuoco e senza fumo (apyrous kai akapnous dice Eusebio)”10. Costantino sarebbe giunto a Roma il 21 luglio del 315, con qualche giorno di anticipo sul natalis imperii (che ricorreva il 25 luglio), e il suo soggiorno si sarebbe protratto fino al 27 settembre. Reliquia insigne di questo passaggio a Roma dell’Augusto è l’arco monumentale presso il Colosseo (il più imponente fra gli archi romani), decorato con pregevolissimi manufatti recuperati da monumenti più antichi qui reimpiegati e completato con un importante bassorilievo storico commissionato espressamente per questo monumento, contenente scene riferibili alla campagna del 312 contro Massenzio (la partenza di Costantino da Milano, l’assedio di Verona, la battaglia del ponte Milvio del 28 ottobre, l’ingresso trionfale in città del 29, l’adlocutio dai Rostri, la distribuzione del congiarium)11. Si è detto che il complesso della decorazione dell’arco è “pagano per quello che esprime, cristiano per quello che tace”12, e questa constatazione trova una conferma nella notevolissima epigrafe che ne decora l’attico, e che può considerarsi il risultato dell’attenzione dedicata dai più illustri esponenti del senato dell’Urbe (tutti di antica religione pagana) alla stesura di una formula che non urtasse la sensibilità religiosa dell’Augusto, al quale, come recita la dedica “il senato e il popolo di Roma hanno dedicato l’arco … perché per ispirazione della divinità (instinctu diuinitatis) e in virtù della
10 EUS., Vita Const. 1, 48. 11 Cfr. G. BONAMENTE, o.c. nella nota bibliografica, p. 59. 12 RUYSSCHAERT.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 123 grandezza del suo animo (mentis magnitudine), con il suo esercito in una guerra giusta ha vendicato lo stato liberandolo dal tiranno (cioè da Massenzio) e da tutta la sua fazione”13. Si è parlato, a questo riguardo, di un’ascendenza platonica di questa formula, che del resto è attestata una volta anche per una divinità pagana in un’iscrizione di Thysdrus14, nella quale si dice che l’azione benemerita di Annio Rufino per l’approvvigionamento idrico della città africana è avvenuta instinctu Mercurii potentis15, ma è anche vero che per i contemporanei di Costantino era ormai compiuto quel lento ma continuo processo di consacrazione della persona dell’imperatore, dopo che il carattere carismatico dell’autorità imperiale, postulato dal titolo di Augustus, si era trasformato da personale in istituzionale, giungendo già con Aureliano – uno dei restitutores Illyrici anticipatori di Costantino – ad una formulazione sempre più precisa ed inequivocabile del carattere ultraterreno del potere imperiale e della nuova ideologia monarchica di “imperatore per grazia di Dio”, che ormai sostituiva l’antico ideale del principato civile di spirito repubblicano e senatorio. Eloquenti, al riguardo, le parole che Aureliano aveva rivolto ai suoi soldati in rivolta, dicendo loro che s’ingannavano, se ritenevano che il destino dei re fosse nelle loro mani: era invece Dio che gli aveva dato la porpora – e la mostrava con la destra – e che stabiliva, anche, il tempo del regno. Possiamo dunque essere certi del fatto che già in 13 CIL VI 1139 = 31254 = ILS 694, cfr. da ultimo “Ann. ép.” 2007, 51. 14 Città della Bizacena, ossia della parte meridionale della Tunisia, corrispondente alla provincia Byzacena istituita con la riforma dioclezianea 15 CIL VIII 51 = ILS 5777 cfr. “Ann. ép.” 2008, 1611.
124 MARIANO MALAVOLTA questo anno 315 la fede di Costantino in quell’unico Dio fosse più che incrollabile.
La terza presenza di Costantino a Roma, forse il più breve
dei suoi soggiorni nella vecchia capitale dell’impero, viene registrata per i vicennalia nel 326, ossia – a detta delle fonti – con il ritardo di un anno sulla ricorrenza, che pare fosse prevista per il 325 (dieci anni dopo i decennalia del 315)16. Si è ipotizzato che questo terzo ed ultimo soggiorno romano debba collocarsi fra il 18 luglio, che sarebbe il giorno dell’arrivo in città, qualche giorno prima del dies imperii del 25 luglio) e il 3 agosto – come ipotizzato da qualcuno – o al più tardi, il 26 settembre, giorno in cui l’imperatore era sicuramente a Spoleto17. Va notata anche la circostanza che l’inizio dei lavori per la fondazione della nuova capitale a Costantinopoli avvenne il 28 novembre di questo stesso anno 326 (anche se poi l’inaugurazione della nuova città fu l’11 maggio 330). In ogni caso a quest’anno 326 viene riferita da Zosimo (scrittore pagano, fortemente ostile a
16 Per il 18 luglio annotato nei fasti filocaliani cfr. I.It. XIII 2, p. 485. Va osservato che a proposito del calcolo del dies imperii di Costantino alle osservazioni di A. FRASCHETTI (che accenna ad una distinzione fra vota suscepta e vota perfecta, sulla scorta di uno studio di S. MAZZARINO, Computo e date di condono dei reliqua: da Costantino al 5° secolo, in “Romanitas-Christianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit Johannes Straub zum 70. Geburtstag am 18 Oktober 1982 gewidmet”, Berlin-New York 1982, pp. 375-392) vanno affiancate le considerazioni di ANDRÉ CHASTAGNOL, Les jubilés impériaux de 260 à 337, in “Crise et redressement dans les provinces européennes de l’Empire (milieu du IIIe- milieu du IVe siècle ap. J.-C.)”. Actes du colloque de Strasbourg (décembre 1981) édités per Edmond Frézouls, Strasbourg 1983, pp. 11-25, specialmente pp. 27 sgg. 17 Al 26 settembre del 326 è datata C.Th. 16, 5, 2
FRA ANTICHITÀ E STORIA 125 Costantino) la notizia di un episodio increscioso, che avrebbe causato un vero e proprio screzio fra Costantino e i Romani: “Quando venne il momento della festa tradizionale – racconta Zosimo – nel corso della quale l’esercito doveva salire sul Campidoglio e celebrare i soliti riti, Costantino per paura dei soldati intervenne alla festa. Ma l’Egiziano gli mandò una visione (un favsma) che condannava senza riserve l’ascesa al Campidoglio; allora egli non partecipò alla cerimonia sacra e si attirò l’odio del senato e del popolo”18. Si tratterebbe di un vero e proprio grave incidente diplomatico, che il pagano Zosimo inserisce nella narrazione di un periodo obbiettivamente difficile per Costantino, divenuto sì unico Augusto e unico signore dell’impero, ma forse proprio per questo motivo gravato dal peso del suo enorme potere, che gli avrebbe fatto dimenticare la sua proverbiale mitezza per spingerlo ad una serie di atrocità, quali l’uccisione di suo figlio Crispo e di sua moglie Fausta, l’eliminazione del già vinto ed inerme Licinio, seguita da quella ancor più odiosa dell’innocente figlioletto di costui, Liciniano, cui si sarebbe aggiunta, qualche tempo dopo, la condanna a morte di uno dei suoi consiglieri, il filosofo neoplatonico Sòpatro di Apamea19. Proprio questa lunga serie di delitti, di colpe non espiabili a detta dei sacerdoti pagani, ma anche del filosofo Sòpatro, avrebbe spinto Costantino, nel corso di quest’anno 326, ad accettare le proposte del vescovo Ossio di Cordova (il ciarlatano egizio cui si riferisce Zosimo nel passo sopra
18 ZOS. 2, 29, 5 citato nella traduzione di FABRIZIO CONCA. 19 Su Sopatro di Apamea si veda PLRE I p. 846 nr. 1; è interessante notare come della versione riportata da Zosimo non vi sia alcuna traccia in Eusebio, che di Sopatro si parli, ovviamente sotto la specie di una smentita, nella Storia ecclesiastica di SOZOMENO, 1, 5.
126 MARIANO MALAVOLTA citato) che lo avrebbe incoraggiato ad abbracciare la religione cristiana, che ai suoi adepti prometteva, per il tramite del sacramento del battesimo, la cancellazione di tutte le colpe, e a lasciare per sempre Roma, andando a fondare sul Bosforo una nuova capitale dell’impero, che fosse veramente la “sua” città. Una versione, quella di Zosimo, che per la sua parzialità non ha mai convinto gli storici, sia perché ricalca punto per punto la leggenda anticristiana elaborata ai tempi di Giuliano l’Apostata (grande detrattore di Costantino)20 sulla base del battesimo che in effetti fu somministrato a Costantino in punto di morte, sia perché ritarda al 326 il momento della conversione, che invece era sicuramente compiuta nel 312 o al più nel 315. Il lavoro di esegesi del passo di Zosimo che abbiamo citato ha condotto in genere a ritenere che probabilmente vi fu un rifiuto di Costantino di salire in Campidoglio, ma che tale rifiuto avvenne - con ogni probabilità - nel 312 o nel 315 (così Paschoud), anche se poi, al di là di qualsiasi elucubrazione degli eruditi, restano ampi margini di dubbio su tutte le innumerevoli soluzioni proposte, anche perché è ovvio che le nostre fonti (si tratti di storici o di panegiristi) non possono essere valutate alla stregua di rapporti della polizia scientifica, che fra l’altro spesso si rivelano anch’essi - ancor oggi - inconcludenti o addirittura fuorvianti.
20 Anche AMMIANO (2, 10, 8) riferisce che Giuliano giudicava Costantino turbator priscarum legum et moris antiquitus recepti; si veda anche la caricatura di Costantino nell’operetta satirica I Cesari (235 D sgg.) e le malignità contenute nell’Orazione contro il cinico Eraclio, nella quale Costantino è accusato, sempre da Giuliano, di conoscere la scienza politica non per princìpi, ma per semplice pratica (227D-228A).
FRA ANTICHITÀ E STORIA 127
Sappiamo, in ogni caso, che una vera e propria rottura con il paganesimo (che ci fu molto tempo dopo, all’epoca dell’imperatore Graziano) era ancora ben lungi dal turbare il rapporto fra l’Augusto e la Città eterna, come mostra la titolatura dell’imperatore nelle epigrafi, che registrano regolarmente il titolo di pontifex maximus, non mai rifiutato dal nostro imperatore.
Così non ci stupisce il fatto che dopo la sua morte Costantino fu, alla pari di molti “buoni” imperatori prima di lui, divinizzato dal senato di Roma, come attestato concordemente da fonti storiografiche, numismatiche ed epigrafiche, dalle quali risulta che questo istituto secolare fu espletato nella sua forma tradizionale, sia dal punto di vista cerimoniale, sia nell’esplicitazione di uno dei nessi fondamentali, quello della stretta connessione fra la relatio in numerum divorum e la legittimazione della successione. Proprio la Vita Constantini testimonia che l’ormai “divo” Costantino ebbe a Roma, la ‘città regale’, un funerale in absentia connotato dagli elementi tradizionali, quali il iustitium (ossia l’interruzione di ogni pubblica attività), l’esposizione di imagines, la raffigurazione dell’assunzione in cielo21, che lo poneva nella lunga serie iniziata da Romolo e consolidata da Cesare e da Augusto. Il senato e il popolo romano, “non appena avuta la notizia della morte dell’imperatore, diedero corso a incontenibili manifestazioni di cordoglio: furono chiuse le terme e i mercati e vennero
21 EUS., Vita Constant. IV 69, 1-2. Cfr. G. BONAMENTE, Apoteosi e imperatori cristiani, cit., p. 110; A. CAMERON - S.G. HALL Eusebius, Life of Constantine, introduction, transaction, and commentary by, Oxford 1999, p. 345 s.
128 MARIANO MALAVOLTA sospesi tutti gli spettacoli e tutti camminavano per la strada tristi e avviliti e tutti a un tempo proclamavano le lodi di quel principe così degno di rivestire l’autorità imperiale. E non si limitavano a queste grida di compianto, ma traducevano in concreto il loro dolore onorando il defunto sovrano con la dedica di ritratti, proprio come se fosse stato ancora in vita: e tali dipinti raffiguravano la distesa del cielo con l’imperatore che dimorava nello spazio etereo al di sopra della volta celeste” (Vita Constantini IV, 69).
Ma è ora di tornare in Campidoglio e di concludere questa breve nota rievocativa: abbiamo detto che quest’antico centro della città è sicuramente da considerare uno dei più frequentati crocevia della storia umana, così come abbiamo ricordato che il nostro grande imperatore si è trovato, come pochi altri, a indicare nuovi percorsi che poi di fatto la storia imboccò. In Campidoglio, potremmo concludere con superficiale leggerezza, egli ha lasciato la sua testa, ma non il suo cuore, che fu sepolto sulle rive del Bosforo, ma sappiamo bene che questo particolare crocevia, sul quale ora siamo, lo vide per ben due volte additare all’umanità due distinte direzioni su due diversi importantissimi percorsi.
Già, perché vi è una grande strada della storia umana che vede Roma come ombelico del mondo, crocevia di tutte le strade, che ad essa inevitabilmente conducono: su questo percorso, che è essenzialmente diacronico, sulla Roma dei Cesari, sui sette colli, centro dell’antica ecumene, è risorta la Roma dei Papi, centro della cristianità ecumenica, creando le premesse dell’espansione di quella terza Roma che si sarebbe dovuta “dilatare su altri colli, lungo le rive del fiume sacro, sino alle sponde del Tirreno”: ed è innegabile che di quella tappa
FRA ANTICHITÀ E STORIA 129 intermedia della Roma dei papi sia stato padre il nostro imperatore Costantino. Una seconda importantissima strada della storia umana è il percorso, anch’esso plurimillenario, della translatio imperii, fatto anch’esso di tre tappe, che portano il nome delle tre Rome22: la prima Roma, che è sempre la Roma dei Cesari, centro originario dell’antico impero; la seconda Roma, che è la Roma del Bosforo, ossia Costantinopoli, sede più che millenaria (330-1453), dell’impero romano cristiano ortodosso d’Oriente; la terza Roma, ossia Mosca, centro del nuovo impero dell’ortodossia cristiana dopo la caduta di Bisanzio nel 1453, già nella dottrina di Filofej (leggi: F’ilafiéi), il monaco russo che profetizzava dicendo “due Rome son cadute, la terza sta, la quarta non ci sarà”. Anche in questo percorso della migrazione dell’impero dalla prima alla terza Roma, ancora una volta, è a Costantino che dobbiamo la scelta della Roma sul Tevere come di un carattere originario da replicare in dettaglio nella fondazione della Roma sul Bosforo, affidando all’umanità “questo” modello eterno dell’impero da custodire nel corso infinito dei secoli futuri.
22 M. PAVAN, Roma, Costantinopoli, Mosca: l’ideologia delle tre Rome, in “Il Veltro” 28, 1984, nr.1-2, pp. 31-35.
130 MARIANO MALAVOLTA
NOTA BIBLIOGRAFICA: Oltre ai lavori citati nelle note a pié di pagina, possono vedersi A.
FRASCHETTI, Costantino e l’abbandono del Campidoglio, in “Società romana e impero tardoantico. 2. Roma. Politica, economia, paesaggio urbano”, Roma-Bari 1986, pp. 59-98 e 412-438; TH. GRÜNEWALD, Constantinus Maximus, Stuttgart 1990; G. BONAMENTE, Eusebio, Storia ecclesiastica IX 9 e la versione cristiana del trionfo di Costantino nel 312, in “Scritti sul mondo antico in memoria di Fulvio Grosso”, a cura di L. GASPERINI, Roma 1981, pp. 55-76; F. PASCHOUD, Ancora sul rifiuto di Costantino di salire al Campidoglio, in “Costantino il Grande dall’antichità all’umanesimo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico” (Macerata, 18-20 novembre 1990), Macerata 1993, pp. 737-748; sulla testimonianza di Zosimo e della sua fonte, Eunapio, R.C. BLOCKLEY, The fragmentary classicising historians of the later Roman empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus, II. Text, translation and historiographical notes, Trowbridge 1983; fra le ultime novità dell’editoria ci limitiamo a citare la suggestiva ricerca di BRUNO
CARBONERO - FABRIZIO FALCONI, In hoc vinces. La notte che cambiò la storia dell’Occidente, Roma 2011; e ancora JONATAN BARDILL, Constantine, divine emperor of the Christian golden age, New York 2012; RAYMOND VAN DAM, Remembering Constantine at the Milvian Bridge, New York 2011.
Cassero, qasr, castrum: destrutturazione del limes
e medioevo nostrano1.
Se sono qui stasera, a conversare con un uditorio così
attento (e, diciamolo pure, così selezionato) sulla relazione di Roberto Bernacchia, non lo devo tanto ad una mia particolare competenza sugli argomenti che egli ha trattato quanto, al contrario, alla mia profonda ignoranza di quegli argomenti, che è quella che mi ha spinto, qualche tempo fa, a rivolgermi all’amico Roberto, che non mi conosceva, e quindi di tutto questo non ha colpa alcuna, per sottoporgli la questione dell’incastellamento un po’ tardo (da me presunto) delle pievi di Cossignano (mia patria) e chiedergli lumi in proposito. Da questa mia invadenza ha avuto origine una lunga ed articolata conversazione, che si è svolta non soltanto per la fredda via della posta elettronica, ma anche nel corso di un incontro ad Ancona, durante il quale fu lui a chiedere a me - studioso del limes orientale dell’impero romano - cosa ne pensavo delle “burgàrie” di cui abbiamo or ora sentito parlare.
Sembra superfluo precisare che il problema trattato questa sera mi è noto soltanto dalle conversazioni che ho avuto con il relatore, che mi ha anche fatto leggere il testo della relazione. Mi manca – voglio dire – quella conoscenza 1 Intervento in margine alla relazione di Roberto Bernacchia, svolto sabato 10 dicembre 2011 a Mondolfo nel Salone Aurora del complesso di S. Agostino.
132 MARIANO MALAVOLTA capillare del territorio (topografica e toponomastica) che è fondamentale, specie per il nostro medioevo, e dunque mi limiterò ad alcune osservazioni di interesse più generale.
Intanto il titolo che ho proposto per questo mio intervento, e che si riferisce proprio alle analogie fra la realtà, la “frammentazione” del territorio marchigiano nel medio evo e la realtà della destrutturazione che sfigurò (è il punto di vista dell’antichista) la fisionomia dell’ecumene antica: capolavoro del processo di costruzione dello stato romano nel corso del millennio dell’evo antico era stata quella reductio ad unum che, a ben vedere, anche il nostro complicatissimo evo sta cercando di raggiungere, ma che ancora oggi – non ostante la cosiddetta globalizzazione – appare ben lontana dall’aver raggiunto una sua compiuta organicità. Lo scambio fra Oriente e Occidente subì di fatto, alla fine dell’evo antico, un processo di accelerazione che però non ebbe lo stesso esito del confronto/scontro fra romanità e germanesimo (la fioritura nell’Europa moderna delle “nazioni” che erano state parti dell’impero), ma al contrario conservò a lungo (si può dire fino ai giorni nostri) la connotazione di una conflittualità non mai risolta, e che ebbe la sua fase acuta in un’epoca assai più tarda, nei secoli delle crociate. Ma anche quello fu uno scambio e un confronto fra civiltà, e la sequenza lessicale da me citata (cassero/quasr / castrum) la dice lunga sul contesto in cui avvennero scambio e scontro.
Il vocabolo ‘cassero’, che finì con l’indicare in Occidente la rocca o recinto interno fortificato di una città o cittadina già di per sé fornita di mura (ma anche la parte sopraelevata rispetto al ponte di una nave, poi destinata all’alloggio degli
FRA ANTICHITÀ E STORIA 133 ufficiali), venne in uso nella nostra lingua volgare dal vocabolo arabo qasr, componente diffusissima nella toponomastica della regione di quello che era stato il confine orientale dell’impero (specie per quanto riguarda la Siria, la Mesopotamia e l’Arabia), proprio a causa della diffusione capillare dei migliaia di castra del limes romano, che lasciò in quelle regioni un indelebile ricordo, se non altro nei nomi dei luoghi, ben oltre il momento della dissoluzione dell’ordinata ecumene antica e del suo immenso sistema difensivo.
E vale la pena di vedere un po’ più da vicino cos’era questo limes, di cui tanto si è parlato fra antichisti, specie nel secolo scorso, quando legioni di studiosi hanno dedicato le loro ricerche al limes dell’impero romano. Del limes si deve osservare prima di tutto il valore etimologico, che non è quello di ‘linea’ ma di ‘fascia’, dunque è essenziale la percezione della sua bidimensionalità, e dunque si adatta benissimo ad indicare il ‘nastro’ di una via o strada. Nelle nostre campagne della Marca “sporca” (volgarizzazione approssimativa, ancorché efficacissima, di Marca spolta, ossia spoletina, con riferimento al Ducato) la voce dialettale glièmito (registrata nel Thesaurus linguae Latinae come esito volgare di limes) è la scarpata sottostante la strada: una specie di sineddoche per la quale il vocabolo limes (= strada, specie strada poderale) trasferisce il suo significato a quello che propriamente si dovrebbe chiamare “aggere” o terrapieno, visto che la maggior parte delle strade sono realizzate in zona collinare, e dunque aperte lungo pendii.
Dunque il significato principale che ci interessa è questo di “strada”, che poi è quello che allude alla strada
134 MARIANO MALAVOLTA (fortificata) o limes che circondava l’impero. D’altra parte va detto che la nozione di limes come frontiera fortificata dell’impero è piuttosto tarda. I confini dell’impero, in Oriente, furono protetti a lungo da stati cuscinetto posti ai margini di province che non ebbero bisogno di un vero e proprio limes, mentre in Occidente essi già in età augustea furono naturalmente fissati rispettivamente sulla sponda sinistra del Reno e sulla sponda destra del Danubio, e in questi casi si parlava di ripa, più che di limes, anche se non mancarono ovviamente strade lungo le rive, necessarie allo spostamento delle truppe lungo la frontiera. La percezione del limes si accentuò con il regno di Vespasiano e dei Flavi in genere (69-96), quando la riottosità delle popolazioni di frontiera consigliò, là dove non vi erano confini naturali, la costruzione di vere e proprie frontiere fortificate in Britannia (Clyde-Forth e Solway Firth - Newcastle upon Tyne), e ancora ai margini degli agri decumates (ossia del vasto territorio compreso fra le anse del Reno e del Danubio), e soprattutto nella steppa siriana, a fronteggiare il metus Parthicus. Fu in questa regione che già sotto i Flavi, ma soprattutto al momento della costruzione della strata Diocletiana, fra Zeugma sull’Eufrate e il mar Rosso (il golfo di Aqaba) si sviluppò una delle più mastodontiche opere di fortificazione della storia umana, con la costruzione dei castra legionarii e dei castella delle formazioni ausiliarie, regolarmente dislocati a intervalli di 15 o 20 miglia l’uno dall’altro, e collegati da una strada che da Trabzon sul Mar Nero si snodava per centinaia di chilometri raggiungendo il corso dell’Eufrate, che poi seguiva la linea di confine segnata dalla sponda destra di quel fiume, per poi staccarsene a
FRA ANTICHITÀ E STORIA 135 Zeugma e proseguire fino al golfo di Aqaba, sul Mar Rosso, senza potersi appoggiare ad alcun confine naturale, che non fosse, in qualche caso, l’invisibile isoieta che delineava il confine fra la steppa desertica e le località fornite di pozzi. Le necessità logistiche del controllo di una così poderosa ed articolata struttura di presidio militare del territorio consigliarono al potere centrale, proprio in età dioclezianea, lo spezzettamento delle unità amministrative dell’immenso territorio dell’impero, che si dimostrò funzionale fino a che il potere centrale restò saldamente nelle mani di imperatori come Diocleziano, Costantino o Teodosio, ma che in seguito si rivelò premessa di una selvaggia inevitabile crescita di poteri locali, proprio in corrispondenza delle province di frontiera.
Una situazione che, a ben vedere, anticipava in qualche modo una delle caratteristiche del nostro medio evo, quella del potere pressoché incontrastato del dominus loci, da allora rimasta endemica per secoli. Insomma, per tornare all’analogia, una sorta di “territorializzazione dello spazio di confine” che in un recente contributo di Chiara Molducci appare basata, anche per questa regione dell’alta Marca, su parte del limes fortificato bizantino costituito nel VII secolo fra la Tuscia Langobardorum e la capitale esarcale di Ravenna. A questo riguardo mi verrebbe in mente che quei burgarii, equiparati ai muliones delle stazioni del cursus publicus nella constitutio del codice teodosiano, potremmo ben ritrovarli lungo il sistema difensivo bizantino del Cesano, il che induce a ritenere non del tutto priva di fondamento le perplessità del Serra, dell’Olivieri e del Cavanna (citati da Roberto) sull’origine del toponimo
136 MARIANO MALAVOLTA Bulgària, anche se l’accurata indagine di cui or ora abbiamo ascoltato una esaustiva relazione sembra escludere questa eventualità.
Tornando al contesto che mi è più familiare, richiamerei ora la vostra attenzione sulla tavola che vi è stata distribuita. La figura 3, con uno stralcio della tavoletta IGM, vorrebbe fornire le coordinate geografiche della formazione del “comune” di Cossignano, originata dalla presenza della pieve rurale di S. Vito, centro della plebs de Coseniano, aggregatasi (forse in corrispondenza di una villa tardoantica) lungo il percorso della strada Ascoli-Fermo; nel mio modo di interpretare la documentazione disponibile la pieve in questione, ubicata in una contrada che tutt’ora è denominata S. Giorgio, si sarebbe progressivamente avvicinata al castrum, fondendosi in un primo momento con la chiesetta rurale di S. Paolo fuori le mura, e quindi entrando nel castrum vero e proprio nel 1265 (per concessione, a quel che dicono i documenti, del vescovo ascolano): si tratta, ovviamente, di una labilissima ipotesi, che ho cercato di contestualizzare in alcuni scritti più o meno recenti2. Nella figura 4, estratta dal catasto gregoriano del 1813-1815, potete osservare la più antica planimetria del centro storico, sulla cima del colle, alla quota di 400 m s.l.m., che consiste di un incasato circondato da mura, a pianta grosso modo ellittica di m 180 per 90, diviso in “quartieri” da due vie che si incrociano in corrispondenza della piazza Umberto I. La via che delinea in qualche modo l’asse maggiore dell’ellisse
2 M. MALAVOLTA, S. Paolo di Cossignano dentro e fuori le mura, Roma [Aracne] 2003; ID., Le molte vite dell’Annunziata, in “La chiesa dell’Annunziata”, Acquaviva Picena 2010, pp. 13-18.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 137 (non vorrei spingermi a chiamarla “decumano”) è ben individuabile e coincide con la via Aiella, che dalla porta di Levante conduce in piazza, proseguendo poi con la via del Cassero, che raggiunge l’estremità sudoccidentale dell’abitato. Meno visibile attualmente il percorso viario che insisteva sull’asse minore, di cui si conservava soltanto, a quel che ricordo, uno stretto vicolo che separava la sede comunale dalla proprietà Santucci, e comunicava con la piazza mediante una copertura a volta poi ostruita dal bugigattolo ceduto in uso (come ricorderanno i più anziani) all’incaricato del dazio: questo sarebbe stato il “cardine” originario, la cui esistenza è peraltro chiaramente indicata in alcune planimetrie, ma che in seguito fu cancellata dalla costruzione delle case Fassitelli (già Feriozzi) e Vinci. Ora, vale la pena di notare che dal sommarione del catasto del 1813-1815 l’incasato appare diviso (dall’asse minore dell’ellisse) in due sole porzioni, denominate rispettivamente Cassero (SO) e Aiella (NE), e che nei documenti più antichi la porta di Levante, o di S. Giorgio, tuttora conservata, viene indicata come “porta del burgo”, mentre la porta “da sole” (crollata prima del 1874 e poi definitivamente cancellata dalla costruzione della rampa di via Passali) è detta “porta di castello”. Non voglio annoiarvi troppo con particolari a mala pena comprensibili (e che mi riprometto di analizzare in altra sede) e salto alle conclusioni: la pianta del centro storico di Cossignano potrebbe essere, secondo questa mia nebulosa ipotesi, il risultato dell’accorpamento al Cassero, ossia al nucleo più antico del castellum Martis, dell’Aiella, ossia del “burgo” costruito a ridosso del Cassero e poi cinto anch’esso da mura
138 MARIANO MALAVOLTA costruite nella seconda metà del XIII secolo, e completate con la costruzione della porta di Levante, detta “del burgo” non perché essa immettesse su un sottostante borgo, ma perché “immetteva nel borgo” ora abbracciato dalla cinta muraria e popolato dalla plebs de Coseniano.
Questa spiegazione, che si basa in sostanza sulla toponomastica, trova forse una conferma nelle figure che vedete sul rovescio del foglio. La prima è una foto (fig. 1) dello stemma conservato sull’antica campana datata 1303 (una delle più antiche della provincia), la cui lettura è agevolata dal disegno che ne ha potuto ricavare l’amico Mario Chighine (fig. 2). Il s(igillum) communis Coseniani (è questa la scritta che circonda lo stemma) consiste nella raffigurazione di una rocca munita di merlatura, alla quale si accede da un varco che si presenta non come apertura della cinta muraria, ma piuttosto come ingresso di una caverna scavata nel corpo della collina sormontata dalla cinta muraria. La figurazione dello stemma conserverebbe dunque l’aspetto originario dell’insediamento al momento della nascita del commune, che del resto è adombrata già nella donazione di Longino del 1039, nella quale leggiamo omnem meam portionem de castello Martae, quod vocatur Cosenianum e, poco oltre, castello de Marte quod vocatur Cosenianum3, nel segno di una sostanziale sovrapposizione dei nomi del castello e della pieve.
Nelle conversazioni che ho avuto con Roberto non poco spazio abbiamo dedicato a possibili analogie toponomastiche, notando ad esempio la vicinanza fra i nomi
3 W. LAUDADIO, Cossignano e i suoi documenti medievali, Roma [Edizioni Nuova Cultura] 2008, nr. 3.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 139 “castello de Marte” e “castel Marco”, e ho pensato che in qualcuno dei documenti citati poco fa si potesse ricercare una variante grafica “castel Março”, che annullerebbe, o quasi, la difformità dei due nomi, ma sembra che questo suggerimento non sia praticabile. In ogni caso, se si considera la diffusione capillare dei toponimi derivati da nomi di divinità antiche, è possibile ipotizzare che entrambi i nomi derivino da quelli di un antico uicus o castellum appartenente all’articolazione paganico-vicana delle più importanti ciuitates romane dei dintorni: per Mondolfo si potrebbe pensare a Senigallia o a Fano, come per Cossignano a Cupra (così pensava il grande Mommsen).
Nella documentazione non mancherebbero certo le analogie: un notissimo toponimo riferibile al dio Marte è sicuramente quello della mansio o statio ad Martis lungo la via Flaminia, che viene identificato con il uicus Martis Tudertium; lo stesso può dirsi di quello elencato nella tabula alimentaria di Vellèia, di età traianea (databile fra il 102 e il 114 d.C.), lunghissima iscrizione nella quale sono registrati centinatia di fundi i cui proprietari hanno accolto l’invito dello stato a contrarre mutui agevolati ipotecando la loro proprietà: il tasso d’interesse era del 2,50 per cento annuo, e non veniva incamerato dal fisco, ma rimaneva nelle casse del municipio, che con quella somma provvedeva borse di studio riservate a fanciulli meritevoli, ma di famiglie non abbienti. Ora, in questa iscrizione (C.I.L. XI 1147 = I.L.S. 6675, col. IV, l. 85) è registrata, fra le altre, l’obligatio di un fundus Antonianus Callianus Valerianus Cornelianus (si tratta evidentemente di una proprietà risultante dalla riunione di quattro particelle catastali originarie, risalenti al momento
140 MARIANO MALAVOLTA dell’assegnazione viritana a quattro persone diverse: un Antonius, un Callius, un Valerius, un Cornelius, che nel corso dei secoli furono accorpate per vicende di matrimoni o compravendite); questo fundus era ubicato in parte nel territorio di Velleia, in parte nel territorio di Libarna, e per di più a cavallo di due regioni augustee: Velleia apparteneva infatti alla regio VIII (Aemilia), e il suo centro antico era a 15 km SO di Lugagnano Val d’Arda; Libarna, invece, localizzabile nei pressi dell’odierna Serravalle Scrivia, apparteneva alla IX (Liguria); l’indicazione dell’ubicazione del fundus, meticolosamente registrata dalla tabula (qui est in Veleiate et in Libarnensi pagis Martio et Albense), è seguita, al solito, dalla menzione dei fondi confinanti, come prescritto da una norma conservata da Ulpiano (forma censuali cauetur ut agri sic in censum referantur: nomen fundi cuiusque, et in qua ciuitate et in quo pago sit, et quos duos uicinos proximos habeat). Nel caso del nostro fundus la tabula dice: adf(inibus) Caelidis Proculo et Prisco et pop(ulo), ossia dichiara che il fundus in questione confinava con il fundus di un Celidio Proculo, con quello di un Celidio Prisco e con una pubblica strada (così va inteso quel pop.). Dunque l’iscrizione attesta con sicurezza che nel territorio di Libarna vi era un pagus Albensis, e che nel territorio di Velleia vi era un pagus Martius, e che queste partizioni del territorio delle due città devono essere cercate nelle vicinanze del fiume Trebbia, che probabilmente faceva da confine fra il pago Albense di Libarna e il pago Marzio di Velleia, attestando inoltre la rimarchevole ampiezza, verificabile su una qualsiasi carta, dell’ager o territorio di queste due città.
Un caso completamente diverso è quello della colonia
FRA ANTICHITÀ E STORIA 141 latina di Ariminum (Rimini), per la quale sappiamo dell’esistenza di sette vici, che però sono da considerare non una divisione dell’ager di Ariminum, come credeva il Beloch (Karl Julius), ma (come nota opportunamente il Bormann in C.I.L. XI pag. 77) ripartizioni della plebs urbana di Rimini, ossia degli intramurani che vivevano in quella città, divisa in quartieri o uici, a somiglianza - nota lo stesso Bormann - dell’esempio analogo osservabile nei sette uici della lontanissima Antiochia di Pisidia, che sicuramente risalgono alla deduzione, ad opera di Augusto, di una colonia di veterani. Dunque anche i uici di Ariminum sarebbero stati denominati non all’epoca della deduzione della colonia latina, ma dopo una deduzione di veterani. In effetti l’analogia appare sorprendente, ad esempio, nella coincidenza dei nomi di questi uici, che corrispondono per almeno due di essi: i romanissimi nomi Cermalus e Velabrum ricorrono ad Antiochia come a Rimini: in entrambi queste città i nomi di due notissimi quartieri di Roma furono “calati” all’atto dell’insediamento di nuovi assegnatari di terre. Per tre degli altri cinque uici riminesi conosciamo i nomi di Aventinus, Dianensis, For(...), e il Bormann ipotizza di completare la lista aggiungendovi i nomi Aedilicius e Tuscus, che non sono attestati dalle iscrizioni di Rimini; ad Antiochia i nomi sarebbero: Aedilicius, Cermalus, Tuscus, Velabrum, Patricius, Salutaris. L’assenza di un pagus Martius in questo contesto - dobbiamo notarlo - può spiegarsi con la circostanza che, com’è più che plausibile, non tutte le deduzioni coloniarie seguirono lo stesso schema, ma sembra anche suggerire che la presenza del nome di Marte nella toponomastica vada messa in relazione con l’esistenza
142 MARIANO MALAVOLTA concreta di un luogo di culto preesistente alla cosiddetta “romanizzazione” dei territori italici via via incorporati nell’ager Romanus.
Lasciatemi concludere questa confusa accozzaglia di innocue farneticazioni con due suggestioni che, posso dirlo, mi vengono dagli occhi più che dalla mente, e che hanno a che vedere con quel filo d’Oriente che ho voluto intessere nel titolo di questo contributo: la prima riguarda la figurazione conservata nello stemma della campana cossignanese, dove il muro del castrum o castellum è sormontato da una strana merlatura, fatta di merli “trilobati” (fig. 1 e 2), di cui non sono riuscito a trovare modelli nella nostra iconografia coeva, e che invece assomigliano stranamente - uso quest’immagine per farmi meglio capire - ai merli di Nìnive, o a quelli del castello normanno di Santa Severina in Calabria: io credo che un archetipo orientale di questa merlatura sia un indizio significativo che va esplorato (da gente di me più esperta di queste cose) e che del resto si affianca al culto del patrono del paese, S. Giorgio, anch’esso di origine marcatamente orientale; l’altra suggestione, ancor più significativa, che mi ha rinviato a un ben vicino Oriente, l’ho avuta poco fa durante la visita al sito probabile della antica statio ad Pirum mostratomi da Roberto, nella chiesa di San Gervasio in Bulgaria (forse sito della statio ad Pirum), dove ho potuto leggere un’epigrafe greca con una locuzione comunissima nella regione del limes siriano (tharsi, oudeis athanatos)4, tipica delle iscrizioni sepolcrali di veterani
4 Oltre ai molti epitafi di questo tenore publicati nei volumi delle Inscriptions grecques et latines de la Syrie, si vedano ora S. ŞHAHIN, Oudeis athanatos in den Grabinschriften aus der Gegend von Germanikeia (Maraç)
FRA ANTICHITÀ E STORIA 143 limitanei, stabilmente stanziati in quella sterminata regione di confine e dunque ivi morti e sepolti fra il IV e il VI secolo dell’era volgare. Non saprei dire se sia stata la pietra a viaggiare dalla lontana Anatolia alla sponda marchigiana, o se più semplicemente l’epitafio che ho visto qualche ora fa (e che G. Paci data alla prima età imperiale) sia stato composto da qualcuno che aveva avuto personalmente occasione di frequentare quella lontana regione: è chiaro, in ogni caso, che questa millenaria conversazione, spesso degenerata in zuffe, con i nostri vicini d’Oriente va avanti da parecchi secoli fra metus Parthicus, limes della provincia di Siria, impero d’Oriente, sante Crociate, petrolio e risorgenti integralismi che ne interrompono troppo spesso la innegabile fascinazione.
in Kommagene, in “Ark. Derg.” 1, 1991, pp. 183-190 e, soprattutto, G. PACI, Nessuno è immortale, in “Picus” 20, 2000, pp. 324-330 e le figg. 3 a p. 327, 4 a p. 328, 5 a p. 329 con l’apografo dell’iscrizione.
FRA ANTICHITÀ E STORIA 145
Figura 2 - Apografo del sigillo con la scritta s(igillum) communis Coseniani (disegno dell’arch. Mario Chighine).
FRA ANTICHITÀ E STORIA 147
Figura 4 - L’abitato di Cossignano nella mappetta del Catasto Gregoriano (Archivio di Stato di Roma).
Per un archivio dell’effimero1
Quest’uso dei nick sembra alludere ad una chiusura esoterica e mi fa sentire come se prendessi la parola in una riunione degli alcoolisti anonimi. In effetti non mancherò di far cenno a come ho preso questo vizio e a come non ho alcuna intenzione di smettere. Ma una precisazione devo farla subito su questo particolare della mia “partecipazione straordinaria”, che ovviamente va intesa non nel senso che la mia partecipazione sia un evento straordinario, ma semplicemente che il mio intervento è un intervento extra ordinem, ossia esterno, di un non ancora socio di Orarossa, di Augustus, di LLRAP. Ma lasciamo perdere gli scherzi e veniamo al dunque.
“Archivio” ed “effimero”, che sono termini apparentemente antinomici, ci rimandano, di fatto, proprio ai due versanti di “memoria“ e di “immagine”. La straordinaria quantità di “immagini” che Orarossa sta raccogliendo nel suo archivio mostra un tentativo abbastanza inedito, a quel che mi risulta, e anche ben riuscito (e che sta avendo il meritato successo) di creare e di rendere immediatamente disponibile, visibile, il risultato della giustapposizione delle innumerevoli tessere singole del
1 Testo della relazione svolta ad Ascoli Piceno il 16 novembre 2012 nella sala “Valentino Bompiani” (Polo culturale Sant’Agostino) in occasione del III Incontro con la cittadinanza proposto da Ascoli com’era – Immagini di memorie.
150 MARIANO MALAVOLTA grande mosaico di “memoria” collettiva di questo microcosmo provinciale, dove la definizione di “provinciale” non è assolutamente da intendersi come qualcosa di limitativo, ma semplicemente specifica la provenienza della maggior parte del materiale raccolto. Insomma, se c’è un’anima ascolana collettiva, un genius loci della provincia, intrecciato con la sua plurimillenaria storia e in qualche modo artefice di tratti stilistici comuni alle migliaia di storie, di volti e di vite còlti dallo scatto del fotografo, che ha fissato in un’immagine l’effimero di quegli attimi, be’, io mi auguro che la fisionomia di quel genius loci ne risulti meglio definita e, per così dire, documentata.
La parola “archivio” allude poi - opportunamente - anche all’epoca della maggior parte delle immagini, che restituiscono per lo più attimi di un tempo lontano, appunto di “Ascoli com’era”, riportandoci ad una stagione in cui la fotografia era ancora un evento relativamente eccezionale, al quale ci si accostava con pudore e riverenza, e con una qualche ritrosia dovuta all’aura di sacralità dell’icona che si voleva produrre: un’icona che di fatto non risulta mai banale, come i miliardi di scatti che ora, direi quasi “impietosamente”, documentano l’insopportabile volgarità dei tempi che viviamo, popolati di molte maschere, ma di pochi volti (basti pensare alla banalità, quando non allo sconcio, delle immagini postate su facebook).
Quelle antiche figure al contrario, preziose per il loro valore di documento, e che Orarossa in qualche caso ha dovuto sottoporre ad un pazientissimo quanto sapientissimo lavoro di restauro, erano in quelle condizioni perché gualcite in grazia del loro instancabile circolare custodite in un
FRA ANTICHITÀ E STORIA 151 portafogli, o in tasca o nella confusione promiscua di un cassetto dal quale venivano tirate fuori per essere mostrate a parenti, amici, figli e nipoti. E dunque le “immagini di memoria” si rivelano non soltanto come presidio della memoria rinverdita dall’immagine, ma anche come testimonianza dell’affetto, talora feticistico, tributato al supporto materiale dell’immagine intesa quasi come oggetto di culto.
Allo storico, e in special modo ad uno storico del mondo antico, che appunto considera fatto non secondario l’enorme valore documentale di quelle foto, e che quotidianamente vive il presente nel costante ineludibile confronto con le testimonianze dei millenni trascorsi, viene quasi naturale la domanda: ma come ha fatto l’umanità a sopravvivere - per almeno due millenni - senza la fotografia? Questo è un modo volutamente sciocco di porre la questione, così come ugualmente sciocca è una possibile risposta a tono: per eternare una fisionomia, un ritratto, il ricordo di un volto, essa ha dovuto accontentarsi delle opere d’arte. I capolavori della pittura e del disegno, della scultura, della glittica, dell’arte musiva (in qualche caso) hanno svolto egregiamente la funzione postulata da un’insopprimibile anelito della mente e dell’intelletto umano di opporre una qualche resistenza all’ingiuria del Tempo. Quando poi si è reso disponibile un artificio meccanico che ha consentito a tutti di fermare i propri attimi, pur senza che l’artefice possedesse le divine doti di un Fidia, di un Policleto, di un Apelle o di un Raffaello, di un Caravaggio o di un Rembrandt, i primi passi di questa nuova “arte” furono mossi sulla falsariga di archetipi già canonizzati, nella
152 MARIANO MALAVOLTA maggior parte dei casi, dalla pittura. Nei più umili tuguri, come ricorderanno le persone di età più avanzata, abbiamo potuto così osservare ieratici “ritratti” di padri e nonni, ossia il corrispondente moderno di quelle imagines maiorum che erano sempre state ornamento esclusivo di una classe privilegiata, che già nell’antichità ne ornava gli atrii dei propri palazzi.
L’antica ossessione dell’immagine, intesa come estremo ricettacolo della vita perduta e non riproducibile, è illustrata magistralmente - grazie al genio poetico di Virgilio - nelle parole che Enea pronuncia fra le lacrime rivolto verso l’amico Acàte, dopo essere stato inaspettatamente commosso dalle scene della guerra di Troia affrescate sulle pareti del tempio di Giunone in costruzione a Cartagine: parole che si adattano perfettamente al groviglio di emozioni che oggi queste foto provocano in noi: sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt (1, 462), dice Enea ad Acàte, ossia “la storia è lacrime, e l’umano soffrir commuove la mente” - nella traduzione del Rostagni, o, forse ancor meglio “ché ferità non regna là ‘ve umana miseria si compiagne” (così Annibal Caro, che coglie l’essenza “rassicurante” del messaggio che Enea rivolge ad Acate). Subito dopo, il vigile intelletto di Virgilio, che vive in un’epoca non dalla nostra dissimile, fa seguire la constatazione dell’inganno, della pietosa illusione suscitata dalle immagini: Enea, nota poco oltre il poeta, animum pictura pascit inani (464, che Annibal Caro traduce “va di vana pittura il cor pascendo”), con un realistico richiamo alla realtà fittizia, e per così dire bidimensionale, delle immagini inanes, ossia vuote, prive di vita, di cui del resto lo stesso Enea si mostra ben
FRA ANTICHITÀ E STORIA 153 consapevole, allorché “col sembiante riscontra il vivo e ‘l vero”.
Virgilio visse in un’epoca di evolutissima cultura materiale, che ben apprezzava la pittura e ne riempiva musei e collezioni private, e il secolo di Augusto poteva ancora sentire il fascino delle imagines maiorum, i ritratti degli antenati, che però erano privilegio quasi esclusivo delle famiglie di più antica nobilitas. Il tempo di Virgilio, e, a seguire, i primi secoli dell’impero, assistono ad un enorme proliferare di immagini, di “ritratti”, che del resto già nell’ultimo secolo dell’età repubblicana avevano fortemente connotato una delle peculiarità dell’arte romana, fino al crudo realismo di monumenti che riproducono tratti peggiorativi del volto (deformità, emiparesi, cicatrici) in nome della riconoscibilità del personaggio raffigurato. Allo stesso modo noi oggi possediamo, grazie alla grande diffusione della fotografia già verso la fine del XIX secolo, un presidio “meccanico” (absit iniuria verbo) in grado di fissare e rendere perpetui gli attimi della nostra memoria visiva, sottraendoli alla deformazione e all’usura del ricordo, insieme con l’immensa quantità di particolari che magari essa (la nostra memoria) aveva considerato trascurabili, e che invece si rivelano di importanza vitale nelle successive letture che la nostra (e però anche l’altrui) mente vorrà dedicare a quelle immagini, indagandole alla luce delle esperienze acquisite e del confronto con il contesto documentale di immagini coeve: occasioni preziose e spunti di indagine offerti in copia dal materiale fotografico, che si rivela - al pari di qualsiasi metodologia scientifica - strumento prezioso di trasformazione dell’esperienza in
154 MARIANO MALAVOLTA conoscenza.
Per me in particolare - ecco che vi dico come ho preso questo vizio - il confronto con il materiale fotografico ammucchiatosi alla rinfusa fra i ricordi di famiglia e l’indagine sul mio piccolo archivio di memoria ha avuto inizio proprio con un censimento delle foto che non erano state già raccolte in album dai miei: diverse centinaia di stampe e altrettanti negativi che già tanti anni fa ho provveduto a dividere per anno, isolando poi i numerosi doppioni e non mancando di informarmi su ciascuno scatto, col sottoporre a stringenti interrogatori mia madre, mio padre e i miei zii e le mie zie, e quindi scegliendo le stampe migliori per sistemarle in altri album, corredati di tutte le indicazioni disponibili. Questo lavoro, iniziato non a caso all’incirca nel 1971 (l’anno della mia laurea), è poi proseguito instancabilmente negli anni successivi, costandomi non poco tempo e non pochissimo denaro (soprattutto per le ristampe di negativi di cui non trovavo la stampa), e si è intrecciato con altre iniziative, quali la mostra fotografica dedicata a “Cossignano ieri (del 1979), che ha avuto esito in una pubblicazione finanziata dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (ai tempi del presidente Lelli). Inutile dire che l’indagine e soprattutto il lavoro di catalogazione e sistemazione ha coinvolto mia moglie (la più innocente delle vittime) e numerosi amici e conoscenti che ho avuto modo di tormentare a più riprese per procacciarmi parte del materiale. L’approdo alla rete, invece, lo devo a Walter Malavolta, che mi ha spedito via mail un centinaio di foto - conservate da Luigi Malavolta, mio padrino - e scattate nel periodo fra le due guerre da Emidio Malavolta, zio di Luigi. Posso dire che proprio questo è stato l’evento
FRA ANTICHITÀ E STORIA 155 scatenante, oltre che di un mare di lacrime, di questa mia recente ricaduta, dal momento che è stata la proposta di Walter, di creare un album su Flickr, denominato COSSIGNANO ALBUM, a rendermi visibile a Orarossa, che a sua volta mi ha interpellato proponendomi la partecipazione ad ASCOLI COM’ERA con un set denominato COSSIGNANO E I
MALAVOLTA. E non esagero se vi dico che immergermi ancora una volta in queste antiche immagini, riconsiderate all’indomani del compimento dei miei sessant’anni (e rotti), è stata un’esperienza di enorme interesse, oltre che un dono prezioso, che non pensavo potesse riservarmi così intense emozioni, innescando - ancora a quest’età tutto sommato avanzata, anche se non avanzatissima - tutta una serie di emozioni, di stimoli e di interrogativi sul senso più profondo della mia vita, insieme con la consapevolezza dell’inestimabile valore che si addensa attorno a questi innumerevoli granelli di sabbia della mia memoria.
Un archivio dell’effimero, dunque, questo di Mimmo (Orarossa), che nulla ha di effimero (almeno fino a che riusciremo a tenere in piedi il complicatissimo miracolo tecnologico di questo mondo globalizzato), ma che anzi si candida a divenire contenitore del più prezioso dei prodotti di ciascun individuo: queste lacrimae rerum, ossia la memoria, sempre più oggettiva, condivisa e leggibile, dei momenti che hanno reso umana la nostra esistenza e che potremo conservare come un’aura vitale, ritardando il momento inevitabile in cui anche queste preziose lacrime si perderanno nella pioggia.