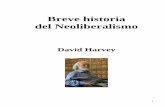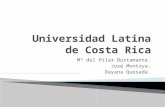Breve storia dell'ostia e dell'Eucarestia
-
Upload
liceojuvara -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Breve storia dell'ostia e dell'Eucarestia
Breve storia dell’ostia e dell’Eucarestia1
a cura di diego gulizia
I Vangeli raccontano che durante l’Ultima2 Cena, tenuta a Gerusalemme, in occasione della
ricorrenza della Pesah (Pasqua ebraica), Gesù, piuttosto che seguire la tradizione, disse: (15) «Ho
desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia
passione, (16) poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di
Dio». (17) E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, (18) poiché vi
dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio».
(19) Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è
dato per voi; fate questo in memoria di me». (20) Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi». (Luca
22,15-20)
Il “fate questo in memoria di me”, stando alle traduzioni della Bibbia C.E.I., Nuova Riveduta, Nuova
Diodati, è solo in Luca3 che lo riporta e non si riscontra negli altri Vangeli sinottici, pur narrando,
questi, sempre lo stesso episodio e lo stesso Luca riferisce che Cristo pronunciò queste parole solo
allo spezzar del pane e non lo ripeté per il vino.
Ma siccome Cristo sapeva che i fatti che sarebbero successi da lì a poco avrebbero demotivato i
suoi apostoli e questi stessi lo avrebbero rinnegato per salvarsi la vita, a Emmaus
[30] Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. [31]
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. (Luca 24,30-31)
Di questo episodio è solo Luca che ne parla, mentre Marco ne accenna succintamente. Dobbiamo
pure dire che Luca è l’unico a non essere presente allo svolgersi dei fatti e il suo vangelo è frutto di
indagini svolte da lui. 4
1 Buona parte di quanto è riportato nel presente lavoro, opportunamente adattato al fine del presente lavoro, è stato prelevato dallo scritto di
Mirella Lovisolo, presente nel sito http://www.saluzzo.chiesacattolica.it 2 I Vangeli Sinottici collocano l "ultima cena" dove avvenne l’istituzione dell’Eucarestia, in "una sala al piano superiore addobbata con
tappeti"(Mc.14,15), il cosiddetto "Cenacolo". I sondaggi archeologici condotti da padre B. Bagatti a Gerusalemme, hanno rivelato che nel luogo indicato oggi come il "Cenacolo" (una sala crociata medioevale) esiste traccia della sede di un antichissimo culto cristiano. E’ quindi probabile che proprio in quest’area sorgesse la casa dove Gesù, in quella notte tra il 13 e il 14 di Nisan (aprile) dell’anno 30, abbia celebrato la sua ultima pasqua terrena seguendo il rituale giudaico - cena notturna, canto dell’hallel, i segni dei pani azzimi e delle coppe di vino. Gesù però anziché ripetere le parole tradizionali dell’Esodo, introdusse alcune nuove e sorprendenti dichiarazioni; spezzando il pane azzimo disse: "Questo è il mio corpo" e sulla coppa di vino: "Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue" poi, con la solennità del comando aggiunse: "Fate questo in memoria di me"(Lc.22,19). (http://www.saluzzo.chiesacattolica.it/gris/articoli/arte_fede/eucaristia1.html) 3 Luca sente parlare per la prima volta di Gesù nel 37 d.C., quindi non ha mai conosciuto Gesù se non tramite i racconti degli apostoli e di altri
testimoni: tra questi ultimi dovette esserci Maria di Nazareth, cioè la madre di Gesù, poiché le informazioni sull'infanzia di Gesù che egli ci riporta sono troppo specifiche e quasi riservate per poterle considerare acquisite da terze persone. Inoltre è l'unico evangelista non ebreo. Il suo emblema era il toro, ovvero il vitello o il bue, secondo varie tradizioni e interpretazioni. (http://it.wikipedia.org/wiki/Luca_evangelista) 4 Il primo vangelo ad essere stato scritto è quello di Marco, il quale è databile al 70 d.C. Nonostante il nome che ad esso gli viene attribuito, lo scritto è anonimo e per tale motivo non è possibile dire chi fosse l'autore. Tenendo conto che la morte del Cristo si ritiene sia avvenuta intorno al 33 d.C, è plausibile pensare che questo personaggio anonimo sia potuto anche essere un evangelista: ma questa è tutta una teoria. Ci sono però dei problemi nella datazione, visto che un frammento [ http://it.wikipedia.org/wiki/7Q5 ] del testo di Marco è stato trovato tra quelli di Qumran e la sua datazione è anteriore di qualche anno a quella che si ritiene plausibile. Ma visto il dubbio degli studiosi è meglio non andare oltre. Tutti gli altri vangeli sono stati scritti dopo di questo: Matteo e Luca (attorno al 80 d.C.) ed infine Giovanni, la cui composizione ha subito varie fasi travagliate e arrivato ad ultimarsi il 100 d.C. Se pure, la tradizione cristiana, vuole vedere in Giovanni l'evangelista, è più probabile - tesi degli studiosi moderni- che siano stati i discepoli di questo a completarlo. Non è detto quindi, che una prima bozza non possa essere stata scritta dallo stesso Giovanni in persona. Fonti: "Difficile quindi che gli autori abbiano conosciuto direttamente Gesù"
Eppure, dovremmo dire, che sia l’invito a ripetere il gesto compiuto durante l’ultima cena e sia la
“fractio panis” di Emmaus siano i nodi centrali del cristianesimo.
Coerentemente con quanto riportato dal Vangelo di Luca, pare che le prime comunità cristiane
ripetessero il rito della “fractio panis” con lo stesso significato che attribuiamo noi all’Eucarestia.5
Di questo rito ci sono diverse immagini presenti nella catacombe che sono altamente significative,
come quella presente nella Cappella Greca delle Catacombe di Priscilla a Roma6
FRACTIO PANIS sec. II (part.) Cappella Greca. Catacomba di Priscilla –Roma
Non è affatto vero. Anzi, il 70 d.C. indica la data di fine della stesura del testo. Quindi, dalla morte di Cristo erano passati 37 anni. Tenendo conto che il libro potesse essere scritto al termine della vita e una vita media di 80 anni (cosa non rara al tempo) possiamo dire che se l'autore fosse morto a 80 anni nel 71 d.C., questo porta a pensare che avrebbe potuto incontrare Gesù benissimo. Averlo conosciuto, ed essere stato suo discepolo in quanto, l'apostolo in questione sarebbe nato circa 10 anni prima del Cristo. Nato: 9 a.C. Nascita di Cristo: lui aveva 9 anni Inizio delle scritture, Gesù aveva 30 anni: lui ne aveva 39. Gesù viene crocefisso: lui aveva 42 anni. Dopo un periodo di scrittura finisce il libro nel 70 d.C. : lui aveva 79 anni. Muore l'autore a 80 anni nel 71 d.C. Si noti che l'autore poteva avere anche più di 80 anni alla sua morte. Questo non cambierebbe molto. E che era prassi comune scrivere libri nei periodi conclusivi della vita, o in fase "matura", visto che erano i periodi umani di relativa calma (come è oggi la pensione d'altronde) come sorta di memoria e di lascito. 5 Il gesto dello "spezzare il pane" compiuto da Gesù, fu la prima denominazione della celebrazione eucaristica di cui parla nel II secolo la Didachè e
Ignazio di Antiochia, così Giustino che, nell’inviare la sua Prima Apologia all’imperatore Antonino Pio, descrive lo svolgimento dell’eucaristia nelle riunioni cristiane della domenica. A queste assemblee fa riferimento nel 112, Plinio il Giovane, scrivendo a Traiano: "Hanno abitudine di riunirsi in un giorno stabilito, prima del levar del sole e di cantare inni a Cristo come se si trattasse di un dio"(Ep.10,96) (http://www.saluzzo.chiesacattolica.it/gris/articoli/arte_fede/eucaristia1.html) 6 Un locale sotterraneo diviso da un arco, mostra sulle pareti affreschi che risalgono alla metà del II secolo d.C dove, tra festoni e ghirlande, sono
raffigurati episodi biblici. Nell’arco della nicchia centrale che conclude l’ambiente è dipinta, su uno sfondo rosso pompeiano, una mensa presso la quale sono disposte sette figure: cinque uomini adagiati sul divano tricliniare, una donna seduta col capo velato e, all’estremità destra, nel posto d’onore, un uomo barbato che indossa tunica e pallio; è seduto, ha le braccia protese sulla mensa e compie l’atto di spezzare il pane. Davanti a lui un calice, un piatto con due pesci e un altro piatto con cinque pani. Ai lati della mensa sette ceste contenenti dei pani: tre da una parte quattro dall’altra. (http://www.saluzzo.chiesacattolica.it/gris/articoli/arte_fede/eucaristia1.html)
O quelle presenti nelle catacombe di S. Callisto
Roma, catacombe di S. Callisto: cena eucaristica
Roma, catacombe di S. Callisto: cena eucaristica.
Roma, catacombe di S. Callisto: cena eucaristica
Quasi tutte le rappresentazioni, comunque, riportano sette figure, in quanto il numero sette è un
numero simbolico e indica come tutti sono chiamati alla salvezza.
L’ultima cena, così come la intendiamo noi, pertanto, non veniva raffigurata dai primi cristiani, in
sua vece ritrovano, nelle catacombe, immagini di un banchetto e della fractio panis,
accompagnate, a volte, dalla raffigurazione del sacrificio di Isacco e da due figure in piedi accanto
ad una tavola con due pesci, come chiara allusione all’agape, alla cena eucaristica delle prime
comunità.
Come è possibile vedere, la “fractio panis” viene continuamente associata alla moltiplicazione dei
pani e dei pesci. I pesci e le ceste di pane rinviano, di solito, al segno della moltiplicazione dei pani
e dei pesci, unito alla promessa di un pane che non viene meno: “Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha la vita eterna” (Gv.6).
Roma, catacomba di San Callisto
Nei sarcofagi cristiani è presente la raffigurazione del miracolo dei pani come allusione al cibo
dell’Eucaristia, per indicare la fede e la speranza in Cristo.
La “fractio panis”, come rievocazione del gesto di Cristo compiuto nell’ultima cena, è una delle
prime espressioni per designare la cena eucaristica. Troviamo traccia delle riunioni cristiane della
domenica sia nella Didachè, in Ignazio di Antiochia e nella prima Apologia che Giustino dedicò ad
Antonino Pio, ove descrive lo svolgimento dell’eucarestia. Plinio il Giovane scrive nel 112 d.C.
riportando che i cristiani nel giorno della domenica usavano riunirsi all’alba e cantare inni a Gesù
Cristo. (Ep.10,96)
Nell’Evangeliario di Rossana, del V secolo, appare la raffigurazione i Gesù che consegna in mano
agli Apostoli il pane eucaristico . La comunione veniva infatti ricevuta in mano, il pane era offerto
in forme circolari, dopo la Consacrazione, al canto dell’Agnus Dei, i pani venivano spezzati in piccoli
frammenti - con un simbolismo che rimanda al corpo di Cristo spezzato durante la Passione -
e veniva distribuito dai diaconi ai fedeli che lo ricevevano in mano.
In S.Vitale a Ravenna l’offerta del pane fatta da Melchisedech, figura di Cristo (Gn.14,17-20) è
costituito da pani circolari.
CAPUA – S. ANGELO IN FORMIS - Sec.II - Ultima Cena
Melchisedec offre un pane circolare mentre la mano di Dio accoglie l’offerta
Nella Basilica Inferiore di S.Clemente a Roma del sec. XI, alla ‘Messa’ del santo, due piccole figure (ragazzi o bambini) avanzano portando nelle mani il pane rotondo dell’offerta. L’uso si conservò sino al sec. IX., quando l’offerta in natura venne sostituta da offerte in denaro, diventate anche oggi la forma simbolica dell’offerta liturgica con la quale il fedele si unisce al grande atto che si compie sull’altare. Nel sec. XI , la pratica dell’offerta del pane e del vino da parte dei fedeli decadde, venne introdotto l’uso delle "ostie", un termine che significa "vittima". Nel ‘400 Beato Angelico nell’armadio degli argenti del Museo di S. Marco a Firenze, presenta in una scena articolata il momento in cui gli apostoli nel Cenacolo vengono comunicati da Cristo con le ostie. Anche la raffigurazione della Cena si aggiorna. Il Duomo di Modena nello stupendo ciclo della
Passione del pontile, realizzato tra il 1165-75 da Anselmo da Campione e dalla sua bottega,
presenta un bassorilievo policromo di influenza provenzale, dove le compatte figure si dispongono
in ritmo serrato lungo la tavola orizzontale mentre Cristo consegna a Giuda il boccone intinto.
Il Anselmo da Campione, Pontile con il ciclo della Passione, 1165-75, Duomo di Modena
secolo XIII-XIV, per influsso della predicazione francescana e domenicana, si predilige la
meditazione dei "misteri" di Cristo Crocifisso, ma nel sec. XV la struttura iconografica della Cena
viene ripresa e collocata sugli sfondi prospettici del nuovo gusto rinascimentale: Ghirlandaio in
S.Marco a Firenze, Andrea del Castagno nel Cenacolo di S.Apollonia e altri.
Ghirlandaio, Cenacolo del Convento di San Marco, Firenze
Figura 1Andrea del Castagno, Cenacolo di Sant'Apollonia, Firenze
Alla fine del ‘400, Leonardo da Vinci, nell’Ultima Cena realizzata nel Refettorio del Convento di S.
Maria delle Grazie a Milano, presenta il momento animato in cui Gesù, nell’atteggiamento del
totale abbandono, esclama "Uno di voi mi tradirà". L’artista "restituisce, nella forza dell’immagine,
l’attimo cruciale nel quale si condensa l’evento fondatore del sacramento memoriale cristiano. La
genialità dell’intuizione leonardesca sta proprio nell’aver individuato la densità drammatica del
momento scelto, l’ombra del tradimento nell’intimità di agape. (Sequeri).
Leonardo da Vinci, Cenacolo di Santa Maria delle Grazie, Milano
Un secolo più tardi in pieno clima post-tridentino Jacopo Robusti detto Il Tintoretto, compone, in
una luce corrosiva che annienta le forme, una scena scandita diagonalmente in due parti dal lungo
tavolo, dove Gesù, che ha l’aureola splendente come i raggi aperti di un ostensorio barocco,
"comunica" gli apostoli. Giuda, che non ha l’aureola, se ne sta isolato sul lato opposto. Il dramma
si svolge stupendamente spettacolare su un palcoscenico illimitato, aperto verso il luminoso
infinito, dove irrompono gli angeli aprendo uno squarcio di liturgia celeste.
Tintoretto, Ultima Cena, Basilica di San Giorgio Maggiore, Venezia
Ma il culto eucaristico è ormai per eccellenza il Corpus Domini.
Con il 1500 il culto eucaristico, espresso in nuove dimensioni popolari, è ormai centrale nella
religiosità cristiana. "Prendete e mangiatene TUTTI, questo E' il mio corpo". Cristo che si fa cibo e
speranza di vita eterna per tutti gli uomini – non solo per alcuni eletti,– resta attraverso i secoli
nella vita e nell'arte.
Gli ebrei hanno un termine che designa l’aspetto più santo della spiritualità ebraica:
la shekhinà, che è la "gloria", cioè la "presenza" di Dio sul coperchio dell’arca tra i cherubini;
l’Arca, che conteneva le tavole della legge, la verga di Aronne e la manna, si trovava nel Santo dei
Santi (Sancta Sanctorum) di Gerusalemme, davanti al quale bruciavano le lampade
della menorah, il candelabro dalle sette braccia. Nelle sinagoghe gli ebrei continuarono sempre a
pregare rivolti verso Gerusalemme, anche dopo la distruzione del tempio.
I primi cristiani invece, pur uscendo dalla sinagoga ebraica, non pregavano rivolti verso
Gerusalemme , ma rivolti verso oriente, là dove sorge il sole, simbolo di Cristo "sole di giustizia".
La mensa, l’altare dove si "spezza il pane" e si celebra la morte e risurrezione di Cristo, diventa
la Shekhinà in cui, Dio non solo è presente, ma per amore, si fa cibo di vita eterna, "pane vivo
disceso dal cielo" (Gv 6,51).
Il simbolo più noto del Pane eucaristico, che nel sec. XI assume la forma dell’ostia, diventerà nel
‘300 il trigramma del nome di Cristo (JHS= Gesù salvatore degli uomini) proposto da S.
Bernardino da Siena, un simbolo molto diffuso, presente anche in tutte le antiche chiese Saluzzo.
Nell’altare, luogo della celebrazione e simbolo di Cristo, come abbiamo visto, venivano collocate le reliquie dei testimoni, i martiri in riferimento ad Ap.6,9. Erano conservate in cassette di legno e avorio le capselle; alcune di queste sono opere di alto valore storico e artistico, come la capsella di Samagher (Venezia Museo Archeologico) e la Lipsanoteca di Brescia. Dal IX secolo le reliquie vennero spesso collocate in un’urna sopraelevata sull’altare, su cui si innalza un piccolo padiglione d’onore; nelle chiese gotiche francesi quest’uso è molto frequente. Siccome non tutte le chiese avevano le reliquie, in mancanza di queste, sull’altare, venivano poste delle icone e delle statue sino a creare strutture a dossale di grandi proporzioni, spesso con sportelli apribili, dipinti all’esterno e all’interno. Un uso che si generalizzò e di cui abbiamo un
Pinacoteca di Siena, Trigramma del nome "Gesù" di S.Bernardino da Siena
notevole esempio a Staffarda nel polittico di Pascale Oddone del 1531. Un’altra struttura di grande interesse è ancora visibile in chiese di influenza bizantina. E’ l’iconostasi che in S. Marco a Venezia che presenta i 12 apostoli, opera trecentesca di Jacobello e Pierpaolo delle Masegne; oppure il pontile, o jubè, come quello bellissimo del Duomo di Modena con l’Ultima Cena scolpita da Anselmo (o Bonino) da Campione, precedentemente citata.
Jacobello e Pierpaolo delle Masegne, Iconostasi della Chiesa di San Marco a Venezia
Queste strutture che erano presenti nella maggioranza delle chiese, vennero distrutte nel 1600.
L’iconostasi costituiva lo sviluppo del cancello che, originalmente, separava il presbiterio dalla
navata; ampliandosi, divenne un vero diaframma che rese impossibile ai fedeli partecipare alla
celebrazione eucaristica e, mentre il timore dell’inadeguatezza allontanava i fedeli dalla pratica
Abbazia di Staffarda (Cn) - Abside con il Polittico di Pascale Oddone 1531
della Comunione, emergeva nel popolo - sensibilizzato
dalla meditazione del mistero della Passione di Cristo - il
desiderio di vedere l’Ostia consacrata, la Vittima del
sacrificio. Si crearono allora pissidi trasparenti di vetro
prezioso, ma soprattutto venne introdotto nella Messa
dopo la Consacrazione, il rito dell’Elevazione dell’ostia e
poi del calice, come appare in una formella di Maso di
Banco (trecentesco scolaro di Giotto), che si trova del
Museo dell’Opera di Firenze.
Con l’eresia di Berengario di Tour (1088), che metteva in dubbio la presenza di Cristo nell’Eucaristia, venne istituita nel sec. XIII la Festa e la Processione del Corpus Domini, ispirata da S. Giuliana di Liegi, e istituita da Urbano IV in seguito al miracolo di Bolsena. Questo fatto miracoloso, che segue quello accaduto a Lanciano nell’VIII secolo, avvenne nel 1263 quando l’ostia spezzata dal sacerdote Pietro di Praga, dubbioso sulla
presenza di Cristo, sprizzò sangue vivo. Il corporale macchiato in quella Messa, venne conservato ad Orvieto nella splendida cattedrale gotica, appositamente costruita nel 1309-1330 e sottilmente decorata da Lorenzo Maitani. Il fatto di Bolsena venne rappresentato da Raffaello nelle Stanze Vaticane nel 1512. Dalla fede vivissima nell’Eucarestia accaddero altri fenomeni mistici, come quelli di Torino: il tabernacolo della chiesa del Monte dei Cappuccini reca ancora il segno dello scasso da parte dei ladri allontanati da una fiamma improvvisamente uscita dalla porticina; la Chiesa del Corpus Domini a Torino sorse sul luogo di un miracolo eucaristico avvenuto il 6 giugno 1453.
Orvieto, facciata del Duomo
Maso di Banco, Formella con l'eucarestia, Firenze
L’adorazione eucaristica, l’esposizione prolungata del SS Sacramento, le S. Quarantore, diedero un impulso straordinario alla costruzione degli ostensori che comparvero in Germania nel sec. XIV. Sono preziosissime opere di oreficeria, oggi conservate presso i Musei delle Cattedrali. Alle volte l’ostensorio raggiungeva le dimensioni di alcuni metri come quella del Duomo di Genova. Nel 1600 per le processioni del Corpus Domini, l’ostensorio assunse la forma del sole raggiante giunta sino a noi. Il dramma della Riforma Luterana che spoglia le chiese delle immagini e di ogni superflua
decorazione, spoglia altresì gli edifici di culto della presenza di Cristo Eucaristia per privilegiare,
nella fredda nudità dell’ambiente, la Parola e il canto.
La Chiesa cattolica che in epoca rinascimentale aveva semplificato l’esuberanza gotica sul
modello dell’essenzialità classica, alla fine del ‘500, reagendo alla Riforma, rifonda un’arte di
gusto popolare, iconografica e scenografica che sfocerà nel trionfalismo barocco dove l’oro, il
colore, la suggestione luministica, esprime ed esalta la Divina Presenza dell’Eucaristia, custodita
nel tabernacolo dell’altare.
Fino al IX secolo il "tabernacolo" - termine che significa "tenda" - non c’era; l’Eucaristia era
custodita in sagrestia o nelle "colombe eucaristiche" del ciborio, nel sec. XIII era collocato in
apposite edicole murali. Nel 1600 S. Carlo Borromeo accolse per la sua diocesi la proposta di
porre il tabernacolo sull’altare. In seguito, tale uso venne caldeggiato dal papa, finchè,
nell’Ottocento, il tabernacolo sull’altare, inserito nel ricco dossale, divenne l’unica forma di
custodia e assunse talvolta la forma di tempietto.
Dopo le vicende dei secoli successivi, il concilio Vaticano II togliendo "ciò che era stato meno
utilmente aggiunto", semplificherà le strutture e l’altare, sobriamente concepito come alle
origini, tornerà ad essere il centro intorno a cui si riunisce l’assemblea dei fedeli per celebrare la
"cena del Signore", la Messa.
La conservazione eucaristica, avrà una collocazione propria nell’apposita cappella
dell’adorazione. Nella maggioranza delle nuove chiese, la luce, simbolo di Cristo "luce del
mondo", irrompe suggestiva come nella Cappella di Ronchamp di Le Corbusier, o riempie le
chiese come il canto altissimo di una nuova spiritualità, con l’immaterialità cromatica e luminosa
delle vetrate colorate di Matisse a Vence e di Costantino Ruggeri nella Chiesa del Divino Amore di
Roma.
Le Corbusier, Cappella di Rochamp - interno ed esterno
Matisse, Cappella di Vence, interno
Roma, Chiesa del Divino Amore, Vetrate di Costantino Ruggeri
Concludiamo l’indagine volgendo, dal nostro tempo "post- moderno", uno sguardo prospettico a questi secoli di cristianità. Attraverso le sovrastrutture del tempo, ci appare il punto focale, la costante: "Cristo, pane spezzato", presente da 20 secoli sugli altari della Chiesa come sulla mensa della comunità del primo secolo, quando Paolo esortava i Corinzi: "Il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e disse ‘Questo è il mio corpo che è per voi …questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me’ (1Cor.11,23-25).
Breve storia dell’ostia
La parola ostia viene dal latino hostia, “vittima”, in quanto il pane rappresenta nell’Eucarestia il
corpo di Gesù, vittima sacrificale. La trasformazione dal pane dei primi cristiani alla sottile sfoglia
di fior di farina non avvenne in un momento preciso, ma con un passaggio lento e graduale. Fin
dall’inizio il pane con cui veniva celebrata l’Eucarestia era piuttosto piatto, perché si trattava di
pane azzimo, non lievitato, che non si gonfia con la cottura.
Pane azzimo cotto sulla brace
L'uso del pane azzimo è importante nella religione ebraica e in quella cristiana.
Gli ebrei mangiano pane azzimo (in ebraico matzah, IPA: ma'tsa) durante la מצה,
settimana pasquale (15-21 di Nisan), celebrata in ricordo dell'uscita del popolo israelita dall'Egitto,
secondo la prescrizione contenuta nel capitolo XII dell'Esodo; la preparazione del pane azzimo
spettava ai leviti.
Il pane azzimo entrò in uso solo nella chiesa latina, mentre in quella orientale rimase in uso il pane
lievitato.
L’uso del pane azzimo nella religione cristiana suscitò una accesa disputa, che va sotto il nome di
controversia sugli azzimi, sorta tra il 1052 e il 1053 contro la Chiesa latina accusata di utilizzare per
l'eucarestia il pane azzimo, e non quello fermentato come si usava nelle Chiese orientali antiche,
ad opera del patriarca di Costantinopoli Michele Cerulario.
L'uso del pane azzimo nelle Chiese latine veniva spiegato con il fatto che Gesù istituì il sacramento
dell'eucaristia nella settimana pasquale durante la quale, secondo la prescrizione delle leggi
ebraiche, ci si serviva soltanto di pane azzimo. La Chiesa bizantina, invece, utilizzava per
l'eucarestia del pane fermentato.
La controversia venne discussa con passione da ambo le parti, ma i testi utilizzati non furono
dirimenti perché troppo vaghi o apocrifi. Solo più tardi, nel II concilio di Lione (1274) e in quello
di Firenze (1439) la Chiesa latina dichiarò, che per la consacrazione eucaristica, sono ugualmente
validi sia il pane azzimo che quello fermentato e che i sacerdoti delle due Chiese, la Latina e
l'Orientale, dovevano seguire l'uso invalso presso la propria Chiesa, ma senza pregiudizio.
La forma schiacciata del pane consacrato cominciò ad apparire in Oriente alla fine del quarto
secolo. San Epifanio, morto nel 403 d.C., fu il primo a fare degli accenni su questo tipo di pane
rotondo "Hoc est enim rotundae formae". Anche in Occidente le ostie, dopo il quinto secolo,
assunsero la forma arrotondata, ma di diametro superiore e di spessore notevolmente maggiore di
quelle odierne.
II più antico stampo di pietra fu trovato a Cartagine ed è risalente al sesto secolo.
A partire dall'undicesimo secolo si utilizzò d'abitudine un'ostia più grande destinata al sacerdote e
una più piccola per i fedeli; la produzione avveniva nei monasteri ed era riservata agli uomini.
Verso l'inizio del secolo dodicesimo diminuirono la dimensione dei pani e si formarono
simultaneamente più ostie, sovente grandi e piccole.
II più antico ferro da ostie datato che si conosca in Italia risale al 1132 ed è conservato al museo
del vino di Torgiano (Pg).
Ferri per ostie della collezione del Museo di Torgiano (Pg)
Ostie per l'eucaristia cattolica, preparate senza fermentazione
Stampi per ostie con simboli religiosi
La decorazione degli stampi per ostie aveva come temi principali l'Agnello Pasquale, la
flagellazione, la crocifissione ed i monogrammi IHS e IHC, completati a volte da XPS.
Stampi per ostie personalizzate dalle famiglie nobili
A partire dal XV sec. la produzione passò anche in mano ai
laici e con il tempo le immagini incise sui ferri assunsero,
oltre al simbolo della sacralità, la funzione profana di
contraddistinguere un casato o una proprietà.
Il Rinascimento fu il periodo dell’ostia personalizzata,
quindi i ferri portavano incisi con gli stemmi araldici, i
nomi dei proprietari e talvolta quelli dell'incisore. A partire
da questo momento iniziò la produzione di ferri di grande
pregio artistico.
In Umbria i nobili ed i vescovi facevano decorare i loro
ferri dagli orafi, in Spagna questi strumenti entravano nei
beni inventariati delle diocesi, mentre in Francia non
mancavano nelle liste di nozze delle famiglie borghesi
facoltose.
Il ferro, riportato accanto, è cesellato e presenta, su di un
piatto, uno stemma partito: a destra increspato in tre
fasce a sinistra una vespa; nella zona intermedia dodici
festoni sorretti da bucrani, al di sopra dodici serafini; sul
bordo esterno la scritta: +GIOVAM.BATISTE. DE. S PIETRO. Stampo per fare ostie, 1512 in ferro cesellato
di 16 x 86
DE. S LORENZO. E. PATRONE. DE. LI. FERRA. COMO. PENSO. MDXII. Sull'altro piatto al centro uno
stemma femminile con due semisfere con due punti, sormontato da una X e da una doppia croce;
intorno tre ordini di decorazioni e all'esterno la scritta: +COLVI. CHE. FA. LE. CIALDE. HA. BEL.
TACERE. CHE. EL PIV. BEL. TENPO. CHE SE. POSSA AVERE
Custodia dell’ostia
L’ostia è stata da sempre custodita, ma non solo all’interno delle mura della chiesa. In effetti la
custodia pubblica e solenne, come, d’altronde, i riti del culto eucaristico (esposizione, benedizione,
processioni, ecc.) sono maturati nei secoli ed hanno uno sviluppo storico ben definito.
L’Eucarestia è sempre stata conservata, intimamente adorata e frequentemente assunta anche
fuori della celebrazione.
Essa veniva consegnata ai diaconi per gli assenti e i fedeli stessi, laici ed eremiti, la portavano con
sé nelle loro dimore per cibarsene frequentemente.
La custodia eucaristica nasce così nelle case dei cristiani per conservare con circospezione il
Sacramento.
I pellegrini la portavano avvolta in un piccolo panno e con una corda appesa al collo in quanto,
data la pericolosità del viaggio e la possibilità di potere morire durante il pellegrinaggio, prima di
spirare qualcuno gliela avrebbe potuto somministrare.
Stampo per ostie in ferro battuto di origine olandese
Le ostie non consacrate venivano offerte durante i pellegrinaggi o nei giubilei; distribuite alle porte
delle chiese permettevano ai fedeli di sostentarsi fino all'ora dei pasti. Il loro consumo non violava
i precetti della Chiesa, perché non venivano considerate un alimento, ed erano un risparmio per il
pellegrino che le riceveva gratuitamente.