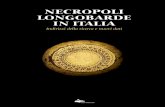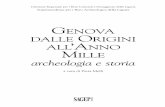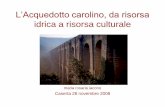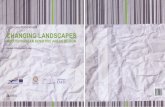Paesaggi dello zafferano. La riscoperta di una risorsa
Transcript of Paesaggi dello zafferano. La riscoperta di una risorsa
AlimentAzione, Ambiente,Società e territorioper uno Sviluppo SoStenibile e reSponSAbile
Contributi e riflessioni geografiche a partire dai temi di Expo Milano 2015 A cura di Alessandro leto
Supplemento al numero 2/3, 2015, anno 60, di Ambiente Società Territorio Geografia nelle ScuoleISSN 1824 – 114XPubblicazione riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali “di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti” e classificata dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) “rivista scientifica” per l’Area 11 della quale fa parte la Geografia.Rivista dell’associazione Italiana Insegnanti di GeografiaSocietà di cultura del territorio(membro della European Standing Conference of Geography Teachers).Associazione accreditata alla formazione del personale docente dal MIUR con il quale ha firmato un Protocollo d’intesa.Direttore: Carlo BrusaProgetto grafico: Claudia CrociPreparazione redazionale: Michele Pigliucci
IV
V
IndiceAlessandro Leto, Premessa metodologica III
I Le Società geografiche ed Expo 2015 Sergio Conti, Paesaggi culturali, patrimoni del gusto 1Gino De Vecchis, Il mondo della nutrizione: ragionamenti geografici per la ricerca e la didattica 7Franco Farinelli, La geografia, il budino, la prova 11
II La geografia ed Expo 2015: realtà, percezione, “Carta di Milano” Carlo Brusa, La Geografia e le “idee di Expo 2015”: dai percorsi di visita all’Esposizione Universale agli impegni della “Carta di Milano” per gli anni futuri 15
III Alimentazione, culture, territori Elena Dell’Agnese, Dalle radici alle rotte: intersezioni e percorsi nella geografia culturale del cibo 19Riccardo Morri, Cibo, memoria e territorio 23Daniela Pasquinelli D’Allegra, Stili alimentari, geografia e intercultura.Piste di ricerca e spunti progettuali per la scuola 27Luisa Spagnoli, Nuovi orizzonti agricoli e paesaggistici. Un mondo rurale in trasformazione 31
IV Alimentazione, ambiente, sviluppo sostenibile e responsabileSimone Bozzato, Paesaggi tipici. Eterogeneità territoriale ad alto impatto turistico 35Claudio Cassardo, Naima Vela e Valentina Andreoli, Cambiamenti climatici e loro ripercussioni sulle risorse idriche: l’esempio dell’area alpino-padana 39Alessandro Leto, Evoluzione del concetto di Sviluppo: da Sostenibile a Sostenibile e Responsabile 49Fausto Marincioni, Cibo in emergenza; facilitare il ritorno alla normalità con i saporidella cucina locale.
55
Maria Paradiso, Geopolitica del Mediterraneo, cambiamento climatico, cibo e vita delle persone 59Michele Pigliucci, Lo sviluppo sostenibile e responsabile e l’impatto ambientale dell’industria zootecnica 63
V Esempi e casi di studioMichele Castelnovi, Il cibo nell’Impero cinese secondo l’Atlante di Martino Martini 69Pierluigi Magistri, Paesaggi dello zafferano. La riscoperta di una risorsa 73Alessia Mariotti, Il paesaggio nel bicchiere: il vino come risorsa turistica 81Paola Pepe, Alimentazione sostenibile e tradizione. Consumo critico dei prodotti ittici: il casodel tonno del Mediterraneo 85Antonella Primi, Le TIC a sostegno delle donne nelle aree rurali dell’Africa sub-sahariana 89Chiara Rabbiosi, Alimentazione e ibridazione geo-culturale. Note dall’Argentina 93Sergio Zilli, Dal Tocai al Friulano, dal Prosecco a Prosecco. Di vini e geografia in Friuli Venezia Giulia 97
III
II
I
73
PIERLUIGI MAGISTRI
PAESAGGI DELLO ZAFFERANO. LA RISCOPERTA DI UNA RISORSA
L’ormai imminente avvio dell’Esposizione Universale di Milano 2015 ha acceso i riflettori su un
tema particolarmente importante, a scala globale, qual è l’alimentazione. Di conseguenza anche
l’agricoltura, che è il settore basilare di produzione dei beni destinati all’alimentazione stessa, ne è stata
significativamente interessata. Ma, come ha insegnato la pluridecennale esperienza europea della Politica
Agricola Comune31, la produzione alimentare non può e non deve declinarsi esclusivamente in termini
quantitativi, a discapito dell’ambiente e della qualità della vita, della biodiversità e della genuinità dei
prodotti, oltre che delle tradizioni culturali di specifiche regioni. È fondamentale, infatti, che si presti
attenzione alla qualità e ad una qualità certificata: dei cibi, innanzitutto, ma anche dell’ambiente, nel
quale essi vengono prodotti, e dei paesaggi, che di quelle produzioni sono il risultato più evidente e
maggiormente visibile, nei quali, alla componente ambientale, si intreccia quella antropica. In realtà
negli ultimi anni, almeno in quei paesi che hanno maturato una forte coscienza ambientalista, una
particolare attenzione è stata posta al tema della qualità accanto a quello della riscoperta di un tipo di
agricoltura “neo-tradizionale”, che ripensa se stessa, cioè, nel segno della sostenibilità32. Sempre più
spesso, infatti, si sente parlare di produzioni biologiche, a chilometri zero, a basso impatto ambientale e
così via, con una significativa riscoperta delle specificità territoriali e delle tipicità locali.
In tale contesto ben si inserisce la coltivazione del crocus sativus, pianta erbacea risultato dalla
domesticazione e selezione di un croco selvatico33, al fine di ricavarne una spezia particolarmente
pregiata e costosa, apprezzata per moltissime qualità ed impiegata per diversi usi (dalla medicina alla
cosmesi, dalla cucina alle pratiche religiose, eccetera): lo zafferano.
La nicchia di origine di questa pianta non è precisamente individuabile, sebbene si possa ipotizzare
debba collocarsi fra le terre del Mediterraneo centrale (Creta o la penisola anatolica) ed il Vicino
Oriente (in particolare l’Iran)34. Tuttavia la sua coltivazione è già attestata in tutto il Mediterraneo ed il
Vicino Oriente da fonti assai antiche: da racconti, miti e leggende, ma anche da reperti archeologici (fig.
1) risalenti alla civiltà minoica, all’antico Egitto, a quella persiana della dinastia Achemenide, passando
per la tradizione ebraica, per la Grecia classica, la Roma imperiale e fino al periodo delle grandi
immigrazioni di popolazioni alloctone all’interno del limes romano, meglio conosciute come invasioni
barbariche. Con l’avvento delle culture romano-barbariche questa produzione subì, almeno nei territori
“occupati”, una fase di abbandono, finché, dopo un arco cronologico relativamente lungo, non venne
reintrodotta nelle regioni europee del Mediterraneo Nord-occidentale ad opera degli Arabi, fra VIII e X
secolo, e, successivamente, si diffuse anche in altre realtà territoriali dell’Europa settentrionale, in
particolare in Inghilterra, dove venne importata intorno alla metà del XIV secolo35, segnandone non
31 Per un inquadramento in materia si veda Società Geografica Italiana 2012, pp. 49-55 e anche Mafrici A. 2011, pp. 121-160. 32 A tal proposito, per quanto riguarda il dibattito scientifico, si veda, ad esempio, il volume curato da Lichtfouse E., Navarrete M., Debaeke P., Souchère V. e Alberola C. 2009. 33 Si ritiene che l’antenato del croco sativo sia il crocus cartwrightianus. 34 La letteratura esistente, nella maggior parte dei casi, propone diverse localizzazioni come ambiente endemico della pianta. Ad esempio, secondo Neghbi (2005, p. 1) la nicchia d’origine del moderno croco sativo sarebbe l’isola di Creta, mentre altri, fra i quali Kafi, Hemmati Kakhki e Karbasi (2006, p. 2), ritengono che l’area originaria di domesticazione della stessa sia stata l’Iran. 35 Golmohammadi F. 2014, p. 578.
solo il paesaggio delle aree di arrivo, ma lasciandone traccia perfino nella toponomastica, come nel caso
della cittadina di Saffron36 Walden, nella contea dell’Essex, oppure nella strada londinese di Saffron Hill.
In Età Moderna, poi, la produzione di zafferano subì nuovamente una fase di declino a seguito
dell’introduzione di altre spezie provenienti da oltreoceano, limitandone così la produzione, rimasta
significativa solo nelle regioni di antica tradizione. Per alcune di esse, inoltre, a partire dal secondo
dopoguerra, sono intervenuti nuovi fattori di contrazione nella produzione, in modo particolare la
meccanizzazione dell’agricoltura e la sua “industrializzazione”, che si sono avvantaggiate
dell’innovazione tecnologica e che hanno favorito le produzioni monoculturali economicamente più
redditizie. In definitiva, dunque a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, in diverse realtà
europee, si è avviato un radicale ripensamento dell’agricoltura, condizionato da cause diverse, ma agenti
contestualmente: l’affermarsi del settore secondario e terziario a discapito di un settore primario ormai
obsoleto; l’avvio di un nuovo processo di internazionalizzazione dell’economia, che ha riguardato anche
la produzione agricola; il verificarsi di un esodo di popolazione dalle aree rurali, che ha causato una
forte emorragia di forza-lavoro da quelle aree (per lo più interne e montuose) nelle quali il settore
agricolo non beneficiava di caratteristiche fisiche ed ambientali richieste da una più recente forma di
conduzione del settore primario37. Ma anche l’aumentato costo del lavoro ha giocato una parte di non
poco momento in questo processo di decremento antropico nelle aree rurali più marginali rispetto ai
poli urbani, naturale sede delle industrie e, pertanto, luoghi di aggregazione della popolazione.
Fig. 1. Raccoglitrici di zafferano. Particolare dell’affresco rinvenuti nella Xesté 3 di Akrotiri a Thera,
XVII sec. a.C.
Di questo nuovo contesto socio-economico ed organizzativo-territoriale la coltivazione di croco si
è dimostrata una sorta di indicatore, in quanto ha risentito in maniera assai significativa, più di tante
altre tipologie di colture, delle conseguenze dello spopolamento delle aree rurali più disagiate, quelle,
cioè, nelle quali essa si era maggiormente adattata e diffusa.
36 Il termine saffron è un vocabolo di derivazione persiana (da sahafran che a sua volta viene dalla parola asfar cioè giallo) utilizzato, insieme ad altre varianti che si sono cristallizzate nelle lingue moderne (per esempio zafferano in italiano, azafrán in spagnolo, safran in francese, e così via), per indicare la spezia ricavata dagli stimmi del croco sativo. 37 Per un approfondimento dell’argomento si veda Grillotti Di Giacomo M. G. 2005, Grillotti Di Giacomo M. G. 2000, Grillotti Di Giacomo M. G. e Moretti L. (a cura di) 1995, Salvatori F. 1994, Ruggieri M. 1976.
75
Le caratteristiche colturali e produttive di questa pianta, infatti, e del suo derivato hanno
determinato, nei paesi in cui la meccanizzazione dell’agricoltura ha svolto un ruolo fondamentale nella
trasformazione del settore primario e, di conseguenza, dei paesaggi rurali, una forte contrazione in
termini di estensione di suolo destinato a questa coltura. A ciò deve sommarsi la difficoltà di
meccanizzazione, se non di tutte, almeno di buona parte delle fasi del processo di produzione della
spezia: dall’impianto del bulbo, alla raccolta degli stimmi, alla loro trasformazione nella preziosa spezia.
Fig. 2. Diffusione, a scala globale, della coltivazione di croco sativo
Tuttavia, osservando la situazione che riguarda la coltivazione del croco ed il caratteristico paesaggio
che ne consegue, a scala globale38 (fig. 2), ci si rende conto delle enormi differenze che interessano le
diverse regioni di produzione. Ci sono, infatti, delle realtà territoriali in cui tale produzione continua a
rappresentare una fra le principali (se non la prima in assoluto) fonti di reddito per la popolazione
locale. È questo, ad esempio, il caso di alcune aree dell’Iran, al primo posto nella classifica mondiale per
la coltivazione di croco. L’Iran, infatti, annualmente fornisce la stragrande maggioranza dello zafferano
a scala mondiale39, con circa 40-50.000 ettari di suolo dedicati a detta coltivazione, per una resa che si
aggira fra le 160 e le 230 tonnellate di prodotto40, imponendo così la primazia nel settore della
zafferanicoltura. A netta distanza seguono altre realtà come la Spagna, l’India, la Grecia, l’Azerbaijan ed
il Marocco. L’Italia, con circa 30-35 ettari di superficie dedicata alla coltivazione del croco sativo e con
38 Con la globalizzazione dei traffici e dei mercati, conseguente alle esplorazioni geografiche e alla scoperta dei nuovi continenti, la coltivazione di croco, oltre ad interessare l’Europa, il Vicino ed il Medio Oriente e l’Africa mediterranea, ha raggiunto anche il Nord America, l’Estremo Oriente e l’Oceania, sebbene la produzione di zafferano in tali realtà sia quasi trascurabile. 39 Purtroppo le fonti a tal proposito sono discordanti indicando in quella iraniana una produzione che varia tra il 65% ed oltre il 90%. A tal proposito si veda, ad esempio, ancora Golmohammadi F. (2014, p. 579) che quantifica la produzione iraniana al 90-93% del raccolto mondiale; mentre Kaloo M. J., Patidar R. e Choure T. (2014, p. 817) quantificano la stessa produzione all’88% e Kafi M., Hemmati Kakhki A. e Karbasi A. (2006, p. 2), utilizzando evidentemente dati meno recenti, riferiscono di un 65% di produzione rispetto alla scala mondiale. 40 Anche in questo caso le fonti sono alquanto discordanti.
una produzione annua che si aggira intorno 0,2-0,4 tonnellate41, rappresenta il fanalino di coda dei
principali paesi produttori della spezia, sebbene fino ad un paio di secoli fa, principalmente attraverso
l’istituto camerale dell’Aquila e la coltivazione abruzzese della Piana di Navelli e, più in generale,
dell’intera provincia, abbia giocato un ruolo di non secondario piano a scala continentale42. E mentre
per le regioni di Khorasan, di Fars e di Kerman, in Iran, o lo stato di Jammu e Kashmir, nel Nord
dell’India, tale produzione continua a rappresentare una delle principali forme di utilizzo del suolo, se
non la più importante per estensione e quantità di prodotto, lasciando tracce assai evidenti nel
paesaggio agrario, e divenendo un’attività economica di non poco momento, in grado di scongiurare o,
comunque, di tenere a bada il fenomeno dello spopolamento delle aree rurali, per altri contesti
territoriali, quale l’Italia, ma anche la Spagna e la Grecia, la diminuzione di terreni sottoposti alla coltura
del croco, negli ultimi decenni, ha rappresentato una perdita non solo per quanto concerne l’economia
locale, ma anche la diversità dei paesaggi, a maggior ragione se si pensa che, ad esempio, esclusi gli
Emirati Arabi, il principale paese di importazione della zafferano di provenienza iraniana è la Spagna43,
ma anche la Francia e l’Italia hanno il loro peso nell’importazione di questa spezia dall’Iran.
I paesi europei che ancora ne producono (i principali sono, appunto, la Spagna, la Grecia e l’Italia),
proprio perché interessati nei decenni passati da importanti trasformazioni in campo agricolo, hanno
registrato le maggiori perdite sia in termini di estensione di aree sottoposte alla coltura del croco, sia, di
conseguenza, in termini di quantità prodotte.
La situazione italiana, in realtà, non è di facile comprensione in quanto l’organizzazione, in tema di
coltivazione di croco, delle principali regioni produttrice, cioè la Sardegna, al primo posto, seguita
dall’Abruzzo e da altre regioni quali la Toscana e l’Umbria, è assai disomogenea (fig.3). In più, come già
accennato alla nota 11, c’è da mettere in evidenza il fatto che, molto spesso, la coltivazione del fiore e,
soprattutto, la produzione della spezia rappresentano un’attività integrativa al reddito principale di
quanti sono impegnati in questa attività e solo in alcuni casi essi sono consorziati, acquisendo, in questo
modo, un valore aggiunto rappresentato da una maggiore visibilità, sia in termini di mercato, sia in
termini di conoscenza alle varie scale. Tuttavia, se è vero quanto finora affermato, cioè che i paesaggi
tradizionali dello zafferano dei più importanti paesi occidentali produttori della spezia stanno
attraversando una fase critica e di contrazione, è altrettanto vero che, proprio in risposta a
quell’esperienza maturata nell’ambito della Politica Agricola Comune dell’Unione europea, che alla
quantità della produzione ha preferito anteporre la qualità della stessa, questi stessi paesi hanno risposto
attraverso un processo di ripensamento del modo di praticare la coltivazione del croco finalizzata
all’ottenimento delle certificazione del prodotto con i marchi DOP. L’Italia in ciò ha conseguito buoni
risultati con l’esperienza dei consorzi DOP dello Zafferano di Sardegna, dello Zafferano dell’Aquila e
dello Zafferano di San Gimignano, che, oltre a garantire un’alta qualità della spezia che viene immessa
sul mercato, hanno permesso anche di identificare, a scala mondiale, le aree nelle quali i principali
41 Pure per l’Italia, (o, a maggior ragione per l’Italia, essendo la produzione italiana diffusa a macchia di leopardo) i dati sono approssimativi, in quanto molto spesso la produzione di zafferano interessa piccole aziende cooperative o a conduzione familiare e non appartenenti ad alcuna associazione di categoria. In più, altrettanto spesso la produzione dello zafferano rappresenta un’attività integrativa al reddito familiare. Per tali motivi, dunque, non è particolarmente agevole avere dati precisi e puntuali. La determinazione della superficie di suolo destinata alla coltivazione del croco sativo e la quantità di produzione di zafferano riportate in questo articolo sono il frutto di una valutazione derivante da informazioni raccolte attraverso il contatto con alcune associazioni di produttori, con alcune CCIAA e prendendo in considerazione i dati forniti da altre pubblicazioni citate in bibliografia. 42 Si consideri che storicamente l’Abruzzo ha avuto un ruolo fondamentale nella coltivazione di croco sativo e nella produzione di zafferano fin dalla sua introduzione nella Penisola (per la precisione a Navelli, appunto). A tal proposito, ad esempio, si veda quanto scrive Landi 2007, p. 10. Ancora nel 1900 la superficie agricola provinciale dedicata alla coltivazione del croco per ricavarne zafferano ammontava a 300 ettari. 43 A tal proposito si veda Ghorbani M. 2008, p. 523.
77
zafferaneti italiani continuano a rappresentare una presenza paesaggistica di non scarsa rilevanza. Cioè
si tratta di salvaguardare alcuni paesaggi agrari derivanti da pratiche agricole tradizionali, che –
prendendo in prestito una felice espressione di Elio Manzi – «sono anche importanti “icone
simboliche” geostoriche dell’Italia» divenendo, dunque, «paesaggi identificativi sia localmente che
regionalmente ed anche a livello nazionale ed europeo»44, ma, oserei dire, persino mondiale. Anzi, come
auspicava lo stesso Manzi nel già citato articolo, si sono verificati esempi di rivivificazione di certi
paesaggi, che nel tempo si erano estinti e che oggi, invece, sono tornati in auge, seppure in forme
limitate, grazie ad una riscoperta della tipicità delle produzioni (figg. 4-6).
Fig. 3. Diffusione, a scala nazionale, della coltivazione di croco sativo
In definitiva, dunque, sempre utilizzando le parole espresse da Manzi, si può affermare che «questi
paesaggi» e segnatamente quelli dello zafferano per alcune realtà territoriali dell’Italia rurale
«racchiudono non soltanto una lunga storia sistemica di uomini e natura, ma anche i segni
dell’evoluzione recente, spesso connessa alla rivitalizzazione di produzioni pregiate, di nuovo richieste
sul mercato in quantità non rilevantissime ma qualitativamente importanti, talora trainanti di un
mercato più vasto. In tal modo alcuni di questi paesaggi conoscono un perdurare attuale “vivente”,
“attivo”, non una museificazione altrimenti improbabile se non difficilissima»45.
44 Manzi 2012, p. 64. 45 Manzi, op. cit.
Fig. 4. Particolare di un paesaggio dello zafferano nell’Abruzzo marsicano: fioritura del croco
Foto: cooperativa Terre Alte - ottobre 2006
Fig. 5. Particolare di uno zafferaneto in fiore
Foto: cooperativa Terre Alte - ottobre 2006
79
Fig. 6. Filari di croco sativo, particolare
Foto: cooperativa Terre Alte - ottobre 2006
Bibliografia
GHORBANI M., “The Efficency of Saffron’s Marketing Channel in Iran”, World Applied Sciences
Journal, 4, 2008, pp. 523-527;
GOLMOHAMMADI F., “Saffron and its Farming, Economic Importance, Export, Medicinal
characteristics and Various Uses in South Khorasan Province- East of Iran”, International Journal of
Farming and Allied Sciences, 3-5, 2014, pp. 566-596;
GRILLOTTI DI GIACOMO M. G. (a cura di), Atlante delle campagne italiane, Roma, Società Geografica
Italiana, 2005;
GRILLOTTI DI GIACOMO M. G. (a cura di), Atlante tematico dell’agricoltura italiana, Roma, Società
Geografica Italiana, 2000;
GRILLOTTI DI GIACOMO M. G. e MORETTI L. (a cura di), I valori dell’agricoltura nel tempo e nello
spazio. Atti del Convegno geografico internazionale: Rieti, 1-4 novembre 1995, Roma, Società Geografica
Italiana, 1995;
KAFI, HEMMATI KAKHKI A., KARBASI, Saffron (Crocus sativus). Production and processing, Enfield,
Science Publishers, 2006;
KALOO M. J., PATIDAR R. E CHOURE T., “Status of Saffron in Jammu and Kashmir: An
Economic Analysis”, International Journal of Research, Vol-1, Issue-4, May 2014, pp. 814-822;
LANDI R., Lo zafferano. Tradizione e tipicità, Firenze, Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Firenze, 2007;
LICHTFOUSE E., NAVARRETE M., DEBAEKE P., SOUCHÈRE V. E ALBEROLA C. (a cura di),
Sustainable Agriculture, Dordrecht, Spinger, 2009;
MAFRICI A., Globalizzazione agricola e libertà di mercato, Gangemi Editore, 2011;
MANZI E., Paesaggi italiani tra identità difficile e “supplenza” europea, in GHERSI A. (a cura di), Politiche
europee per il paesaggio: prospettive operative, Roma, Gangemi Editore, 2007, pp. 53-71;
NEGHBI M., Saffron.Crocus sativus L., Amsterdam, Harwood Academic Press, 1999;
RUGGIERI M., “I terreni abbandonati: nuova componente del paesaggio”, Bollettino della Società
Geografica Italiana, serie X, vol. 5, 1976, pp. 441-464;
SALVATORI F., “L’agricoltura italiana nell’attuale trasformazione”, Bollettino della Società Geografica
Italiana, serie XI, vol. 11, 1994, pp. 1-3;
SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, Rapporto Annuale 2012. I nuovi spazi dell’agricoltura italiana,
Roma, Società Geografica Italiana, 2012.
Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, dei Beni Culturali e del Territorio dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”