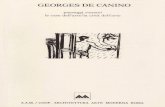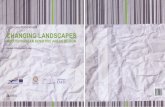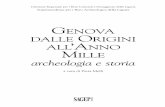58. La "seconda vita" delle epigrafi: casi studio per la ricostruzione dei paesaggi storici nella...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of 58. La "seconda vita" delle epigrafi: casi studio per la ricostruzione dei paesaggi storici nella...
SABRINA PIETROBONO
La “seconda vita” deLLe epigrafi: casi studio per La ricostruzione deipaesaggi storici neLLa vaLLe Latina1
L’analisi del paesaggio come metodologia2 eredita e trasforma una consoli-data tradizione di studi di topografia interrogando le fonti più diverse: fonti let-terarie ed iconografiche; monete ed iscrizioni; stampe, carte storiche e documen-ti d’archivio; riproduzioni satellitari e fotografie aeree; per passare infine a siste-matizzare gli apporti incrociati tra scienze, quali la geologia, e discipline, qualiquelle antropologiche, concludendo nella verifica dello scavo archeologico, altermine possibilmente di ricognizioni sistematiche3.
La riflessione preliminare a questo studio4 ha investito la quantità di datitopografici, anche se di diversa qualità, sui molteplici contesti da esse testimo-niati, nei quali le epigrafi vivono una sorta di seconda vita, portatrici di signifi-cati sempre aggiornabili: esse diventano imprescindibili testimoni di perdutipaesaggi, indizi dei quali sono talvolta contenuti nel testo inciso, altre volte rin-tracciati nei documenti.
attraverso alcuni casi studio nel Lazio Meridionale interno si soppeseràl’apporto delle epigrafi alla ricostruzione del paesaggio storico mediante i datiricavabili da testo, fonti e complessivo apparato informativo ad esse connesso(storia degli studi, contesto archeologico, etc).
1 desidero sentitamente ringraziare il prof. Heikki solin per l’emozionante accoglienzadata a questo contributo; all’instancabile domenico cedrone rinnovo i ringraziamenti costan-ti per avermi coinvolta nel convegno e il suo supporto continuo. ringrazio poi adriano deangeli ed infine Maria consiglia pompei, alessandra negroni e adele palumbo, alle qualimi legano amicizia e interessi di studio, per il sostegno ricevuto.
2 pietrobono, s., 2009. Insediamenti fortificati nella Diocesi di Veroli (II contributo). IlCastrum Castri: materiali per lo studio del paesaggio medievale di Castro dei Volsci. inpietrobono, s. (a cura di). «Le storie della terra. un quaderno per la formazione la didatticala ricerca». Museo civico archeologico di castro dei volsci, castro dei volsci, pp. 41-82.pietrobono, s.; turner, s., 2010. Comparing methods in European context: HistoricLandscape Characterisation and new perspectives for research in Italy. «archeologiapostmedievale», 14, pp. 111-133.
3 caMbi, f., 2009. Archeologia (globale) dei paesaggi (antichi): metodologie, procedure,tecnologie. in MaccHi Jánica, g. (a cura di). «geografie del popolamento: casi di studio,metodi e teorie». università degli studi di siena, pp. 349-357.
4 si tratta di indagini riformulate grazie alla realizzazione del progetto europeo n-LinK(normannitas: Landscape, identity and norman Kingdoms), finanziato dalle Marie-curieactions / people – fp7, nel 2011, e che si basano sui risultati di uno studio ormai più che ven-tennale.
1. L’epigrafia del paesaggioesiste consapevolezza che il paesaggio non può dirsi “naturale” ma è conse-
guenza stessa dell’azione dell’uomo che si esplica in molteplici forme. possiamoricreare la sequenza di paesaggi, che si sono sovrapposti, mediante tecniche vir-tuali o procedimenti descrittivi, e possiamo anche comprendere, grazie alla rela-zione che esiste tra resti materiali, documenti e testimonianze orali, le connes-sioni tra le parti di un tutto in continua trasformazione. Molte opere dell’uomohanno prodotto modifiche sul territorio, consistenti ma talvolta transeunti, chepossono però essere riconosciute e analizzate. acquedotti, ponti, strade, hannodefinito invece una modifica spesso permanente del paesaggio, di cui si può pos-sedere il monumentum epigrafico: il taglio del pisco Montano di terracina, nelLazio Meridionale costiero, può agilmente esserne un esempio.
La moderna porta napoletana fu innalzata, forse da pio vi, lungo la viaappia presso la “rapa rossa” (cosiddetta per la sua cromia “carsica”) altrimentidenominata “sasso dei cento piedi” (per l’altezza del taglio): uno sperone diroccia con parete ben disegnata a picco sulla marina ormai tra i simboli dellacittà, ritratto in diverse occasioni (schizzi di J.M.W. turner nel 1819; dipinto diterracina ad opera di carlo bossoli nel 1850, etc)5. La parete di questa roccia fuappositamente tagliata per facilitare il transito della strada romana lungo lacosta, prima costretta a salire la china del monte s. angelo. al tempo dell’impe-ratore traiano (98-117), secondo la più tradizionale delle versioni6, si decise diabbreviarne la percorrenza, dovendo perciò intervenire in corrispondenza delpisco: le conseguenze paesaggistiche di quest’operazione sono state di recenteriassunte in nuovi studi7.
segnalato dalla scansione delle cifre incise sulla roccia che rilevano il pro-cedere dei lavori dall’alto verso il basso a marcarne in progressione l’altezza(CIL, X, 6849)8, il taglio di questa rupe fu un’opera insolita: furono asportati 128
5 per i lavori di Joseph Mallord William turner (1819) si veda http://www.tate.org.uk/art/artworks/, vatican fragments sketchbook; tetro, f., 2013. I modi di Carlo Bossoli ed il suouso dell’arte, dal paesaggismo alla pittura “risorgimentale”, in cipoLLa, c., Il sogno diGaribaldi. Oltre Terracina, contro i Borboni. Milano, p. 179.
6 ventre, f., 2004. From the Pontine Plain to Benevento. in deLLa porteLLa, i. (a curadi). «the appian Way: from its foundation to the Middle ages». Los angeles, p. 126.
7 cui prevalentemente mi rifaccio in questa sede: cassieri, n.; bLanco, a.; patti, g.;rose, d.; veLLa, a., 2013. Il taglio del Pisco Montano a Terracina: anamnesi di una grandeopera di epoca imperiale. in gHini, g.; Mari, z. (a cura di). «Lazio e sabina 9» (atti delconvegno “nono incontro di studi sul Lazio e la sabina”, roma, 27-29 marzo 2012), Lavorie studi della soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, 9. roma, pp. 399-407. conbibliografia precedente.
8 soLin, H.; KaJava, M., 1992. Iscrizioni rupestri del Latium adiectum. in «rupes loquen-tes» (atti del convegno internazionale di studio sulle iscrizioni rupestri di età romana in
sabrina pietrobono42
piedi di roccia, corrispondenti a quasi 38 m. Le cifre ancora ben visibili sonocontenute in cartigli (eccetto la prima) di diversa misura con scansione di 10piedi (m. 2,90 circa) dall’alto, dalla cifra X fino all’ultima visibile, cXX (=120):l’attuale livello stradale copre la cifra cXXiiX (=128), rilevata nel 1911, insie-me a due gradini di raccordo tra la rupe ed il pavimento antico. Lo sbancamentofu effettuato senza soluzione di continuità su entrambe le pareti orientale edoccidentale del pisco; tecnica e fasi sono riconoscibili grazie ai segni di lavora-zione del cantiere antico. al suo oriente un’intensa attività di cava, per la produ-zione di calcare per calce, durò fino agli inizi del secolo scorso. L’accumulo deidetriti di questa produzione ha sigillato parti della zona, permettendo la raccoltadi alcuni dati relativi all’assetto di età romana9.
L’epigrafe rende esplicito l’intervento sul paesaggio anche non dichiarando-lo: non si tratta di un crollo di parete rocciosa poi regolarizzato per motivi disicurezza o altre simili eventualità, bensì di un progetto unitario scandito in fasidi lavorazione precise, anche se veloci, con la conseguenza di poter saggiareanche la qualità di una pietra, forse proprio in seguito commercialmente apprez-zata. L’opera viene esaltata in senso celebrativo da alcuni accorgimenti, comela prospettiva data dalle dimensioni dei cartigli, che differiscono aumentando inparallelo al ridursi della quota, a enfatizzare volutamente la percezione dell’al-tezza del taglio10. L’impatto sul paesaggio fu pertanto massiccio e forse propriola mancanza di una dichiarazione di paternità della personalità che ne decisel’avvio sottolinea il fatto che fosse ovvia, cioè l’imperatore.
2. Iscrizioni testimoni del paesaggio storicoLe epigrafi rupestri sono immediatamente connesse al paesaggio per supporto
ma spesso, anche se non sempre, per contenuto, come nel caso di CIL X, 5163 =ILS 3863 (metà ii d.c.11), di casalucense, il cui testo consacra alle ninfe l’area cir-costante: Numphis Aeter/nis sacrum / Ti. Cl(audius) Praec(ilius) Ligar (ius?ianus?)Magonianus per / Praecilium Zoticum / patrem aqua(m) induxit («alle ninfe eterneitalia, roma - bomarzo, 13-15 ottobre 1989), roma, pp. 356-357; zucca, r., 2001. Ancorasulle iscrizioni rupestri di Tarracina (Regio I Italiae). in «saxa scripta» (actas do iiisimpósio ibero-itálico de epigrafia rupestre). viseu, pp. 209-227.
9 Le ultime ricerche hanno dimostrato sensibili differenze tra le condizioni geomorfologi-che del sito in età romana e l’attuale situazione; in particolare la linea di costa in antico eranotevolmente a ridosso del sito di porta napoletana, mentre ad est del taglio le pendici delmonte si propendevano verso il mare, presso cui è stato riconosciuto un bacino di escavazio-ne di cava lungo circa 320 m: lo sfruttamento della pietra calcarea locale è noto fin dal iiisecolo ed è continuata anche se forse a fasi alterne fino al secolo scorso. il codice teodosiano,in particolare, attesta che nel v secolo la città provvedeva a fornire la calce necessaria allamanutenzione di Portus e del suo faro. cassieri, et alii, 2013, cit., p. 400.
10 cassieri, et alii, 2013, cit., p. 402, e nota 19. 11 soLin, KaJava, 1992, cit., n. 18 (=AE 1992, 246), pp. 369-376.
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 43
sacro. tiberio claudio precilio Ligario Magoniano attraverso precilio zotico(suo) padre condottò la sorgente»)12.
È incisa in una tabella nella roccia viva, circa 100 metri a valle del passaggiodell’acquedotto di Casinum; è preservata nell’orto sito dietro il convento di casaLuciense. il suo contenuto riconduce a un preciso e condizionante intervento sulpaesaggio, che riguardò una sorgente effettivamente presente nell’area antistan-te13; fu pure estratta una conduttura fittile a circa 120 metri più a valle nell’ortodel convento, presso il quale vennero infine “riportati alla luce due muri di un pic-colo ambiente con resti di pitture dai colori ormai evanidi e frammenti di grossiorci e tegole; infine nell’area antistante il convento, erano visibili fino al secoloscorso due tombe scavate nella viva roccia, una delle quali recante incisa, sulcoperchio, un’iscrizione”14.
nota peculiare, in ultima analisi, sta nel suo essere stata fraintesa allorché si èvoluto dissociarla dal contesto: un’opera di captazione delle acque di una sorgentelocale, per espiare la violazione della quale si incise l’iscrizione15. si tratta dellacelebrazione di un evento contenuto in dimensioni ed importanza, ma che pure fuconnesso ad un’opera pubblica quale l’acquedotto della vicina città romana, solotransitante nei pressi. ricognizione topografica, descrizione tecnica e rilievi delmanufatto pubblico chiarirono quanto inverosimile fosse tale associazione.
il sito del convento dovrebbe corrispondere ad un precedente abitato antico oalmeno del fondo i cui proprietari sono nominati nell’epigrafe16. seppur lentamentele iscrizioni suggeriscono la presenza di gruppi attivi tra questi boschi circostantiMonte cairo, che ne curavano e sfruttavano le risorse. al momento sfuggono datisignificativi sul primo medioevo, ma l’attestazione di un casale (casa Luciense ocasalucense) nella menzione della chiesa nel 1411 (s. Maria de casalicensi17)
12 vaLenti, M., 1992. L’acquedotto romano di Cassino. «Journal of ancient topography»,2, pp. 139-140, con bibliografia precedente. per l’epigrafe, in ultimo MoLLe, c., 2008. UnCavaliere Patrono di Aquinum. in soLin, H. (a cura di). «Le epigrafi della valle di comino»(atti del Quarto convegno epigrafico cominense. atina, palazzo ducale, 26 Maggio 2007),pp. 119-133, con bibliografia precedente.
13 petrucci, g., 2008. Il santuario di Casalucense. cassino, p. 40, che riporta a nota 39 latestimonianza di un oblato cassinese: “[...] un fortunato scavo di pochi metri ci fece trovareuna notevole polla d’acqua potabile nel nostro orto, sotto la lapide dell’acquedotto romano”.
14 vaLenti, 1992, cit., p. 140. altre testimonianze antiche sono elencate in petrucci, 2008,cit., pp. 22-39, con immagini fotografiche.
15 da ultimo MoLLe, 2008, cit., p. 125, nota 16. 16 cfr. Ibidem, cit., pp. 131-133.17 gattoLa, e., 1733. Historia Abbatiae Cassinensis, venetiis, i, pp. 206-207:
“describuntur verbis mox allatis hae ecclesiae in inventario ejusdem coenobii sub praepositoHieronymo, facto a notario antonio nigro de s. elia die 2. Januarii a. 1411, in quo bona,libri, suppellectiles tunc ab ecclesia illa possessa recensentur”; bLocH, H., 1986.Montecassino in the Middle Ages. roma, ii, 722.
sabrina pietrobono44
tra questi boschi sacri (tra i quali valle Luce18) lascerebbe ben sperare in tal senso. a casalattico, come a casa Lucience, il nesso tra epigrafe (fig. 1) ed inter-
vento umano si è dovutoricostruire gradualmente e laricognizione viene diretta-mente guidata dall’epigrafe,pure rupestre (AE 1922, 125=AE 1922, 127 =AE 1973,175 =AE 1981, 210 =AE1992, 243)19. su un percorsomontano che dal paese sot-tostante conduceva alle fra-zioni di Monforte, un tempoMortale20, si trova il testoinciso: C(aius) PomponiusC(ai) l(ibertus) Tigranus /viam plostralem fecit de suapecunia / (sestertiis) n(ummum)(mille) D / sene (!) a(d)iuto-re vicanis.
L’epigrafe rupestre men-ziona una viam plostralem,strada rotabile usufruibile da un carro di medie dimensioni, realizzata da unliberto di caio pomponio, Caius Pomponius Tigranus, il quale la fece costruire asue spese spendendo 1500 sesterzi senza alcun aiuto da parte dei vicani. il testo,oggi ancora meno leggibile, è inciso in uno specchio epigrafico incassato alla som-mità della parete di un monumento celebrativo ricavato nella roccia e collocatolungo il percorso della via, in un punto dove possibilmente un carro ed uominipotevano sostare. È composto da tre spezzoni di roccia in giacitura naturale adatta
18 ponari, f., 1867. Ricerche storiche sulle antichità di Cassino. napoli, pp. 57-58;pantoni, a., 1961. Il Santuario diocesano di S. Maria di Casalucense. «bollettinodiocesano», Xvi, 121-124. valle Luce è attestato nella confinazione riportata dai ChronicaMonasterii Casinensis (da qui cMc), i, 5, m. cdMs, p. 26: ‘‘[...] et inde vadit per locum quidicitur anglone et ascendit ad furcam quę dicitur de valle luci; et quomodo vadit per ipsasserras montium, et descendit ad petram scriptam; [...].
19 soLin, H. (in collaborazione con e. béranger), 1981. Iscrizioni di Sora e di Atina.«epigraphica», XLiii, pp. 45-102. giudici, M., 2008. Escursioni epigrafiche in Valle diComino: spunti di ricerca. in soLin, 2008, cit., pp. 103-118, con bibliografia precedente.
20 ringrazio sentitamente i signori italo forte e Mario forte, di Monforte, per avermiaccompagnata in ricognizione e la cortese assistenza fornitami in loco.
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 45
fig. 1 – Mortale-Monforte, presso Montattico ecasalattico, val comino. La pietrascritta, il monumento,prospetto (foto pietrobono).
a comporre una parete continua21.non potrei dire se nel testo vada letta una nota polemica verso i vicani che non
sostennero il progetto, ma si ipotizza che la strada fosse destinata al trasporto dilegname, non solo di derrate alimentari22, il che significherebbe che l’ampio sfrut-tamento delle risorse boschive, atteso per l’età medievale, avrebbe avuto dei sicuriantecedenti in età romana, come anche il contesto di casalucense suggeriva.
ricostruirne il tracciato non è sempli-ce: partiva dal fondovalle, forse staccan-dosi dal percorso che dal ponte dellaMola puntava verso atina, cui si allaccia-va la strada privata costruita da tigrane;perdita di interesse ed eventi naturali nehanno fatto crollare gran parte23. i restidella strada non erano stati decifrati nelpaesaggio (fig. 2): il percorso montano èsì prevalentemente scomparso, ma èanche distinguibile nei pressi dell’iscri-zione inoltrandosi nella boscaglia pervisionare lo stato attuale del contesto. Lasede stradale, o meglio ciò che ne resta, siestende ora per un’ampiezza, in media di1,5 m, e per circa 30 passi. era pavimentatain maniera essenzialmente pratica in pietredi monte sulle quali resterebbero visibilisegni delle ruote di carro (fig. 3). in veritàprocedendo dal luogo dell’epigrafe lungo ilprofilo del colle, la strada sembra puntare
verso la sella montana in direzione della località cisterna a sud di Monforte,lasciando Montattico sulla destra, il cui sito, all’epoca ugualmente occupato
21 per un’altezza complessiva di 2,60 m ca, ampiezza di 1,56 m ca lungo la linea inferioredello specchio epigrafico, spessore 69 cm ca (in difficili condizioni di rilievo e con l’aiuto delsign. M. forte).
22 giudici, 2008, cit., pp. 116-117.23 ribezzo, f., 1921. Comunicazioni epigrafiche. «rivista indo – greca – italica», v, p. 88,
da giudici, 2008, cit., p. 117. Lo studioso fece coincidere il tracciato visibile ai suoi tempi conquello di età romana: «La via si disegna in un intaglio o risega della balza rocciosa scendendoa picco sul vallone camposanto. il tracciato parte da Montattico, costeggia val di cecca, passasul colle buona sciagura, di fronte a casalattico, e, costeggiandolo in giro, scende sulla via cheda sora conduce ad atina». béranger, e. M., 1986. Osservazioni storico-archeologiche sualcuni toponimi della media valle del Liri. in guLia, L. (a cura di). «omaggio al dialetto per gliottant’anni del poeta riccardo gulia» (atti del convegno, sora 1985), p. 56, nota 12.
sabrina pietrobono46
fig. 2 - Mortale-Monforte (val comino).La pietrascritta, resti della sede stradale(foto pietrobono).
da boschi, era forse servito da un diverticolo minore: lo scopo era chiaramentecollegare queste aree di montagnacon la pianura sottostante, ma, non-ostante un’epigrafe sia stata regi-strata in passato nella chiesa di s.Maria della pace24, l’area doveoggi ricade il centro di Montatticonon pare essere immediatamenteinteressata da questo tratto del per-corso; anche se il toponimo vienelocalmente spiegato con la presen-za di una villa di tito pomponioattico (109 – 32 a.c.), sulla qualesarebbe sorto il centro in etàmedievale, i dubbi sulle modalitàdi popolamento dell’area in etàromana permangono25.
L’epigrafe di Mortale è anche nota come la “pietra scritta”. una menzione di 24 a parte il non poterne determinare l’effettiva provenienza, si tratta di una significativa
dedica di un luogo di culto a Liber, o Libera, divinità agresti, con un signum a diana, protet-trice dei boschi, raramente attestate assieme, ma significativi in un contesto di silva. cfrgiudici, 2008, cit., pp. 115-116.
25 MarseLLa, c., 1949. Un grande romano Tito Pomponio Attico e la sua villa diMontattico (ristampa anastatica a cura di c. castellucci, prefazione L. riccardi). isola delLiri 2014. si tratta di una tradizione locale estremamente radicata ma non provabile. MonsAtticus emergerebbe nel 1140, nel documento sui confini di atina (1140, ottobre, ind. iv,atina. ruggero ii conferma le consuetudini di atina ed i confini del territorio che fa verifi-care per mezzo del regio camerario ebulo da Mallano, Leccisotti, t., 1972. I Regestidell’Archivio, vii, roma, n. 17, doc. 1379, p. 241). Questo viene considerato vincolante nellaricostruzione della storia della torre di Montattico, dove appare in quanto Montem Atticum,ma è ritenuto, con indubbi appunti critici, “di dubbia autenticità” da antoneLLi, d., 1999.Alvito dalle origini al secolo XIV, nella ricorrenza del IX centenario della fondazione dellacittà (1096-1996). castelliri, pp. 146-147. il testo del documento è trascritto dal palombo, oravirciLLo franKLin, c. (ed.), in collaboration with bLocH, H., 1996. The Ecclesiae Atinatishistoria of Marcantonio Palombo (Codd. Vat. Lat. 15184-15186). città del vaticano:archivio segreto vaticano, pp. 408-412. i documenti mostrano varianti nel toponimo: nel1268-69 il Mons Actachy paga alla regia camera pro focul vii unc. i tar XXii 1/2. Manieririccio, c., 1878. Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche scritture dall’Archiviodi Stato di Napoli. napoli, p. 44. ciò potrebbe anche ribadire una connessione tra Actachy edAtticum, però esiste nei documenti anche un monte acze oggi Monte Meta, gattoLa, e.,1734. Accessiones, venetiis, i, p. 151. bLocH, 1986, cit., p. 198. studierei questi toponimi nelloro contesto orografico per individuare se si tratti in realtà di una forma molto più diffusa che si
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 47
fig. 3 - Mortale-Monforte (val comino). Lapietrascritta. pietra con segno per le ruote (fotopietrobono).
una terra cassinese in località Pietrascritta trapela dai cMc26: non è al momentopossibile associarla con sicurezza a questa epigrafe, anche se il contesto del branoche narra gli avvenimenti della fine dell’Xi secolo che condussero adenolfo e i deaquino ad avviare la costruzione del vicino castrum di alvito potrebbe suggerirlo.il commentatore dei cMc portò però come confronto un documento del 1068 con-servato a Montecassino e relativo ad una località pietrascritta in territorio atinate27,che rinvia al problema del riconoscimento della “pietra scritta” segnante il confinedella terra di san benedetto: è un toponimo, come si vede generico ma pregnante,che si carica di contenuti nel corso del tempo.
3. Marcare il territorio. Dalle “pietre scritte” alle architettureun numero imprecisabile di columnellae, epigrafi o anepigrafi, con la funzionedi segnare i confini di proprietà erano distribuite nella valle Latina; in alcuni casici sono giunte, in altri resta soltanto il toponimo: colonnella, termine, o anchepiù semplicemente pietrascritta; quest’ultimo risulta comune ma non troppo dif-fuso. in linea di principio potrebbero essere volgarmente dette “pietre scritte”tutte le epigrafi disperse nella campagna ma il toponimo si è affermato ogni qualvolta la prolungata esposizione e conservazione in un dato luogo ne consentivala sua fissazione nell’uso, quindi ogni volta che la pietra scritta assumeva fun-zioni importanti anche se con differenti valori nella memoria collettiva locale.
ad una prima rapidissima ricerca sono definite tali sia lapidi di età romanasia di età moderna, ma ancora più interessanti sono le pietre scritte medievali,poiché emergono dai documenti abbaziali: nelle cronache di Montecassino, nellastesura dei confini delle terre dell’abbazia, una pietra scritta in località valleLuce segnava, come sopra accennato, uno dei limiti della confinazione del terri-torio monastico. L’uso è noto anche tra fondi ed itri ... “Pietra Scritta, che staaccosto detta strada Appia da sopra S. Andrea; da detta Pietra Scritta cala alloFossato e per detto fossato saglie allo Varcaturo de Rifezza, e saglie alla sommitàispiri alla situazione altimetrica. si vedano inoltre per l’area di casale (casalattico) i docu-menti raccolti in Polianthea Casinensis. Auctore, P. D. Antonio a Fractis 145. comune digallinaro - ass. genesi, 2003, pp. 25; 42; 59; 94.
26 cMc, iv, 14, pp. 483-484: excipitur et Miluczu cum rebus soceri sui et presbiteriLandonis avunculi sui; et refutavit terram huic monasterio pertinentem, que est ad petramscriptam, quam post mortem patris sui idem comes ab huius loci dicione subduxerat.
27 cfr. Leccisotti t., 1973. I regesti dell’Archivio, viii, roma, n. 1911, pp. 58-59: 1068,aprile, ind. vi, atina. pietro cellararu, abitante di atina, offre (in monasterio cui bocabulumest sancto benedicto de clea), retto da don atto monaco e preposito, sotto il regime didesiderio abate di Montecassino, una pezza di terra nei confini di atina, in località pietrascritta.
sabrina pietrobono48
della collina detta la Forcella di Monte Candela ...”28. se pensiamo che, sul piano giuridico, l’efficacia di un limite era tra l’altro
legata ad una garanzia di inamovibilità, per quanto possibile, queste pietre scrittedovettero rappresentare un elemento chiaramente preminente nel paesaggio persecoli. il problema risiede nella corretta identificazione a posteriori tra la testi-monianza letteraria e il resto materiale, quando il numero delle epigrafi in unaristretta area che potrebbero aspirare a tale denominazione trascina con sé unproblema riconoscitivo ed interpretativo.
ci sono però anche altri elementi, talvolta macroscopici, e non ultime chiese etorri, che possono marcare confini e territori, porsi nell’ambito dei loro fines, edattribuire a luoghi da tempo frequentati dei nuovi significati che si sovrappongonoad altri precedentemente molto forti. una particolare chiesa di confine tra il territo-rio della contea di Aquinum ed il monastero di Montecassino è al centro del presentecaso studio, che abbandona l’epigrafiarupestre e porta l’attenzione a paesaggimaggiormente condizionati dall’operadell’uomo mediante grandi architetture.preservata in un contesto apparentemen-te periferico della città medievale diAquinum, ho da qualche anno espressa-mente proposto di identificare nellachiesa di s. Maria della Libera l’edificiodella chiesa cattedrale29.
Aquinum è un sito controverso el’analisi sulla trasformazione della cittàattraverso i secoli non può prescinderedall’integrazione tra dati materiali edati di natura linguistica: tra questi, i testi epigrafici forniscono più di uno spuntodi riflessione. Le epigrafi che direttamente o indirettamente supportano il pro-cesso di riconoscimento della funzione quale sede vescovile sono conservatenell’edificio, meglio sulla sua fronte di ingresso, in quanto contenute nel portalecentrale. sono sia esempi di scrittura su pietra (fig. 4) sia di epigrafia musiva. Laloro realizzazione va compresa tra il momento della costruzione del portale e 28 ai confini tra fondi ed itri, presso la scomparsa chiesa di s. andrea, in angeLoni, b.;pesiri, g. (a cura di), 2008. Apprezzo dello Stato di Fondi fatto dalla Regia Camera nell’an-no 1690. associazione storico culturale Monti ausoni, firenze, pp. 15; 108.
29 pietrobono, s., 2013. Nuovi dati per lo studio della cattedrale di Aquinum in età paleo-cristiana e altomedievale. in «atti del Xv congreso internacional de arqueología cristiana(Xv ciac)». toledo (spagna) 8-12 settembre 2008. roma - città del vaticano, pp. 1179-1194.
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 49
fig. 4 – aquino (fr). santa Maria della Libera.iscrizione nello stipite sinistro del portale cen-trale (foto pietrobono, 13/02/2007).
la conclusione della sua decorazione nella lunetta con mosaico dell’arco supe-riore. tale portale è stato di recente al centro di nuove ricerche30 con revisioni eproposte di datazione31; in particolare i suggerimenti cronologici del gandolfo(sulla scorta dello stile del mosaico, considerato derivato dalla maniera bizantinatardo-comnena, datato a “non prima della fine del Xii secolo, se non addirittura
agli inizi del seguente”32), diven-tano punto di partenza per nuoveriflessioni.
il mosaico, rappresentante alcentro la Madonna conbambino, affiancata da duepalme e due sarcofagi al cuiinterno si trovano rispettivamen-te un volto femminile con capelliraccolti da veli, preserva duecoppie di iscrizioni33: la prima,restaurata, è collocata ad altezzacentrale ai lati della figura dellaMadonna, ed è composta dainomi di ottolina, sulla sinistra dichi legge, e Maria, sulla destra34,
in capitale epigrafica35(fig. 5). sono posti al di sopra della rappresentazione didue sarcofagi dalla fronte strigilata, semiaperti a lasciar intravedere i due volti
30 rinvio all’articolo di gerMani, M. e fLorissi, v., in questo volume, per i materiali architet-tonici reimpiegati ed i problemi di arricchimento stilistico; officine di produzione; ricontestua-lizzazione e attribuzione dei singoli frammenti ai diversi contesti architettonici di appartenenza.
31 gandoLfo, f., 2009/10. Il riuso di materiali classici nei portali medievali del Lazio. in«rendiconti. pontificia accademia romana di archeologia» vol. 82, pp. 73-108.
32 gandoLfo, 2009/10, cit., p. 93. 33 cayro, p., 1811. Storia sacra e profana di Aquino e sua diocesi. ii, napoli, pp. 25-26. 34 cayro, 1811, cit., pp. 25-26 descrive “una testa a man dritta, e sopra la medesima si
legge ottolina, e nella sinistra altra testa, e fu questa Maria”: la descrizione si riferisce alladestra della Madonna, evidentemente, altrimenti le iscrizioni sarebbero state capovolte, e nonpare possibile, in quanto la na di ottolina appare essere originale.
35 il mosaico è restaurato, per cui dobbiamo fidarci del lavoro dei restauratori nell’averricalcato le forme originali: la scrittura si inquadra negli esempi di Xiii secolo. confrontiinteressanti sono possibili con la tabella della croce dipinta ai santi domenico e sisto, aroma, riccioni, s., 2012. La croce dipinta ai Santi Domenico e Sisto. Iscrizioni. in roMano,s. (a cura di). «il duecento e la cultura gotica, 1198-1287 ca.», corpus v, vol. v, Milano, p.274, sesto decennio del Xiii secolo. per l’evoluzione della capitale in questo periodo si vedarubeis, f., 2008. La capitale romanica e la gotica epigrafica: una relazione difficile.«scripta», 1, pp. 33-34.
sabrina pietrobono50
fig. 5 – aquino (fr). santa Maria della Libera.Mosaico della lunetta nell'arco superiore del por-tale centrale di ingresso alla chiesa (fotopietrobono, 27/07/2014).
femminili, con gli occhi chiusi, quindi di defunte, quasi a contrasto con gli occhigrandi ed aperti della Madonna, rivolti allo spettatore, mentre il bambino fissa lamadre36. La datazione del mosaico, come delle iscrizioni nel loro complesso, silega alla loro identità.
grazie al cayro, della prima se ne conosceva la parentela con Landolfoconte de albeto: costui cedette al proprio figlio adinolfo ii le proprietà a luispettanti nel castello di Monte san giovanni, sostenuto da gregorio e aimonedell’isola sulla base degli accordi presi in occasione della dote per la loro sorella,ottolina, al momento del matrimonio di costei con lo stesso adinolfo ii, il qualerisultava in vita ancora nel 119637. L’aspetto interessante riguarda la prole diottolina dell’isola: fu madre di tommaso i, conte d’acerra (nato prima del 1201e morto il 27/02/1251)38, attivissimo nel novembre 1210 quando, rinchiuso inaquino con i suoi familiari, si oppose alle truppe di ottone iv guidate dadiopoldo di spoleto. i domini di aquino in quel periodo erano Landulfus,Thomas, Pandulfus e Robbertus39: tommaso era il conte d’acerra, ma Landolfoera il figlio di andrea di grottaminarda (a sua volta figlio di Landolfo di albeto)e di Maria gesualdo40. della seconda donna del mosaico, Maria, proporrei trat-tarsi proprio di Maria di gesualdo, che risulta essere così la cognata di ottolina41 e
36 in realtà il bambino, dal volto severo, è raffigurato come un giovanetto con un rotolo inmano. stessa posizione benedicente, con rotolo, sguardo rivolto alla madre la quale invece quasisi rivolge allo spettatore si trova nella cripta della cattedrale di anagni, i cui affreschi si collo-cano prima del 1231; cfr.cappeLLetti, L., 2002. Gli affreschi della Cripta Anagnina. Iconologia.editrice pontificia università gregoriana. roma, pp. 15; 255-256.
37 cayro, 1811. cit., p. 26. nonostante il cayro vada accuratamente vagliato, l’associazio-ne di ottolina con il documento stilato è credibile, ma se la data è veramente quella del 1160ripresa dall’erudito, allora all’epoca la fanciulla doveva essere notevolmente giovane.
38 si veda al momento cuozzo, e., 2005. Tommaso d’Acerra. in «federiciana», versioneonline. Landolfo era figlio di pandolfo di aquino e aveva un fratello con lo stesso nome delfiglio, adenolfo (il che ha tratto in inganno alcuni studiosi) come pure un Landone: furonotutti coinvolti nella permuta del castello di britti (Monte Libretti) e di un castello diruto insabina, con Monte s. giovanni in campagna l’8 aprile 1157, in fabre p. (ed.), 1905. LeLiber censuum de l’Église Romaine, i, paris, docc. 107-111, pp. 391-394; documenti inscandone, f., 1956. Roccasecca patria di S. Tommaso de Aquino. in «archivio storico diterra di Lavoro», anno i, vol. i, a cura della società di storia patria di terra di Lavoro, pp.132-133, docc. XLiX-L. Landolfo risulta morto nel 1197, Ibidem, doc. Lv, pp. 134-135.
39 garufi c. a. (a cura di) 1938. Ryccardi de Sancto Germano notarii Chronica. bologna, p. 33:la mia proposta diverge dalle interpretazioni del garufi.
40 zigareLLi, g., 1856. Storia della Cattedra di Avellino e de’ suoi pastori, napoli, p. 387;spies, r.g., 1975. Die Familie des St. Thomas von Aquin in Italien, Frankreich undWestindien. in genealogisches Jahrbuch, 15, degener, p. 73.
41 come suggerito da grossi, e., 1907. Aquinum. Ricerche di topografia e di storia. romapp. 13-14.
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 51
madre, come lei, di uno dei quattro signori di Aquinum nel 1210. La giacitura incasse sepolcrali a questo punto potrebbe essere chiarita sulla base di un rimando esplicito all’avvenuta morte delle due aquinati e non obbligatoriamente alla loroopera come fondatrici della chiesa, come la tradizione vorrebbe sulla base di unascomparsa iscrizione in abbreviazione V(otum) F(ecerunt-fecit): “a dirittura deldeposito e a man dritta, ed a lato si vede parimenti una croce con le lettere v, ef ... ”42: un voto che non sappiamo invece se sia stato sciolto dai rispettivi figli,nella prima metà del Xiii secolo, sulla base della volontà (quindi del denaro)delle due donne, o anche solo in loro onore, in quanto sepolte nel complessoecclesiastico. il voto è certamente relativo al mosaico, mentre non credo abbialegame alcuno con l’appellativo di Libera dato al culto mariano locale43.
tommaso in particolare divenne intimo dell’imperatore federico ed il 1°gennaio 1221 fu nominato dal re di sicilia capitano e Maestro giustiziere dellapuglia e della terra di Lavoro. i due cugini condividevano proprietà e cura deibeni lasciati loro dal nonno, sui quali proprio nel 1221 si trovarono in lite44.pandolfo non risultò coinvolto nella questione, ma si dimostrò tenace custode diAquinum ancora nel 1229, quando gli eserciti pontifici e imperiali si scontrarononella valle Latina: tommaso fu costretto a rientrare precipitosamente per sup-portare i familiari, i quali per ricevere l’imperatore avevano apprestato solide
42 cayro, 1811, cit., p. 25. Lo spazio dove avrebbe dovuto trovarsi la scritta è stato ripri-stinato senza, ulteriore conferma dei notevoli restauri effettuati all’opera.
43 L’invocazione di Libera sembra apparire molto tardi e non è possibile collegarlo allapestilenza di Aquinum del 1045, cfr. carbonara, g., 1979. Iussu Desiderii: Monte Cassinoe l’architettura romano campana nell’Undicesimo secolo. saggi di storia dell’architettura 2,roma, pp. 99-145. anche nel Xvii secolo una serie di epidemie si abbatterono sull’italia ein particolare fu colpito il regno di napoli, compresa la valle Latina, nel 1656: allo statodelle nostre conoscenze non possiamo escludere che sia stato quello il momento in cui ilpopolo di aquino si sentì salvato dalla vergine e liberato dal flagello, per cui alla primaopportunità, ripristinata una favorevole congiuntura economica, si sarebbe poi intervenuticon nuovi restauri alla sua chiesa, avvenuti difatti nel 1679 (infra).
44 un documento del 1 settembre 1221 rivela un momento di tensione tra la progenie diLandolfo de albeto. tommaso di acerra, da una parte, si trovò di fronte roberto ed i cuginiLandolfo e adenolfo de aquino, figli di andrea, i quali asserirono che «essendo alcuni anniprima seguita divisione tra Landolfo d’albeto (dicono i tre) padre [di roberto] et avo nostro[nonno di Landolfo e adenolfo] da una parte et adinolfo d’aquino, padre di tommaso contedell’acerra dall’altra sopra la metà del castello di albeto, la metà del castello di vicalbo, etutto il castello detto di settefrati, la rocca delle nuore e due parti del castello campoli e laottava parte della città di aquino, pare ad essa dividendi che non fosse detta divisione proce-duta egualmente. Laonde di mera e spontanea volontà riducendo prima ogni cosa in comunecome era avanti che si dividessero vengono di nuovo a partir tra loro le dette castella [...»:scandone, 1956, cit., n. Lviii, pp. 136-137.
sabrina pietrobono52
difese alla città («domini etiam de aquino pandulfus et robertus aquinum profide caesaris laudabiliter munierunt»)45.
Questa ultima menzione, unita a ricerche all’epoca in itinere sui personaggi delmosaico, mi avevano già indotta a ritenere possibile che ad Aquinum, tra il 1155ed il 1229, si fosse attuata una serie di committenze inserite in un programmacostruttivo che coinvolse pienamente la famiglia de aquino46, la quale dai primianni del Xiii secolo era rappresentata in città soprattutto dal ramo di tommaso diacerra e dai familiari prossimi; queste committenze sarebbero state rispettate dafederico, il quale fu ospitato in diverse occasioni ad Aquinum47.
se ci fu intervento dei signori aquinati, e non delle rispettive madri, menoprobabile a parer mio, poté essere con più facilità effettuato prima del 1221, vistoche Landolfo di grottaminarda, forse proprio in seguito alla suddivisione deibeni, dopo tale data non parebbe essere direttamente inserito negli affari dellacittà, forse preso dall’amministrazione dei feudi avellinesi, mentre tommaso fuassorbito dai numerosi incarichi conferitigli dal re. non da ultimo, dovette essere coinvolta anche la cattedra vescovile, che vide susseguirsi due Gregorius,entrambi osb: il primo, magister, nel 1197-1205, il secondo nel 1206-122148. ilprogramma costruttivo che investì Aquinum dovette riguardare non solo la chiesadi s. Maria della Libera, ma anche il castello sulla rupe in travertino posta a suddella chiesa e soprattutto la porta capuana o di san Lorenzo: al momento del ter-remoto del 1231, una porta sulla via Latina esisteva già, anche se ebbe poi neces-sità di restauri, come con ogni probabilità la stessa chiesa49.
45 Ryccardus de Sancto Germano, cit, p. 153. 46 de acutis, r.; pietrobono, s., 2009. Contributo per lo studio delle murature medievali
in opera quadrata nel Comitatus Aquinensis e nelle Marche costiere. Confronti e status quae-stionis. «atti v congresso nazionale della società degli archeologi Medievisti italiani»,foggia 1-3 ottobre 2009, pp. 751-756. pietrobono, s., 2011. Strutture castellane feudali. Lafamiglia d’Aquino, esempi dalla Valle Latina. in peduto p., santoro a.M. (eds),«archeologia dei castelli nell’europa angioina (secoli Xiii-Xv)», Medioevo scavato v,firenze, pp. 250-251.
47 come ricordava lo stesso grossi, 1907, cit., pp. 191-194.48 furono i successori del grande Rainaldus, vescovo di Aquinum nel 1156/7-1192, si veda
KaMp, n., 1973. Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien I. Prosopographi-sche Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194–1266. bd. i: abruzzen undKampanien, München (Münstersche Mittelalter-schriften, 10/i, 1), pp. 143-147.
49 pietrobono, s., 2003. Aquinum: Porta Capuana o di San Lorenzo. Una nuova interpre-tazione. in «Journal of ancient topography», Xiii, pp. 167 – 184; Ead. Un potere territorialenel medioevo della Valle Latina: gli insediamenti dei Signori di Aquinum. in atti «v congressonazionale della saMi», società degli archeologi Medievisti italiani, foggia 1-3 ottobre2009, pp. 349-354; de acutis, pietrobono 2009, cit., pp. 751-756. La problematica riguar-dante la porta va ripresa in altra sede.
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 53
La seconda “coppia” è posta nella parte superiore della lunetta, direttamenteconnessa all’immagine mariana: Mt – ov, comunemente ritenuta abbreviazione di Mhvthr Qeou (Mp-Qy), riprodotto con errori, separata dal nimbo della vergine50.
4. Il paesaggio di una cattedrale: l’Aula Dei GenitrixQuesto titolo di Maria, Madre di dio, nel mosaico introduce la problematica
epigrafe marmorea del portale, contenuta alla base del piedritto/stipite a sinistradell’osservatore, per la quale propongo una nuova interpretazione che parrebbeconciliare diversi aspetti della problematica questione della sua lettura.
Le lettere sono prevalentemente in nesso, e non abbreviate, per cui va sem-plicemente estesa: Aula Dei Genitrix / i(n)choata moderna. L’epigrafe sarebbestata incisa su un blocco lapideo con caratteri di tipo capitale ed elementi paleo-grafici caratteristici dell’area della Langobardia minor; parrebbe composta inesametri dattilici, con una croce iniziale a suggerire la natura di invocazione.infine, sarebbe stata affrettatamente commissionata ad uno scalpellino nondigiuno di tecnica lapicida, che avrebbe dovuto supplire ad un’imprevista man-canza dell’ultima lastra figurata a chiudere la linea del portale, nel corso dellaricostruzione della chiesa sul luogo di una precedente nella seconda metà dell’Xisecolo: l’inizio dei lavori sarebbe stato in tal modo al centro della celebrazionecon un’iscrizione richiamante sia l’erigendo tempio, sia alcune invocazionimariane quasi a predisporre il fedele alla preghiera51. che quello sia il testo, nonvi sono più dubbi da tempo. che la traduzione proposta (“è iniziata la costruzionedella nuova Chiesa della Madre di Dio” e simili) contenga invece numerosi inter-rogativi legati al messaggio ed alla funzione dell’iscrizione, è pure indubbio.
riprendendo l’analisi del galdolfo, “si arriva a datare nel corso della secondametà del Xii secolo anche la vistosa operazione di reimpiego di materiali antichiche caratterizza il portale con il ricordo delle due benefattrici”, operazione secon-do la quale tutto lo stipite sinistro si trova chiaramente programmato in sintoniacon l’inserimento del basamento inscritto. inoltre, trattandosi di materiali di reim-piego in condizioni non eccelse, è accettabile che non si sia scelto di iscrivere iltesto sul bordo delle lastre, come si è fatto per il portale di sora52, bensì di adottare
50 si confronti l’interpretazione delle architetture e dei nessi con le decorazioni nel lorocomplesso nell’imprescindibile saggio di carbonara, 1979, cit., pp. 99-145. non è questala sede per riprendere il problema delle architetture, per le quali la rilettura apportata a talesaggio sarà dettagliata in altra sede.
51 Ho cercato di riassumere in maniera chiara l’ultima sintesi rinvenuta in bibliografia:sbardeLLa, M., 2012. L’iscrizione del portale di ingresso di Santa Maria della Libera diAquino: un’ipotesi interpretativa. in nicosia, a. (a cura di). «aquino e oltre. studi e scrittisul Lazio Meridionale». aquino, pp. 57-71, con bibliografia precedente.
52 cerrone, f.; ferro, c., 2007. Note su alcune epigrafi medievali di Sora. temporissigna, ii, pp. 345- 356.
sabrina pietrobono54
scientemente “con un colpo di genio” un diverso sistema, adattando sapientementei materiali a disposizione, con un risultato oltretutto più accessibile53; la posizionedell’epigrafe, infatti, viene a rispondere a criteri di utilità: si trova nella parte piùalta del blocco, visibile a tutti, non per motivi legati alla fretta o per lasciare spazioad altro testo successivamente, ma perché in tal modo venga letta adeguatamente,distribuita utilizzando una riga superiore incisa per ordinare il testo.
a questo punto il senso dell’epigrafe differisce e la sua cronologia cambia,una cronologia che veniva determinata in realtà dall’ipotesi di una chiesacostruita intorno al 1070 - 1080/90 sul modello cassinese dell’abate desiderio,eretta in luogo di una precedente, esistente forse già nel iX secolo54; un’ipotesi,quella di un edificio precedente, che non scarto a priori, ma che ha troppo con-dizionato precedenti letture.
L’iscrizione lapidea potrebbe essere datata, stando ai criteri paleografici ed inconsiderazione delle sperimentazioni possibili in sedi periferiche, nonché del man-tenimento di alcuni caratteri regionali radicati, al Xii secolo55. di fatto, in connes-sione con il mosaico, il testo inciso - oltretutto preceduto da croce – ribadisce ladevozione mariana di Aquinum ma soprattutto rivela il nome della chiesa.
53 “ciò malgrado è evidente che i marmi erano già da prima in condizioni frammentarie ein quantità limitate, probabilmente da molto tempo smontati e saccheggiati, altrimenti non sigiustificherebbe la necessità di integrare la porzione mancante a completare lo stipite con unblocco liscio, solo segnato marginalmente da tre incorniciature rettangolari, l’una all’internodell’altra. con un colpo di genio, chi guidava il cantiere provvide a fare apporre nella parteinterna della tabella l’iscrizione: Aula Dei Genitrix inchoata moderna. ora è evidente che ilconcetto di modernità, oltre che la struttura architettonica nel suo insieme alla quale fa espli-cito riferimento, vuole coinvolgere anche la faticosa operazione di riuso dell’antico che carat-terizza, in maniera così decisamente inconsueta, il portale e nello stesso tempo ammiccarealla novità rappresentata in questo campo dall’intervento desideriano a Montecassino”.gandoLfo, 2009/10, cit., p. 98.
54 sbardeLLa, 2012, cit., pp. 58; 62. 55 senza neppure dover presupporre un riutilizzo di blocco già inscritto, ma riprenderemo
il problema della sua cronologia in un successivo contributo. Questo può riguardare la a conasta trasversa spezzata, che la presenza contemporanea di a con asta trasversale continuaindica usata come (per citare esempio di aree non distanti) nell’epigrafe di s. domenico disora, per la quale è stata proposta una datazione al Xii secolo, cerrone, ferro, 2007 cit., p.353-356, fig. 7, r. 3, e con la quale ha più di una somiglianza: nesso tr (r. 5); o ridotta, inse-rita in minimo spazio tra le lettere (r. 9); in generale il lapicida mostra la stessa maestria nelladistribuzione delle lettere in spazi ridotti del lapicida aquinate. Le aste non presentano mar-cate curvature, come invece visibili successivamente in esempi locali di seconda metà delXiii secolo: si veda ad esempio la lettera a dell’epigrafe di casamari, in patriarca, s., 2012.La rilettura di un’epigrafe medievale. in soLin, H. (a cura di). «Le epigrafi della valle di comino». atti dell’ottavo convegno epigrafico cominese, atina, palazzo ducale,28/29 maggio 2011, cassino, pp. 147-154.
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 55
L’espressione iniziale di “aula dei” è la diretta attestazione di un attributo usatonell’ufficio ecclesiastico (proprio Aula Dei): “haec est aula dei amplissima, de quaecclesia: Deus, qui virginalem aulam Beatae Mariae Virginis in qua habitares, eli-gere dignatus es”56; si elenca tale frequente uso da ambrogio (Dei Aulam eamvocat57), attraverso agostino (virginalem aulam), arnobio (virgineam aulam), edaltri. “genitrix” è direttamente connesso all’“aula”, con il centrale “Dei” in iperba-to, quindi è l’aula (= Maria, più propriamente l’utero verginale) ad essere genitrice:in definitiva si può tradurre letteralmente con “aula di dio genitrice”.
al centro del titulus/invocazione mariana rimane a questo punto più propria-mente Maria, la quale risulta inchoata moderna. in questa prospettiva si apronomolti significati.
Inchoata (incohata), immediatamente legato al Genitrix, è da tradurre con“incominciata”, “intrapresa”, se in riferimento ad un edificio, ma in senso figuratoanche “data ad inizio”, “istituita”, “proposta inizialmente”, per finire con “creata”(“Congrue autem Deus, qui vera lux est, a luce ornatum mundi voluit incohare”58)il che potrebbe anche condurre in ultima analisi a “generata”59.
Moderna è certamente contrario per significato ad antiquus, quindi: “ora”,“contemporaneo”; ma si contrappone in primo luogo proprio al termine inchoata
56 in particolare sono partita dalla voce “aula dei”, in spineLLo, p. a., s.J. 1619. MariaDeipara Thronus Dei, de Virginis Beatissimae Mariae laudibus praeclarissimis, napoli, pp.63-64, che raccoglie i passi dei padri di cui ho peraltro avuto riscontro. si veda tuttora ilMessale romano: “deus, qui virginalem aulam beatae Mariae, in qua verbum tuum habitaret,eligere dignatus es, da, quaesumus, ut, eius nos defensione munitos, iucundos facias interesseeius commemorationi”, barba, M., 2003. La figura di Maria nella terza edizione tipica delmessale romano. in tonioLo, e.M. (a cura di). «La vergine Maria nel cammino orante dellachiesa: liturgia e pietà popolare». roma, pp. 47-70, p. 13. interessante la data del momentoin cui si recita, il 14 agosto, vigilia dell’assunzione al cielo, il che spiega perché roccobonanni consideri la chiesa della Libera dedicata alla Madonna dell’assunta. bonanni, r.,1922. Ricerche per la Storia di Aquino. isola del Liri, p. 43. L’invocazione è già nelsacramentario gregoriano del iX secolo, WiLson, H.a., 1915. The Gregorian Sacramentaryunder Charles the Great, London, p. 96.
57 tra i molti passi dei trattati e delle epistole menzionati, cito, come nota esplicita: “anvero dominus Jesus eam sibi matrem eligeret, quae virili semine aulam posset incestarecoelestem, quasi eam cui impossibile esset virginalis pudoris servare custodiam?”,ambrosius, De Institutione Virginis Et Sanctae Mariae Virginitate Perpetua. capo vi. inMigne, J-p., 1880. patrologia Latina, n. 148, col. 317, n. 44.
58 remigius altissiodorensis, expositio super genesim, cura et studio, b. van naMeedWards, turnhout, 1999, (cccM 136), p. 10, linea 155, in spinosa, g., 2008. Ornatusmundi. Nota di terminologia filosofica medievale. «bulletin du cange: archivum latinitatismedii aevi», t. 66, pp. 201-212; nota 2, p. 201.
59 Ma a questo “generata” (pertanto prima “concepita”) occorre fermarsi, perché introdurreb-be un problema impossibile da affrontare in queste pagine, che è quello del dibattito sulla
sabrina pietrobono56
immediatamente precedente, che rappresenta esso stesso l’antichità, il punto d’i-nizio.
per cui l’Aula Dei Genitrix, cioè Maria, fu letteralmente “incominciata moder-na”: intrapresa, proposta, e così via, già moderna, come risulta ora, vergine primae dopo del parto come stabilito in principio, niente di cambiato, e simili significati,che a mio parere possono ruotare intornoalla Madonna. si potrebbe considerare ilsenso di “generare/concepire” per inchoare,che però apre un problema che sposterà l’in-dagine a studiare il contesto culturale delclero locale e della famiglia de aquino: sipuò già ricordare l’emergere dalle fontidell’energico rainaldo (1156/7-1192)60.non va neppure escluso un ricercato richia-mo all’edificio a lei dedicato, visto l’uso dif-fuso di incohare/inchoare nell’indicarecostruzioni materiali, che un colto vescovopoteva aver dettato, unendo ad un tempo lavergine/genitrice e la chiesa edificio, in unlegame figurale che può sussistere in untempo teologico quale il Medioevo.
Questa lettura, difatti, non annulla lapossibilità che ci sia stata una chiesa rinno-vata, anche radicalmente, dai lavori chevidero comporre l’iscrizione, ma ciò nonsolo per le previe interpretazioni dell’aula ...inchoata moderna, ma anche per le strutture incorporate nella muratura nord dellachiesa attuale, con tanto di portale e finestre61, che devono invece essere megliostudiate per verificare tale ipotesi (fig. 6).
ricordando l’abitudine alla metafora degli uomini di fede del medioevo, anchel’aula intesa come tempio fisico poteva essere stata intrapresa fin dal principio nellaimmacolata concezione, vivissimo nel Xii secolo, soprattutto in ambito anglosassone, coneadmerius ed il Tractatus de conceptione sanctae Mariae. si veda, ad esempio, una sintesiin Maranesi, p. 2005. Gli sviluppi della dottrina sull’Immacolata concezione nei secoli XII-XV. «italia francescana» 80, pp. 97-122.
60 KaMp, 1973, cit., p. 143-145. pietrobono, s., 2009. Note di topografia cultuale nell’a-gro pontecorvese medievale. in carcione f. (ed.). «culto, pastorale e uomini di chiesa nellastoria religiosa di pontecorvo», roccasecca, pp. 47-70.
61 oltretutto, se il bonanni 1922, cit., p. 42, non fu tratto in errore, tali porte e finestre siaprivano sulla via Latina, almeno fino al 1270.
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 57
fig. 6 – aquino (fr). santa Mariadella Libera. portale murato nell'ambi-to della parete laterale nord dell'edifi-cio (foto pietrobono, 07/01/2015).
“maniera” in cui fu infine visibile, sancendo quindi l’epigrafe un momento cele-brativo sì, ma complessivo.
non è quindi escluso che, al momento della costruzione del portale, i com-mittenti stessero costruendo la chiesa “iniziata moderna”: voluta fin da principioin maniera moderna (anche Maria fu voluta fin da principio nel modo in cui fu,ed è tuttora, per i credenti: prefigurata tale nel disegno divino). almeno, in unacittà periodicamente colpita da saccheggi, conflitti, terremoti e distruzioni comeAquinum, questo era il messaggio che si intendeva forse trasmettere. il senso diunità globale che l’edificio ecclesiastico rende oggi (nonostante i numerosi restaurieffettuati nel corso del tempo62), rifletterebbe un’unità di disegno generale inizialedi matrice cassinese, certamente allora moderno63. ad ogni modo, la mia propo-sta è che l’iscrizione contenga di fatto in primo luogo il titolo di dedica della chie-sa cioè il nome stesso della Madre di dio, espressa con un’invocazione non solopoetica ma di estrema bellezza, che può ispirare l’identificazione tra la figurastessa della vergine e il tempio sacro: una forza spirituale resa fisica come segnoimprescindibile nel territorio.
d’altra parte il bonanni ricordava il vescovato di aquino nelle note di un nonmeglio definito privilegio di alegaria (aloara) in episcopio vocabulo St. DeiGenetricis et Virginis64. una conferma che questo documento al momento perdutoLa particolarità di questo lato della chiesa fu segnalata da JacobeLLi, M.,1990. Gli enigmidella chiesa della Libera di Aquino. in coLafrancesco, g.b. «La chiesa di santa Mariadella Libera in aquino», cassino, p. 104.
62 un dubbio attinente la composizione del portale è sorto considerando la storia posterioredell’edificio. La chiesa attuale è il frutto di sostanziali ristrutturazioni avvenute in più occasio-ni; ulteriori interventi di restauro seguirono la radicale ristrutturazione che nel 1875 il vescovodi aquino paolo de niquesa aveva iniziato: pietrobono, 2013, cit., pp. 1189-1190. nel 1830,prima degli interventi di restauro, la chiesa si trovava in stato di abbandono, senza tetto:iadecoLa, c., 2000. La Libera di Aquino. Montecassino, pp. 38-39: per i restauri moderni, pp.54-67. stando ad una precedente relazione a re carlo iii di borbone, di casimiro gamboa,datata al 2 gennaio 1740, il suo stato «è cosa troppo spiacente a vedersi, essendo un edificiocotanto specioso, e coll’altare grande, coll’effigie di nostra signora, lavorato a musaico, conarchi e porte di finissimi intagliati marmi, che può al sicuro paragonarsi all’arcivescovado dinapoli»: interessante parallelo, che induce a riflettere sul tipo di percezione che si dovevaavere della chiesa della Libera, un edificio preminente nel contesto che richiamava devozionie fedeli, paragonabile ad una cattedrale. Ibidem, pp. 31-32. i portali, e quindi il portale diingresso ancora visibile oggi, erano composti da “finissimi intagliati marmi”, notizia che alme-no ci conforta sul fatto che il vescovo non operò sul portale ricomponendolo. nel 1679, però,la chiesa era stata restaurata da popolo e “da tempo in tempo” dal duca boncompagni,bonanni, 1922, cit., p. 47: cosa fu restaurato in quell’intervento? escludo che il portale possaessere stato alterato, pertanto l’epigrafe è nella sua sede primaria.
63 carbonara, 1979, cit., pp. 99-145; cfr la proposta di gandoLfo, 2009/10, cit., pp. 93-99. 64 bonanni, 1922, cit., p. 28. pietrobono, 2013, cit., p. 1188.
sabrina pietrobono58
fosse noto agli aquinati di età moderna proviene dai documenti di archivio, dauna lettera del pelagalli, il proprietario della forma d’acqua presso la chiesa dellaLibera, nel 1874; viene così datato alla fine del X secolo (985/6) dalla presenzadi Landenolfo di capua e della madre algaria (aloara), morta intorno al 992 emoglie di pandolfo testadiferro65. di conseguenza, dando credito al bonanni,occorre accettare che l’episcopio noto in città fin dal 97866 e che ospitava ilvescovo adalgiso includesse un edificio dedicato alla vergine e Madre, intuiti-vamente già collocato in corrispondenza dell’attuale s. Maria. un edificio che,se il carbonara colse nel segno, possiede attestazione fin dal iX secolo67, maanche successivamente ed ora possiamo tentare un riordino.
5. Un’epigrafe chiarificatrice?il problema sorge con la scomparsa del vescovo dalle fonti. cosa accadde dopo
il 985? Mansone fu al governo dell’abbazia e i conflitti tra cassinesi ed aquinatierano frequenti. il vescovo locale era riuscito a tenere sotto il suo controllo l’acqua
65 «adalgisus, episcopus aquini cui d[omi]na algariae dei gratia principessa, etd[omi]nus Landenolphus divina ordinante provvidentia, Longobardorum gentis princeps,filius d[omi]nae algariae et do[mi]ni pandulphi gloriosi principis coniugum, donaveruntaquam fiumicelli (ut ex registro ecclesia aquinatis confecto anno 1314 fol. 4). principatusipsorum Mense augusto quartadecimae indictionis», in castrianni, L., 2011. Aquinum.Documenti per la carta archeologica. foggia, p. 102. La menzione delle cariche longobardepre-normanne conferma la datazione al X secolo del documento e dell’episcopio e soprattuttoconferma l’azione che i principi capuani dovettero condurre a beneficio della città di cui nonrimane altra traccia a causa della perdita della documentazione.
66 nel gennaio 978, ind. vi, aa XXXv. pandolfo i e X, Landolfo vi, [aquino], «aduino,detto punzo, del fu giudice aduino vende all’abate aligerno una pezza di terra, in localitàulmito, che aveva avuto dall’episcopio «huius sancte aquinensis sedis», per venti soldicostantini». Leccisotti, 1972, cit., doc. 1291, n. 8, 205.
67 donazione di daniele di taranto, cMc i, 19, p. 64, sotto l’abate apollinare (817-828),Registrum Petri Diaconi, c. 84r/v. in Registrum Petri Diaconi: Il Registro di Pietro Diacono,deLL’oMo, M. (ed.), stampa anastatica i - Commentario codicologico, paleografico, diplo-matico, ii, badia di Montecassino, 2000, n. 190, p. 107. bLocH, 1986, cit., pp. 205-207.trascrizione gattoLa, e., 1734, Accessiones, venetiis, p. 28. una chiesa di s. Maria emergenel (962), luglio, ind. v, aa Xviii. pandolfo i e iv, Landolfo v, in aptu Aquini. «alcuni cit-tadini di aquino, alla presenza del gastaldo e signore adenolfo riconoscono a Leone prepo-sito di Montecassino e inviato dall’abate aligerno il diritto di proprietà del monastero suquattro pezze di terra nelle contrade di aquino, s. gregorio e Mandaturi», Leccisotti, 1972,cit., doc. 1288, n. 5, p. 204; scandone, f., 1909. Il castaldato di Aquino dalla metà del secoloIX alla fine del secolo X. «archivio storico per le province napoletane», XXXiv, 1909, doc.n. i, pp. 64-67, con testo. il documento rivela la presenza di una terra sancte marie, che sidovrebbe associare alla chiesa di s. Maria della Libera, ed una terra di s. pietro, forse la chie-sa di s. pietro vetere di aquino.
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 59
del Le sogne e questo a Mansone, di cui ancora nel 1272 si ricordano i mulinicostruiti lungo la corrente di capo d’acqua (a nord di s. Maria, alle falde delmonte s. silvestro, appendice del monte cairo), non poteva dare piacere68.Montecassino operò pressioni su questa porzione di terra occupata da acque,aree incolte e boscose da rendere produttive.
sono note da tempo due carte datate all’aprile 101269 e al gennaio 104370riguardanti una chiesa di s. Maria in gualdo71 detto ursitrude72: la prima è unatto in cui si offrono vigne, orti e case nella chiesa eretta nelle proprietà diMagiperto, figlio di giovanni, nota solo in regesto73: potrebbe pertanto trattarsi
68 20 aprile 1272, contenuto all’interno del regesto di bernardo i ayglerio; capLet, a.M.(a cura di) 1890. Regesti Bernardi I Abbatis Casinensis, Fragmenta ex archivo Casinensis.roma, n. 308, pp. 130-131.
69 (1012), aprile, ind. X, a. vi. pandolfo ii, aquino. «Magiperto, abitante di aquino efiglio del fu giovanni, offre nella chiesa di s. Maria eretta nella sua propria eredità nel teni-mento di aquino, in località Gualdo detto Ursetrude, la quarta parte dei suoi beni sia in teni-mento di aquino, che altrove, tanto in vigne che in orti e case», Leccisotti, 1972, cit., doc.1301, n. 18, pp. 209-210.
70 (1043), gennaio ind. Xi, a. v. guaimaro, aquino. «il prete stefano del fu Magiperto, nativoed abitante di aquino, offre al monastero di s. benedetto in Montecassino, tutta la parte che glispetta per eredità paterna della chiesa di s. Maria nel tenimento di aquino, in località gualdodetta ursitrude, con la corte ed i codici», Leccisotti, 1972, cit., doc. 1316, n. 33, p. 215; cayro,1811, cit., pp. 24-25. Oblatio Stephany presb(y)teri de Sancta Maria in Aquino, Registrum PetriDiaconi, 143v, deLL’oMo, 2000, cit., n. 330, p. 130; cMc, ii, 65, p. 296.
71 «gualdus»: Nemus, silva (c. du cange, 1678), du cange, et al., 1883-1887. Glossariummediae et infimae latinitatis, éd. augm., niort: L. favre, t. 4, col. 122c. on line.
72 il cayro, 1811, cit., p. 24 avanza l’ipotesi di coincidenza tra ursitrude ed ulmito, atte-stato in cMc, iv, 53, 519. La località ulmito è la stessa dove l’episcopio possedeva terre nel978. da qui si conferma che il cayro aumenta con i suoi dubbi il numero delle chiese di s.Maria (4 chiese ed un monastero); dopo l’altare dell’827 circa, elenca una s. Maria urbino,pure a p. 24, toponimo che sinceramente non spiego (urbana?), ma che l’autore indica esisterenel documento di Lotario iii, dove invece sicuramente si tratta della sola chiesa di s. Maria cheMontecassino documentava a scopo di rivendicazione: diploma di Lotario iii, Leccisotti t.,1965, I regesti dell’Archivio, ii, n. 49, p. 54; HottentHaL, e; HirscH, H., 1927. Die Urkun-den Lothars III und der Kaiserin Richenza, MgH, berlin, doc. 120, p. 197: in comitatuAquinensi ecclesiam sancti Mauri cum villa * Eucheria, * sancti Gregorii, sancti Mauricii,sancti Pauli, sancti Constantii, sancti Christofori, sancti Nicholai, sanctę Barbarę, sanctęMarię, sancti Laurentii, sancti Felicis et sancti Martini.
73 il testo non è edito ma dal regesto la parola usata è semplicemente eretta: non si evinceche sia stato proprio Magiperto a costruire la chiesa, ma lo sostiene il cayro, 1811, cit., p. 25,mentre il bLocH, 1986, cit., pp. 778-9, che studiò i documenti in archivio, attesta genericamentebuilt. va messo a disposizione il documento originale per comprendere il senso di “eretta”. eragià stata fondata su una proprietà poi ottenuta o pretesa da Magiperto o la eresse egli stessomagari per sostituirne un’altra? La casistica potrebbe essere molteplice: vitoLo, g.L’organizzazione della cura d’anime nell’Italia Meridionale Longobarda, in andenna, g.;
sabrina pietrobono60
di una fondazione laica. La seconda, che trasmette parziale donazione a Monte-cassino, si trova trascritta nel registro di pietro diacono, che ne rivela la dedica:de ipsa ecclesia sce Dei Genitricis et Virginis Marie que est constructa intra fini-bus de suprascripto Aquino loco Gualdo ubi dicitur Ursior (ursitrude)74. Questachiesa è stata ritenuta diversa dalla Libera, mentre invece sulla base del titolo ladistinzione cadrebbe: quante chiese ad Aquinum potevano portare la stessa esattadedica?
ammesso che la carta non sia stata costruita sulla base di diritti montati adarte per spianare la strada alle rivendicazioni monastiche nell’area, un privatopotrebbe tuttavia aver permesso alla chiesa locale, in un periodo di pressionecome gli inizi dell’Xi secolo, di usufruire di proprie porzioni di terreni, ad esem-pio confinanti con le terre o l’area dell’episcopio, per un ampliamento o similiprovvedimenti di un altare preesistente, o ancora potrebbe aver ricevuto, a variotitolo, porzioni di beni precedentemente ecclesiastici, terreni ad esempio, e poivolerli restituire alla chiesa stessa, per motivazioni ugualmente varie, nonché almomento ignote. avendo pochi documenti sull’area, non siamo certi che tipo direlazioni in questo caso esistettero tra l’episcopio già attestato e i privati, ma vene erano: sono spunti di ricerca su eventuali nessi col “gualdo”, cioè terrenoincolto e boscoso di origine pubblica75, segnale di una trasformazione da tempoin atto delle proprietà in Aquinum laddove Montecassino voleva avere un ruolo.
sappiamo inoltre che negli anni 1011-1022 si rinfocolò il conflitto tra l’aqui-nate atenolfo e l’abbazia76: non si può affermare che l’episcopio fu reso sedevacante ma, dalla fine del X secolo, di un vescovo aquinate, intuitivamente anti-cassinese, non vi è traccia.
nel 1043, nel corso della reazione di Montecassino contro i normanni insedia-tisi nella terra s. benedicti, la donazione ai monaci di porzioni di questo edificioda parte di stefano, il figlio di Magiperto, anticipa il riapparire del vescovo aqui-nate Angelus, poi deposto dal papa nel 1059. con tale pressione cassinese, sicomprende la decisione di assegnare la cattedra aquinate, nel 1060, a Martinus,osb77. picasso, g. (a cura di) 1996. Longobardia e Longobardi nell’Italia Meridionale. Le Istituzioniecclesiastiche. Milano, pp. 101-147, ha in precedenza chiarito alcune delle possibilità e laposizione dei vescovi circa le chiese erette dai privati.
74 anche bLocH, 1986, cit., pp. 778-9. 75 toubert, p., 1976. Pour une histoire de l’environnement économique et social du Mont-
Cassin (IXe-XIIe siècles). «comptes rendus des séances de l’académie des inscriptions etbelles-Lettres», 120e année, n. 4, pp. 689- 702.
76 Houben, H., 1989. Tra Roma e Palermo. Aspetti e momenti del Mezzogiorno medievale.galatina, p. 68.
77 si veda carcione, f., 2006. Pietro da Salerno e la sua missione presso l’imperatore
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 61
eppure se la Libera, come ho sostenuto, era il sito della chiesa vescovile78ma, come potrebbe essere, coincideva con questa chiesa in Gualdo Ursitrude,perché non specificare nei due documenti trattarsi di una parte dell’episcopio?perché forse i monaci, impegnati in quegli anni a ridimensionare i diritti altruiper enfatizzare i propri, non intendevano farla risaltare in quanto tale: a loro inte-ressavano il gualdo circostante, le acque, i fossi, i prati, i mulini “di Mansone”,il lago. una chiesa episcopale – tra l’altro fondatamente cattedrale quando vi èun vescovo in carica, preposto alle sue cure, ma debole qualora fosse in sedevacante – sarebbe stata più difficile da reclamare: certo in un documento legaleoccorreva chiarire quale fosse la chiesa in questione, infatti il titolo è stato scrittoper intero per non creare confusioni. ad ogni buon conto, fu solo una questionedi tempo, poiché un monaco benedettino quale vescovo ad Aquinum potevarisultare un grande aiuto nel gestire una simile situazione. e non soltanto lui,visto che un decennio dopo appare in città un inaspettato amministratore: l’abatedesiderio in persona.
Mentre nel 1066 iniziava la costruzione della nuova basilica di Montecas-sino, poi dedicata nel 107179, la lotta per le investiture si preparava anche per lavalle Latina: i signori di Aquinum dovettero affrontare le forze di goffredo diLorena e Matilde di canossa80 presso Aquinum, giungendo infine ad un accordocon il margravio di toscana81.
nel 1071 riccardo di capua diede la città di Aquinum, ma più probabilmentela metà incamerata dal fisco per eredità, a giordano, suo figlio e collega82. La ful-minea ribellione al padre fece sì che il principe decidesse di affidare la facoltà diamministrare la giustizia ad adenolfo di Aquinum, che continuava a detenerneuna metà, mentre la cittadella (la ròche) e la difesa militare vennero affidateall’abate desiderio. gli aquinati scacciarono i monaci e gli uomini che controlla-vano la rocca, prendendone il posto; il cassinese ed il capuano furono costretti aconvocare la cittadinanza, per sanare il dissidio83.bizantino Michele VII. in cappeLLetti, L.; MoLLe, a. (a cura di). «pietro da salerno, monacobenedettino e vescovo di anagni», venafro, pp. 74-75, nota 30.
78 pietrobono, 2013, cit., p. 1190. 79 Annales Casinenses. g.H. pertz (ed.) 1866, MgH, scriptores (in folio) (ss), t. Xviiii,
Hannoverae, pp. 306-307; codd. 2-3. 80 1067. gotfridus dux cum exercitu venit campaniam usque aquinum. Ann. Casin., cit.,
n. 79, p. 306; codd. 2-3. Storia dei normanni volgarizzata in antico francese di Amato diMontecassino (Ystoire de li Normant), v. de bartHoLoMaeis (ed.) 1935, fonti per la storiad’italia 76, roma, lib. 6, 10, 272.
81 cMc, iii, 23, 389-390. Amatus, cit., 6, 10, 272.82 scandone, 1956, cit., p. 59.83 Amatus, cit., 6, 24-27, pp. 286-289. 1071, primavera - estate.
sabrina pietrobono62
il 28 giugno 1074, il papa ricorda di aver consacrato nel primo anno di pon-tificato «Leonem episcopum in campania aquinensem»84. La lotta per Aquinumfu risolta forse verso questo periodo: «o tu, aquin! cestui mal est venut sur toi!et finie ceste chose, Jordain tint la roche et la cité»85. intanto i rapporti tra Leonedi aquino e il monastero erano più che cordiali, se il vescovo aquinate salì alMonte per consacrare l’altare di san pietro86: l’abate aveva ottenuto il suo scopo,ma avrebbero potuto prima desiderio, poi Leone e successori, accontentarsi diuna chiesa esistente all’inizio dell’Xi secolo? in quali condizioni versava? é tantoinverosimile che siano intervenuti nell’episcopio, proponendo un loro “disegnomoderno” di stampo cassinese, avviando dei lavori, visto che la sede vescovile daLeone in poi dimostrò maggiore stabilità e che nel 1148 sarà ricordato il palazzodel vescovo guarino (1136-1148)87? ed in quali condizioni santa Maria giacquesuccessivamente agli attacchi del 1155, che portarono addirittura allo smantella-mento delle mura cittadine88, in una diocesi dal 1156/7 sulle spalle del ricordatorainaldo89?
L’impatto di questa identificazione sul paesaggio aquinate chiarirebbe d’uncolpo i dubbi inerenti la posizione apparentemente isolata dell’edificio in un’a-rea circostante il Lago Maggiore indiziata di contatti con il culto della Mefite90,il che spiegherebbe la sovrapposizione precoce del culto mariano e la necessitàdel suo radicamento anche fisico nel luogo. intorno alla chiesa si estendevaun’ampia pianura acquitrinosa, solcata da fossati e canali. La strategia monasticaera chiara: in primo luogo controllarne le acque, in particolare il Lago Maggiorea ridosso della chiesa, ed il Le sogne, il fiumicello di capo d’acqua che dal Xsecolo era legato alla chiesa di Aquinum, concessione rinnovata nel 1166 proprioa rainaldo91.
84 cMc, iii, 34, 410. caspar, (ed.) 1955. Das Register Gregors VII. berlin, i, 85a, p. 123.85 Amatus, cit. Lib. 6, 29, 289. 86 carcione, 2006, cit., p. 77. 87 regesto di s. Matteo de castello o servorum dei, tabularium casinens regesta 2, badia
di Montecassino, 1914, doc. Xvii, pp. 34-37. 88 de acutis, pietrobono, 2009, cit., p. 751. 89 per il gaMs, p. b., 1957. Serie episcoporum ecclesiae catholicae, gratz, c. 852, anche
rainaldo era monaco benedettino.90 La località Méfete ad Aquinum, presso il Lago Maggiore, sulla sponda opposta rispetto
alla chiesa di santa Maria della Libera viene costantemente associata alla divinità pagana.per la Mefite, cedrone, c., 2005. Il culto di Mefite nella Valle di Comino. in soLin, H. (acura di). «Le epigrafi della valle di comino. atti del primo convegno epigrafico cominese».alvito, palazzo ducale, 5 giugno 2004, abbazia di casamari, pp. 11-32.
91 bonanni, 1922, cit., p. 13. pelagalli, 1874, in castrianni, 2011, cit., p. 102.
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 63
dopo un primo dono dei principi capuani delle acque del Lago Maggiore92Montecassino temporaneamente prevalse: ottenne la rinuncia degli aquinati93, stan-do sempre alla documentazione di parte cassinese, ed ancora nella seconda metà delXiii secolo i monaci detenevano diritti sullo sfruttamento delle sue acque94.
si percepisce che intorno a santa Maria le tensioni tra cassinesi e clero localedovettero essere frequentemente vive e provocarono una sua decisa “discrimina-zione” nelle fonti, prevalentemente monastiche, con durature conseguenze, inparticolare quando la città si spopolò. Questa chiesa che portava il nome di“vescovato” nei secoli cadde così in oblio seguendo il declino del centro abitato,che dalle guerre del Xv e Xvi secolo decrebbe progressivamente95. nonostantegli abitanti ne conoscessero l’esatta identità, erano pochi i letterati aquinati apotersi opporre alla visione erudita, ma confusa, che della chiesa si andava con-solidando in letteratura basandosi sui documenti medievali monastici ormaipatrimonio comune.
92 1081, settembre 16, ind. v., aa. XXiiii e XiX., capua. «giordano i di capua: ad inter-cessione della moglie gaitelgrimma, dà a Montecassino, retto dall’abate desiderio, le treparti del lago maggiore, che furono già dei ribelli conti di aquino». Leccisotti, 1965, cit., n.9, p. 108. «preceptum eiusdem de lacu aquinensi», da parte di giordano di capua e dellamoglie, Registrum Petri Diaconi, c. 180v/181r; deLL’oMo, 2000, cit. n. 417, p. 141; cMciii, 47, p. 425; iii, 61; 441, nota 10, gattoLa (ed.), 1734, cit., pp. 187-188 («videlicet trespartes de lacu Majore, qui fuit comitatum aquinensium, qui contra animam nostram cogita-verunt, et consiliati sunt unde omnes res eorum legaliter nostro fisco adducte sunt, et est insuperiori parte civitatis cum ripis suis et cum introitu, et exitu suo, et cum omnibus rivis, etvenis aquarum, quae in ipso lacu influunt, et cum omnibus piscacionibus suis, quae quovismodo in ipso lacu fieri possunt, et cum omnibus trecenariis, que sunt iuxta ipsam silicem adpossessionem suprascripti monasterii [...]»); scandone, 1956, cit., n. XXXiii, p. 129.
93 1083, (1082), febbraio, ind. vi, a. XXXv. giordano, Montecassino. «i conti di aquino,adenolfo, Landolfo, pandolfo e Lando, con i figli del conte giovanni Landone: danno aMontecassino, retto dall’abate desiderio, il lago Maggiore presso aquino». Leccisotti,1965, cit., n. 31, p. 116. scandone, 1956, cit., n. XXXiv, p. 130. 1083, febbraio. «oblatio delacu aquinensi». Registrum Petri Diaconi, f. 151 r/v; deLL’oMo, 2000, cit., n. 346, p. 131;ed. gattoLa, 1734, cit., p. 188: cMc iii, 47, p. 425, n. 4 («per eos etiam dies comesadenulfus simul et fratres fecerunt oblationem suam in hoc loco de lacu maiori, ubi est iuxtacivitatem aquinensem, cum omnibus eiusdem loci pertinentiis super eam oblationem, quamante annum princeps iordanus fecit»).
94 interessante la descrizione presso “il muro della terra”: Monasterio cassinensi provisioquod non molestetur in possessione partis piscationis lacus aquini, qui est iuxta muros dicteterre. in MazzoLeni, b. (a cura di), 1939. Gli atti perduti della cancelleria angioina transuntida C. De Lellis, vol. i, roma, n. 689, p. 115.
95 dall’epistolario di onorato caetani, si viene a sapere che per un anno circa, nel 1461,costui occupò aquino. in seguito ad un accordo stipulato nel 1460 con il figlio del re renato,giovanni d’angiò, il caetani aveva ottenuto la promessa di ricevere roccasecca, castrocieloe aquino. in una lettera del 9 Marzo, il caetani specifica la data della morte di berardo
sabrina pietrobono64
ConclusioniLe epigrafi hanno storia complessa: è noto che siano in prevalenza materiali
mobili, di rado conservate nel luogo al quale erano in principio destinate, ma neiloro spostamenti furono rilevate mediante schizzi, oppure dipinte, descritte, piùtardi fotografate, infine pubblicate.
La seconda vita delle epigrafi, quella iniziata dopo la cessazione della lorofunzione primaria, una volta distrutta la strada o la canalizzazione alle quali siriferivano, e molti altri casi ancora, si rivela in una lunga ricerca tra terreno,codici e libri, nel tentativo di ricostruirne i contenuti ed il contesto.
una seconda vita che nel corso dei secoli ha talvolta contribuito a dipingeremediante schizzi il paesaggio mutevole trasformato intorno ad esse; e propriograzie ad esse, più o meno direttamente si sono accumulati appunti e dati rile-vanti non soltanto per chi le considera oggetto primario del proprio studio, maanche, e talvolta soprattutto, per lo studioso del paesaggio.
alcune di esse, le pietre scritte, assunsero nuove funzioni ufficiali, inserite asegnare confini territoriali. altre rimasero in vista, ma incomprese, o poco valo-rizzate, a volte assumendo un valore nuovo proprio per il loro essere divenuteincomprensibili.
in questa sede è stato deciso di analizzare epigrafi che hanno avuto ruoloimportante nella comprensione di come i nostri predecessori abbiano percepitoe trasformato il proprio paesaggio: lo si è visto nel caso delle iscrizioni rupestridi casalucense e di Montattico, dove guidano a riconoscere l’azione dell’uomonel contesto ambientale: violato, nel primo caso, con il quale doversi rappacifi-care mediante dedica incisa alla divinità, oppure un contesto disperso tra i monti,da dover dominare rendendolo accessibile e rivendicare attraverso l’epigrafe.
un paesaggio in mutamento si è rivelato ad Aquinum, nell’usare il contenutodi un testo per viaggiare tra i documenti medievali allo scopo di ricomporre ilcontesto intorno ad una chiesa affascinante ma ancora poco compresa. La connes-sione tra epigrafe, monumento e paesaggio – anche architettonico - nella letturadell’iscrizione del portale di santa Maria della Libera ad Aquinum rappresentauna proposta ponderata che suggerisce una dimensione spirituale impressa nellapietra, dimenticata per secoli, ma che tesaurizza il senso figurato delle paroletipico della cultura medievale: una dimensione spirituale oggigiorno non piùimmediatamente percepibile, ma che fornisce dei significati nuovi da considera-re nel cammino della ricerca.gaspare de aquino, a strangolagalli nel giorno della festa di s. tommaso d’aquino. nel1462, a gennaio, aquino risultava persa, e il signore rivendicava danni materiali. caetani,g., 1926. Epistolarium Honorati Caetani. Lettere familiari del cardinale Scarampo e corri-spondenza della guerra angioina (1450-1467). san casciano val di pesa, pp. 70-176.
La seconda vita deLLe epigrafi: casi studio per... 65