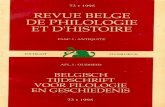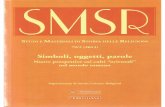G. R. BELLINI- L. COPPOLA- M. ZAGAROLA, Novità epigrafiche da Aquinum, in Le epigrafi della Valle...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of G. R. BELLINI- L. COPPOLA- M. ZAGAROLA, Novità epigrafiche da Aquinum, in Le epigrafi della Valle...
Premessa
Negli ultimi tempi il convegno epigrafico cominese ha ampliato il campodi interesse anche alle zone contermini alla Valle di Comino. Per questo motivoho aderito con piacere all’invito degli organizzatori per presentare alcune te-stimonianze epigrafiche dal territorio di Aquinum.
- Fig. 1. Stralcio della carta dell’ager di Aquinum (BELLINI-MURRO-TRIGONA 2012 in c.s.): ta-vola riepilogativa.
Come è noto, da anni sono impegnata con il mio gruppo di lavoro nel pro-getto “ager di Aquinum conoscere per tutelare”, nato dall’esigenza di struttu-rare e correlare i dati che provengono dalle necessarie attività di tutela legatealle numerose opere pubbliche, di pubblica utilità e private che si susseguonoincessantemente nel territorio della colonia.
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA
NOVITÀ EPIGRAFICHE DAAQUINUM
In queste attività - di scavo e di ricognizione - sono state acquisite le tretestimonianze epigrafiche che presenterò coadiuvata da due dei miei collabo-ratori, il dott. Luca Coppola e il dott. Matteo Zagarola.
La prima testimonianza è pertinente ad un’ara funeraria rinvenuta negliscavi archeologici nell’area della Chiesa di San Tommaso sulla via Latina aCastrocielo (fig. 1, n.1)
La seconda è pertinentead un monumento funerarioin contrada Filetti Superioread Aquino, rinvenuta nelcorso di ricognizioni nonlontano dalla via Latina inuscita dall’aeroporto dellacittà, nella parte di ageraquinate che ancora con-serva intatti i caratteri del-l’organizzazione di etàromana (fig. 1, n. 3).La terza è una tabella de-
fixionis dalla necropoli oc-cidentale di Aquinum im-mediatamente all’esterno
della porta romana, in territorio di Castrocielo, rinvenuta nel 2007 nel corso degliscavi sistematici condotti ininterrottamente dal 2005 al 2010 nell’area di servizioCasilina Est dell’autostrada Roma-Napoli (fig. 1, n.2).
1. L’ara funeraria dalla Chiesa di San Tommaso
L’ara funeraria è stata rinvenuta nel 2010 nell’area antistante la Chiesa diSan Tommaso, raffigurata sullo stucco “Aquini civitas roman(o)r(um) colonia”nel Palazzo Boncompagni Viscogliosi di Isola Liri (fig. 2)1 e in una stampa dianonimo del XIX secolo (fig. 3)2.
1 NICOSIA 2006, 34 fig. 9. Lo stucco fa parte di una serie di 18 raffigurazioni rappresentanti ipossedimenti dei Boncompagni nel ducato di Sora e di Arce e negli "stati" di Arpino e diAquino; ornano la Sala degli stucchi nel Castello Boncompagni a Isola Liri e sono databili trail 1665 e il 1669, in occasione dei lavori di ristrutturazione del castello in seguito al terremotodel 1654, v. CEDRONE 1997; gli stucchi isolani dovrebbero quindi essere coevi di quelli del"Casino della Pesca" a Posta Fibreno, raffiguranti i domini del Ducato di Alvito, e forse rea-lizzati dallo stesso decoratore.2 NICOSIA 2006, 18, fig. 2.
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA8
- Fig. 2. Veduta del centro medievale di Aquino (sullo sfondo)e dell’area della città romana (in primo piano) nello stuccoseicentesco del palazzo Viscogliosi di Isola del Liri (FR).
In epoca romana l’area, immediatamente al di fuori dalla città di Aquinum,è caratterizzata dalla presenza di sepolcri monumentali, i cui resti sono ancoravisibili nella stampa sopra citata; da questa zona provengono infatti numerosireperti funerari, epigrafici e scultorei, in parte dispersi, in parte conservati nelmuseo di Aquino3, in parte inseriti nel muro di delimitazione di via degli Orefici4
o, infine, reimpiegati nelle strutture della Chiesa5.
3 Nel museo di Aquino sono esposti, nella sezione romana, due notevoli reperti rinvenuti nel1989 durante i lavori di ampliamento di via degli Orefici, costituiti da una statua femminilepanneggiata di destinazione funeraria databile tra l’età augustea ed il I sec. d.C. (NICOSIA 2006,39 e fig. 12) ed un grande blocco calcareo con iscrizione funeraria decorato da un fregio agirali di acanto, uccelli ed eroti, databile ad età augustea; questo blocco si integra con un repertoacquistato sul mercato antiquario di Roma ed immesso nel 1912 nel Museo Nazionale Romano(Inv. 59506, v. Museo Nazionale Romano. Le sculture, I, 7, 1984, 402, nr. XIII.12). Dalla ri-composizione grafica dei due frammenti si desume una larghezza del monumento funerariosuperiore ai due metri, ed è possibile ricomporre il testo epigrafico che riporta la dedica delseviro C. Eppanius Philo a sé stesso, al liberto C. Eppanius Menophilus ed alla moglie EppaniaAntiopae anch’essa liberta, v. NICOSIA 2006, 50-51, fig. 15, BIANCHI 1989, 215- 224, tav. 1 eGÜNTHER SCHÖRNER 1996, 269–270.4Nel muro di delimitazione di via degli Orefici sono stati inseriti -al termine dei lavori di ampliamentodella strada – numerosi reperti architettonici (blocchi in calcare, soglie in marmo, parti frammentariedi colonne scanalate) tra cui spicca un fregio con metopa (su cui è schematicamente rappresentatauna corazza) e triglifi ascrivibile per la tipologia ai monumenti funerari con fregi dorici, ed in parti-colare a quelli con armi attestati da analoghi reperti sulla via Latina nel tratto tra il Melfa e porta Ro-mana, riferibili a sepolcri di veterani, per cui in generale v. POLITO 1998, 134- 143.5 Nella chiesa di San Tommaso è inserito nella parte inferiore della facciata un blocco calcareo
NOVITÀ EPIGRAFICHE DA AQUINUM 9
- Fig. 3. La Chiesa di San Tommaso in una stampa anonima del XIX secolo.
L’ara funeraria con maschere tragiche era reimpiegata nelle strutture tardoantiche su cui si è impostata la chiesa medievale. Il reperto ed il suo contestosono stati presentati da me e da Simon Luca Trigona in occasione della mu-sealizzazione dell’ara nella Casa comunale di Castrocielo il 14 febbraio 2011,e pubblicati sui folders di Fasti on line6. Ne parlo dunque in questa occasionenon come inedito, ma come recente acquisizione, che arricchisce il già notevolepatrimonio epigrafico aquinate7.
L’ara, a corpo parallelepipedo di calcare, è del tipo con colonnine tortili ecimasa di coronamento triangolare desinente in due acroteri a quarto di cerchiodecorati con maschere tragiche (fig. 4). Al centro del fastigio di coronamentoin una lunetta sono due mostri marini (grifi?) affrontati e separati da un tridente(fig. 5). Sui lati dell’ara campeggiano due geni alati con fiaccole rovesciate(fig. 6), mentre il retro è privo di decorazioni.
Lo zoccolo è costituito da alto plinto, toro e scozia. La specchiatura epi-grafica è racchiusa da una partitura architettonica con colonnine tortili su basicomposte da plinto e doppio toro, terminanti con capitello ionico.
Lo stato di conservazione è mediocre8, anche a causa del reimpiego. La su-perficie mostra evidenti segni di un’erosione generalizzata a carico della com-ponente carbonatica del blocco; questo fenomeno, di natura chimica, ha causatol’indebolimento della struttura cristallina con la conseguente formazione di mi-crocrateri superficiali ed appare particolarmente evidente nel campo epigrafico,soprattutto nella porzione superiore destra ed inferiore sinistra.
Nella specchiatura epigrafica (h. 64, largh. 38 cm) il testo, di difficile let-tura (fig. 7), si dispone su 9 righe e sembra rimandare alla dedica dell’ara da
con fregio a girali di acanto, uccelli, erote centrale ed iscrizione funeraria CIL X 5450, mentresulla parete del lato destro si trova un blocco pertinente ad un monumento funerario con festone(NICOSIA 2006, p.88). All’esterno della chiesa ed oggi dispersi erano inoltre conservati una pic-cola ara con l’iscrizione CIL X 5420 e le iscrizioni funerarie CIL X 5438 e 5557. A questo proposito inoltre è molto significativa la stampa del XIX secolo, che mostra pressola chiesa di San Tommaso vari blocchi con iscrizioni funerarie (oltre al miliare LXXX di C.Calvisio Sabino). Da notare sul margine destro della stampa, l’ara dei Cultori di Ercole fedel-mente disegnata, e l’iscrizione CILX 5407, entrambe reimpiegate nelle strutture di Santa Mariadella Libera. Il terzo blocco a sinistra della chiesa è simile, per dimensioni, forma e colloca-zione, alla nostra ara con maschere tragiche, pur se riporta il testo epigrafico sul lato in vista. 6 BELLINI-TRIGONA 2011.7L’ara è musealizzata nell’atrio della casa Comunale di Castrocielo, su progetto diG.R. Bellini,S.L. Trigona e F. Pittiglio. Si ringrazia la soc. Cominio s.r.l, ed in particolare l’arch. R. Moscone,che ha reso possibile l’allestimento.8 Per le osservazioni sulla tecnica di esecuzione e sullo stato di conservazione si ringrazia il re-stauratore dott. E. Montanelli cui si deve l’intervento di pulitura e consolidamento.
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA10
parte di una non meglio identifica-bile Prima ad una defunta probabil-mente omonima (figlia?):
1 [Dis] M(anibus)+[---]M[- c. 3 -]+[-?]P+[---][------]
5 ++[- c. 2 -]+[- c. 4]QV[a]E VIX(it) ANN(is) +[.]E++L<E>A PRIMA[---]+[---][BENE] MER[enti?]
La trascuratezza esecutiva deri-vante dalla copia di prototipi resicon grafia grossolana ed approssi-mativa suggeriscono una realizza-zione dell’ara nell’ambito del IIsecolo d. C. ad opera di un artigianolocale.
Il reperto rientra nella tipologiadegli altari o are funerarie, in uso trail I sec. a.C. ed il II sec. d.C. (con at-testazioni anche nel III sec. d.C.), edin particolare in quella degli altaricon funzioni commemorative, suiquali si potevano versare libagioni9.
Ad Aquinum sono note l’ara deicultori di Ercole Vincitore (CIL X5386), murata nella parete esterna destra del transetto della chiesa della Ma-donna della Libera; due are dalla località Torre San Gregorio, tra cui la probabileara di Publio Plotio Rrustico con urceus sul lato destro e patera sul lato sinistro,oggi conservata nell’Aeroporto di Frosinone10, l’ara funeraria sormontata da-timpano desinente in acroteri con patera e urceus sui lati datata al II sec. d.C.
9ALTMANN 1905 distingue i grabaltare, delle dimensioni di m 1,00- 1,20, dagli aschenaltarepiù piccoli, utilizzati come cinerari.10 SOLIN 2005, p.372 n. 1.
NOVITÀ EPIGRAFICHE DA AQUINUM 11
- Fig. 4. Vista frontale dell’ara funeraria (foto diE. Montanelli).
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA12
- Fig. 5. Particolare della fascia sommitale dell’ara funeraria (foto di E. Montanelli).
- Fig. 6. Particolare del lato sinistro del-l’ara (foto di E. Montanelli).
- Fig. 7. Particolare del campo epigrafico dell’ara (fotodi E. Montanelli).
con dedica al duoviro M. Atilio / Restituto patri da Contrada Filetti Superiore(Case Petrilli-Masseria Colella); e infine l’ara funeraria di Baebia Prima con-servata nel Museo Nazionale di Varsavia (CIL X 5447)12 che riporta lo stessocognome della persona menzionata nell’epigrafe presentata.
Il rinvenimento assume una particolare valenza sotto molteplici aspetti: in-nanzi tutto è da notare come, tra le are funerarie ad oggi note da Aquinum, soloquesta presenti motivi decorativi dal forte simbolismo di derivazione dioni-siaca, pur se ormai immiseriti rispetto ai prototipi e forse di fatto privi di va-lenze simboliche. In secondo luogo l’ara conferma la presenza di officinemarmorarie nell’area presa in esame, già ipotizzate per il vaso con segni dellozodiaco e per la testa femminile da Torre San Gregorio13. Il retro non lavorato,infine, lascia supporre che l’ara fosse addossata a parete, quindi inserita in unmonumento funerario, presumibilmente identificabile con le strutture anticherinvenute durante le recenti indagini archeologiche, così come doveva avvenirenella stessa epoca per molti dei sepolcri monumentali lungo la via Latina14.
L’attestazione di monumenti funerari lungo la via Latina (sia nel tratto ex-traurbano occidentale che in quello orientale) contribuisce inoltre a confermareanche per Aquinum l’evoluzione degli usi funerari che portano, in età impe-riale, ad una distinzione di censo tra la sopravvivenza di aree funerarie per lesepolture dei ceti meno abbienti e la definizione di una via monumentale ca-ratterizzata dalla presenza dei sepolcri dei ceti più ricchi15.
Giovanna Rita Bellini
11 GIANNETTI 1969, 80, n. 33; AE 1988, 266.12 SOLIN 1997, pp. 73-74, fig. XXV.13 BELLINI-MONTANELLI-TRIGONA 2010, p. 211 e ss.14 Il riutilizzo come materiale da costruzione di reperti architettonici ed epigrafici funerari, oltreche nella chiesa di San Tommaso (NICOSIA 2004, 26 ed il recente contributo in MURRO 2010,72-77), è ben attestato in tutto il territorio aquinate, in particolare nelle strutture della chiesaurbana della Madonna della Libera (v. DI FALCO 2007, in particolare la n. 12 con bibliografiarelativa alla dibattuta problematica del riutilizzo) e negli insediamenti monastici della TorreSan Gregorio a Est (SOLIN 1998) e di San Vito sul Melfa ad Ovest (GIANNETTI 1988, 346-349).15 V. von HESBERG 1994.
NOVITÀ EPIGRAFICHE DA AQUINUM 13
2. Un’epigrafe inedita da Contrada Filetti
In occasione delle ricognizioni archeologiche effettuate nell’anno 2011 inlocalità Filetti Superiore nel Comune di Aquino (FR) sono stati identificati,all’interno di un vecchio casale in via Selvotta, alcuni elementi lapidei parti-colarmente interessanti tra cui un’iscrizione parzialmente leggibile16. L’epi-grafe oggetto di questa presentazione è incisa su un lato di una lastra calcareadi forma quadrangolare (ca 100 x 80 x 35 cm)17, probabilmente rinvenuta neglianni ‘60 durante lavori agricoli e successivamente trasportata all’interno delcortile del casale (fig. 8)18.
Il campo epigrafico è molto consunto e presenta un alto grado di abrasionedovuto probabilmente all’esposizione agli agenti atmosferici. L’autopsia haevidenziato due “momenti epigrafici” (fig. 9).
M
------ S P M ---
Nella porzione centrale della lastra è stato possibile leggere alcune letterealte ca. 4 cm e due linee guida che presuppongono un intento scrittorio noneffettuato. Al primo rigo è visibile la lettera M leggermente inclinata verso de-stra, seguita da un rigo sottostante illeggibile; al terzo rigo si leggono tre lettere
16 Si coglie l’occasione per ringraziare la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio,nella persona della Dott.ssa Giovanna Rita Bellini, per avermi dato la possibilità di studiarel’epigrafe recuperata. Allo stesso modo voglio ricordare i colleghi Trigona, Murro, Azzalea eZagarola con i quali condivido la passione per la ricerca.17 Il retro non risulta visibile.18 Preziosa è stata la testimonianza di alcuni contadini del posto che hanno fornito precise indica-zioni riguardo al rinvenimento di blocchi e altro materiale lapideo dal terreno adiacente il casale.
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA14
- Fig. 8. Particolare dell’epigrafe al momentodel rinvenimento (foto di L. Coppola).
- Fig. 9. Calco del reperto (ril. L. Coppola).
in successione: una S, una P ed una M con tratti intermedi non allungati finoalla base della lettera.
------ ?P(ublio) HOSTILIO [---?]M(arco) MESSIO [---?]
Nella porzione angolare dellalastra (fig. 10) è ben riconoscibileun campo epigrafico (ca. 42 x16,5 cm) meglio conservato ri-spetto al precedente, di cui restanodue righe alte 7 cm ognuna conun’interlinea di 2,5 cm; l’iscri-zione menziona due forme ono-mastiche terminanti in -o: P(ublio)Hostilio e M(arco) Messio.
Caratteri distintivi di questa iscrizione sono il segno di interpunzone diforma triangolare con apice rivolto verso l’alto, la P di Publio con l’occhielloaperto e la S con asse verticale leggermente inclinato verso destra. Si evidenzia,inoltre, la T di Hostilio con asta montante ed i tratti della lettera M, di Messio,che appaiono leggermente divaricati.
Particolarmente difficoltosa, visto il grado di deterioramento, è la letturadella parte centrale dell’epigrafe di cui è stato possibile riconoscere solamentepoche lettere; queste risultano diverse da quelle del campo epigrafico angolareda cui si discostano per le dimensioni (ca. 3 cm di differenza)19. Il dato rilevanteche emerge da questa iscrizione è la presenza di due personaggi, Publio Ostilioe Marco Messio, finora sconosciuti tra le epigrafi aquinati.
Un P. Hostilius è attestato ad Anagnia in una dedica funeraria del II sec. d.C.20, a Venafrum come duoviro (CIL X 4883)21, a Reate in un iscrizione funerariadatata tra il 30 a. C. ed il 30 d. C.22 e a Belluno in un’iscrizione sacra datata al
19 Ciò indurrebbe ad ipotizzare un rapporto di anteriorità dell’iscrizione centrale rispetto aquella angolare che implica un riutilizzo del blocco.20 EDR 032652 del 14/11/2008 (Ilaria Gabrielli): P(UBLIUS) HOSTILIUS P(UBLI) l(IBER-TUS) PRIMUS / SIBI ET P(UBLIO) HOSTILIO (MULIERIS) l(IBERTO) PLATYPODI / PA-
TRONO SUO.21 CIL X 4883: L. HOSTILIO L. F. TER. P[---] / P. HOSTILIO L. F. TER. PI[---] / AED. DUO-VIRO[---] / M. HOSTILIO L. F. TER[---] / HOSTILIA L. F. PRI[---] / SOROR FECIT. Semprea Venafrum, in CIL X 4952, c’è l’iscrizione ”Hostiiae � L Amaryllidi”.22AE 1999, 0576(2) = EDR 104131 del 09/06/2010 (Giada Cenerini): P(UBLIUS) HOSTI-LIUST(ITI) F(ILIUS) / QUIR(INA).I caratteri paleografici delle due epigrafi sono molto
NOVITÀ EPIGRAFICHE DA AQUINUM 15
- Fig. 10. Particolare del campo epigrafico angolare(foto di L. Coppola).
I-II sec. d. C.23 Il gentilizio è inoltre testimoniato in Campania24, a Iuvanum,25 a Roma26 e ad Ostia27.
M. Messio è presente su iscrizioni provenienti principalmente dall’area co-stiera laziale e campana. La formula prenome + gentilizio, simile a quella del-l’iscrizione aquinate, è presente a Roma28, a Ostia29 e a Cumae30. Più ingenerale il gentilizio Messio si ritrova sovente a Roma31, a Formiae (CIL X6085 e 6108), a Teanum Sidicinum (CILX 4780)32, a Pompei (CILX 888, 892,901, 8058 n. 53), a Surrentum (CIL X 8129), a Neapolis (CIL X 2732-33), aCumae (CIL X 2734), a Puteoli (CIL X 2735) ed a Capua33.
Dal confronto con le iscrizione edite34, le forme onomastiche attestate nel-l’epigrafe, riconducono ad importanti famiglie inserite nel contesto economico-commerciale dell’area campano-laziale tra la tarda età repubblicana e la primaetà imperiale; inoltre alcuni di essi hanno ricoperto cariche amministrative indiverse città: un Publio Ostilio è stato duoviro a Venafro, un Lucio Messio cu-rator è attestato a Roma ed un Publio Messio, insieme ad altri magistrati, è
affini tranne che per il tratto montante della T che, nell’iscrizione reatina non si prolunga oltreil tratto orizzontale.23 EDR 097703 del 30/01/2007 (Damiana Baldassarra).24 Su tegole bollate da Sorrento, Ercolano, Pompei, Torre del Greco, Napoli, Puteoli (CIL X8042 n. 58: HOSTI[---]) e da Eboli (CIL X 8042 n. 59: T. HOSTIL[---]). Infine su un delfinodi bronzo da Napoli (CIL XII 8072 n. 12: A. HOSTILIUS A. F. / MANCIN[---]).25 AE 1990, 0225 = EDR 081770 del 06/08/1997 (Scheithauer).26 AE 1923, 0080 = EDR 072912 del 01/08/1996 (Scheithauer); due epigrafi funerarie datataal I sec. d. C. EDR 006396 del 10/01/2003 (Ilenia Gradante) ed EDR 107818 del 13/02/2011(Ilaria Doriente); una iscrizione sacra datata tra il 71 a.C. ed il 30 a.C. (?) EDR 106436 del27/12/2010 (Giovanni di Brino).27 AE 1971, 0066 = EDR 075099 del 26-06-1997 (Niquet).28 In un epitaffio funerario EDR 109538 del 28/03/2011 (Grazio Urso): D(IS) �(ANIBUS) /M(ARCUS) MESS[IUS] / MARTIA[LIS] / VIXIT A[N- - -] / - - - - - -.29 AE 1989, 0126 = EDR 081273 del 02/06/1997 (Scheithauer): M(ARCUS) MESS[IUS ? ---]/ [Q(UIN)Q(UENNALIS) COL[L(EGII) ---].30 Un’epigrafe funeraria della prima metà del I sec. a. C. è in AE 1980, 0244(2) = in EDR077681 del 25/04/2009 (Giuseppe Camodeca): M(ARCUS) MESSIUS / M(ARCI) L(IBERTUS)HERACLIDA.31 Su due iscrizioni onorarie datate al III sec. d.C. in EDR 104184 del 19/10/2010 (Simone Pa-stor) e EDR 104508 del 19/10/2010 (Simone Pastor). Su iscrizioni funerarie datate tra il I sec.a. C. ed il II sec. d. C. in EDR 005347 del 01/11/2003 (Laura Capurso), EDR 006434 del10/04/2003 (Ilenia Gradante) e EDR 104324 del 22/06/2010 (Giorgio Crimi). Infine su unaiscrizione che menziona un “… Lucius Messius Rusticus curator alvei et riparum Tiberis etcloacarum urbis…” in EDR 072781 del 28/07/2004 (Feraudi).32 Con cognome grecanico (Stichus). EDR 102134 del 13/09/2009 (Giuseppe Camodeca).33 EDR 072866 del 19/12/2006 (Margherita Foglia): … / P(UBLIUS) MESSIUS Q(UINTI)
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA16
ricordato per la costruzione di opere pubbliche e private a Capua.La frequenza delle attestazioni di entrambe i gentilizi in iscrizioni pubbliche
dell’area campano-laziale, nonché la loro posizione nel campo epigrafico, po-trebbe identificare i due personaggi come coppia magistratuale, forse duoviri,attiva ad Aquinum in un periodo compreso tra la tarda età repubblicana ed iprimi secoli dell’impero. Laposizione del campo epigra-fico, a ridosso della porzioneangolare della lastra, sugge-risce l’accostamento di que-sta ad altri elementi lapideiin modo da completare untesto epigrafico più esteso(fig. 11), probabilmente rife-ribile ad una dedica funera-ria contenuta in una facciatadella struttura sepolcrale incui la presenza dei magistratiin carica poteva assumere valenza cronologico35.
Tale interpretazione trova conferma nell’areale di rinvenimento, nell’imme-diato suburbio orientale della città (fig. 1, n. 3), caratterizzato da una forte persi-stenza centuriale e da numerose testimonianze archeologiche di caratterefunerario: nell’area di Contrada Filetti, già nota alla storiografia locale36, sonoconservate nel cortile delle Case Petrilli-Masseria Colella (fig. 1, n. 4) l’ara di M.Atilius Restitutus37, e un cippo funerario38, mentre un’altra iscrizione sepolcrale
L(IBERTUS) / … / [HEISCE MAGISTREIS --- TR]EIB(UNAL) CUNIU(M) MULIEREB(US)
/ [---] LUDOSQ(UE) FECERUNT[t ---] / [---]O CO(N)S(ULIBUS).34 La ricerca di questi due gentilizi ha focalizzato l’attenzione sul Lazio e sulla Campania,anche se numerose testimonianze riguardanti la gens Hostilia provengono da Brescia (CIL V4427, 4429, 4161, 4243).35A tal proposito è interessante citare l’iscrizione CIL XIII 5708: “… I[N]SCRIBATUR(QUE)IN AEDIFICIO EXTRINSECUS NOMINA MAG(ISTRATUM), QUIBUS COEPTUM ERIT ID
AEDIFICIUM ET QUOT ANNIS VIXERO …” (CIL XIII 5708).36 BONANNI 1922, pp. 119-120.37 GIANNETTI 1969 p. 80, n. 33: D(is) M(anibus) / Atiliae M. f. Resti/tutae M. Atilio / Restitutopatri /aed(ili) IIviro quae(stori) / et Pomponiae Coene / matri Liberalis e(t) Profuturus patro/nis
b(ene) m(erentibus) fecerunt / [li]bertis libertabusq(ue) / posterisque suis.38 GIANNETTI 1969 pp. 75-76, n. 11: V(ivi) F(ecerunt) / C. Pomponius / Fortunatus / ---- / etCaediciae He[---] / coniugi / posterisque / in fr(onte) p(edes) XXIIII / in ag(ro) p(edes) XII.
NOVITÀ EPIGRAFICHE DA AQUINUM 17
- Fig. 11. Ipotesi ricostruttiva dello sviluppo epigrafico suiblocchi della facciata.
documentata nel 197539 (fig. 12) risulta oggi dispersa; in prossimità della Mas-seria Fusco sono attestati sarcofagi, urne funerarie ed elementi architettonici40
(fig. 1, n. 5-7); altre epigrafi sono testimoniate nei pressi della Chiesetta di SanMarco41 dove è stata ipotizzata la presenza di un mausoleo42 (fig. 1, n. 8).
I dati a disposizione, unitamente al contesto topografico, offrono la possi-bilità di ricostruire il paesaggio agrario di epoca romana attraverso la localiz-zazione puntuale dei siti che spiegano le scelte insediative all’interno dellamaglia centuriale di epoca triumvirale43 e meglio definiscono lo sviluppo dinuclei funerari monumentali legati alle grandi proprietà fondiarie della zona,sorti in corrispondenza della viabilità centuriale.
Luca Coppola
39Scheda di catalogo SBAL n.14563 (1975) redatta da P. Vittucci, con trascrizione: ..... /DALV.../ ACUME SIBI ET / SUIS LIBERTIS / LIBERTABUS e foto. Ancora inedita nel 1975, vienepubblicata in SOLIN 1993, p. 403-nota 123, con lettura differente: Dam… e Acume.40 COARELLI 1964, pp. 51-5441 BONANNI 1922, p. 120, descrivendo la Contrada Filetti, affermava: “… La Chiesa era co-struita con pietre di grosse dimensioni e varie lapidi con iscrizioni sono state rinvenute negli
scavi fatti nei dintorni. Alcune lapidi iscrizionali vedonsi murate nelle casette di più o meno
recente costruzione. …”.42 MOLLE 2009, p.116, nota 149.43 BELLINI-MURRO-TRIGONA in c.s.
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA18
- Fig. 12. L’iscrizione murata nel lato anteriore sinistro della Masseria Pasquale Colella
(Scheda di Catalogo SBAL 14563, Maggio 1975).
3. Una tabella defixionis da Aquinum
La lamina plumbea presa in esame44 è una tabella defixionis provenientedalla tomba 14 (fig. 13) degli scavi di Casilina Est 200745. Presenta una formaquadrangolare (fig. 14) e misura 110 x 110 x 4 mm. Al momento del ritrova-mento era piegata a metà e trapassata da un chiodo di ferro. Aperta, presentatre fori passanti del diametro di 9 mm, due dei quali nella parte destra della la-mina, attraversati dal chiodo; l’altro foro, situato nella parte superiore sinistradel reperto, è il risultato di un primotentativo di perforazione non riu-scito. Residuo di questa operazioneè un rigonfiamento nella parte infe-riore sinistra in corrispondenza delforo superiore; in pratica la durezzadella lamina ha impedito una primaperforazione sulla parte sinistra,mentre è riuscita nella parte destra.
Il chiodo è a testa tonda, lungopoco meno di 20 cm, equivalenti adun bes46, cioè otto dodicesimi (8\12)di piede, ed ha un diametro di circa0.5 cm; tuttavia il diametro originale poteva essere maggiore, in quanto il re-perto è notevomente corroso dalla ruggine. Il ruolo svolto dal chiodo di ferropotrebbe non essere meramente funzionale: tale oggetto aveva infatti nelle pra-tiche magico-rituali una forte connotazione simbolica, e tuttora, nei riti di magiamoderni, soprattutto in quelli afferenti alla cosiddetta “magia nera”, in partico-lare per le maledizioni e le fatture, vengono utilizzati chiodi di ferro e spilli47.
44 Ringrazio vivamente la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, nella personadella Dott.ssa Giovanna Rita Bellini, ed il Dott. S. L. Trigona, per la possibilità di studio of-fertami e per l’aiuto fornitomi, il Dott. G. Murro per le fotografie e la digitalizzazione delleimmagini, e ringrazio il Dott. L Coppola e la Dott.ssa V. Azzalea per la loro collaborazione.45 TRIGONA 2007.46 DI STEFANO 1987, p. 184, cfr. HULTSCH 1882 e SEGRE 1928.47 Tali pratiche si ritrovano sia in “ricettari” moderni di magia che in studi più autorevoli di carattereantropologico. v. MOIA 2003, pp. 119- 122, AA. VV. 1999, pp. 198- 200. In entrambi i libri dimagia, gli spilli di ferro sono connessi alle fatture con il limone, le moderne defixiones; un esempio:“...incidete il nome dell’avversario, fate il segno della croce... infiggete 99 spilli...”. cfr. AA. VV.1981 pp. 235- 241, AA. VV. 1927 pp. 34- 35 e 466- 468, BARTOLI 1994, in cui si analizza, sotto ilprofilo antropologico, l’utilizzo nei riti magici di chiodi e spilloni in vari contesti, non solo in Italiaed in Europa, ma anche in Africa ed in Sud America. Si veda anche GAGER 1992.
NOVITÀ EPIGRAFICHE DA AQUINUM 19
- Fig. 13. Il contesto di ritrovamento della tabelladefixionis (foto di S. L. Trigona).
Il significato intrinseco del chiodo è ancora molto dibattuto e molte sono leinterpretazioni fornite dagli studiosi. Secondo alcuni il chiodo servirebbe peraumentare il senso di paura e mistero unite all’augurio di morte, e dunque peraccrescere nel maledicente la sicurezza della riuscita del rito48. Sicurezza chederiverebbe, secondo un’altra interpretazione, dal patto con la divinità: in praticainfilzare il chiodo nella tabella in cui è scritta la maledizione equivale a sug-
gellare l’accordo con la divinità stessa,gesto paragonabile alla nostra strettadi mano. Un’altra interpretazione vedeil chiodo fungere da catalizzatore delleenergie tra la dimensione terrena equella ultraterrena, dunque sarebbe unmedium tra il mondo dei vivi ed ilmondo dei morti, o comunque ilmondo infernale, da cui le forze infereavrebbero dovuto tornare per colpireil malcapitato, ciò spiegherebbe ancheperchè venivano infisse con il chiodoben piantato in terra: le energie prove-nienti dal mondo sotterraneo infero,avrebbero avuto libero accesso, attra-verso il chiodo, al testo della defixio,che quindi non correva il rischio di es-sere male interpretato oppure non ca-
pito, e dunque sarebbe stato più probabile che le forze infere avrebberosoddisfatto le richieste49.
Il chiodo può trovare anche spiegazione in una tipologia di magia meno sim-bolica: infilzare un feticcio raffigurante il nemico è un gesto che vuole trasportareil dolore dall’oggetto alla persona; infatti esso diventerebbe la persona stessa, equindi infilzarla con un chiodo equivarrebbe ad infilzare direttamente il bersaglio,e la stessa cosa poteva dunque accadere per le defixiones: colpire e traforare latabella era come traforare e colpire il maledetto, attraverso le imprecazioni scritte.
La lamina è pressoché integra, salvo per una porzione dell’angolo inferioredestro. La parte esterna è anepigrafe, mentre la parte interna è fittamente iscritta.
48 V. KAGAROW 1929.49 PGM VII, 1973, r. 451- 2: “...le tavolette erano bruciate o gettate in un fiume, o nella terra,o nel mare, il luogo di appartenenza del bersaglio desiderato; per le gare, il piano dello stadio.”
Per una più approfondita disamina della questione v. JORDAN 1989, PP. 55 e ss.; SGD 1985.
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA20
- Fig. 14. La tabella defixionis (foto di G. Murro).
Il campo epigrafico corrisponde all’intera superficie della lamina. Ben rico-noscibile è un testo di 15 righe, scritto in maiuscola corsiva a sgraffio (dettaanche capitale corsiva)50, inciso con un oggetto appuntito. Le righe 6, 7 e 8 sonomolto lacunose a causa della piega della lamina, che ha obliterato quasi com-pletamente le due righe. In generale comunque tutta la parte inferiore è moltorovinata e lacunosa, soprattutto la parte destra delle righe, mentre la parte supe-riore è relativamente ben conservata. Il testo è probabilmente inciso con la puntadel chiodo di ferro poi utilizzato per perforare la tabella; ciò spiegherebbe perchèverso il basso i solchi delle lettere si fanno sempre meno profondi: dopo le primerighe infatti subentrava la stanchezza nel braccio dello scrivente, per la difficoltàdi incidere un testo con un chiodo su una superficie liscia come il piombo.
Riporto di seguito la trascrizione del testo emerso dall’autopsia (fig. 15):
1 M(arcus) Satrius, M(arci) fili(us),his <h>ostis M(arci) Luteini (!)Simedi, M(arci) f<i>l(ii), siu{s} (!)invidia, damno tibi,
5 sic unio ne sit tibi i<n> his ossis,
ut acuis [---]RI i<n> <h>is ossis,in suis ++[---]++++ Satriu(s) i<n> <h>is ossis;sic [- c. 5 -] nesu(s) (!) ringensib(us) (!)a canibus +i++++++o sit [---?],
10 idem s<i>t pinem(!) [---]no.Mem<i>nist(i) mi(!) +n+osiS+a++g++ sua [---] (unum) (sestertium) dedi s[- c.3 -]ne+++[---]duxiseris(!) as+++[---]
15 omnes [---?]
Dal punto di vista paleografico, le lettere non hanno tutte le stesse dimensioni,e vanno dai 4 millimetri delle lettere delle ultime righe ai 16 millimetri circadelle S delle prime righe. Essendo un testo graffito l’impaginazione non è armo-nica, le righe in alcuni casi si incurvano verso l’alto o verso il basso; l’angolo diinclinazione delle lettere è vario e non segue alcun criterio; il testo procedeinclinandosi leggermente verso sinistra, come a riga 14, dove vediamo la pa-rola duxiseris, e specialmente le lettere D e X molto inclinate. Le lettere, nel
50 PETRUCCI 1992, pp. 45- 50.
NOVITÀ EPIGRAFICHE DA AQUINUM 21
corpo del testo, non sono prati-camente mai incise allo stessomodo: ciò è evidente soprattuttoper alcune lettere, come adesempio la M, la quale già nellariga 1 compare prima in tre trattiverticali di cui il primo piùlungo, dopodiché invece conquattro tratti verticali; ancoraquattro tratti verticali per le M diriga 2 e 3, mentre poi da riga 7in poi troviamo le M a quattrotratti obliqui. Stesso discorsopuò essere fatto per la lettera D,che in alcuni casi è più simile aduna D capitale piuttosto che aduna corsiva, come invece sivede in altri casi, come a riga 14(Duxiseris); ancora più partico-
lare è il caso della parola dedi di riga 13, in cui la prima D è con pancia a si-nistra, mentre la seconda, di dimensioni maggiori, è a pancia destra. La letteraS è forse quella che, nel testo, ha più varianti; va infatti dalle S di dimensioniridotte e ben curve delle ultime righe al segno pressochè verticale e molto al-lungato di riga 2; tale differenza è imputabile alla difficoltà di incisione sulpiombo e dall’utilizzo di un oggetto scrittorio improprio. Nel testo troviamotre nessi, il primo a riga 9 (A\C di a canibus) (fig. 16), il secondo a riga 11(M\N di memnist) (fig. 17), il terzo a riga 12 (U\A di sua).
La traduzione, abbastanza libera, che propongo, è la seguente:
“Marcus Satrius, figlio di Marcus, per invidia nei tuoi confronti, del suo ne-
mico Marcus Luteinus Simedus, figlio di Marcus, ti maledico, così che ti si di-
sarticolino le ossa, e si acuisca il dolore(?) nelle tue ossa, (lacuna) le ossa;così che il tuo naso sia sbranato dai cani ringhiosi (lacuna), e la stessa sortetocchi al tuo pene! Ricordati di me (lacuna). Ho dato un sesterzio per quandogli capiteranno (lacuna) tutte le maledizioni scritte di sopra”.
Il testo è articolato in 4 momenti.
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA22
- Fig. 15. Apografo del reperto (rilievo di G. Murro).
Le righe 1-4 contengono inomi del maledicente e del male-detto, e la motivazione della ma-ledizione.
Le righe 5-10 contengonol’elencazione delle parti delcorpo oggetto dell’attuazionedella maledizione, e le modalità.
Il rigo 11 contiene l’impreca-zione terribile e drammatica me-ministi mi, cioè “ricordati di me”.
Le righe 12-15 contengonol’affidamento della maledizioneal defunto della tomba ove la ta-bella viene infissa affinchè sia portata negli inferi e da lì torni a colpire il ne-mico, oppure ad una entità superiore.
La prima parte del testo nonpresenta particolari problemi in-terpretativi: è infatti presente laformula onomastica (MarcusSatrius Marci filius) della per-sona che scaglia la maledizione,la formula onomastica della per-sona da colpire (Marcus Lutei-nus Simedus Marci filius) ed ilmotivo di questa maledizione,cioè l’invidia. il gentilizio Sa-trius è abbastanza frequente intutto il mondo romano ed è atte-stato dall’Africa alla Gallia, con
una forte presenza a Roma; nel Lazio centro meridionale, è attestato una voltaad Anagni51, una volta ad Atina52 e due nella stessa Aquinum53,
51 AE 1993, 440.52 CIL X, 5047.53 CIL X, 5520: P(ublius) Satrius L(uci) f(ilius) / loc(us) mon(umenti) ded(it) / P(ublio) HilaroTyrannidi / libert(o) et Perenno et S(exto) / Tertio in f(ronte) p(edes) XII in agro p(edes) / XIIII
e CIL X, 5521: V(ivi) / N(umerius) Satrius / N(umeri) l(ibertus) Hilarus / N(umerius) Satrius/ N(umeri) l(ibertus) Andrea / in f(ronte) p(edes) XVI / in a(gro) p(edes) XVI / Fertoriae / uxori
NOVITÀ EPIGRAFICHE DA AQUINUM 23
- Fig. 16. Particolare della r. 9, nesso delle lettereA/C (foto di G. Murro).).
- Fig.17. Particolare della r. 11, nesso delle lettereM/N (foto di G. Murro).
anche se il praenomen non è lo stesso, oltre che a Pompei54 e Capua55. Il male-dicente dunque si presenta solo con praenomen e nomen, fatto non inusuale nelledefixiones56.
Nessuna attestazione invece per la seconda formula onomastica, nè per ilnomen Luteinus57 nè per il cognomen Simedus58. Il gentilizio Luteinus potrebbetuttavia essere riconducibile al già attestato Latinius, conosciuto in zone limi-trofe ad Aquinum59. Sarebbe dunque una forma corrotta di tale gentilizio, cosache non stupisce in un testo redatto da un individuo con scarsa dimistichezzacon la scrittura, il quale peraltro commette una serie di errori disseminati inogni parte del testo. Il cognomen Simedus invece, mai attestato, può probabil-mente essere messo in relazione alla parola Semi-medus, cioè “mezzo medo”,di sangue mezzo persiano, o in genere orientale: da un originale semimedus siottiene Simedus per contrazione delle lettere -em60. Il nome potrebbe tuttaviafar riferimento invece alla città di Simena61, in Licia, e sarebbe dunque da leg-gere Simenus62. Tutte le opzioni dunque sembrano rimandare ad una ambienteorientale, di cui probabilmente la famiglia del personaggio era originaria.
Interessante l’utilizzo della parola hostis, che ci spiega meglio il motivodell’invidia provata da Marcus Satrius: hostis è inteso come il rivale amoroso,dunque Marcus Luteinus Simedus è in tal senso il nemico di Satrius. Quindi èper invidia amorosa che Satriusmaledice Simedus, augurandogli che gli si di-sarticolino le ossa, che i cani gli sbranino il naso. Le righe 6 e 7 sono purtroppomolto lacunose, e solo la parte finale è leggibile: il finale della riga 5 è ripetutoanche alle righe 6 e 7. É verosimile ritenere che si tratti di una formula magica63
dato che il procedimento della ripetizione di formule o frasi fa parte dei caratteri
54 CIL IV, 1978: M(arcus) Satr(ius) e CIL IV, 5364.55 CIL X, 3979.56 V. AUDOLLENT 1904.57 V. SOLIN, SALOMIES 1994.58 V. SOLIN 1982, KAJANTO 1982.59 CIL X 5256, da Casinum: M. LATINI / PHILEROTIS ...; CIL X 5257, sempre da Casinum,SEX. LATINI SEX I[---]... / SABO...; CIL X da Atina, ... / P. LATIN LUCANUS / ...; CIL XIV2067, da Pratica, LAVINIA LATINI / FILIA; CIL XIV da Aricia TI. LATINIUS ... / PANDUSA.60 Tale procedimento è attestato in Varro, L. 5 174; 10. 38: Simbella, quod libellae dimidiumquod semis assis. Da semi+libella dunque si ottiene simbella. Il termine semimedus è utilizzatoin Apul., Apolog., 24: Semimedus et semipersa. Termini silmili poi sono comuni in latino (cfr.semigraecus, seminumida).61 Plin. 5, Hist. Nat. 27. 28. 62 Plin. 34, Hist. Nat. 8. 19.63 V. AUDOLLENT 1904; OGDEN 2002.
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA24
strutturali del rituale praticamente in ogni religione64. Anche il numero di taliripetizioni, 3, ha presuminilmente un significato magico.
Le righe 8, 9 e 10, anche se presentano lacune abbastanza estese, possonocomunque essere interpretate: Marcus Satrius infatti condanna il suo hostis ad essere sbranato dai cani, iniziando dal naso. Questa interpretazione troverebbeconferma in un modo di dire tutt’ora utilizzato in alcune zone del Lazio meri-dionale, topograficamente affini al luogo di ritrovamento della defixio, che initaliano suona come “possano i cani sbranarti cominciando dal naso”; questaè la “maledizione” peggiore che, ancora oggi, si possa scagliare contro il ne-mico: infatti non solo ad esso si augura la morte, ma l’essere sbranato comportaanche la completa sparizione del cadavere, e dunque l’impossibiltà di riceveresepoltura.
Non è raro ritrovare nelle defixiones qualche imprecazione che abbia a chefare con il naso o con altre parti del corpo, come ad esempio la defixio da Min-turnae65, che presenta una lista di parti del corpo che dovevano essere colpitedalla maledizione, tra le quali c’era il naso. La riga 10, collegata strettamentealle due righe superiori, ci da la conferma dell’interpretazione della motiva-zione alla base della maledizione e quindi dell’utilizzo della parola hostis: aSimedus infatti si augura che, oltre ad essere sbranato dai cani, essi sbraninoanche il suo pene; d’altronde, quale male peggiore si può augurare al rivaleamoroso?
Purtroppo le righe rimanenti sono molto lacunose e solo poche parole epoche lettere sono leggibili. A riga 11 sono riconoscibili le parole Mem(i)nist(i),che potrebbero far parte di una formula del tipo “quando ti succederà questoti ricorderai di me”.
Nelle ultime tre righe il dedicante si rivolge direttamente alla entità chedovrebbe esaudire la sua maledizione, dicendogli chiaramente che gli ha datoun sesterzio; purtroppo il testo è molto lacunoso, ma l’interpretazione che sipuò avanzare è che il sesterzio dato da Marcus Satrius sia un “pegno” lasciatoalla entità, nella sicurezza che essa duxiseris omnes, cioè che recapiterà al mal-capitato tutto ciò che lui gli augura. Come infatti succedeva per gli ex voto, lastessa cosa poteva accadere in casi come questi66.
64Ampie ed autorevoli sono le trattazioni sul tema. Per un approfondimento di questo aspettospecifico si veda ad es. ELIADE 1966 e LÉVI- STRAUSS 2008; per quanto riguarda la religioneRomana arcaica, minuziosa è la trattazione di DUMÉZIL 1977.65 CIL X, 8249.66V. SEG, 4. 61, da Centuripae, in cui si legge, riferito alla divinità, “se mi vendicherai, ti faròfare uno spadix d’argento”.
NOVITÀ EPIGRAFICHE DA AQUINUM 25
La datazione può essere desunta da elementi interni al testo. La presenza incui nessi e legature iniziano ad essere inseriti nella scrittura corsiva; la leggeradeitre nessi suggerisce una datazione posteriore al I sec. d.C.67, cioè al periodoinclinazione verso sinistra è invece tipica del II secolo, mentre non compaionoancora segni derivati dalla scrittura su papiro, che diverranno usuali anche sumateriali più duri nel III secolo, come ad esempio la E angolare. Sulla base ditali elementi si può avanzare una datazione probabile del reperto e del contestodi ritrovamento al II sec. d.C.
Matteo Zagarola
67 V. PETRUCCI 1992, pp. 45- 50; BISCHOFF 1990; DI STEFANO 1987, pp. 221- 230.
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA26
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
AA. VV. 1927, Rivista di antropologia: atti della società romana di antropologia, vol 27, (a cura di) Società Romana di Antropologia, Roma pp. 34- 35 e 466- 468.
AA. VV. 1981, Chiodi e ferri da cavallo nel folklore europeo, in Archivio per l’antropologiae l’etnologia, vol. 111- 112, (a cura di) Società Italiana di Antropologia e Etnologia, So-
cietà Italiana di Antropologia, etnologia e psicologia comparata, Roma, pp. 235- 241. AA. VV. 1999, Autori vari, Magia Pratica 1, Milano, pp. 198-200.ALTMANN R. 1905, Die romischen Grabaltare der Kaiserzeit, Berlin.AUDOLLENTA. 1904, Defixionum tabellae quotquot innotuerunt, Luteciae Parisiorum.BARTOLI P. 1994, Tocca ferro: le origini magico- religiose delle superstizioni su fortuna e
sfortuna, Perugia.BELLINIG.R -MONTANELLI E.-TRIGONA S.L. 2010, Il restauro di un grande recipiente marmoreo
con segni dello zodiaco da Aquinum - Un caso di sinergia tra tutela (Soprintendenza) esviluppo economico (Cosilam) nella provincia di Frosinone (Lazio), in Restauro: sinergietra pubblico e privato - XVII Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei beniculturali e ambientali, Ferrara 24-27 marzo 2010, p.211 ss.
BELLINI G. R.–TRIGONA S. L. 2011, Un’ara funeraria con maschere tragiche dai pressi dellachiesa di San Tommaso sulla via Latina fuori porta San Lorenzo, in FOLD&R FastiOnLinedocuments & research (222), pp. 1-11.
BELLINI G. R –MURRO G.–TRIGONA S. L., L’ager di Aquinum: la centuriazione, in Lazio & Sabina 8, in c.s.
BIANCHIA. 1989, Un cippo inedito di Aquino, in Miscellanea greca e romana, 14, 215- 224.BISCHOFF B. 1990, Latin palaeography: antiquity and the Middle Ages, Cambridge.BONANNI R. 1922, Ricerche per la Storia di Aquino, Alatri.CEDRONED. 1997, Gli stucchi della villa della Pesca, in Il ducato di Alvito nell’età dei Gallio, I,
Castelliri, 243-263.CERAUDO G. 2004, (a cura di), Ager Aquinas, Marina di Minturno.COARELLI 1964, Note sulla topografia extraurbana di Aquino, in QuadIstTopA, 1, pp. 51-54.DELPLACE Ch. 1980, Le griffon: de l’archaisme à l’époque impérial: étude iconographique
et essai d’interprétation symbolique, Bruxelles-Rome.DI FALCOA. 2007, Novità epigrafiche dalla chiesa della Madonna della Libera di Aquino, in
ArchCl, LVIII, n.s. 8, Roma.DI STEFANOMANZELLA I. 1987, Mestiere di epigrafista, Roma.DUMÉZIL G. 1977, La religione romana arcaica, Milano.EDR, Epigraphic Database Roma in www.edr-edr.itELIADEM. 1966, Il mito dell’eterno ritorno, Roma. GAGER, J. G. 1992, Course tablets and binding spells from the ancient world, New York Oxford.GIANNETTI 1969, Ricognizione epigrafica compiuta nel territorio di Casinum, Interamna Lirenas
ed Aquinum, in RAL, XXIV, Roma.GIANNETTIA. 1988, Notiziario archeologico. Ciociaria e zone limitrofe, Cassino. GÜNTHER SCHÖRNER 1996, Nicht Abruzzen, sondern Aquinum. Zur lokalisierung eines Sevirn,
in ZPE, 111.von HESBERG H. 1994, Monumenta - I Sepolcri Romani e la loro Architettura, Omegna.Hultsch 1882: Hultsch F., Griechische und romische Metrologie, Leipzig.JORDAN 1989: Jordan D. R. New Evidence for the activity of scribes in Roman Athens, in Abstracts
of the American Philological Association - 120th Annual meeting, Baltimore, Atlanta, pp. 55 e ss.
NOVITÀ EPIGRAFICHE DA AQUINUM 27
KAGAROW 1929, Griechische Fluchtafeln, Leopoli.KAJANTO I. 1982, The latin cognomina, Roma.LÉVI- STRAUSS C. 2008, L’uomo nudo, Milano, [tit. orig. L’homme nu, Paris, 1971].MOIAG. 2003, Manuale di stregoneria, Roma.MOLLE C. 2009, Ancora sulla “patria” di Giovenale, in H. Solin (a cura di), Le epigrafi della
Valle di Comino (Atti del V Convegno Epigrafico Cominese), pp. 83-132.MURRO 2010, Monumenti antichi di Aquino: la Porta San Lorenzo e il cosiddetto Capitolium,
Castrocielo.NICOSIAA. 2004, Il centro medievale, in CERAUDO 2004, 24-29.NICOSIAA. 2006, Museo della Città e del Territorio. Aquino, Roma. OGDEN D. 2002, Magic, Witchcraft and ghosts in the Greek and Roman worlds, Oxford.PETRUCCIA. 1992, Breve storia della scrittura latina, Roma.PGM 1973: rev. ed. Henrichs A., Papyri Graecae Magicae, Munchen-Leipzig.POLITO E. 1998, Fulgentibus armis: introduzione allo studio dei fregi d’arme antichi, Roma.SEGREA. 1928, Metrologia e circolazione monetariadegli antichi, Bologna.SGD 1985: Jordan D. R., A survey of Greek defixiones not included in the special corpora, in
Greek, Roman and Byzantine studies, 26. SOLIN H. 1982, Die Griechischen personnamen in Rom, Berlin- New York. SOLIN 1993, L’epigrafia dei villaggi del cassinate ed aquinate, in L’epigrafia del villaggio(Epigrafia e antichità, 12), a cura di A. Calbi, A. Donati, G. Poma, Faenza, pp. 363-406.SOLIN H., SALOMIES O. 1994, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum,
Hildesheim. SOLIN H. 1997 [1998], Un’iscrizione di Aquino a Varsavia, in Archeologia. Rocznik Instytutu
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 48.SOLIN H. 2005, Iscrizioni di Torre San Gregorio ad Aquino, in Epigraphica, LXVII. TRIGONA S. L. 2007, Casilina est-Ristorante Fini 2007, Relazione di scavo, Archivio S.B.A.L.
GIOVANNA RITA BELLINI – LUCA COPPOLA – MATTEO ZAGAROLA28