‘Le iscrizioni e le epigrafi in arabo. Una rilettura’
Transcript of ‘Le iscrizioni e le epigrafi in arabo. Una rilettura’
47
D i tutte le opere prodotte dagli opifici dei re normanni diSicilia, le iscrizioni in arabo sono fra le più straordinariee le più importanti da un punto di vista storico, e mal-
grado ciò, proprio perché sono in arabo, continuano ad essereignorate, tranne che dagli specialisti, e la loro portata è general-mente sottovalutata e spesso fraintesa. Sebbene in quantità relati-vamente esigua, e dai contenuti estremamente limitati, le iscrizio-ni arabo-normanne rappresentano un corpo coeso di testimonian-ze che fanno luce sulla natura della monarchia normanna daun’angolazione particolare e rivelatrice. Nessun altro sovrano lati-no ha fatto dell’epigrafia in arabo un uso altrettanto ampio e nes-suno si è servito dell’arabo come mezzo di legittimazione dellamonarchia in modo altrettanto efficace; del resto, pochi sovranimusulmani contemporanei sono stati più innovativi nell’uso delleiscrizioni arabe.
I principali dati relativi al corpus delle iscrizioni arabo-nor-manne sono esposti nella tav. I. Se escludiamo la monetazione, cherappresenta un campo peculiare e autonomo, le iscrizioni possonoessere considerate in tutto sedici: dodici composte solo in arabo,tre trilingue (latino, greco e arabo) e una quadrilingue (giudeo-arabo, latino, greco e arabo) (fig. 3). Undici portano il nome dei renormanni Ruggero II o Guglielmo II e almeno altre tre – più pro-babilmente cinque – epigrafi invocatorie erano rivolte a Ruggero,ma non ne menzionano il nome. Due compaiono su lapidi funera-rie fatte costruire dal chierico di Ruggero, Grisanto, in memoriadei genitori, tre sono ricamate su paramenti reali, e undici sonoiscrizioni monumentali. Quest’ultima categoria può essere suddivi-sa in base al contenuto: cinque iscrizioni contengono versi encomia-stici rivolti a Ruggero II (dai palazzi reali di Palermo e di Messina) ea Guglielmo II (una dal palazzo della Cuba e due dalla Zisa).Quattro sono liste di invocazioni, paragonabili a quella che si trovasul manto di Ruggero: due sul soffitto dipinto della CappellaPalatina (figg. 1 e 8), una sul campanile della chiesa – ora distrutta– di S. Giacomo la Mázara, e una in S. Maria dell’Ammiraglio.Infine, due epigrafi commemorano la costruzione di manufatti: laclessidra di Ruggero a palazzo Reale (fig. 2) e una struttura di pub-blica utilità a Termini Imerese da parte dell’eunuco di Ruggero,Pietro-Barrün. Cinque iscrizioni si presentano nei tradizionalicaratteri angolari, generalmente noti con il nome di cufico, mentreundici sono scritte in corsivo, nella scrittura comunemente defini-ta nasƒ che, a metà del sec. XII, era ancora relativamente nuovanell’epigrafia monumentale del Mediterraneo islamico.
Nessuna delle iscrizioni arabo-normanne sembra essere data-bile a prima del 1130, anno della fondazione del regno, e questosottolinea il fatto che le loro radici non affondano nel periododella dominazione islamica. I musulmani che avevano governatol’isola, naturalmente, avevano proclamato la loro autorità in testiepigrafici: sopravvivono frammenti di un’iscrizione a nome dell’e-miro kalbide Abü l-˘usayn A˛mad ibn al-˘asan (953-970), checommemora l’erezione di un edificio a Termini Imerese1, e unaparte dell’iscrizione presente sulla Torre di Baych, una delle due
torri ai lati della Bb al-Ba˛r («Porta a Mare») di Palermo, soprav-visse fino al 1564, anno della sua demolizione2. Anche se alcuneepigrafi risalenti a prima della conquista normanna, come quellasulla Torre di Baych, rimasero presumibilmente visibili durantetutto il periodo normanno e forse furono in parte responsabilidella decisione presa da Ruggero e dai suoi ministri sulla necessità,da parte della nuova monarchia, di esporre testi pubblici in arabo,non esistono prove che il loro stile o il loro contenuto abbianoinfluenzato l’epigrafia arabo-normanna. Prima della conquista erastato utilizzato solo il cufico, mentre la maggior parte delle iscri-zioni arabo-normanne si serve del corsivo; in quanto ai contenuti,le iscrizioni arabo-normanne non contengono formule coraniche e,come si vedrà, impiegano protocolli reali che non erano in usopresso gli emiri kalbidi, ma sono tipici della monarchia normanna.
Prima di procedere oltre, è necessario superare un ostacoloiniziale di questa rilettura e cioè l’iscrizione proveniente da quelloche sembra essere stato il campanile della chiesa di S. Giacomo laMázara, che si trovava all’interno dell’attuale Caserma dellaLegione dei Carabinieri, un tempo nota con il nome di Quartieremilitare di San Giacomo, nella parte settentrionale di Via VittorioEmanuele, all’interno delle mura, subito prima di Porta Nuova. Lachiesa di S. Giacomo fu demolita nel Seicento, ma il suo campani-le rimase intatto almeno fino al quarto decennio dell’Ottocento3.Nulla sappiamo della sua sorte, e l’iscrizione sembra ormai disper-sa. Michele Amari la vide quand’era ancora un giovanotto, benprima che si risvegliasse in lui l’interesse per l’Islam e per la linguaaraba, ma quando si mise a studiare le iscrizioni arabe in Sicilia ilcampanile era ormai scomparso e la lettura ch’egli diede dell’iscri-zione si basò sui ricalchi che gli furono inviati a Parigi daDomenico Lo Faso Pietrasanta, duca di Serradifalco, nel 18534.Questi ricalchi erano stati eseguiti nel 1837 dall’architetto SaverioCavallari su ventiquattro fogli separati, su cui l’autore aveva appo-sto delle lettere latine per indicare la sequenza originale, annotan-do anche fratture e lacune. Pare che Giuseppe Caruso, che lesse etradusse l’iscrizione per Serradifalco, avesse sistemato i fogli nel-l’ordine da lui ritenuto migliore, e non secondo la sequenza indi-cata dal Cavallari5. L’Amari tentò di ricostruire la sequenza delCavallari; l’iscrizione ricomposta aveva una lunghezza di m 12 ca.e in origine correva lungo tutti e quattro i lati della torre di SanGiacomo, con i soli primi tre metri mancanti e qualche altra lacu-na di minori dimensioni. La tavola pubblicata dall’Amari6 è unafotografia delle copie dei ricalchi da lui commissionate a un arti-sta parigino, ma non può definirsi una riproduzione soddisfacenteper i seguenti motivi: né Cavallari né il copista parigino conosce-vano l’arabo; nella sequenza che l’Amari ricevette da Serradifalcovi era un foglio mancante; l’ordine di due fogli dovette essereinvertito; un foglio fu erroneamente spostato dal copista parigino;si dovette ipotizzare l’esistenza di un foglio mancante. Su questebasi precarie l’Amari diede una lettura da lui definita «certa inmolti luoghi, probabile in altri (…) e possibile negli ultimi trevocaboli», ma sono proprio questi ultimi tre vocaboli ad essere
LE I SCRIZIONI E LE EP IGRAFI IN ARABO. UNA RILETTURA
fig. 1
NOBILES OFFICINAE. PERLE, FILIGRANE E TRAME DI SETA DAL PALAZZO REALE DI PALERMO 48
cruciali. Il grosso del testo consiste in una lista di invocazioni(adfiiya) simili a quelle che si trovano sul manto di Ruggero e sulsoffitto della Cappella Palatina. Tuttavia le ultime tre parole, chel’Amari tentò orientativamente di leggere come una data – sana-ta[?] mi[√atin] wa-al[fin] («nell’anno 1100 [A.D.]») – sono estre-mamente dubbie e si basano sul foglio spostato dal copista parigi-no: «io non ne son punto sicuro», ammise scrupolosamente lo stu-dioso. Potrebbero suggerirsi diverse letture alternative, tutte trattedal lessico delle adfiiya arabo-normanne (cfr. tav. III), ma una sola– al-i©gml wa-l-[…], «summa e […]» – si adatta in modo assai cal-zante alla forma delle parole. Dell’intera iscrizione proponiamoquindi la seguente lettura: […] wa-l-difiya wa-l-yumn wa-l-©sukr al-k[mil? wa-]l-nifima [wa-?] l-kifya wa-l-fiizz[?] wa-l-birr wa-l-naßra[…] wa-[…] wa-l-sa[fi]d wa-l-iqbl[? … wa-] l-naßr wa-l-i©gml[?]wa-l-[…] («[…] e dichiarazione di fede e beatitudine e gratitudineperfetta e favori [e] competenza e potere[?] e devozione e vittoria[…] e […] e buona sorte e fato propizio[? … e] vittoria e summa[?]e […]»). Dal momento che i dubbi che circondano la lettura delleultime tre parole ormai non saranno risolti in modo definitivo, ameno di una miracolosa ricomparsa dell’iscrizione stessa, altresono le priorità da considerare: l’elenco di adfiiya contenuto nell’e-
pigrafe è estremamente affine ad elenchi analoghi impiegati daRuggero nel decennio 1130-1139 (cfr. tav. III), e ciò rappresentadi per sé una motivazione sufficiente per diffidare della lettura del-l’anno proposta dall’Amari e attribuire orientativamente l’iscrizio-ne al regno di Ruggero (1130-1154).
Occorre dedicare qualche parola alle iscrizioni arabe presentisulle monete, al fine di chiarire l’affermazione secondo cui le iscri-zioni arabo-normanne non derivano da un’ininterrotta tradizioneepigrafica risalente al periodo della dominazione musulmana. Iltarì emesso da Roberto il Guiscardo e Ruggero I immediatamentedopo la conquista utilizzava sì legenda basate, in tutto o in parte,su quelle di emissioni precedenti, presumibilmente per garantireche il sistema monetario continuasse ad essere ritenuto affidabilenonostante il cambio di regime, ma questi elementi di continuitàfurono presto abbandonati e, immediatamente dopo l’incorona-zione di Ruggero II, furono introdotte nuove formule che trovanostretti parallelismi nelle iscrizioni arabo-normanne7.
In effetti, sia i cambiamenti avvenuti nelle legenda arabe pre-senti sulle monete sia lo sviluppo dell’epigrafia araba sotto reRuggero sono intimamente connessi alla rinascita di una pubblicaamministrazione araba – il regio dıwn – diretta da Giorgio
a pag. 46fig. 1. Soffitto ligneo intagliato e dipinto (part.), Palermo, Cappella Palatina
fig. 2. Lastra con iscrizione trilingue dalla clessidra di Ruggero II, Palermo,Palazzo dei Normanni
fig. 2
LE ISCRIZIONI E LE EPIGRAFI IN ARABO: UNA RILETTURA 49
d’Antiochia, principale ministro di re Ruggero, negli anni imme-diatamente successivi al 1130. Il regio dıwn segnò anche unanuova tendenza e non solo una continuità rispetto al periodo delladominazione islamica. Sebbene Ruggero I e la di lui vedova, la reg-gente Adelaide, con il conte bambino Ruggero II, abbiano emana-to documenti in arabo o in due lingue, arabo e greco, nessun docu-mento in arabo viene emanato dalla cancelleria comitale dopo il1111. Tuttavia nel 1132, appena due anni dopo l’incoronazione diRuggero, la regia cancelleria inizia a produrre documenti in arabodiversi dai predecessori comitali8. La vicinanza del rapporto fra ilregio dıwn e l’epigrafia arabo-normanna è meglio dimostrata conuna trattazione sull’uso epigrafico dei titoli reali in arabo.
L’evoluzione nell’uso dei titoli arabi utilizzati per i sovraninormanni in Sicilia può suddividersi in tre fasi. Nella prima,Roberto il Guiscardo, Ruggero I, la reggente Adelaide e il giovaneconte Ruggero II adoperano appellativi arabi che sono semplice-mente traslitterazioni di titoli greci e latini, come al-düqa per duxo ‘o dot̂jay, e al-qümis per comes o ‘o jÞlgy.
Nella seconda fase, che si sovrappone in parte alla prima,Ruggero I, Adelaide e il giovane Ruggero II utilizzano appellativiarabi che sono traduzioni approssimative di titoli greci e latini, fracui sul†n, sayyıd e mawl. Nella terza fase invece, che si inauguracon l’incoronazione di Ruggero II, viene adottato un nuovo siste-ma di titolatura importato di sana pianta dalla coeva cancelleriadei califfi fatimidi del Cairo9.
Il nuovo titolo si incontra per la prima volta sulle monete inuna forma abbreviata, adatta allo spazio limitato disponibile suquel mezzo, e compare in seguito nelle iscrizioni arabe di reRuggero. Tuttavia il protocollo completo viene riservato ai docu-menti emanati dal regio dıwn, mezzi che offrono molto più spa-zio alle formule estese. Così, nella sua formula ampliata al massi-mo il re Guglielmo II compare nell’aprile del 1183 come: al-˛a∂ratu l-mufia÷÷amatu l-mlikatu l-malakiyyatu l-∞ulylimiyyatu l-bahiyyatu l-mustafiizzatu bi-llhi l-mufita∂idatu bi-qudratihi l-mustanßiratu bi-qüwatihi mlikatu ı†liyata wa-nkabardata wa-qalaw-riyata wa-ßiqilliyyata mufiizzatu immi rümiyyata l-nßiratu li-l-millatil-naßrniyyati ƒallada llhu mamlakatah wa-ayymah wa-abbadaduhürah wa-afiwmah wa-naßara ©gyü©sah wa-afilmah wa-ayyadasuyüfah wa-aqlmah, («la gloriosa presenza, il sovrano, il rega-lissimo, il guglielmiano, il magnifico, il bramoso di potere in Dio,l’assistito dalla Sua onnipotenza, il bramoso di vittorie per la Suaforza, il signore d’Italia, Longobardia, Calabria e Sicilia, il difen-sore del Papa di Roma, il protettore della comunità cristiana –possa Dio perpetuarne il regno e i giorni, renderne eterni gli annie le stagioni, assisterne gli eserciti e i vessilli, e sostenerne le spadee le penne!»)10. Tutti gli elementi tipici della titolatura reale arabaillustrati in questa formula possono ritrovarsi nelle iscrizioniarabo-normanne.
Il primo elemento consiste nell’uso reverenziale con cui ilsovrano non è nominato direttamente ma piuttosto menzionato inmodo obliquo mediante un termine impersonale che ne sostituisce
il nome o il titolo11. Così, nel suddetto esempio il sovrano noncompare come «re Guglielmo» ma piuttosto come al-˛a∂ra … al-∞ulylimiyya («la guglielmiana presenza»). Lo stesso uso si ritrovain due iscrizioni di re Ruggero: la sua clessidra è stata commissio-nata da al-˛adra … al-ru©g™riyya («la ruggeriana presenza»; infra,cat. n. VIII.4), e Grisanto era il chierico di al-˛a∂ra al-mlikiyya(«la sovrana presenza»; infra, cat. n. VIII.7).
Il secondo elemento è l’uso di una lunga sequenza di aggettiviche qualificano il termine sostitutivo impersonale. Si tratta per lamaggior parte di aggettivi relativi (al-asm√ al-mansüba o al-nisabt), formati aggiungendo il suffisso -iyy ai termini da cui deri-vano, al fine di conferire loro un valore iperbolico (li-l-mubla∞a)cosicché, per esempio, al-qiddıs («il santo») diventa al-qiddısiyy («ilsantissimo»). Un raffronto sull’impiego di tali aggettivi nelle iscri-zioni e nei documenti dei re normanni viene proposto nella tav. II,dove è chiaramente indicato che i nisabt utilizzati nelle iscrizionisono derivati dal lessico del regio dıwn. Questi elenchi di nisabtdella Sicilia normanna trovano corrispondenti molto simili nelmondo islamico non nei titoli usati per i sovrani, quanto piuttostonelle lunghe liste di magniloquenti appellativi adoperati dai visirdei califfi fatimidi dall’ultimo quarto del sec. XI in poi12.
Terzo elemento: l’inclusione di al-mufia÷÷am/a e al-mufia÷÷amiyy/a («il glorioso» e «il gloriosissimo») fa riferimento aquello che effettivamente era il titolo dinastico dei sovrani nor-manni – al-malik al-mufia÷÷am («il glorioso re») – uno stile usato datutti i monarchi normanni (ad eccezione del povero Guglielmo III),e da Federico II13.
Quarto elemento: alla sequenza di nisabt seguono tipicamen-te uno o due appellativi più personali (laqab). Così Ruggero II
fig. 3
fig. 3. Lapide con iscrizione quadrilingue, Palermo, Museo della Zisa
NOBILES OFFICINAE. PERLE, FILIGRANE E TRAME DI SETA DAL PALAZZO REALE DI PALERMO 50
compare nel testo arabo della lapide di Anna (infra, cat. n.VIII.7b) come al-mufitazz bi-llh («il fortificato da Dio»), mentreGuglielmo II è al-mustafiizz bi-llh («il bramoso di potere in Dio»)sui palazzi della Zisa14 e della Cuba15, come anche sulla sua alba(fig. 4) e sulle sue calze (infra, cat. nn. I.3-4): ciascun monarca siservì del laqab personale anche su monete e documenti. Il laqab ècomposto da due parti: la prima è un participio attivo (al-mufitazz,al-mustafiizz, che enfatizza l’origine divina dell’autorità e del pote-re regale; la seconda è il complemento bi-llh («da» o «in Dio»)che rende esplicito il principio teocratico. Due coppie di alqb sup-plementari, una usata da Ruggero II nella lapide funeraria di Anna(infra, cat. n. VIII.7b) – al-muqtadiru bi-qudratihi l-manßüru bi-qüwtihi («colui che è reso potente dalla Sua onnipotenza, coluiche è sostenuto dalla Sua forza») – e l’altra da Guglielmo II nellaCuba e nella Zisa, come sull’alba e sulle calze, e nei documenti delsuo dıwn (al-mufita∂idu bi-qudratihi l-mustanßiru bi-qüwatihi, l’assi-stito dalla Sua onnipotenza, il bramoso di vittorie per la Suaforza), hanno entrambe la stessa forma. Proprio come gli elenchidi nisabt erano modellati sui titoli dei visir fatimidi e non deicaliffi, loro superiori, così questi alqb personali evidenziano ladipendenza dei re normanni da Dio e non, come nel caso dei tito-li dei califfi fatimidi, il loro ruolo attivo in quanto agenti dellavolontà divina16.
Quinto elemento: la lista dei possedimenti reali, che costitui-sce una tipica parte del titolo arabo, è particolarmente interessan-te nelle iscrizioni di Ruggero II. L’evoluzione nel tempo dei terri-tori posseduti dagli Altavilla è rintracciabile nei loro titoli arabi. Iprimi epiteti – malik ∑iqilliyya («signore di Sicilia») e malik ∑iqil-liyya wa-Qalwriya («signore di Sicilia e Calabria») – furono uti-lizzati da Roberto il Guiscardo, Ruggero I, la reggente Adelaide eRuggero II, ma nel 1137-1138, in una lettera indirizzata aRuggero II, il califfo fatimide al-˘fi÷ li-dın Allh si rivolge alsovrano siciliano con al-maliku bi-©gazırati ∑iqilliyyata wa-nküriyya-ta [da leggersi Ankabardata] wa-n†aliyyata [da leggersi †liyyata] wa-Qalawriyata wa-S.t.r.lü [da leggersi Salrnü] wa-Malfa wa-m in∂fail dlika, «il re dell’isola di Sicilia, di Lombardia, d’Italia, diCalabria, di Salerno, d’Amalfi e quant’altro sia a questi collega-to»17. È improbabile che sia pura coincidenza il fatto che, da quelmomento in poi, i re normanni nei loro appellativi arabi abbianorivendicato possedimenti altrettanto vasti. Così nei testi in giudeo-arabo e arabo della lapide di Anna (infra, cat n. VIII.7b) Ruggero
compare come re di «Italia, Lombardia, Calabria, Sicilia e Africa(Ifrıqiyya)». L’aggiunta dell’Africa in quest’unica occasione potreb-be spiegarsi con la cattura della capitale ziride, al-Mahdiyya, adopera di Giorgio d’Antiochia nel giugno del 1148; in seguito ilmonarca normanno è re di «Italia, Lombardia, Calabria e Sicilia»,ma mai più di «Africa»18.
Sesto elemento: Ruggero II, nella commemorazione funebre diAnna e Guglielmo II, sulla sua alba (infra, cat. n. I.3), compaionoentrambi con due titoli esplicitamente cristiani – mufiizzu immiRümiyyata l-nßiru li-l-millati l-naßrniyyati («il difensore del Papadi Roma, il protettore della comunità cristiana»). Quest’ultimaformula è stata utilizzata da Ruggero II e dai suoi successori sumonete coniate dalla zecca di Salerno, ed entrambi gli epiteti furo-no usati da Ruggero II e Guglielmo II anche nei loro documenti.Ci sono forti motivi per ritenere che queste formule siano statedate ai sovrani normanni da una cancelleria islamica, presumibil-mente quella fatimide del Cairo19.
Settimo ed ultimo elemento: le iscrizioni arabo-normannefanno uso delle stesse formule invocatorie (adfiiya) impiegate dalregio dıwn: sulla clessidra di Ruggero II (infra, cat. n. VIII.4),abbada llhu ayymah wa-ayyada afilmah («possa Dio perpetua-re i [suoi] giorni e sostenere i [suoi] vessilli!»); e sulla lapide diAnna (infra, cat. n. VIII.7b), ßammada llhu mamlakatah («possaDio conservare il [suo] regno!»). L’impiego di adfiiya come partedel protocollo reale era ben consolidato nel mondo islamico, ma èforse significativo che il più antico esempio conosciuto di una for-mula invocatoria rivolta a un monarca siciliano si ritrovi in unalettera del califfo fatimide al-˘fi÷ li-dın Allh a Ruggero II – waf-faqahu llhu fı maqßidi wa-ar©sadahu il al-fiamali bi-†fiatihi fımaßdirihi wa-mawridihi, «possa Dio accordargli la riuscita deisuoi piani e guidarlo affinché agisca in obbedienza a Lui, ad ognipartenza e ad ogni ritorno!»20: anche questo uso siculo-normannosembra ispirarsi alla cancelleria fatimide.
Se rivolgiamo adesso la nostra attenzione alle iscrizioni checommemorano la costruzione di due opere, ancora una volta sirivelano dei legami fra l’epigrafia arabo-normanna e il regiodıwn. Il testo arabo dell’iscrizione tratta dalla clessidra diRuggero (infra, cat. n. VIII.4) è sostanzialmente un regio decreto:si sarebbe potuto trovare su una pergamena emanata dal regiodıwn senza significative modifiche – si noti in particolare l’incipitƒara©ga amru … etc. («emanato fu l’ordine…ecc.»), l’identica locu-
fig. 4. Iscrizione dell’alba di Guglielmo II, Vienna, KunsthistorischesMuseum, Weltliche Schatzkammer
LE ISCRIZIONI E LE EPIGRAFI IN ARABO: UNA RILETTURA 51
zione con cui inizia la maggior parte dei decreti in arabo. Il testo èin netto contrasto con il testo latino della clessidra, che risultarozzo, inesatto e lontanissimo dal protocollo cancelleresco; ma loè anche con il testo greco che, pur con la data esatta e impiegan-do i corretti titoli reali, adotta una forma in versi che non pertie-ne alla cancelleria. L’altra iscrizione che commemora la costruzio-ne di un manufatto è quella dell’eunuco di Ruggero, Pietro-Barrün,a Termini Imerese (infra, cat. n. VIII.3). Il testo arabo si basa sulmodello islamico classico delle iscrizioni che commemorano lacostruzione di opere di pubblica utilità – da notare, in particolare,la supplica con cui si conclude – ma incorpora anche formule,come i titoli reali, che sono chiaramente tratte dal regio dıwn. Ilfatto che lo stesso Pietro sia stato uno dei principali funzionari deldıwn, almeno dal 1141 fino al 1166, suggerisce un possibilemodo in cui questo rapporto fra dıwn e opifici reali abbia fun-zionato nella pratica.
È valsa la pena soffermarsi così a lungo sul nesso esistente frail regio dıwn e l’epigrafia reale per dimostrare quanto fosse strettoe con quale accurato coordinamento fosse portato avanti il rappor-to fra il dıwn e gli opifici reali – includendo fra questi anche lazecca e il guardaroba – e in che modo questo rapporto si sia pro-tratto ed evoluto durante la storia del regno, dall’inizio del quartodecennio alla metà del nono decennio del XII secolo. Analogamenteal dıwn e alla zecca, gli opifici reali avevano il compito di legitti-mare l’autorità reale, e in nessun altro caso ciò sembra essersi veri-ficato in modo più esplicito che nei titoli arabi utilizzati per i re nor-manni. In questa sede abbiamo inoltre evidenziato fino a che puntol’elemento arabo della monarchia normanna abbia costituito unnuovo punto di partenza e non una continuazione dell’emirato kal-bide siciliano, e si sia basato su importazioni dal Mediterraneo isla-mico di quel periodo, in particolar modo dall’Egitto fatimide.
Nel catalogo si sostiene che anche i versi encomiastici prove-nienti dal palazzo di Ruggero II a Palermo illustrano questa dipen-denza dell’elemento arabo della monarchia normanna dal califfa-to fatimide: in una serie di immagini mutuate dai panegirici fati-midi e facenti riferimento alle cerimonie di quella corte, i versiinvitano il visitatore ad accordare al palazzo reale la venerazionedovuta dai pellegrini alla Kafiba nella Mecca, e raffigurano gli attidi omaggio e sottomissione al re con termini che appartengono alsacro cerimoniale dello ˛a©g©g (infra, cat. n. VIII.1). Ma il panegiri-co fatimide fu solo una delle fonti a cui attinsero i poeti arabi che
composero i versi epigrafici arabo-normanni. I versi provenientidal palazzo di Ruggero a Messina, trattati in modo esaustivo daAnnliese Nef (infra, cat. n. VIII.2), descrivono il palazzo Reale conimmagini più ortodosse, paragonandolo al leggendario palazzo dial-∫awarnaq costruito dai re laƒmidi preislamici di Hira per l’©sh-in-©sh sassanide e giungendo addirittura a definire il palazzo diRuggero come il dr al-ƒulüd («il paradiso», letteralmente «ladimora degli stati dell’esistenza perpetua»; cfr. dr al-ƒuld, Corano41:28). Le iscrizioni in versi di Guglielmo II sulla Zisa e sulla Cubahanno un tenore simile: Guglielmo è il malik al-zamn («il re deltempo»), il ƒayr mulük al-ar∂ («il migliore re del mondo»), e il suopalazzo è un ©gannat al-duny («paradiso sulla terra»).
Ma l’influenza del dıwn è evidente anche in queste iscrizioni inversi. Abbiamo già visto che il laqab personale del sovrano, trattodal protocollo ufficiale, è impiegato nell’epigrafia encomiastica:così, nell’iscrizione sul fregio in stucco del vestibolo (qfia) dellaZisa Guglielmo è al-Mustafiizz («il bramoso di potere [in Dio]) e laZisa è al-fiAzız («la maestosa»)21. Il modo in cui iniziano le iscrizio-ni sul coronamento della facciata della Zisa22 e della Cuba23,entrambe con l’apertura islamica di precetto bismi llhi l-ra˛mni l-ra˛ımi («nel nome di Dio, il Misericordioso, il Compassionevole»)– anche se di norma non ci si aspetterebbe di trovare questa formu-la all’inizio di un testo pubblico di un monarca cristiano – potreb-be in effetti riflettere un suo uso occasionale nei documenti deldıwn24. Nell’iscrizione della Cuba sorprende in modo particolare ilfatto di trovare, intessuta fra i versi, una formula di datazione cheutilizza il calendario cristiano – wa-li-l-sayyidi l-ması˛i alf wa-mi√a[wa] tamnün («1180 del Signore Messia») – un’altra indicazione,forse, dell’influenza del dıwn, nei cui documenti l’anno poteva esse-re espresso secondo il calendario bizantino, latino o islamico.Questa formula, insieme a quello che può plausibilmente essereconsiderato un riferimento ai ‘cristiani’ nell’assai danneggiata eframmentaria iscrizione del coronamento della facciata della Zisa25,evoca la possibilità che alla corte di Guglielmo II fosse attiva unascuola di panegiristi arabi cristiani. In questo caso, le loro opere nonsarebbero state conservate dai successivi compilatori di antologiemusulmani, riluttanti a trasmettere se non qualche occasionaleesempio di versi composti in onore di un re cristiano.
Qualcosa deve dirsi in questa sede sulla terza categoria diiscrizioni arabo-normanne – i due epitaffi commissionati dal chie-rico di re Ruggero, Grisanto, per i genitori Anna e Drogo (infra,
LE ISCRIZIONI E LE EPIGRAFI IN ARABO: UNA RILETTURA 53
cat. n. VIII.7b-c). Si tratta degli unici epitaffi cristiani in arabo notinella Sicilia normanna, e la mancanza di qualsiasi altro riscontrorende impossibile giudicare se si sia veramente trattato di un uni-cum come appare oggi ai nostri occhi. La brusca apertura di tuttie tre i testi – quelli in giudeo-arabo e in arabo sulla lapide di Anna,e quello in arabo sulla lapide di Drogo – senza basmala e senzanessuno dei ben noti passaggi tratti dal Corano, ha un che di sor-prendentemente non islamico. Ma il verbo tuwuffiya/t («egli/ellamorì») – rievoca un precedente uso islamico che era quasi scom-parso già alla metà del sec. XII, quando il defunto era quasi sem-pre introdotto dalla locuzione h≤a qabr… («questa è la tombadi…»). Il corpo del testo è stato chiaramente composto ad hoc,fatta eccezione per i titoli reali, basati sui protocolli ufficiali arabidel regio dıwn. Tuttavia, le formule di chiusura dei due testi inarabo dell’epitaffio di Anna – fa-ra˛ima llhu man qara√a wa-dafilah bi-l-ra˛mati mın («Possa Dio avere misericordia di chi legge[questo epitaffio] e prega per la misericordia [della defunta].Amen.») – sono modellate sulla formula islamica classicamentepresente in questo punto dell’epitaffio (cfr. infra, cat. n. VIII.5, vv.16-17).
Solo per lunghezza, la quarta ed ultima categoria di epigrafiarabo-normanne – le cinque iscrizioni invocatorie – superano didiversi metri la somma di tutte le altre iscrizioni esistenti. Questogruppo comprende tre epigrafi sicuramente rivolte a re Ruggero –le iscrizioni sul manto (infra, cat. n. I.1) e sul soffitto della navatacentrale26 e della navata destra della Cappella Palatina27 – oltre adaltre due iscrizioni, probabilmente anche queste rivolte a lui: quel-la del campanile della chiesa demolita di S. Giacomo la Mázara, equella di una colonna in S. Maria dell’Ammiraglio28. Il contenutoprincipale di tutte e cinque queste iscrizioni (cfr. tav. III) è rappre-sentato da un elenco di sostantivi, alcuni con aggettivi qualificati-vi, che sono sia invocazioni (adfiiya), impetranti particolari bene-dizioni divine sul re, sia anche, per estensione, attributi reali(alqb), che costituiscono quasi degli elementi ufficiosi del titoloreale. Tali invocazioni sono un tema estremamente comune nelleiscrizioni islamiche, in cui viene impiegato esattamente lo stessolessico delle adfiiya siciliane, specialmente su manufatti trasporta-bili come ceramiche, oggetti di metallo e tessili.
Finora non sono state condotte indagini esaustive sull’uso diqueste formule invocatorie nell’epigrafia islamica, ma alcune con-siderazioni generali potranno essere utili per collocare gli esempisiciliani in un contesto più ampio. Fra i primi esemplari esistenti dimanufatti islamici di metallo recanti iscrizioni vi sono due oggettidove si invoca la benedizione di Dio sul proprietario mediante for-mule come barakatun mina llhi li-߲ibihi («la benedizione di Diosul suo proprietario»). Dal sec. XI queste semplici preghiere si svi-luppano lungo due direzioni diverse. La richiesta di una baraka(«benedizione») generale spesso può ampliarsi, diventando unalista di benedizioni particolari, fino a raggiungere il numero ditrenta; in secondo luogo, sebbene in molte iscrizioni si affermiancora in modo esplicito che tali benedizioni sono invocate mina
llhi … li-߲ibihi («da Dio … sul suo proprietario»), e sebbene inalcune iscrizioni ci si riferisca al proprietario con il suo nome, nellamaggioranza dei casi questo elemento si dà per scontato e ci silimita ad elencare le benedizioni senza menzionare né Dio né ilproprietario dell’oggetto29. Entrambe queste trasformazioni sonovisibili nelle iscrizioni della Cappella Palatina, di S. Giacomo laMázara e di S. Maria dell’Ammiraglio, che sono tutte liste diadfiiya dove né Dio né il destinatario sono menzionati. L’iscrizionesul manto di Ruggero, tuttavia, contiene un riferimento al pro-prietario, sebbene nel modo indiretto di cui si è già parlato e, poi-ché in questo senso rappresenta un’eccezione, sarà analizzata piùin dettaglio.
L’iscrizione sul manto di Ruggero (fig. 7) è composta in sa©g,una prosa ritmata esperta ed elegante, e recita così (le barre obli-que sono state inserite per indicare il stet. della prosa): mimmfiumila bi-l-ƒiznati / l-malakiyyati l-mafimürati / bi-l-safidi wa-l-i™lli /wa-l-ma©gdi wa-l-kamli / wa-l-†awli wa-l-if∂li / wa-l-qabüli wa-l-iqbli / wa-l-sam˛ati wa-l-©galli / wa-l-faƒri wa-l-©gamli / wa-bulü∞il-amnı wa-l-mli / wa-†ıbi l-ayymi wa-l-layl[ı] / bi-l zawli wa-lntiqli / bi-l-fiizzi wa-l-difiayati / wa-l-˛if÷i wa-l-˛imyati / wa-l-safidiwa-l-salmati / wa-l-naßri wa-l-kifyati / bi-madınati ∑iqilliyyata /sanata tamnin / wa-fii©srına wa-ƒamsimi√atin («Ciò è stato eseguitonel fiorente guardaroba reale, con fortuna, onore, splendore, per-fezione, possanza, superiorità, approvazione, prosperità, magna-nimità, dignità, gloria, bellezza, realizzazione di desideri e speran-ze, piacere dei giorni e delle notti senza fine né rimozione, conpotere, dichiarazione di fede, riverente cura, protezione, fortuna,integrità, vittoria, competenza, nella città di Sicilia, nell’anno 528»[1133-1134 A.D.]). Nella frase di apertura re Ruggero non ènominato, ma la sua presenza si riconosce dal riferimento al «benfornito guardaroba reale»: l’aggettivo relativo al-malakiyya si rife-risce al malik, al «re» in persona; al tempo stesso al-mafimür[a], let-
fig. 5
fig. 5. Lastra frammentaria con iscrizione araba in lode di Ruggero II dalpalazzo Reale di Palermo (part.), Palermo, Galleria Regionale della Sicilia
fig. 6. Blocco frammetario con iscrizione araba in lode di Ruggero II dal palazzo Reale di Messina, Messina, Museo Regionale
fig. 6
ingrandimento 160%
Johns - B(file alta risoluzione dal cap VIII,scheda n. 2: IM0948 1.01)
NOBILES OFFICINAE. PERLE, FILIGRANE E TRAME DI SETA DAL PALAZZO REALE DI PALERMO 54
fig. 7. Iscrizione del manto di Ruggero II (part.), Vienna, KunsthistorischesMuseum, Weltliche Schatzkammer
fig. 7
LE ISCRIZIONI E LE EPIGRAFI IN ARABO: UNA RILETTURA 55
teralmente «fiorente, prospero», viene usato nella Sicilia norman-na esclusivamente per le istituzioni reali, fra cui la cancelleria (al-dıwn al-mafimür) e il palazzo reale (al-qaßr al-mafimür), così dadiventare quasi un sinonimo di «reale».
A questo punto è doveroso parlare brevemente del sostantivoqualificato da questi aggettivi, al-ƒizna, che merita particolareattenzione nel contesto di questa mostra. Appare anche nell’iscri-zione sul bordo dell’alba di Guglielmo II, fabbricata bi-ƒizntihi l-mafimüratihi («nell’opificio fiorente»). Nella lingua classica questotermine significa «un luogo dove gli oggetti vengono depositati,custoditi, conservati, riposti, ecc.» e quindi ‘ripostiglio’, ‘armadio’,‘magazzino’. Al-ƒizna può anche essere usato metaforicamentecon il significato di ‘cuore’, di un luogo dove si ripongono i proprisegreti; ƒizna deriva dalla stessa radice di ƒazna (‘tesoro’), delquale è quasi sinonimo; dalla stessa radice si forma maƒzan omaƒzin (plur. maƒzin), da cui il francese magasin, l’italiano magaz-zino, ecc. Usate per un’istituzione reale, entrambe le parole arabehanno un po’ il valore della camera latina, la camera privata delre, che poteva contenere sia il suo tesoro sia il suo guardaroba:così ߲ib al-ƒizna, («il signore del ƒizna») è il camerarius latino(camerario o ciambellano). Entrambe le parole possono essereseguite da un genitivo che ne definisce la funzione – per esempio,ƒaznat al-ml, letteralmente ‘magazzino delle ricchezze’, cioè ‘teso-ro’; ƒiznat al-sil˛, letteralmente ‘magazzino delle armi’, cioè‘arsenale’. Se usati da soli, però, ƒazna sottintende generalmente iltesoro reale e ƒizna un magazzino di beni regali diversi dal dena-ro. Il ƒizna può essere il luogo dove i beni regali sono prodotti enon soltanto custoditi: l’esempio più famoso è il ƒiznat al-bunüd(ƒizna dei vessilli) fondato dal califfo fatimide al-⁄hir li-ifizz dınAllh (1021-1036), dove tremila artigiani lavoravano alla realiz-zazione di armi, armature, macchine da guerra, ecc. In questo casoparticolare l’iscrizione ci rivela che ƒizna è l’istituzione in cui èstato realizzato il manto di Ruggero, ma la parola stessa implicaanche che si tratta del luogo in cui il manto era custodito, presu-mibilmente insieme ad altri paramenti reali. Si è pertanto preferi-to tradurla con ‘guardaroba’ piuttosto che con ‘laboratorio’: comechiaramente dimostra Ugo Monneret de Villard (1946), questaparola non dovrebbe certo considerarsi l’equivalente del terminearabo †irz, che implica un’istituzione e un’organizzazione di cuinon vi è traccia nella Sicilia normanna.
Dopo questa digressione torniamo ad occuparci del resto del-l’iscrizione: la preposizione bi- (‘con’) introduce una lista di adfiiyache dovrebbero essere interpretate come una richiesta affinché Diopossa concedere «fortuna, onore, splendore, ecc.» al regale pro-prietario del mantello. Dopo dodici sostantivi, l’elenco è interrot-to da due formule composte dove il sostantivo viene integrato dagenitivi che chiariscono ulteriormente la natura della benedizionerichiesta: non soltanto al-bulü∞ («compimento, realizzazione»), ma«realizzazione di desideri e speranze [del re]»; non soltanto al-†ıb(«piacere»), ma «piacere dei giorni e delle notti [del re] senza finené rimozione». Queste due formule si riferiscono indirettamente al
sovrano, e chiedono in modo esplicito il coronamento dei suoidesideri mondani: che egli debba godersi i suoi piaceri senza ‘rimo-zione’ (intiql), sottintende da un lato senza ‘cambiare residenza’ edall’altro senza ‘morire’. Il testo continua con altri otto sostantiviper un totale di ventidue adfiiya, una soltanto delle quali – safid,‘fortuna’ – si ripete, prima che l’iscrizione si concluda con il luogoe l’anno di realizzazione del mantello.
Rivolgendo la nostra attenzione agli elenchi di adfiiya moltosimili che formano il margine di diciotto delle venti stelle a ottopunte sul soffitto della navata centrale della Cappella Palatina, lalettura che di tali iscrizioni fa l’Amari30 è insoddisfacente, e se daun lato la revisione intrapresa da Staale Sinding-Larsen nel 1989 èsostanzialmente corretta, essa contiene tuttavia alcuni travisamen-ti e non ricostruisce le iscrizioni come testi ma semplicementecome parole slegate fra loro. Né Amari né Sinding-Larsen tentanodi leggere tutte le iscrizioni arabe dipinte sugli altri elementi delsoffitto, ma si limitano ai margini dei cassettoni a forma stellata.Un’analisi esaustiva delle iscrizioni sul soffitto della CappellaPalatina va molto oltre l’ambito di questo breve saggio, e tuttaviaesse sono troppo importanti e non possono essere ignorate.Pertanto in questa sede trascriviamo le iscrizioni che compaionosui margini dei cassettoni stellati e sul soffitto della navata latera-le destra. La sequenza ha inizio partendo dal lato ovest con la stel-la di sinistra (n. 1), quindi con quella di destra (n. 2), e prose-guendo in avanti, sempre coppia dopo coppia, fino ad arrivareall’ultima stella, quella di destra, nel versante orientale del soffitto(n. 20). All’inizio di ogni trascrizione abbiamo indicato con unpunto cardinale la punta della stella da cui si inizia la lettura. Ladivisione di ciascuna iscrizione in otto ‘versi’, corrispondenti agliintervalli fra le punte di ogni stella, sono indicate da aste oblique.Per la traduzione si rimanda alla tav. III.
1. (est) wa-l-fiizz wa-l-÷afar / al-fiizz a[?] wa-l-[…?] / al-naßr al-kaml wa- / l-k[?…] wa-l-ifd[l?] / wa-l-fiizz al-fiizz al-k[sic] / al-kamlal-fiizz wa- / l-iqbl wa-l-sal / ma wa-l-iqbl 31
2. (nord-ovest) al-naßr wa-l-kaml / al-kaml wa-l-kifya / wa-l-fiizz wa-l-difiya / wa-l-kaml wa-l-÷afar / wa-l-yumn wa-l-÷afar a[?] /wa-l-naßr wa-l-fiizz / al-kafiyy wa-l-kaml / wa-l-salma wa-l [sic] 32
3. (sud-est) al-yumn wa-l-kaml wa- / l-safid wa-l-if∂l wa-l-ta√ /yıd wa-l-˛if÷ wa-l-salma wa- / l-yumn wa-l-iqbl wa- / l-iqbl wa-l-salma wa- / l-fiizz wa-l-difiya wa-l-ta√ / [yıd …?] wa-l-di / fiya wa-l-if∂l wa- 33
4. (sud) baraka kmila wa-nifima©s / mila wa-∞ib†a mutawßilawa- / ∞ib†a mutawßila wa-fiizz d / √im safid q√im wa-yumn wa-iqblwa- / fiizz d√im wa-safid q√im wa-fiizz q[√im?] / […] fiizz d√im safid/ q√im fiizz d√im [wa?]-kif[ya] / wa-yumn wa-safida wa-l-iqbl 34
5. (est) wa-l-yumn al-fiizz al-÷afar / wa-l-naßr al-fiizz al-kam / lwa-l-safid wa-l-salma / wa-l-yumn wa-l-fiizz wa-l-naßr wa- / l-safid wa-l-kaml wa-l-fiizz[?] / al-naßr wa-l-iqbl wa- / l-yumn wa-l-÷afar wa-l-sal / ma wa-l-˛if÷ wa-l-˛imya wa [sic]35
6. (est) wa-l-kaml wa-l-kafiyy[?] wa- / l-salma wa-l-naßr wa-l-kam / l wa-l-˛if÷ wa-l-÷afar wa-l-d / fiim [sic] wa-l-iqbl wa-l-naßr /
NOBILES OFFICINAE. PERLE, FILIGRANE E TRAME DI SETA DAL PALAZZO REALE DI PALERMO 56
wa-l-yumn wa-l-kaml wa- / l-salma wa-l-iqbl wa-l-d / fiim [sic]wa-l-safid wa-l-kaml / wa-l-salma wa-l-tafiayyud36
7. (nord) wa-l-yumn wa-l-naßr al-baq√ al- / difiya[?] wa-l-yumnwa-l-salma / wa-l-kaml wa-l-ta√ayyud[?] wa-l-i / f∂l wa-l-safid wa-l-if∂l / wa-l-yumn wa-l-[… wa-l-i] / qbl wa-l-salma wa-l-difi / yawa-l-safida wa-l-i / qbl wa-l-salma wa-l-d[sic]37
8. (nord-est) wa-l-yumn wa-l-kaml wa-safid / wa-l-iqbl wa-l-t√yıd wa- / l-salma wa-l-difiya wa- / l-kifya wa-l-salma wa- / l-kaml wa-l-safid wa-l-iqbl wa- / l-ta√ayyud wa-l-kaml wa-÷afar wa-/ l-if∂l wa-l-fiizz wa-l-i /qbl wa-l-salma wa-l-fiizz38
9. (est) wa-l-yumn al-kaml wa-l-fiizz / wa-l-÷afar al-yumn al-kaml / wa-l-fiizz al-kifya al-naßr / wa-l-fiizz al-kaml wa-l-k[sic] / wa-l-÷afar al-ta√ayyud wa-l-naßr / wa-l-÷afar al-fiizz wa-l-ta√ / ayyud wa-l-salma wa-l-di / fiya wa-l-salma wa-l-d[?sic]39
10. (est) wa-l-salma wa-l-kaml wa- / l-safid wa-l-iq[b]l wa-l-i/ ©gml wa-l-salma wa-l-y[sic] / wa-l-yumn wa-l-kaml wa- / wa[sic]-l-iqbl wa-l-salma / wa-l-naßr wa-l-if∂l wa- / l-ta√ayyud wa-l-safidwa-l-d / √im wa-l-fiizz[?] al-iqbl40
11. Ridipinto: pseudo-iscrizione41
12. Ridipinto: pseudo-iscrizione42
13. (sud-est) wa-l-fiizz wa-l-kam / l wa-l-naßr wa-l-if∂l / wa-l-÷afar wa-l-i©g™ll / l wa-l-˛if÷ wa-ta√/ ayyud wa-l-÷afar wa-l-y[sic] / al-yumn wa-l-kaml wa- / l-safid wa-l-iqbl wa-/ l-÷afar wa-l-salma43
14. (sud) al-baraka l-kmila wa-nifima ©s / mila wa-∞ib†amutawßila wa- / fiizz q√im safid d√im fiizz d / √im safid q√im fiizz d√/ im safid q√im fiizz d√im / wa-fiizz wa-iqbl wa-yumn wa-safid / fiizzd√im safid q√im / fiizz d√im safid q√im44
15. (nord-est) wa-l-kaml wa-l-yumn wa- / l-salma wa-l-i©g™llwa- / l-˛if÷ wa-l-if∂l […] / [… yu]mn wa-l-kaml wa- / l-safid wa-l-iqbl wa-l- / rifiya[?] wa-l-kaml wa- / l-ta√yıd wa-l-salma wa- / l-fiizz wa-l-kifya wa-l-naßr45
16. (nord) wa-l-kaml wa-l-safid wa- / l-difiya wa-l-÷afar wa- /l-kifya wa-l-safid wa- / l-yumn wa-l-salma wa-l-ta√ / ayyud wa-l-fiizzwa-l-kaml wa-l-di / fiya wa-l-kaml wa- / fiizz wa-iqbl wa-safid wa-/ salma wa-l-fiizz wa-l-÷afar46
17. (est) wa-l-salma wa-l-kaml / wa-l-safid wa-l-iqbl wa- / l-yumn wa-l-kaml wa- / l-safid wa-l-iq[bl wa-]l-d / ifiya wa-l-naßr wa-/ l-salma wa-l-÷afar wa- / l-˛imya wa-l-÷afar / wa-l-kifya wa-l-naßr47
18. (est) ˛if÷ wa-infim wa-baraka k / mila wa-nifima ©smila wa-∞ib / †a[?] safid[?] q√im wa-naßr wa-i / f∂l wa-salma wa-fifiya / wa-kaml wa-ta√yıd wa-safida / wa-l-i©gll wa-safida wa-fiizz[?] wa-l-yumn wa-l-safid wa-i / ©g™ll wa-yumn wa-if∂l wa-48
19. Iscrizione assente49
20. Iscrizione assente50
A queste iscrizioni possiamo aggiungere ciò che resta di quel-le nasƒ dipinte sul soffitto della navata destra51:
[... wa-l-salma wa-l-kaml wa-l-©gaml wa-l-rifiya wa-l-safidawa-l-baq√ wa-l-kifya wa-l-yumn wa-l-rifiya wa-l-kaml wa-l-©gallwa-l-[...]
[...] al-naßr wa-l-rifiya wa-l-difiya wa-l-salma wa-l-baq√ wa-l-÷afar wa-l-safida wa-l-i©g™ll wa-l-kifya wa-l-rifi[ya ...]
«Di certo tutte le qualità replicate nelle nostre iscrizioni si rife-rivano al re o meglio al suo soggiorno». Poco ci sarebbe daaggiungere al sunto che l’Amari52 fa del significato di tali iscrizio-ni sul soffitto della Cappella Palatina, se non fosse per la stranaaffermazione di Sinding-Larsen, secondo cui esse non contengono«alcun tipico lessico islamico, né tipico della persona del monar-ca, né tipicamente diplomatico», ma al contrario sono state sceltecon cura per descrivere lo stato di benessere di cui avrebberogoduto i Musulmani convertiti al Cristianesimo53. Questa asser-zione tradisce la scarsa familiarità dell’autore con l’epigrafia isla-mica; come Amari ben sapeva, tutte le adfiiya usate nella CappellaPalatina compaiono ubiquitariamente nel mondo medievale isla-mico nelle iscrizioni augurali presenti su oggetti trasportabili, inparticolar modo quelli di metallo. Ciò non può essere totalmentedocumentato nell’ambito limitato di questo saggio, ma la questio-ne viene illustrata nel modo più esaustivo possibile in questa sedededicando due colonne della tav. III alle adfiiya presenti su oggettidi metallo pubblicati da Sarre54 e Melikian-Chirvani55: ben sedicidei venticinque sostantivi e quattro dei cinque aggettivi usati nelleadfiiya della Cappella Palatina compaiono su oggetti di metallopubblicati in queste due opere, che comprendono solo una minu-scola parte dell’intera gamma di produzione di manufatti metalli-ci dell’Islam medievale. Contrariamente a quanto sostenuto daSinding-Larsen, le adfiiya usate nell’epigrafia arabo-normannasono interamente tratte dal lessico islamico standard, si riferisco-no tutte al sovrano e costituiscono un completamento dei proto-colli ufficiali; non sono state assolutamente adattate alle partico-lari circostanze socio-politiche della Sicilia normanna, né all’am-biente cristiano della Cappella Palatina.
Pochi sono i soffitti di strutture residenziali o istituzionali delmondo islamico risalenti a prima del Trecento sopravvissuti finoai giorni nostri, ma simili adfiiya attestate su fregi architettonicilignei con frequenza sufficiente indicano che l’uso di tali iscrizionisul soffitto della Cappella Palatina non fu esclusivo. I primissimiesempi sono tutti fregi di legno scolpito provenienti dal Cairo edatabili ai secc. IX e X: quattro frammenti custoditi nel Museod’Arte Islamica del Cairo, con le formule baraka wa-yumn wa-safida li-s˛ibihi e baraka wa-nifima wa-∞ib†a56, e uno al Louvre,che recita baraka wa-yumn wa-safida wa-nifima wa-∞ib†a li-߲ibihi57. Fra gli esempi coevi alla Cappella Palatina vi sono duepannelli facenti parte di una fascia decorativa in cufico fiorito pro-veniente dalla tomba di Sayyida Nafısa al Cairo, databile proba-bilmente al 114658; due frammenti di fregi risalenti alla metà delXII secolo, reimpiegati nella moschea di Mu√ayyad al Cairo59; euna struttura divisoria dalla moschea di al-∑li˛ ‡al√ıfi ibn Ruzzıkal Cairo del 116060. Come si vedrà in seguito, simili iscrizioniinvocatorie sono anche presenti sui soffitti di architetture religio-se almoravidi nel nord Africa, fra cui la Qubbat al-Barüdiyyin aMarrakesh (Marocco), risalente al 1117.
Nel contesto di questa mostra, l’elemento da sottolineare è l’e-vidente presenza di una stretta collaborazione fra chi dipinse le
fig. 8
fig. 8. Soffitto ligneo intagliato e dipinto (part.), Palermo, Cappella Palatina
NOBILES OFFICINAE. PERLE, FILIGRANE E TRAME DI SETA DAL PALAZZO REALE DI PALERMO 58
iscrizioni sul soffitto della Cappella Palatina e chi ricamò la fasciaepigrafica sul manto di Ruggero: delle ventuno adfiiya usate sulmantello, tredici ricompaiono sul soffitto della Cappella Palatina.Inoltre, è assai improbabile che sia pura coincidenza la ricompar-sa del tema iconografico saliente del mantello – il leone che atter-ra il cammello – anche fra le immagini dipinte nella navata destradella Cappella Palatina61. La collaborazione evidentemente esiste-va non solo fra gli epigrafisti che lavorarono al mantello e al sof-fitto, ma anche fra gli artisti che progettarono le immagini.
Altre due iscrizioni invocatorie presenti su edifici erano proba-bilmente rivolte a Ruggero II: di quella nella chiesa distrutta di S.Giacomo la Mázara abbiamo già trattato in modo esauriente, enon è necessario protrarre oltre la discussione in questa sede; maquella di S. Maria dell’Ammiraglio richiede qualche chiarimento.Si ritiene che i due famosi pannelli dedicatori, con i mosaici che raf-figurano Ruggero II incoronato da Cristo e Giorgio d’Antiochiadavanti alla Vergine, decorassero originariamente la parete orien-tale del nartece, occupando i lati del portale che conduceva all’in-terno della chiesa. Ma non si tratta dell’unica coppia di simboliche nella chiesa di S. Maria dell’Ammiraglio sono riferiti al re e alsuo ministro, in quanto due colonne – anche queste, come i pan-nelli musivi, spostate in un’altra collocazione nella nuova chiesacinquecentesca – alludono rispettivamente a Ruggero e a Giorgio.Con tutta probabilità queste colonne furono originariamenteimpiegate nel loggiato del cortile esterno che fiancheggia l’entrataoccidentale, in corrispondenza dei due pannelli musivi dedicatoriall’interno. La colonna che fa riferimento a Giorgio reca due fascecon un’iscrizione: sulla ghiera sotto il capitello si legge inna llhumafia lla≤ına ttaq [sic! da leggersi ittaqaw] («In verità, Dio è concoloro che Lo temono», Corano 16:128); un pannello posiziona-to al centro del fusto della colonna reca un’iscrizione con lo ̨ asba-la, il motto introdotto come apprecatio nei documenti in arabo delregio dıwn durante il visierato di Giorgio d’Antiochia – bi-smillhi l-ra˛mni l-ra˛ımi ˛asbiya llhu wa-nifima l-wakıl («Nel nomedi Dio, il Misericordioso, il Compassionevole, Dio è a me bastan-te ed Egli è il miglior guardiano»). L’esplicito tenore islamico diqueste iscrizioni indica che la colonna era probabilmente uno spo-lium proveniente da un edificio religioso e fu reimpiegata in S.Maria in virtù di questa stretta associazione fra lo ˛asbala e il visirGiorgio. La seconda colonna reca un’iscrizione con quattro adfiiya– al-naßr wa-l-÷afar wa-l-fiizz wa-l-iqbl – appartenenti al normalerepertorio reale utilizzato da re Ruggero (cfr. tav. III) e fu presu-mibilmente realizzata ex novo per fare da contraltare alla primacolonna.
Finora ci siamo concentrati sul contenuto delle iscrizioniarabo-normanne; è adesso arrivato il momento di occuparci delloro stile. Abbiamo già osservato che sette di queste epigrafi sonostate eseguite in quella scrittura angolare nota con il nome di cufi-co, mentre nove sono state scritte in corsivo (cfr. tav. I): è l’uso delcorsivo ad esigere molta attenzione in questa sede, ma dapprima èdoveroso dedicare qualche parola alla scrittura angolare.
È unanime il consenso sull’opinione che lo stile della scritturaangolare utilizzata nella Sicilia dei Normanni si sia basato sullostile fatimide, a sua volta modificato incorporando la vastagamma delle esuberanti ornamentazioni ideate nell’Ifrıqiyya ziride:questo è vero non solo per gli epitaffi, come quello di al-Dıbπı(infra, cat. n. VIII.5) e di Ibn Muƒallaf (infra, cat. n. VIII.6), maanche per molte altre iscrizioni arabo-normanne, come quelle sulmanto di Ruggero (infra, cat. n. I.1) e sull’alba e sulle calze diGuglielmo II (infra, cat. nn. I.3-4), quelle presenti sulle due colon-ne in S. Maria dell’Ammiraglio, le adfiiya di San Giacomo laMázara e il fregio epigrafico sul coronamento della Zisa. Le iscri-zioni sui margini dei cassettoni stellati della navata centrale dellaCappella Palatina sono invece più problematiche. Secondo UgoMonneret de Villard62 esse furono eseguite in puro stile fatimide,senza ornamentazione ziride: «solo un filo vegetale corre fra leaste alte delle lettere che sorpassano la linea d’appoggio, svilup-pandosi in volute e qualche fogliame là dove deve riempire deivuoti eccessivi che esistono fra tali aste». Sebbene egli riconducatale ornamentazione alle sue origini nel ∫ursn, ne nota l’arrivoin Egitto su †irz già a partire dal regno di al-Mustanßir bi-llh(1074-1094), e un’ininterrotta presenza in quei luoghi almenofino al 541/1145-1146 (iscrizione incisa su legno nella tomba degliAbbasidi)63. Ma Sourdel-Thomine64, analizzando lo stile di questestesse iscrizioni, è giunta a conclusioni notevolmente diverse: laforma delle lettere non appartiene al repertorio fatimide e moltefra esse non hanno semplicemente nessun riscontro – la curva pie-gata all’indietro di ©gim; il modo in cui viene portata in alto lacoda, non solo quella di nün, ma anche quella di r√ e zy; la ten-denza alla semplificazione, così che dl finisce per somigliare a kfe fiayn a f√. Ma è sullo stile dell’ornamentazione che Sourdel-Thomine diverge nettamente da Monneret de Villard: per lei talestile dimostra un chiaro legame con la Siria post-salgiuchide: «unprocédé décoratif étranger à l’heritage fatimide, quoique connu enEgypte à l’époque considerée: l’adjonction aux lettres d’un rinceauindépendant, aux délicats enroulements et aux souples fleuronspolylobés de type büyide et saljüqide, passant alternativement au-dessus et au-dessous des hampes hautes et maintenant une fonda-mentale distinction entre élément floral et élément épigraphique,juxtaposés sans être jamais confondus”. Le influenze siriane sonoancora più evidenti nell’elaborato intreccio delle lettere della deco-razione pseudoepigrafica in alcuni alveoli delle cornici a muqar-nas65. Ciò conferma con forza, sostiene la Sourdel-Thomine, l’in-dicazione di Monneret de Villard secondo il quale alla pittura delsoffitto della Cappella Palatina presero parte artisti provenienti daregioni islamiche orientali. Riteniamo cosa migliore rimandare ladiscussione di queste tesi e della loro importanza dopo avere esa-minato le questioni relative alla scrittura corsiva.
Le iscrizioni in corsivo nella Sicilia normanna possono suddi-vidersi in due gruppi: quelle semplici e quelle ornate. Al gruppodelle iscrizioni semplici appartengono tutte quelle che sono stateincise e non eseguite a rilievo: rientrano in questo gruppo gli epi-
LE ISCRIZIONI E LE EPIGRAFI IN ARABO: UNA RILETTURA 59
taffi di Anna e Drogo (infra, cat. n. VIII.7b-c), l’iscrizione dellaclessidra di Ruggero (infra, cat. n. VIII.4) e quella di Pietro-Barrüna Termini Imerese (infra, cat. n. VIII.3). I due epitaffi sono incisicon caratteri corsivi grossolani, senza la benché minima pretesacalligrafica, e sarebbero più adatti a documenti, lettere o libri piut-tosto che all’epigrafia monumentale. I caratteri dell’iscrizione dellaclessidra sono di gran lunga più eleganti, incisi con cura e ben pro-porzionati, con alif e lm allungate e dalle estremità affusolate,eppure non si tratta di una calligrafia epigrafica raffinata, e note-vole è il parallelismo con le calligrafie più accurate impiegate dalregio dıwn. La scrittura dell’iscrizione di Pietro-Barrün, dalle let-tere nettamente smussate e dalle aste con apici spessi, è delibera-tamente calligrafica ed è stata incisa da un abile artigiano, ma sitratta ancora essenzialmente di una calligrafia da scrivano. Ilnostro sospetto è che tutte le scritture presenti in questo gruppoderivino in ultima analisi dalle scritture corsive del regio dıwn,che la loro origine possa risalire alla rinascita del dıwn, avvenutaintorno al 1130, e che esse siano state adottate nell’epigrafia realeprimariamente perché erano già in uso nel dıwn.
Nel gruppo ornato rientrano le iscrizioni in opus sectile (figg.5-6) di Palermo (infra, cat. n. VIII.1) e Messina (infra, cat. n.VIII.2), le iscrizioni in corsivo dipinte sul soffitto della navatelladestra della Cappella Palatina66, il fregio in stucco della qfia dellaZisa67, e quello in arenaria della facciata della Cuba68. Le iscrizio-ni in opus sectile di Palermo sono scritte in caratteri corsivi chenon si conformano strettamente a nessuno dei canoni epigraficiarabi: alif e lm hanno forma a cuneo e sono molto affusolate; icaratteri non si proiettano al di sotto della linea d’appoggio, cosìche le parti inferiori di kf, lm e nün risultano goffamente appiat-tite, mentre dl, r√, zy e ww sembrano quasi aggranchite. I carat-teri delle iscrizioni messinesi sono più rozzi, ancor meno propor-zionati e ancor più lontani dai canoni epigrafici. Entrambe le seriedi iscrizioni presentano alcune vocali e alcuni segni diacritici: inquelle palermitane ritroviamo il puntino su qf, alla manieraMaghribı, in quelle messinesi l’uso dei puntini classico. Per quantoriguarda la decorazione, nelle iscrizioni di Palermo gli spazi fra leaste allungate sono riempiti da un arabesco fitomorfo derivatodallo stile orientale. Nelle iscrizioni messinesi la decorazione èsimile, ma eseguita in modo incompetente. In entrambi i casi si hal’impressione che gli artigiani abbiano disperatamente cercato, convarie percentuali di successo, di seguire il proprio modello usandoil mezzo poco conosciuto dell’opus sectile. Il fregio di stucco nellaqfia della Zisa è un’opera molto meno eccentrica: la scrittura èfluida, ben proporzionata e ben progettata, con aste lunge e affu-solate, inserita su uno sfondo di ricche ornamentazioni vegetaliprofondamente incise nello stucco. A confronto i caratteri sul fre-gio di arenaria della facciata della Cuba sono pesanti, corti e spes-si, ma sono stati eseguiti con vigorosa fluidità e ritmo esuberante;le fotografie dell’iscrizione in situ fatte dall’Amari indicano chenon dovevano essere solo visibili, ma anche leggibili. Negli spaziliberi fra le aste è presente qualche leggera decorazione vegetale, e
l’iscrizione sembra avere avuto una fascia decorativa, ma l’enfasi èposta sui caratteri, mentre la decorazione è deliberatamente trat-tenuta.
Le iscrizioni, molto frammentarie, sulle calze di Guglielmo IIsono eseguite in una calligrafia scorrevole e ben proporzionata,con hastae lunghe e affusolate su uno sfondo di girali. A differen-za degli altri componenti di questo gruppo, l’iscrizione sull’orlodell’alba di Guglielmo II non presenta sfondi con elementi decora-tivi vegetali, ma è talmente ricca d’oro e bordata di perle da nonpotersi definire semplice o disadorna. I caratteri sono ben propor-zionati, con hastae lunghe e affusolate, e pianificati con arte: alcu-ne parole sono scritte sopra le altre, negli spazi fra i gruppi dihastae, sfruttando nel migliore dei modi il limitato spazio disponi-bile.
Nella fodera delle due fasce attorno alle braccia e del polsinodestro dell’alba di Guglielmo sono stati ritrovati tre appunti rica-mati scritti dagli artigiani dell’opificio reale e a loro destinati. Taliappunti non dovevano essere visibili e non concorrono alla deco-razione dell’alba, ma ciò nondimeno rivestono la massima impor-tanza per quel che ci rivelano dell’organizzazione e delle attivitàdell’opificio reale. Inoltre sono di particolare interesse per le que-stioni relative alla scrittura corsiva.
Edite per la prima volta da Tarif Al Samman (1982), in unimportante articolo che prende in esame tutte le iscrizioni sui para-ti reali siciliani, le tre note sono tutte scritte nella stessa grafia piut-tosto disinvolta, che mostra una notevole rassomiglianza con lecalligrafie utilizzate dal regio dıwn, in inchiostro nero su unastoffa di lino. La loro concisione, il livello con cui la lingua ado-perata si avvicina al registro colloquiale e il fatto che chi le hascritte condivideva con i loro destinatari delle conoscenze che nonsono a noi pervenute, ne rende l’interpretazione estremamente dif-ficile. Si presenta di seguito la nostra lettura annotando, in paren-tesi uncinate, i passi in cui essa differisce da quella di Al Samman.
Nota A (dalla fodera del polsino destro): ˛≤ awwalu l-±ul±<al-thuluth> alla≤ı fiamilahu Muƒr[iz?…] <Mu˛… oppureMa˛…> («Questo è il primo terzo <der Beginn des Thuluth> cheMuƒr[iz?] <Mu˛[ammad] o Ma˛[müd]> fece [.....]»).
Nota B (dalla fodera della fascia del braccio sinistro): h≤ l-±ul± <al-thuluth> alla≤ı fiamilahu fiAlı l-Mli†ı da©g©galahu mina l-lu√lu√ fial yadi l-q√id Damiy[n .....] / ru©g©gifia min ≤lika fiindafatqihi wa-taklılihi ±nı karra fial yadi l-fat <al-fannı> ‡üms bi-ta√rıƒi 12 M[yü .....] («Questo terzo <Dieser Thuluth>, che fiAlı l-Mli†ı fece, fu ricoperto con perle per ordine del q√id Damiy[n.....] / furono restituite quando [l’alba] fu disfatta e decorata per laseconda volta, per ordine dell’eunuco <des Fachmannes> ‡üms,in data 12 Ma[ggio .....]»).
Nota C (dalla fodera della fascia del braccio destro): h≤ l-±ul± <al-thuluth> alla≤ı fiamilahu Marzüq da ©g©galahu mina l-lu√lu√fial yadi l-q√id Damiyn tisfiına dirham / ru©g©gifia min ≤likafiinda fatqihi wa-taklılihi ±nı karra bi-ta√rıƒi 12 Myü l-rbifii fialyadi l-fat <al-fannı> ‡üms tis ƒarib <khurib> (o «Questo terzo,
NOBILES OFFICINAE. PERLE, FILIGRANE E TRAME DI SETA DAL PALAZZO REALE DI PALERMO 60
che fece Marzüq, fu ricoperto per ordine del q√id Damiyn connovanta dirham di perle, di cui nove [dirham] furono restituitespezzate quando [l’alba] fu disfatta e decorata per la secondavolta, in data 12 maggio della Quarta [Indizione], per ordine del-l’eunuco ‡üms»; oppure «Questo terzo, che fece Marzüq, fu rico-perto per ordine del q√id Damiyn con perle, di cui novantadirham furono restituite quando [l’alba] fu disfatta e decorata perla seconda volta, in data 12 maggio della Quarta [Indizione], perordine dell’eunuco ‡üms – nove [dirham] spezzate»); oppure (ii)h≤ l-±ul± <al-thuluth> alla≤ı fiamilahu Marzüq da©g©galahu mina l-lu√lu√ <mina l-lu√lu√i e nota 29, “Die Präposition min (aus, mit)ist irrtümlich in zwei Formen der Thuluth-Schrift geschrieben”>fial yadi l-q√id Damiyn tisfiına dirham / ru©g©gifia min ≤likafiinda fatqihi wa-taklılihi ±nı karra bi-ta√rıƒi 12 Myü l-rbifii fialyadi l-fat <al-fannı> ‡üms tis ƒarib <khurib> («Questo terzo,che fece Marzüq, egli ricoprì per ordine del q√id Damiyn con unmann [circa 900 grammi] di perle, di cui novanta dirham [circa281 grammi] / furono restituite – nove [dirham] spezzate – quan-do [l’alba] fu disfatta e decorata per la seconda volta, in data 12maggio della Quarta [Indizione], per ordine dell’eunuco ‡üms»<Dieser Thuluth, welchen Marzüq hergestellt hat, besetzte er mitPerlen unter Aufsicht des Q√id (Leiter) Damiyn. NeunzigDirham / (davon) wurden wieder verwendet, als (die Alba) aufge-trennet und wieder zusammengesetzt wurde zum zweiten Mal am12. Mai der vierten (Indiktion) mit Hilfe des Fachmanns ‡üms.Neun (Perlen) wurden beschädigt.>)
Il principale punto di divergenza riguarda il significato dellaparola al-±ul± (lett. ‘il terzo’) che compare in tutte e tre le note. AlSamman ha ritenuto che si riferisse alla scrittura chiamata al-±ulu±,uno dei sei stili (al-aqlm al-sitta) della calligrafica classica, che sidice siano stati perfezionati alla corte fiAbbside di Baghdad daYqüt al-Mustafißimı (m. nel 1298). Se Al Samman avesse ragione,si tratterebbe di un interessantissimo protoriferimento a una scrit-tura corsiva come al-±ulu±. Lo stile calligrafico di al-±ulu± vienegeneralmente così definito poiché si basa sul principio che un terzodi ciascuna lettera debba essere inclinato. Che questo non siaovviamente il caso né per la grafia con cui sono scritte le tre notené per l’iscrizione dell’orlo non significa necessariamente che que-sta scrittura non sia – o non fosse considerata – ±ulu±: come nelcaso del nasƒ, il nome di un altro dei sei stili, questo termine tendead essere utilizzato con una certa libertà – le scritture corsivemonumentali e decorative sono spesso definite ±ulu± per distin-guerle dalla grafia quotidiana, cioè il nasƒ. Pertanto, per quantopossa essere sorprendente ritrovare un corsivo chiamato thuluthin questo modo non ufficiale già nel 1156, la morfologia dellascrittura non esclude necessariamente una tale descrizione.Esistono tuttavia altri validi motivi per non accettare la lettura diAl Samman. Innanzitutto, ciascuna delle tre note fa riferimento aun ±ul± separato, ciascuno prodotto da un artigiano diverso, di cuialmeno due sono stati ricoperti con perle. Ne consegue che essinon possano riferirsi né alla grafia delle note stesse, che sono state
scritte da un’unica mano e non sono ricoperte di perle, né al duc-tus della singola iscrizione sull’orlo, che è ricamata in oro e non èdecorata con perle. In secondo luogo, se la parola al-thulth fosseda riferirsi alla grafia, pur anche nel registro colloquiale, avrem-mo potuto aspettarci una locuzione come ˛≤a l-kitbu l-±ulu±ı(«questa iscrizione thuluthi») o ˛≤a qalamu ±ulu± («questi carat-teri ±ulu±»). In terzo luogo, la lettura ovvia e più immediata dellafrase che apre le note B e C è «Questo terzo…». Nella nota A,siamo inclini a considerare ˛≤a awwalu l-±ulu±i come una collo-cazione, ben attestata nell’arabo non classico69, avente il significa-to di «Questo è il primo terzo…». Cosa siano di preciso i tre terzia cui si riferiscono queste note non è chiaro, ma il fatto che cisiano tre note – presumibilmente una per ogni terzo – deve in qual-che modo essere rilevante. Dato il luogo in cui queste note sonostate ritrovate, è possibile che le due fasce delle braccia e il paio dipolsini fossero considerati ciascuno come un terzo, che le applica-zioni di perle siano state affidate a tre artigiani diversi e che è pro-prio a queste tre fasce che le note alludono.
Considerata l’importanza di queste note per la storia e l’orga-nizzazione degli opifici reali, qualcosa va detto nel contesto dellamostra su altri spunti che originano dalla loro lettura.
Per ciò che attiene ai nomi di persona, sembrano essere tuttidi saraceni palatii, Saraceni di palazzo, schiavi o liberti impiegatialla corte regia70. Al-q√id Damiyn e al-fat (lett. ‘giovane’, maqui quasi certamente con il significato di eunuco) ?umas possie-dono entrambi titoli tipici dei Saraceni di palazzo. Come molti deiloro simili, compaiono con nomi cristiani che sono stati dati loroal momento del battesimo, forme arabizzate di Damiano eTommaso. Damiyan non è altrimenti noto, ma ‡üms è probabil-mente da identificarsi con il Gaytus Thomas, qui regie [duane] desecretis camerariatum tenebat, che lasciò l’incarico o morì primadel 118371. Muƒriz, √Alı al-Mli†ı (‘il Maltese’) e Marzüq, invece,non sembrano avere un titolo e, in comune con alcuni dei lorosimili, usano dei nomi musulmani: è possibile che fossero artigia-ni impiegati nel guardaroba reale e non Saraceni di palazzo distato servile o semiservile.
Per quanto riguarda l’applicazione delle perle nella nota C,siamo fortemente inclini ad accettare la conclusione di AlSamman, secondo il quale la preposizione min è stata ripetuta pererrore e a prediligere la lettura (i) data alla nota C. In tal caso, lanota probabilmente significa che il q√id Damiyn aveva conse-gnato a Marzüq 90 dirham (circa 281 grammi) di perle, di cui 9dirham (circa 28 grammi) si spezzarono e furono restituite quan-do l’alba fu scucita e riconfezionata per ordine del fat ‡üms.Un’interpretazione alternativa potrebbe essere quella secondo cui,di una quantità non specificata di perle consegnata a Marzüq, 90dirham furono restituite e 9 dirham erano quelle spezzate. (Restapossibile l’ipotesi, tuttavia, che la locuzione in questione debbaessere letta come da©g©galahu min manni, nel cui caso Damiynavrebbe consegnato a Marzüq un mann [circa 900 grammi] diperle, di cui 90 dirham [281 grammi] furono restituiti, inclusi 9
LE ISCRIZIONI E LE EPIGRAFI IN ARABO: UNA RILETTURA 61
dirham [28 g] di perle spezzate, quando l’alba fu scucita e ricon-fezionata per ordine del fat ‡üms. Tuttavia, la nota B sembre-rebbe non suffragare tale interpretazione.)
Per quanto attiene alla data di questa iscrizione – il 12 mag-gio, Indizione IV – non è possibile aggiungere nulla di nuovoall’indicazione data da Al Samman, secondo il quale potrebbe cor-rispondere all’investitura di Guglielmo I da parte di papa AdrianoIV a Benevento nel giugno del 1156, Indizione IV, nel qual casol’alba dovrebbe essere stata confezionata in origine per Ruggero II.Se al- fat ‡üms fosse invero da identificarsi con Gaytus Thomas,che lasciò l’incarico o morì prima del 1183, allora l’anno 1171,Indizione IV, rimane l’unica alternativa possibile, ma da quanto siconosce in quell’anno non fu celebrata nessuna cerimonia realeche potesse giustificare il riconfezionamento dell’alba.
Che la si classifichi come nasƒ o ±ulu±, la comparsa di un’epi-grafia in corsivo in Sicilia nel 1142 o prima di quella data ponedegli interrogativi sulla sua origine e sul perché venne adottata daire Normanni. Fino alla fine del sec. XII tutte le iscrizioni monu-mentali nel Mediterraneo fatimide impiegarono i caratteri angola-ri noti con il nome di cufico72. La scrittura corsiva venne utilizza-ta nelle iscrizioni monumentali in Afghanistan e Iran dalla secon-da metà del sec. XI73; più a occidente essa è presente in modo spo-radico, sotto la sfera dell’influenza salgiuchide, ma diventa comu-ne in Siria sotto Nür al-Dın (1146-1174), il sovrano zengide diDamasco e Aleppo74. Nell’Egitto fatimide non sembra che il corsi-vo sia stato usato nelle iscrizioni monumentali fino al 1155 circa,quando viene impiegato, insieme al cufico, sul superbo tbüt di al-˘usayn ibn fiAlı ibn Abı ‡lib, oggi custodito al Museo d’ArteIslamica del Cairo75; un po’ più tardi, intorno al 1160, il corsivoviene anche utilizzato nelle iscrizioni invocatorie su un’anta ligneadi un armadio proveniente dalla moschea di al-∑li˛ ‡al√ıfi ibnRuzzık76. È stato sostenuto con vigore che i Fatimidi resistetteroall’uso del corsivo nel Corano e nei testi coranici per motivi ideo-logici77. Sia quel che sia, nell’Egitto fatimide il corsivo fu usato intesti ismfiılı, com’è dimostrato dal tbüt of al-˘usayn e da un’iscri-zione commemorativa ismfiılı custodita al Museo Islamico delCairo e datata al 550/1155-1156 circa78. Il fatto che nelle lapidifunerarie in Egitto si utilizzasse il corsivo dagli inizi del sec. XIIpotrebbe effettivamente indicare che i Fatimidi furono in questosenso più conservatori rispetto ai loro sudditi79. Tuttavia i Fatimidinon evitarono l’uso dei caratteri corsivi in ogni ambito: nel lorodıwn il corsivo fu sempre impiegato nelle lettere e nei documentiufficiali, e la firma (fialma) del califfo era sempre in corsivo80; neiloro †irz il corsivo fu usato per la prima volta al tempo di al-Mustanßir, nel 478/1085-1086, per continuare con al-˘fi÷81. Datoche i soli testi fatimidi a giungere in Sicilia, a parte le monete,sarebbero stati quelli di lettere e documenti scritti in corsivo, equelli su oggetti trasportabili come manufatti di metallo e †irz, èaltamente improbabile che la corte normanna abbia associato lascrittura cufica ai Fatimidi, cosa che è invece apparsa lapalissianaagli storici dell’arte sin da quando fu evidenziata da van Berchem.
Il Maghreb adottò la scrittura corsiva prima delle provincefatimidi del Mediterraneo: sembra probabile quindi che lo stilecorsivo abbia fatto un ‘salto’ dall’Islam orientale all’estremo Islamoccidentale senza attraversare l’area fatimide. Il corsivo compareper la prima volta in epitaffi tunisini del 490/1096, quando il raf-finato e ben proporzionato nasƒ, dalle lunghe e spesse aste, inseri-to in un ricco sfondo floreale, sembra testimoniare una direttainfluenza orientale, crescendo in popolarità durante il XII secolo.È forse significativo che la maggior parte di queste prime iscrizio-ni in corsivo provengano dal cimitero di Banı ∫urasn, i cui forticontatti con l’oriente potrebbero aver condotto a questa precoceadozione di stili epigrafici e decorativi di derivazione orientale82.Agli inizi del sec. XII il corsivo era ormai stato adottato nelle iscri-zioni monumentali dagli Almoravidi dell’estremo Maghreb. Laprima iscrizione di cui si ha testimonianza è costituita dal fregiointorno alla base di Qubbat al-Barüdiyyin a Marrakesh (Marocco),databile al 1117. La scrittura non ha vocali né punti diacritici edè collocata su uno sfondo di arabeschi vegetali nello stile orienta-le; le iscrizioni cufiche nello stesso monumento hanno invocazioniparagonabili a quelle che si trovano nella Cappella Palatina83. Icaratteri e le decorazioni dell’iscrizione in corsivo sulla cupolatraforata della Grande Moschea di Tlemcen in Algeria, risalente al1135, sono estremamente affini a quelli del Qubbat al-Barüdiyyin84.Nel 1137, quando la navata centrale della moschea di al-Qarawiyyin a Fez fu ricostruita dagli Almoravidi, il corsivo fuimpiegato su larga scala: in un medaglione sopra il mi˛rb, neglialveoli della volta a muqarnas più vicini al mi˛rb, nella grandevolta a muqarnas e sulle maniglie in bronzo del Bab Sbitriyn85. I pri-missimi esempi di corsivo in al-Andalus – frammenti di un fregio instucco con iscrizione decorata da un arabesco vegetale, ritrovato ael Mauror (Granada), ai piedi delle Torres Bermejas – è ritenutoplausibilmente coevo agli esemplari almoravidi del nord Africa86.
Il corsivo è presente inoltre, intorno allo stesso periodo, sumanufatti trasportabili originari del nord Africa: per esempio nelcandelabro frammentario in bronzo proveniente dal Qalfiat Banı˘ammd e recante iscrizioni invocatorie sia in cufico che in nasƒ87.Questo oggetto ha degli stretti parallelismi con l’importante cande-labro, quasi completo ma ancora praticamente inedito, della ChiesaMatrice di Petralia Sottana, il quale reca anch’esso iscrizioni invo-catorie in entrambe le scritture88. I caratteri nasƒ, pesanti e arro-tondati in entrambi gli oggetti, sono particolarmente vicini allo stilecorsivo utilizzato sul soffitto della navata laterale della CappellaPalatina e sulla facciata della Cuba. Manufatti trasportabili d’attri-buzione egiziana e nordafricana, databili ai secc. XI e XII e recantiiscrizioni in corsivo, si trovano in diversi tesori di chiese siciliane edell’Italia meridionale: per esempio, la poco conosciuta cassettacilindrica in bronzo del Tesoro del duomo di Barletta e l’ineditocoperchio di un’analoga cassetta del Tesoro del duomo di Caiazzo,che recano entrambi iscrizioni invocatorie in cufico e in corsivo89.La presenza di diversi esemplari di un peculiare gruppo di mortai inbronzo, basati su un prototipo iraniano, alcuni dei quali recano
NOBILES OFFICINAE. PERLE, FILIGRANE E TRAME DI SETA DAL PALAZZO REALE DI PALERMO 62
iscrizioni invocatorie in corsivo, è attestata in diverse collezioni inSicilia e in Italia meridionale, fra cui quella della Galleria Nazionaledi Palermo90; esempi simili a quelli presenti a Palermo appartene-vano al carico di una nave naufragata al largo di Orano (Algeria),una chiara indicazione della produzione spagnola o maghrebina diquesti manufatti, successivamente esportati in Sicilia91.
In Sicilia, al di fuori della corte reale il corsivo fu impiegatooccasionalmente su lapidi funerarie: la maggior parte degli epitaf-fi in corsivo pubblicati dall’Amari sembrano essere stati di impor-tazione nordafricana92, ma la nisba di Ibn fiAbd al-¡Gaffr al-∑iqillı,la cui pietra tombale proviene da Termini Imerese, suggerisce unamanifattura isolana: la data è mancante ma la scrittura, fluida edelegante su uno sfondo di arabeschi fitomorfi, presenta forti paral-lelismi con le iscrizioni nordafricane di cui si è già parlato93. Lapietra tombale di al-Sitt bint Abı l-Qsim ibn ˘usayn («la Signora,figlia di Abü l-Qsim, figlio di ˘usayn»), datata dicembre 1238,che arriva alla Galleria Regionale da San Martino delle Scale, è piùproblematica94: non esistono motivi convincenti per identificarlacome siciliana, ma grande è la tentazione di collegare la defunta –commettendo probabilmente un errore – alla famiglia di Abü l-Qsim Mu˛ammad ibn ˘ammüd, capo ereditario della comunitàmusulmana in Sicilia95. Non è difficile immaginare che la scrittu-ra corsiva di questo epitaffio – contratta e mal proporzionata,dalla scarna decorazione vegetale – possa riflettere il basso livelloin cui era caduta l’arte dell’incisione su pietra a Palermo in conse-guenza delle ribellioni musulmane e della loro repressione adopera di Federico II. Se così fosse vale la pena di rievocare la lapi-de funeraria prismatica venuta alla luce nel rifugio dei ribellimusulmani sul monte Iato, che con la sua rozza iscrizione in cor-sivo può essere considerata una commovente testimonianza delladeterminazione con cui una famiglia ribelle volle osservare i buonicostumi del vivere civile nonostante le disperate circostanze96.
Per riassumere la discussione sullo stile delle iscrizioni arabo-normanne, è indubbiamente vero che la forma delle lettere cufi-che, lo stile della scrittura corsiva più epigrafica e alcune orna-mentazioni delle iscrizioni arabo-normanne derivano tutti in ulti-ma analisi da modelli orientali. Tuttavia queste influenze orienta-li avevano già cominciato ad evidenziarsi nell’epigrafia fatimide,ziride e almoravide prima di comparire in Sicilia, e potrebberoavere raggiunto l’isola da queste fonti mediterranee invece di pro-venire direttamente da Oriente. Nell’uno o nell’altro caso, stili edelementi ornamentali epigrafici potrebbero facilmente essere statitrasmessi su oggetti trasportabili come tessili e manufatti di metal-lo, e quindi non occorre ipotizzare una migrazione degli stessi arti-giani. Molto rimane da fare nello studio degli aspetti stilistici del-l’epigrafia arabo-normanna: in particolare esiste l’urgenza di com-pilare cataloghi dettagliati relativi alla forma delle lettere e aglistili decorativi, non solo per quel che riguarda la produzione dellaSicilia normanna ma anche quella dell’Egitto fatimide, dell’Africasettentrionale e della Spagna, in modo da rendere possibile un raf-fronto sistematico.
In conclusione, il modo in cui i re normanni si servirono del-l’epigrafia araba non fu ereditato dai loro predecessori, gli emirikalbidi di Palermo, ma piuttosto importato sull’isola dal contem-poraneo mondo islamico, in particolare dall’Egitto fatimide edall’Africa settentrionale ziride e almoravide. In altre parole, l’usodell’epigrafia araba da parte dei re normanni fu un atto delibera-to e creativo, non una casuale sopravvivenza del passato. Nellamaggior parte dei casi l’epigrafia arabo-normanna seguì il model-lo già consolidato presso le corti islamiche: iscrizioni su operepubbliche, decreti, versi encomiastici nei palazzi, iscrizioni invo-catorie (adfiiya) su edifici e paramenti reali. Sebbene sia singolareritrovare un uso della scrittura corsiva così diffuso in un’epocacosì remota, ciò sembra essere una fortuita conseguenza dellarinascita del dıwn e degli stretti legami geografici e culturali fraSicilia e Africa settentrionale: sarebbe probabilmente erroneo leg-gere un significato ideologico nell’uso del corsivo nella Sicilia nor-manna. Di contro, è solo l’ideologia ad avere ispirato la creazionedi un’epigrafia trilingue, di testi scritti nelle tre lingue amministra-tive del regno – latino, greco e arabo – che proclamano la politicadel populus trilinguis, ovvero delle tre comunità isolane forgiate inun unico popolo siciliano dal potere unificatore del re. Nel cata-logo si sostiene che l’epitaffio ‘quadrilingue’ di Anna (infra, cat. n.VIII.7b), dove viene aggiunto il giudeo-arabo, la lingua quotidia-na della comunità ebraica, contribuisce a suffragare l’evidenzadella finalità di Ruggero di convertire ebrei e musulmani isolani efarli diventare, insieme ai cristiani greci e latini, parte di una chie-sa siciliana trilingue. Ma chi leggeva queste iscrizioni? A chi eranodestinate? Ci sono pochissime prove nella Sicilia normanna che gliappartenenti a ciascuna delle tre comunità conoscessero le linguedegli altri gruppi. Solo un’esigua cerchia di amministratori ed eru-diti all’interno della corte o gravitanti intorno ad essa sarebberostati in grado di leggere due o più dei testi presenti nelle iscrizionitrilingue. Con una manciata di eccezioni, solo i musulmani coltisarebbero stati in grado di leggere le iscrizioni in arabo: i notabilidella comunità musulmana in Sicilia, i poeti e gli eruditi mantenu-ti a corte, gli ambasciatori del mondo musulmano, gli ammini-stratori e gli scrivani del dıwn e i pochi pellegrini e viaggiatori chegiungevano alle mura esterne dei palazzi. La vasta maggioranza dicoloro che videro le iscrizioni arabe dei re normanni non era ingrado di leggerle. In misura minore, naturalmente, questo era veroanche per le iscrizioni greche e latine: l’alfabetismo non era diffu-so, neanche fra la nobiltà, e sembra che lo stesso Ruggero fosse unanalfabeta funzionale, dal momento che non depose mai la pro-pria firma, neanche in greco, lingua in cui fu educato97. Per di più,molte di queste iscrizioni – quelle sulle vesti regali, le adfiiya sulsoffitto della navata centrale della Cappella Palatina, il fregio incufico sulla facciata della Zisa – non potevano essere lette perchénon erano visibili. Tutto ciò suggerisce due conclusioni: il conte-nuto dei testi era importante primariamente per il re e per l’esiguogruppo di regi consiglieri responsabili delle commesse agli artigia-ni mentre al pubblico più vasto perveniva il messaggio secondo cui
il re normanno somigliava a un sovrano islamico per l’uso che eglifaceva dell’arabo. Questa fu certamente l’impressione che i docu-menti e le iscrizioni in arabo dei re normanni fecero sui contem-poranei musulmani. Ibn ©Giubayr riferisce che «tra le cose straordi-narie che si raccontano di [Guglielmo II] è ch’egli sappia leggere escrivere in arabo»: uno degli aspetti arabi della monarchia nor-manna che lo persuade del fatto che Guglielmo II «imita i gover-nanti dei musulmani»98. È rimarchevole pertanto che nessunafonte coeva commenti le iscrizioni arabe dei re normanni.L’originale arabo del passaggio tratto dalla storia di Palermo di al-Idrısı, frequentemente citato nella traduzione di Amari, Jaubert oRizzitano e che si riferisce alle ornamentazioni epigrafiche nelpalazzo di Ruggero, non fa nessuna menzione delle iscrizioni99.Nel descrivere la fortezza (˛ißn) di Ruggero, con i suoi palazzi(qußür) e i suoi saloni (ma©glis), al-Idrısı scrive solo che essi eranoadorni «delle più stupefacenti curiosità» (bi-afi©gabi l-mu„gtaribt) epieni di «cose di natura straordinaria» (bad√ifi al-ßift); ma in pre-cedenza, nel decantare la cattedrale, egli fa delle osservazioni sulla«varietà di ornamenti e iscrizioni (a©gns al-tazwıq wa- l-kitbt)»da cui è decorata.
Nel contesto di questa mostra, un ultimo punto va evidenzia-to. Le iscrizioni arabo-normanne testimoniano sia dell’organicitàdel programma che dettò la produzione di tutti gli opifici di corte,sia della stretta collaborazione esistente fra le varie arti: si vedechiaramente come gli incisori della zecca, gli scrivani del dıwn, iricamatori del guardaroba, i pittori del soffitto della CappellaPalatina, gli incisori di pietre e stucco e gli artigiani che realizza-rono le iscrizioni in opus sectile abbiano operato tutti insieme inun unico programma accuratamente articolato, il cui scopo erainnanzitutto quello di creare e poi esaltare l’aspetto arabo dellamonarchia normanna.
JEREMY JOHNS
University of Oxford
NOTE
1 AMARI 1875, pp. 11-17, tav. I, figg. 1-2, ed. cons. 1971, pp. 21-29.2 MORSO 1827, pp. 46-72.3 MORSO 1827, pp. 137-148; LO FASO PIETRASANTA 1838, pp. 40-41,
tav. XXVI; DI MARZO 1858-1859, I, pp. 159-161.4 AMARI 1875, n. VII, pp. 42-47, tav. V, fig. 1, ed. cons. 1971, n. VII,
pp. 58-63.5 LO FASO PIETRASANTA 1838, pp. 40-41.6 AMARI 1875, tav. V, fig. 1.7 TRAVAINI 1995, pp. 29-55.8 JOHNS 2002, pp. 31-114.9 JOHNS 2002, pp. 268-274.10 CUSA 1868-1882, p. 245; JOHNS 2002, pp. 165-167.11 JOHNS 2002, p. 270.12 JOHNS 2002, pp. 135-136.13 JOHNS 2002, p. 137.
14 AMARI 1875, n. X, pp. 58-62, tav. V, figg. 4-5, ed. cons. 1971, pp.77-82.
15 AMARI 1875, n. XI, pp. 62-76, tav. VII, ed. cons. 1971, pp. 82-99.16 JOHNS 2002, pp. 269-270, 273.17 JOHNS 2002, pp. 259-265.18 JOHNS 1987.19 JOHNS 2002, pp. 270-271.20 JOHNS 2002, p. 272.21 AMARI 1875, pp. 61-62, ed. cons. 1971, pp. 81-82.22 AMARI 1875, n. IX, pp. 49-58, ed. cons. 1971, n. IX, pp. 66-77;
CARONIA 1987 pp. 86-87.23 AMARI 1875, n. XI, pp. 62-76, tav. VII, ed. cons. 1971, n. XI, pp.
82-99.24 JOHNS 2002, p. 279.25 AMARI 1875, p. 56, tav. VI, fig. m; CARONIA 1987, p. 86, fig, 99, M.26 AMARI 1875, n. VI, pp. 32-42, tavv. III-IV, ed. cons. 1971, pp. 47-
58; SINDING-LARSEN 1989.27 KAPITAIKIN 2002, pp. 74-76, tav. VIII, figg. 24.1-2.28 MORSO 1827, p. 76, tav. 7; AMARI 1875, n. XVIII, p. 79, tav. IX, fig.
9, ed. cons. 1971, n. XVIII, pp. 103-104; KITZINGER 1990, pp. 49-51, figg.A25-26; JOHNS 2002, pp. 279-280.
29 BAER 1983, pp. 208-212; BLAIR 1998, pp. 103-105, 108.30 AMARI 1875, n. VI, pp. 32-42, tavv. III-IV, ed. cons. 1971, pp. 47-
58.31 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 73; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 2; SINDING-LARSEN 1989, n. 20.32 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 74; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 1; SINDING-LARSEN 1989, n.19.33 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 78; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 4; SINDING-LARSEN 1989, n. 18.34 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 79; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 3; SINDING-LARSEN 1989, n. 17.35 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 83; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 6; SINDING-LARSEN 1989, n. 16.36 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 84; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 5; SINDING-LARSEN 1989, n. 15.37 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 88; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 8; SINDING-LARSEN 1989, n. 14.38 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 89; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 7; SINDING-LARSEN 1989, n. 13.39 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 93; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 10; SINDING-LARSEN 1989, n. 12.40 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 94; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 11; SINDING-LARSEN 1989, n. 11.41 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 98; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 11; SINDING-LARSEN 1989, n. 9.42 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 99; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 12; SINDING-LARSEN 1989, n. 10.43 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 103; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 14; SINDING-LARSEN 1989, n. 8.44 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 104; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 13; SINDING-LARSEN 1989, n. 7.45 MONNERET DE VILLARD, 1950, fig. 108; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 16; SINDING-LARSEN 1989, n. 6.46 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 109; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 15; SINDING-LARSEN 1989, n. 5.47 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 113; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 18; SINDING-LARSEN 1989, n. 4.48 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 114; AMARI 1875, ed. cons. 1971,
n. 17; SINDING-LARSEN 1989, n. 3.49 MONNERET DE VILLARD, 1950, fig. 118.50 MONNERET DE VILLARD, 1950, fig. 119.
LE ISCRIZIONI E LE EPIGRAFI IN ARABO: UNA RILETTURA 63
51 KAPITAIKIN 2002, pp. 74-76, tav. VIII, figg. 24.1-2.52 AMARI 1875, p. 42, ed. cons. 1971, p. 57.53 SINDING-LARSEN 1989, pp. 95-96.54 SARRE 1906, pp. 76-77 e passim.55 MELIKIAN-CHIRVANI 1982, pp. 422-425 e passim.56 DAVID-WEILL 1931, nn. 3498-3499, pp. 46-47, 6340/1-2, p. 63. tav.
III.57 ANGLADE 1988, n. 17, pp. 32-34.58 DAVID-WEILL 1931, nn. 1649-1650, pp. 28-29, tav. XXIV.59 DAVID-WEILL 1931, n. 646, pp. 22-23, tav. XX; n. 649, pp. 24-25,
tav. XX.60 PAUTY 1931, n. 672, p. 74, tav. XCV.61 La Cappella 1889, tav. XLVII-A; MONNERET DE VILLARD 1950, fig.
11; KAPITAIKIN 2002, pp. 34-35, fig. 4.1.62 MONNERET DE VILLARD 1950, pp. 31-32.63 DAVID-WEILL 1931, n. 4138, p. 550, tav. XV.64 SOURDEL-THOMINE 1962, pp. 312-315.65 MONNERET DE VILLARD 1950, figg. 57, 59, 62, 64, 125, 133.66 MONNERET DE VILLARD 1950, fig. 6.67 CARONIA 1987, pp. 84-85, figg. 82-87.68 AMARI 1875, n. XI, pp. 62-76, tav. VII, ed. cons. 1971, pp. 82-99.69 HOPKINS 1984, pp. 200-205.70 JOHNS 2002, pp. 212-256.71 MATTEI CERASOLI 1939, n. XII, p. 292-294; JOHNS 2002, pp. 244.72 BERCHEM 1891.73 BLAIR 1992, pp. 13-14.74 TABBAA 2001, pp. 57-63.75 WILLIAMS 1987.76 PAUTY 1931, n. 672, p 74, tav. XCV.77 TABBAA 2001, pp. 68-71.78 COMBE et al. 1931-1991, VIII, n. 3187, pp. 280-281.79 WIET 1939, n. 12716, p. 184. tav. XXXII [506/1112], n. 2721/881,
p. 187, pl. XXXII [519/1125], n. 3558, p. 189, pl. XXXIII [527/1133].80 STERN 1964.81 MARZÜQ 1942, tavv. 21-22; MARZOUK 1943, pp. 165-166.82 ZBISS 1955, n. 14, pp. 54-55, tav. XIX; cfr. anche ZBISS 1955, n. 21,
pp. 58-60, tav XXII [499/1105], n. 22, p. 60, tav. XXII [499/1105], n. 30, pp.64-65, tav. XXVI [senza data], n. 37, p. 68, tav. XXX [510/1116], nn. 40-46,pp. 69-72, tavv. XXXI-XXXIV [515/1121], n. 48, p. 72, tav. XXXV[516/1122]; cfr. anche ZBISS 1961, n. 67, pp. 63-64, tav. XIV [508/1114], n.78, pp. 70-71, tav. XVI [520/1126], Appendice n. 10, p. 111, senza tavola [frail 504/1110-1111 e il 549/1154-1155]; GOLVIN 1986, p. 221.
83 MEUNIÉ et al. 1957, pp. 40-42, 49-53, fig. 28, tavv. 40, 42, 77-84,91-94.
84 MARÇAIS 1955, pp. 194, 250-251, fig. 150.85 TERRASSE 1968, pp. 36-37, 47, 80, tavv. 47, 51-53, 93.86 MARÇAIS 1955, p. 250, nota 2; GOMEZ-MORENO 1951, p. 264, fig.
317.87 GOLVIN 1965, pp. 274-278, tav. CVII, fig. 110.88 SCERRATO 1979, pp. 543-544, fig. 243.89 SCERRATO 1979, p. 558, figg. 343-344.90 SCERRATO 1979, p. 544, figg. 204-205.91 GOLVIN 1962.92 AMARI 1879, n. XXXV, pp. 124-125, tav. VIII, fig. 3; n. XLIII, pp.
134-138, tav. XI, fig. 1; n. XLIV, pp. 138-141, tav. XII, fig. 1; n. XLV, pp. 142-144, tav. XII, fig. 2; n. LI, pp. 150-156, tav. XIII, figg. 1-4, ed. cons. 1971, pp.234-235, 242-251, 235-259.
93 AMARI 1879, n. XXXVI, pp. 125-126, tav. VIII, figg. 2 a-b, ed. cons.1971, n. XXXVI, pp. 235-236.
94 AMARI 1879, n. XLII, pp. 131-134, tav. XI, fig. 5, ed. cons. 1971,n. XLII, pp. 240-242.
95 JOHNS 2002, pp. 234-242.
96 ISLER 1992, pp. 113-114, figg. 7-8.97 JOHNS, JAMIL 2004.98 AMARI 1857-1887, ed. cons. 1988, I, pp. 86-87, ed. cons. 1997-
1998, I, p. 120; cfr. anche JOHNS 2002, pp. 80-83, 212-215, 254-255, 297-300.
99 AMARI 1857-1887, ed. cons. 1988, p. 41.
NOBILES OFFICINAE. PERLE, FILIGRANE E TRAME DI SETA DAL PALAZZO REALE DI PALERMO 64
LE ISCRIZIONI E LE EPIGRAFI IN ARABO: UNA RILETTURA 65
TAVOLA I. Dati desunti dalle iscrizioni arabo-normanne
DATA MONARCA PROVENIENZA DESCRIZIONE LINGUA/E CUFICO NAS∫
1130–1154(?) Ruggero II(?) ‘Campanile’ di S. Giacomo monumentale, invocatoria arabo •la Mázara (disperso)
1130–1154 Ruggero II Cappella Palatina (opus sectile), monumentale, in versi arabo •cfr. infra, cat. n. VIII.1
1130–1154 Ruggero II Messina (opus sectile), cfr. infra, monumentale, in versi arabo •cat. n. VIII.1
1130–1154 Ruggero II Cappella Palatina, margini monumentale, invocatoria arabo •dei cassettoni a forma di stella a otto punte sul soffitto della navata centrale
1130–1154 Ruggero II Cappella Palatina, monumentale, invocatoria arabo •fasce epigrafiche sul soffitto della navatella destra
1133–1134 Ruggero II Manto (Vienna), †irz arabo •cfr. infra, cat. n. I.1
1142 Ruggero II Palazzo Reale, clessidra, cfr. infra, monumentale, opera edile latino, •cat. n. VIII.4 greco, arabo
circa 1143 Ruggero II S. Maria dell’Ammiraglio monumentale, invocatoria arabo •
1142/3 o 1152/3 Ruggero II Termini Imerese, Pietro-Barrün, monumentale, opera edile latino, •cfr. infra, cat. n. VIII.3 greco, arabo
1149 Ruggero II Lapide in memoria di Anna, funeraria giudeo-arabo, •madre di Grisanto, cfr. infra, latino, greco, cat. n. VIII.7b arabo
1153 Ruggero II Lapide in memoria di Drogo, funeraria latino, •padre di Grisanto, cfr. infra, greco, cat. n. VIII.7c arabo
1181 Guglielmo II Alba (Vienna), cfr. infra, †irz arabo •cat. n. I.3
1166–1189 Guglielmo II Calze (Vienna), cfr. infra, †irz arabo •cat. n. I.4
1166–1189 Guglielmo II Palazzo della Zisa (parapetto) monumentale, in versi arabo •
1166–1189 Guglielmo II Palazzo della Zisa monumentale, in versi arabo •(fregio in stucco)
1166–1189 Guglielmo II Cuba monumentale, in versi arabo •
TOTALE
Monarca Provenienza Tipo Lingua/lingue Scrittura araba
Ruggero II: 9/11? Palermo: 14 Monumentale, invocatoria: 4 arabo: 14 cufico: 5
Guglielmo II: 5 Messina: 1 Monumentale, in versi: 5 latino, greco, arabo: 3 nasƒ: 11
Termini Imerese: 1 Monumentale, opera edile: 2 giudeo-arabo, latino, greco, arabo: 1
Funeraria: 2
†irz 3
NOBILES OFFICINAE. PERLE, FILIGRANE E TRAME DI SETA DAL PALAZZO REALE DI PALERMO 66
TAVOLA II. Dati desunti dalle iscrizioni arabo-normanne
NISBA TRADUZIONE RUGGERO II RUGGERO II DOCUMENTI CLESSIDRA GRISANTO DEL DˆW◊N
al-mufia÷÷ama / al-mufia÷÷amiyya «il glorioso / il gloriosissimo» • • •
al-mlika / al-mlikiyya «il sovrano / il sovranissimo» • •
al-malakiyya «il regalissimo» • • •
al-ru©griyya «il ruggeriano» • •
al-∞ulylimiyya «il guglielmiano» •
al-filiya «l’alto» • •
al-fialiyya «l’altissimo» • • •
al-saniyya «lo splendido» • •
al-qiddısiyya «il santissimo» • •
al-bahiyya «il magnifico» • •
LE ISCRIZIONI E LE EPIGRAFI IN ARABO: UNA RILETTURA 67
TAVOLA III. Sostantivi ricorrenti nella iscrizioni arabo-normanne: sostantivi
ARABO TRADUZIONE SARRE MELIKIAN- NAVATA NAVATA MANTO DI S. GIACOMO S. MARIA1906 CHIRVANI CENTRALE DESTRA RUGGERO LA MÁZARA DELL’AMMIRAGLIO
1982 CAPP. PAL. CAPP. PAL.
al-ta√ayyud sostegno •al-ta√yıd fortificato • • •al-birr devozione • • •al-baraka grazia • • •al-baraka al-kmila grazia perfetta • •al-baq√ longevità • • • •bulügh al-amnı realizzazione di •
wa-l-ml desideri e speranze al-©gadd buona sorte • • •al-©gall dignità • • al-i©gll onore • • • al-©gaml bellezza • •al-i©gml summa •[?]al-˛if÷ riverente cura •al-˛imya protezione • •al-difiya dichiarazione di fede • • •al-d√im – cfr. duraturo • •
al-fiizz, al-safidal-rifiya[?] sicurezza • • •al-safid fortuna • • • • • •al-safid al-d√im duratura fortuna •al-safid al-q√im cospicua fortuna •al-safida letizia • • • •al-salma integrità • • • • •al-sam˛a munificenza •al-©sukr gratitudine • • •al-©sukr al-kmil gratitudine perfetta •al-©smila – cfr. al-nifima completo • • •al-†awl possanza • • •†ıb al-ayym piacere dei giorni e •
wa-l-layl[ı] / bi-l delle notti senzazawl wa-l ntiql fine né rimozione
al-÷afar trionfo • • • •al-fiizz potere • • • • • •al-fiizz al-d√im potere duraturo • • •al-fiizz al-q√im potere cospicuo •al-fifiya immunità • • •al-∞ib†a felicità • • •al-∞ib†a al-mutawßila felicità incessante •al-if∂l superiorità • • • •al-faƒr gloria • •al-qabül approvazione •al-iqbl fato propizio • • • • •al-q√im – cfr. al-safid, cospicuo • •
al-fiizzal-kifya competenza • • • • •al-kafiyy competente •al-kaml perfezione • • •al-kmil[a] – cfr. perfetto • • • •
al-baraka, al-©sukral-majd splendore • • •al-naßr vittoria • • • • • • •al-nifima favori • • • •[?]al-nifima al-©smila completi favori •infim beneficenza •al-mutawßila – cfr. incessante •
al-∞ib†aal-yumn beatitudine • • • • •


























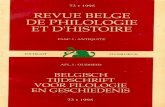







![“Le Monde à son image: le cinéma et le mythe d’Icare [Guest Lecture].”](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633d5f5ad0a2f101870ab50b/le-monde-a-son-image-le-cinema-et-le-mythe-dicare-guest-lecture.jpg)







