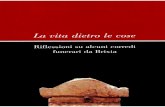G. R. BELLINI- S. L. TRIGONA, Letti funerari in osso da Aquinum, Atti Convegno Römische Gräber...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of G. R. BELLINI- S. L. TRIGONA, Letti funerari in osso da Aquinum, Atti Convegno Römische Gräber...
Römische Gräber augusteischer und tiberischer Zeit
im Westen des ImperiumsAkten der Tagung vom 11. bis 14. November 2010 in Trier
Herausgegeben von Stephan Berke und Torsten Mattern
PHILIPPIKAAltertumswissenschaftliche Abhandlungen
Contributions to the Study of Ancient World Cultures 63
Harrassowitz Verlag
Bis Band 60 : Philippika. Marburger altertumskundliche Abhandlungen
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der
[Bilbliographische Informationen, ISBN etc.]
Inhalt
Michael Rind Vorwort ………………………………………………………………………………… V
Stephan BeRke und toRSten MatteRn Römische Gräber augusteischer und tiberischer Zeit im Westen des Imperiums – Eine Einleitung ………………………………………………………………………… 1
SandRa aMMann und daniel caStella Frühe römische Gräber aus der Schweiz – Beispiele aus unterschiedlichen Regionen … 7
Giovanna Rita Bellini und SiMon luca tRiGona Letti funerari da Aquinum ……………………………………………………………… 35
Stephan BeRke Die römische Nekropole von Haltern …………………………………………………… 58
RoSeMaRie coRdie Augusteische Gräber in Wederath-Belginum …………………………………………… 93
haRRy van enckevoRt und elly n. a. heiRBaut Soldaten und Zivilisten – Frührömische Gräber aus Nijmegen ………………………… 109
Manuel FiedleR Totenbettbeschläge eines frührömischen Grabes in Köln ……………………………… 123
kaRin GoetheRt Die frühen Trierer Nekropolen ………………………………………………………… 146
BiRGit GRoSSkopF Anthropologische Befunde von Brandbestattungen der römischen Nekropole von Haltern, Kreis Recklinghausen …………………………………………………… 162
conStanze höpken und BeRnd lieSen Augusteische und tiberische Gräber in Köln …………………………………………… 178
Giovanna Montevecchi La via sepolcrale di Sarsina e le tombe augusteo-tiberiane della Cispadana …………… 189
WolF-RüdiGeR teeGen Ein bemerkenswerter spätlatènezeitlicher bis frühaugusteischer Grabbefund aus Bibracte …………………………………………………………………………… 217
Letti funerari da Aquinum
Giovanna Rita Bellini e Simon Luca Trigona
Alcuni letti funerari in osso e in osso e bronzo sono stati rinvenuti in tempi recenti ad Aquinum (Italia, Lazio meridionale), la maggior parte in sepolture ad incinerazione, e quindi combusti e frammentari, tranne un esemplare rinvenuto quasi integro all’interno di una tomba a camera e connesso ad un’inumazione femminile: le quattro gambe, ancora in po-sizione verticale, conservavano l’originaria scansione degli elementi decorativi, mentre i fulcra e le sponde giacevano con ordine in posizione di crollo, consentendo una sicura ricomposizione.
Questo fortunato rinvenimento costituisce quindi un momento privilegiato nello stu-dio morfologico e decorativo di una particolare categoria di oggetti legati al rito funebre, nell’ambito di un tema che, nonostante i numerosi e validi studi, presenta ancora grandi in-terrogativi che riguardano sia i modelli culturali ed artistici di riferimento, sia la semantica del complesso apparato decorativo, sia ancora gli aspetti cronologici e il relativo quadro storico-culturale che ha favorito questa “moda” funeraria (fig. 1).
Rinvenuto sul lato di fondo della tomba 6 della necropoli occidentale di Aquinum (Ca-strocielo nel Lazio in provincia di Frosinone), luogo di sepoltura della città italica foederata di Roma, poi del florido e popoloso municipium, infine della colonia triumvirale, il letto in osso rivestito di lamine a foglia d’oro è il reperto più prezioso e significativo restituito dallo scavo: probabilmente commissionato da una famiglia dell’élite aquinate nella seconda metà del I sec. a. C. (forse negli anni tra Cesare e l’avvento del principato augusteo), questo letto non sembra rispondere ad una moda, ma ad un preciso messaggio di appartenenza all’aristocrazia italica e all’antico culto. Le figure femminili alate (aurae o stagioni) e le erme con teste femminili e/o di putti sui cilindri delle gambe, le teste di cigno sulla parte sommitale dei fulcra, le centauresse accovacciate nel campo centrale, le teste maschili di profilo con serto vegetale intorno al collo nei medaglioni, lasciano intuire – in un complesso sincretismo di iconografie e di simboli – il riferimento a culti dionisiaci, orfici, isiaci. Ma soprattutto evocano riti legati alle divinità agresti e all’antico culto di Cerere-Demetra, salvaguardato – con l’imporsi del domino di Roma – come culto gentilizio della gens italica degli Helvii.
I rinvenimenti di Aquinum si inseriscono in un contesto geografico-culturale ben defi-nito, che vede in età tardo-repubblicana e primo-imperiale all’interno delle classi aristocra-tiche centro italiche, ma non solo, l’acquisizione di nuovi modelli funerari ellenistici di cui il letto funebre risulta l’elemento più appariscente. In questo ambito territoriale, che vede una notevole concentrazione di rinvenimenti nel Sannio e nel Lazio meridionale, Aquinum costituisce un nodo viario di primaria importanza, in quanto è uno dei centri urbani situati all’incrocio tra la grande viabilità N-S di collegamento tra Roma e Capua, la via Latina, e i percorsi trasversali che dai passi appenninici mettevano in comunicazione il versante adriatico con quello tirrenico, il mondo pastorale sannitico con i centri urbani a vocazione agricola, commerciale e manifatturiera dell’entroterra e della costa campano-laziale.
Giovanna Rita Bellini – Simon Luca Trigona36
1 Aosta 14 Arna 25 Civitatomassa 37 Collelongo 49 Taranto 61 Cerveteri2 Pollenzo 15 S. Maria 26 Penne (Valle d’Amplero) 50 Modica 62 Marino3 Acqui Terme degli Angeli 27 Pianella 38 Roma 51 Bitia 63 Sezze4 Albenga 16 Spello 28 Bazzano 39 Palestrina 52 Aquileia 64 Calatia5 Mortara 17 Norcia 29 Civita di Bagno 40 Ostia e Acilia 53 Piacenza 65 Capua6 Brescia 18 Maltignano 30 Fossa 41 Mompeo 54 S. Pietro 66 Cuma7 Cremona di Cascia 31 Fagnano Alto 42 Aquinum in Casale 67 Isernia8 Brescello 19 Acquasparta 32 Castelvecchio 43 Ventotene 55 Imola 68 Gubbio9 Modena 20 Orvieto Subequo 44 Boscoreale 56 Riccione 69 Otricoli
10 Cortemaggiore 21 Bolsena 33 Corfinio 45 Pompei 57 Suasa 70 Brindisi11 Volterra 22 Viterbo 34 Aielli 46 Ordona 58 Poggio Picenze 71 Falerii Novi12 Ancona 23 Teramo 35 Venere dei Marsi 47 Canosa 59 Capestrano 72 Monteleone13 S. Vittore di Cingoli 24 S. Vittorino 36 Gioia dei Marsi 48 Monte Sannace 60 Navelli di Spoleto
Fig. 1 Carta di distribuzione dei rinvenimenti di elementi di letti in avorio e osso in Italia (III secolo a. C. – I secolo d. C.). Da Bianchi 2010.
Letti funerari da Aquinum 37
1. Aquinum
Aquinum è situata al centro della valle del Liri in posizione strategica lungo la grande viabilità N-S e le direttrici trasversali sfruttate dalla transumanza, che determinano il coagularsi dell’in-sediamento antropico con il sorgere di due santuari a partire dal VII sec. a. C.1: questa presenza cultuale è connotata da evidenti caratteri emporici, sottolineati dalla posizione geografica del sito in una zona di frontiera tra i territori campani a E, l’area aurunca a S, i territori sanniti a N e quelli volsci a O 2.
I recenti scavi archeologici nell’Area di Servizio Casilina Est hanno consentito di definire cronologicamente la trasformazione in chiave urbana di Aquinum alla fine del IV sec. a. C.3, nell’ottica di un’espansione ed integrazione economico-commerciale campana rivolta ai ter-ritori romanizzati, in stretta correlazione con le coeve fondazioni coloniali di Cales (a. 334), Fregellae (a. 328), Sessa Aurunca (a. 313) e Interamna Lirenas (a. 312), che segnano l’avan-zata romana verso l’Italia Meridionale lungo la valle del Liri.
La favorevole posizione geografica della città in connessione con le abbondanti risorse naturali del suo territorio permette un rapido sviluppo economico di Aquinum sia come centro agricolo che manifatturiero. La città è citata dalle fonti come civitas foederata alla fine del III secolo a. C. in occasione della marcia di Annibale verso Roma 4, come popoloso municipium dopo la guerra sociale (91– 89 a. C.) 5, e infine come colonia in età triumvirale 6. L’importanza della fase triumvirale e augustea ad Aquinum risulta particolarmente evidente a livello archeo-logico e topografico grazie ad una serie di grandi opere infrastrutturali ancora oggi perfetta-mente leggibili sul territorio: l’ampia organizzazione centuriale 7, il rifacimento e la rettifica della Via Latina, e il completamento dell’assetto monumentale urbano 8.
2. La necropoli occidentale
Nell’anno 2009 si è concluso un quinquennio di scavi archeologici condotti in un settore molto particolare del territorio di Aquinum: l’area di servizio denominata Casilina Est dell’autostrada Roma-Napoli, impiantata negli anni ’60 del secolo scorso a ridosso del perimetro urbano, im-mediatamente all’esterno della Porta detta Romana da cui entrava in città la via Latina nel suo percorso verso sud.
Gli scavi hanno documentato contesti funerari significativi databili tra il IV sec. a. C. e il IV sec. d. C., consentendo di acquisire dati fondamentali per la ricostruzione storica delle
1 La nascita e i primi secoli di vita dei santuari aquinati, in particolare del c. d. Capitolium, sono documentati dal rinvenimento di materiali votivi, v. Bellini – Lauria 2009 con bibliografia precedente.
2 Trigona 2012.3 Sulle prime fasi urbane di Aquinum, da mettere in relazione ad un intervento sidicino, v. Bellini – Trigona 2011 a,
489 – 491.4 Liv. 26, 9, 3.5 Cic. Phil. 2, 41.6 Lib. col. 229.7 Per una recente rilettura dell’assetto centuriale del territorio di Aquinum v. Bellini – Trigona – Murro 2012, con
bibliografia precedente.8 Le fonti sottolineano la rilevanza di Aquinum, definita da Strabone (5, 3, 9) μεγάλη πόλις , da Silio Italico (8,
403) ingens e da Cicerone (Phil. 2, 41) frequens municipium. Sulla fiorente produzione manifatturiera di Aquinum, incentrata soprattutto sulla produzione tessile e laniera legata alla sfera economica della transumanza v. Coarelli 1996, 202 – 203 e Gianfrotta 2007 b.
Giovanna Rita Bellini – Simon Luca Trigona38
Fig. 2 L’area urbana di Aquinum, la via latina e la necropoli occidentale.
dinamiche che hanno portato alla strutturazione del territorio ed alla formazione della città prima della colonizzazione nella seconda metà del I sec. a. C. In particolare dagli scavi è tor-nata in luce la necropoli occidentale della città, una vasta area funeraria nel cui ambito sono state evidenziate quattro fasi cronologiche, pur con interferenze e sovrapposizioni nelle tombe familiari monumentali (fig. 2).
Il nucleo più antico è costituito da due tombe che, per i caratteri costruttivi e la tipologia del corredo, possono definirsi sidicine; queste sepolture, rinvenute nel 2009 in corrispondenza dell’angolo sud-ovest dell’Area di servizio, sono strettamente correlate al primo strutturarsi della forma urbana di Aquinum alla fine IV sec. a. C.
Le sepolture della civitas foederata (III – II sec. a. C.), costituite da tombe monumentali a camera e a cassone affiancate da più modeste cappuccine, sono state riportate in luce nelle aree indagate nel 2005, 2007 e 2009, ed occupano sia il settore NO che quello SE dell’area.
Letti funerari da Aquinum 39
Fig.
3
La d
ispo
sizi
one
e la
cro
nolo
gia
dei n
ucle
i fun
erar
i all’
inte
rno
dell’
Are
a di
Ser
vizi
o C
asili
na E
(Ela
bora
zion
e gr
afica
F. P
ittig
lio).
Giovanna Rita Bellini – Simon Luca Trigona40
Le sepolture della colonia (I sec. a. C – inizi I sec. d. C.) si addensano maggiormente a ridos so della via Latina nel settore centro-orientale, come anche quelle di età imperiale (II – III sec. d. C.), maggiormente compromesse dalla prima realizzazione dell’Area di Servi-zio, che costituiscono un tessuto funerario compatto nella parte centrale della stessa.
Un ultimo nucleo con sovrapposizioni databili dal III al IV sec. d. C. è stato rinvenuto infine nella estrema fascia orientale (fig. 3) 9.
2. 1 Le sepolture della civitas foederataIl settore della necropoli occidentale di Aquinum relativo al nucleo sepolcrale di III – I sec. a. C. (Area 2) è stato indagato nel 2005 su un’area di ca. 800 mq, che ha consentito di definirne solo parzialmente l’estensione con l’individuazione dei suoi limiti settentrionale e meridionale: le 74 tombe rinvenute, tutte ad inumazione (ad esclusione della coppia di incinerazioni della tomba 6), sono fosse terragne, cappuccine, cassoni, oltre a quattro sepolture monumentali in blocchi di travertino a camera ipogea o a cassone, una sepoltura infantile in coppo ed una fossa comune. Le successive attività di studio e di restauro hanno portato alla conoscenza a tutto campo della popolazione del centro italico in un arco cronologico compreso tra le guerre annibaliche e la deduzione della colonia triumvirale10.
Gli inumati, sepolti individualmente (pochi i casi di tombe bisome o plurime, un solo caso di fossa comune con 13 individui), erano tutti accompagnati dal corredo, costituito prevalente-mente da balsamari di varie forme e dimensioni, strigili in ferro, specchi in bronzo, lucerne, pedine in pasta vitrea, pesi fittili, monete, ceramica a vernice nera e comune.
2. 2 La tomba 6
All’interno dell’Area 2 spicca per rilevanza monumentale e per i corredi rinvenuti la tomba 6, una delle più antiche di questo settore della necropoli di cui sembra costituire il fulcro. Si tratta di un sepolcro a camera semi-ipogea costituito da un ambiente quadrato in blocchi squadrati di travertino locale, con ingresso sigillato da grandi lastre nello stesso materiale e piano pavimen-tale in terra battuta. Questa tomba familiare è l’unica in uso con continuità dal momento della sua costruzione (fine III – inizi II sec. a. C.) fino all’ultima testimonianza di frequentazione nella prima età augustea, con la deposizione in quattro momenti distinti di ben 13 individui.
Il primo gruppo (5 inumati) intorno alla metà del II sec. a. C. viene ridotto e rideposto con gli oggetti di corredo (specchio, una coppia di balsamari e quattro astragali) in una fossa rettangolare scavata in corrispondenza dell’ingresso. Nella camera vengono quindi deposti, nell’arco del II secolo, forse fino alla metà del secolo seguente, altri 6 individui con un ricco corredo, costituito da 28 balsamari e una coppia di strigili.
Dopo la metà del I secolo a. C. si collocano le uniche due incinerazioni di questo settore fu-nerario. All’esterno della camera sepolcrale viene scavata la fossa dell’ustrinum, al cui interno si allestisce la catasta di legna per la pira funebre, spenta con aspersione dei liquidi delle liba-gioni. I resti combusti insieme a un balsamario piriforme vennero raccolti in una coppia di olle collocate nell’angolo SO della camera. Seguì poi un periodo di abbandono, documentato dallo strato biancastro carbonatico formatosi dalla reazione chimica dell’acqua e degli altri liquidi a
9 Per l’area indagata nel 2005 (Area 2) da cui provengono 74 sepolture, v. Bellini 2007 e Trigona 2007; per le 22 sepolture rinvenute tra 2006 e 2007 (Aree 4 –5), v. Bellini – Trigona 2010, 475 – 477, mentre per le indagini del 2009 (Area 8), in cui sono state documentate 144 tombe, v. Bellini – Trigona 2011 a.
10 In particolare sulle analisi antropologiche v. Vargiu et al. 2009.
Letti funerari da Aquinum 41
Fig. 4 Planimetria delle deposizioni all’interno della Tomba 6 (rilievo G. Foglia).
contatto con la cenere, e dalla essiccazione e fessurazione dello stesso strato con formazione di mud cracks superficiali.
Negli ultimi anni del I secolo a. C. è probabile che si sia anche avviato il processo delle riduzioni dei resti e quindi delle rideposizioni nell’angolo sud ovest della camera sepolcrale. È questo il periodo in cui presumibilmente viene introdotto il letto funerario, cui sembra fosse associato un banchetto, e forse anche il cofanetto per oggetti di toletta, al quale sono pertinenti altri elementi in osso e un medaglione con volto femminile di profilo11.
In questa fase la tomba fu preparata per l’ultima sepoltura, quella dell’individuo di sesso femminile rinvenuto sul letto funerario; l’inumata, probabilmente coperta da una ricca veste
11 Pracchia – Carcieri 2008, 51–52.
Giovanna Rita Bellini – Simon Luca Trigona42
intessuta d’oro (ipotizzata per la presenza di filamenti d’oro), era accompagnata da un cor-redo inquadrabile cronologicamente nell’ambito della prima età imperiale (una lucerna di età augusteo-tiberiana, 6 balsamari piriformi, una moneta augustea, un bastoncino in vetro a tor-ciglione e un coltellino in ferro). Tracce di un grande fuoco nell’area esterna a livello superfi-ciale sono forse da collegare ai riti funebri di quest’ultima deposizione (fig. 4)12.
3. Il letto funerario della tomba 6: emblematico messaggio di appartenenza sociale e religiosa
Il letto in osso rivestito di lamine a foglia d’oro, attualmente esposto al Museo Archeologico Nazionale di Cassino, è il reperto più prezioso e significativo restituito dallo scavo della necro-poli: rinvenuto sul lato di fondo della tomba 6, con le gambe ancora infisse nel piano pavi-mentale e il rivestimento del telaio e dei fulcra in giacitura di crollo (fig. 5), richiama, nella struttura slanciata e nella decorazione ad altorilievo dei cilindri delle gambe e a bassorilievo dei fulcra, i letti in osso derivati da modelli in avorio, mentre il telaio sottile evoca le forme dei modelli in bronzo (fig. 6)13. Il letto, realizzato su un materiale più povero dell’avorio dei modelli di riferimento (ma forse dal forte valore simbolico), era tuttavia impreziosito dal rive-stimento in lamina d’oro, in quanto tracce di doratura a foglia sono state trovate sulla capiglia-tura, sui panneggi di una veste e su di un’ala14.
Fig. 5 Particolare della deposizione del letto funerario all’interno della Tomba 6.Foto M. Letizia.
12 Bellini 2008 e Trigona 2008.13 Per il letto in osso della tomba 6 v. anche Bellini 2008; Pracchia – Carcieri 2008 e Carcieri – Montanelli 2008.14 Carcieri – Montanelli 2008.
Letti funerari da Aquinum 43
Fig. 6 Il letto funerario della Tomba 6. Foto E. Montanelli.
15 Per il motivo vegetale v. Talamo 1987–1988, 32 –33 (A. 2 a e A. 2 c e A. 4 a e A. 4 c) con confronti.16 Il disco o toro con baccellature è presente in questa serie di letti funerari in osso e, in particolare, nel letto di
Cambridge (Nicholls 1979, n. A 5), anche se la ricostruzione proposta per questo esemplare trasla l’elemento discoidale verso il basso, al disotto del disco figurato, v. Letta 1984, 85.
17 Confronti puntuali per i personaggi femminili del cilindro figurato di Aquinum si ritrovano in alcune figure interpretate come Ninfe provenienti dalla decorazione delle gambe di un letto funerario di Ostia, v. Talamo 1987–1988, 80, fig. 108.
18 La presenza di erme femminili sul retro del cilindro con figura panneggiata si riscontra in uno dei letti di Vindo-nissa, mentre erme maschili con funzione analoga provengono da rinvenimenti ostiensi, v. Letta 1984, 86 (Tipo 1. d).
19 Questo particolare tipo di acconciatura è presente nei personaggi bacchici dei cilindri e nelle figure femminili dei medaglioni dei fulcra, v. Letta 1984, 89; per un confronto abbastanza puntuale v. la figura di un putto perti-nente alla decorazione della gamba di un letto in osso da Cremona databile alla fine del I sec. a. C., in Bianchi 2000, Tav. 2 (A. C. 35) e Bianchi 2008, 319, fig. 1.7.
Le gambe erano costituite da una struttura lignea con anima in ferro, e decorate da elementi in osso modulari ( Fig. 7 ); l’articolazione degli elementi delle gambe, la cui scansione è da ritenersi certa dato l’eccezionale stato di conservazione al momento del rinvenimento, è costi-tuita dal basso verso l’alto da: puntale troncoconico ( A.1 ), campana con decorazione a foglie lanceolate bipartite ( A. 2 )15, rocchetto di separazione ( A. 3 ), cilindro figurato ad alto rilievo ( A. 4 ), coppia di rocchetti separati da anello liscio ( A. 5 – A.7 ), disco con baccellature radiali ( A. 8 )16, cilindro liscio ( A. 9 ) e capitello a calice ( A.10 ).
L’elemento centrale della decorazione della gamba è costituito dal cilindro figurato ( A. 4 ) che rappresenta sulla fronte una figura femminile alata, con leggero chitone la cui aderenza svela le gambe; presenta una pettinatura a cercine intorno alla fronte17, con la sinistra sorregge una cornucopia mentre con la destra un lembo del panneggio del mantello; il retro è campito da erme con teste infantili o femminili18, caratterizzate da un’elaborata acconciatura con nodo di capelli a fiocco o crocchia al disopra della fronte19.
Giovanna Rita Bellini – Simon Luca Trigona44
Il telaio presenta nella parte cen-trale elementi torici lisci 20, affiancati ai lati da riquadri con cornice moda-nata campita da listelli traforati che ri-chiamano, semplificandole, le cornici decorate con ricchi motivi floreali ri-tagliati a giorno e sovrapplicati del letto di Cambridge 21.
I quattro fulcra, realizzati con la-strine a basso rilievo accostate, pre-sentano: sul medaglione un busto ma-schile di profilo caratterizzato da una corona vegetale stilizzata intorno al collo 22; nel campo centrale una centau-ressa accovacciata, con pisside nella mano destra ed oggetto globulare nella sinistra ripiegata al disopra del capo; nel culmine un uccello acquatico che sembra scostare con il becco un lembo del sipario per svelare le scene sotto-stanti (fig. 8) 23.
20 Lo spessore limitato del telaio dato dall’al-tezza degli elementi tubolari (4, 6 cm) av-vicina il letto di Aquino all’esemplare di Amplero, in cui compaiono come rivesti-mento del telaio elementi torici analoghi, v. Letta 1984, 78 ( B. 2 ).
21 Nicholls 1979, 7 ( B. 4 ) e Letta 1984, 86.22 Il confronto più stringente per questo ele-
mento è il medaglione del letto di Cam-bridge con soggetto analogo (Nicholls 1979, 8 – 9, C.1), mentre medaglioni decorati da busti femminili di prospetto con grandi corone di corimbi intorno al collo sono ampiamente documentati in ambito cen-tro italico, v. d’Ercole – Copersino 2003, 314 –315 e Caravale 1994, 52 –54 con bi-bliografia.
23 Sull’interpretazione del culmine del fulcrum e, in particolare, per l’oggetto tratte-nuto dal becco dell’uccello v. Ghedini 2008 e Bellini 2008, in cui è avanzata l’ipotesi suggestiva che possa trattarsi del fagotto contenente i resti smembrati di Osiride; un preciso confronto per questa raffigurazione proviene da un letto funerario di Fréjus da-tabile tra fine I a. C e inizi I d. C., v. Béraud – Gébara 1986, 196 –197 e Bianchi 2010, 55. In generale sui culmina con uccello acqua-tico v. Faust 1989, 91– 93.
Fig. 7 Particolare della scansione della gamba del letto della Tomba 6.
Foto E. Montanelli.
Letti funerari da Aquinum 45
Fig. 8 Particolare del fulcrum del letto della Tomba 6. Foto E. Montanelli.
La sintassi costruttiva e decorativa inserisce il letto di Aquinum all’interno della prima serie del Letta (1986) e trova il più immediato confronto nell’esemplare di Cambridge (datato tra il 30 e il 20 a. C.), rispetto al quale è possibile, su dati certi, presentare una rilettura della scansione degli elementi delle gambe; confronti puntuali per quanto riguarda alcuni elementi figurati si ritrovano inoltre in esemplari frammentari da Ostia, da Cremona e da Frejus (fine I a. C. – inizi I d. C.).
Per lo stile rigido e semplificato dei motivi decorativi questo manufatto sembra rientrare, come è stato proposto per il letto di Cambridge, all’interno di una produzione centro-italica, chiaramente distinguibile a livello formale dagli esemplari tipologicamente affini ma contrad-distinti da una sintassi compositiva più elaborata di chiara e diretta ispirazione ellenistica 24.
Nella stessa direzione interpretativa conduce anche l’apparato iconografico che non sembra rispondere ad una moda d’importazione, ma ad un preciso messaggio di appartenenza dell’ari-stocrazia italica all’antico substrato cultuale preromano. Se riferimenti dionisiaci si possono ri-scontrare nella rappresentazione delle figure femminili alate (aurae o stagioni) con cornucopie, nelle erme con teste femminili o di putti sui cilindri delle gambe, e nelle teste maschili di
24 Talamo 1987–1988, 82 – 83.
Giovanna Rita Bellini – Simon Luca Trigona46
profilo con serto vegetale intorno al collo nei medaglioni, uno specifico richiamo ad un antico culto autoctono legato alla sfera della fecondità sembra riscontrabile invece nel motivo della centauressa che campeggia al centro dei fulcra, la quale potrebbe essere letta, in associazione alle figure femminili alate con cornucopia, come rappresentazione della dea Marica, divinità venerata in area aurunca e in particolare nel santuario alla foce del Garigliano 25. Questa parti-colare raffigurazione infatti risulta un hapax nell’iconografia dei letti funerari che può spiegare la modesta resa stilistica del soggetto, richiesto dalla committenza ma non presente nei modelli a disposizione dell’artigiano, che è stato costretto quindi ad improvvisare inserendo la centau-ressa nel campo centrale del fulcrum senza riferimenti a schemi codificati.
4. Le sepolture di età augustea
Le indagini effettuate nell’anno 2009 hanno portato in luce un lungo tratto della via Latina con le sepolture che su di essa si affacciavano o gravitavano. Lo scavo ha evidenziato infatti la complessa scansione stratigrafica attribuibile alle varie fasi di età antica della strada, e in particolare all’impianto di età augustea rappresentato da un importante ed articolato momento costruttivo, con fasi di risarcimento successive e tracciati sottostanti preesistenti 26. In connes-sione topografica è stato possibile documentare inoltre le tipologie sepolcrali ed i riti funerari della necropoli della Aquinum romana, sviluppatasi sui due lati della via Latina nel suo tratto immediatamente extraurbano.
Alla fase di fine I a. C. – I sec. d. C., sul lato nord della via Latina, è pertinente un recinto funerario che racchiude due sepolture: un bustum con cassone in muratura (T. 11), tagliato da un cassone con doppia copertura (T. 10), e una inumazione infantile in cassone (T. 70) addossata alla parete interna S, con spallette costituite da una coppia di blocchi monolitici di travertino sovrapposti e piano di deposizione formato da due tegole, datata ante quem non da una moneta in bronzo di Caligola (36 –38 d. C., fig. 9).
A questo si aggiungono più ad E il basamento in cementizio pertinente ad un monumento funerario a torre o a dado e una sepoltura a cassone (T. 71). Sul lato S della via è stato rin-venuto inoltre un grande ustrinum con al centro un’incinerazione in olla (T. 100), e quattro sepolture monumentali a camera e a cassone (TT. 50, 74, 76 e 78) databili tra la fine del IV e il II sec. a. C., le più recenti delle quali (TT. 50 e 78) riutilizzate tra la tarda età repubblicana e la prima età augustea per nuove sepolture a incinerazione.
4.1 Il recinto funerario
Nell’angolo NO dell’area di scavo, a ridosso della crepidine settentrionale della via Latina è stato parzialmente messo in luce un recinto funerario quadrangolare con orientamento solidale all’asse viario, rasato appena sopra lo spiccato dell’alzato, che conserva traccia, almeno sul
25 Sull’associazione di Marica ad una divinità ippomorfa v. Compatangelo-Soussignan 1999, 30, con bibliografia precedente. Una stretta connessione tra Aquinum e l’area aurunca è comunque probabile data la contiguità territoriale assicurata dalla direttrice fluviale del Liri-Garigliano. Una forte componente aurunca ad Aquinum sembra ipotizzabile al momento della fondazione della città contemporanea o di poco precedente alla definitiva disfatta inflitta dai romani, che ha comportato l’annientamento dell’ethnos aurunco e la probabile delocaliz-zazione coatta nelle città di nuova fondazione. Per il contesto storico-topografico v. Bellini – Trigona 2011 a, 489 – 491, con bibliografia precedente.
26 Sulla scansione e l’interpretazione stratigrafica del tratto extraurbano della via Latina indagato all’interno dell’Area di Servizio Casilina E nel 2009, v. Bellini – Trigona 2011 a, 480 – 482.
Letti funerari da Aquinum 47
Fig.
9
Plan
imet
ria e
ass
onom
etria
del
reci
nto
fune
rario
(Tom
be 1
0, 1
1 e
70, r
iliev
o F.
Pitt
iglio
).
Giovanna Rita Bellini – Simon Luca Trigona48
lato esterno, di un paramento in opera reticolata o quasi reticolata realizzato con cubilia di travertino. Il lato occidentale di questa struttura risulta asportato da una grande fossa riempita da pietrame calcareo di grandi e medie dimensioni, cubilia e frammenti fittili, in parte prove-nienti dalla demolizione del recinto, tra cui un coperchio di urna cineraria ad omphalos con iscrizione OSSA e decorazione vegetale a tralci di edera a basso rilievo, che trova numerosi confronti in ambiti funerari del Lazio meridionale databili tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale 27.
La T. 11, conservata nella sola porzione NO, è in fase con il recinto funerario; si tratta di una sepoltura del tipo bustum sepulcrum, in cui al disopra della fossa di cremazione, simile per tipologia ad altri esempi rinvenuti nell’area, venne realizzato un cassone in muratura, che de-limita e monumentalizza l’ustrinum all’interno del recinto. A contatto con le ceneri e i carboni del rogo funebre sono stati individuati numerosi chiodi in ferro di grandi dimensioni (n. 17), in parte conficcati presso i bordi e i margini del cassone, la cui presenza lascia ipotizzare una struttura lignea (cassa o feretro). Il corredo, i cui elementi combusti sono stati recuperati dal flottaggio dei livelli di ceneri e carboni, era costituito da 3 dadi in osso, da grumi fusi di pasta vitrea policroma in bianco e nero, da un fuso o cavicchio in ferro ripiegato 28 e da un cofanetto al cui rivestimento (nell’ipotesi ricostruttiva proposta) sono attribuibili tre placchette qua-drangolari in osso montate su sottile lamina bronzea, con serratura centrale in bronzo e sottili piedini con modanatura alla base.
Tra i resti combusti si sono rinvenuti 11 chiodi di medie e piccole dimensioni in bronzo, un applique in terracotta e tracce di legno rivestito da sottile lamina in bronzo che potrebbero essere ricollegati alla presenza di un letto funerario. Altri frammenti in osso pertinenti proba-bilmente allo stesso letto sono stati rinvenuti all’interno del riempimento della limitrofa T. 10, una tomba a cassone con copertura alla cappuccina che taglia il recinto funerario e la T. 11 ed è, come quest’ultimi, a sua volta tagliata e sconvolta da un pozzetto moderno 29. All’interno del cassone sono stati infatti rinvenuti frammenti di una grande olla cineraria con coperchio e 28 elementi in osso lavorato combusti, tra cui spicca un frammento probabilmente pertinente ad un medaglione con figura femminile di profilo, associati ad un balsamario piriforme (fram-mentario) e ad un anellino in bronzo a verga semplice.
4. 2 L’ustrinumIl grande ustrinum a S della via Latina, in uso tra la fine del I sec. a. C. e il I sec. d. C, era costituito da una fossa quadrangolare con pareti concotte, parzialmente scavata nel travertino sub-affiorante. Numerosi elementi in osso pertinenti ad un letto funerario, insieme a frammenti
27 Sull’ampia diffusione di questa tipologia di cinerari nel Lazio meridionale v. Diebner 1983; esempi di coperchi a pigna con decorazioni a tralci vegetali provengono dalle vicine località di Broccostella e S. Giovanni Incarico, v. Bellini 1988, 266 e Rizzello 1995, 53 con bibliografia.
28 Tre elementi in ferro analoghi, interpretati come cavicchi di connessione delle strutture lignee della barella o del feretro, provengono insieme a frammenti di due letti funerari da un ustrinum scoperto ad Acquasparta, v. Mo-nacchi – Frenguelli 1994, 104, mentre un identico numero di oggetti identificati come fusi sono stati rinvenuti in connessione con la tomba a incinerazione n. 4 della necropoli di Fossa, v. d’Ercole – Copersino 2003, 27.
29 La T. 10 presenta una struttura articolata costituita da un cassone in muratura sigillato da un doppio livello di copertura in tegole; al disopra gli spioventi della cappuccina sono realizzati con spezzoni di tegole e lastre frammentarie in marmo bianco, disposti in maniera poco ordinata e cementati da una malta friabile beige ricca di carboni, mentre al disotto troviamo due piani di tegole sovrapposti intercalati da una gettata di calce, poggiati sul cassone sottostante realizzato in blocchetti regolari di travertino e tegole.
Letti funerari da Aquinum 49
di balsamari e di strigili erano già presenti nei livelli di riempimento che sigillavano la parte centrale della fossa, dove è stata rinvenuta l’olla cineraria relativa all’ultimo utilizzo funebre dell’ustrinum. L’olla (T. 100), con coperchio sigillato da calce, era collocata in un piccolo pozzetto e conteneva le ossa combuste di un individuo adulto di sesso maschile; al suo interno l’assenza di ceneri, sostituite esclusivamente dal limo-argilloso di infiltrazione, lascia supporre un’accurata selezione e il lavaggio rituale dei resti antropologici.
Lo scavo ha evidenziato le accurate azioni del rituale funerario che seguirono la collo-cazione dell’olla nel pozzetto, con la disposizione di scapoli di travertino con funzione di sostegno ai lati del contenitore e successivamente l’accumulo intorno all’olla delle ceneri e dei carboni prelevati dal rogo funebre. Insieme a questi, inoltre, sono stati rinvenuti numerosi elementi in bronzo (piastre rettangolari e placchette circolari) e in osso pertinenti ad un letto funerario, tra cui spiccano le corolle sagomate riferibili alla modanatura delle gambe, alcuni elementi del fulcrum e una coppia di medaglioni figurati con volti umani. Numerosi sono anche i chiodi semplici e ad anello, in molti casi ripiegati, che lasciano supporre la presenza sulla pira di una struttura in legno a supporto del letto funebre, probabilmente il feretrum su cui erano stati trasportati il letto e il defunto. All’interno dello stesso strato sono stati rinvenuti inoltre alcuni elementi del corredo costituiti da una coppia di strigili frammentari in ferro e da cinque balsamari apodi piriformi, anch’essi frammentari. La gettata circolare a contenimento dell’incinerazione, costituita essenzialmente da scapoli di travertino con evidenti tracce di esposizione al rogo, e l’olla frantumata rinvenuta a contatto con quest’ultimo livello, testimo-niano la conclusione del rituale di deposizione (fig. 10).
Fig. 10 Particolare della Tomba 100 all’interno dell’ustrinum. Foto S. L. Trigona
Giovanna Rita Bellini – Simon Luca Trigona50
4. 3 Il letto funerario della Tomba 11All’interno del cassone che conteneva il bustum sepulcrum sono stati rinvenuti alcuni elementi che lasciano supporre la presenza di un letto funerario, costituiti da labili tracce di legno rivestito da sot-tile lamina in bronzo, 11 chiodi di medie e piccole dimensioni anch’essi in bronzo e una probabile applique in terracotta, in associazione a numerosi frammenti ed elementi in osso relativi ad un cofanetto.
Altri 28 elementi in osso frammentari e combusti sono stati rinvenuti inoltre all’interno del riempimento della T. 10, i quali potrebbero essere riferibili al letto precedente, date la stretta relazione stratigrafica tra le due sepolture e le ca-ratteristiche costruttive della sepoltura in esame che sembra potersi inserire in un ambito cronologico più recente. L’inserzione della T. 10 all’interno del recinto funerario infatti asporta l’intero lato lungo meridionale della T. 11, men-tre lo scasso per la realizzazione di un
pozzetto moderno comporta una seconda pesante lacuna stratigrafica nella porzione NE di entrambe le sepolture, che può aver comportato un trascinamento di parte del corredo dalla tomba precedente alla successiva.
Gli elementi in osso conservati sono costituiti da un frammento di un medaglione con fi-gura femminile di profilo pertinente al fulcrum, da un cilindro liscio con base sottolineata da listello (h. 2, 2, diam. 2 cm ca.) ed un elemento sagomato pertinente ad uno dei tamburi riferi-bili alle gambe e, infine, da numerose sottili fascette di rivestimento a listello liscio con super-ficie fittamente incisa a linee parallele (h. 1,8 cm) e da un frammento di cornice a bastoncello semicircolare strigilata riconducibili al telaio, che trovano immediati confronti da un letto di Vindonissa e dal letto dell’Esquilino (fig. 11) 30.
4. 4 Il letto funerario della tomba 100Il letto rinvenuto all’interno dell’ustrinum, o meglio del bustum sepulcrum, è rappresentato da circa 500 elementi e frammenti riferibili a tutte le sezioni del letto funebre, il che rende possibile un’ipotesi ricostruttiva in linea di massima abbastanza dettagliata che avvicina l’esemplare in esame alla tipologia dei letti imitanti modelli bronzei.
Gambe. A questa sezione, la cui scansione per la frammentarietà dei singoli elementi e la com-plessità interpretativa è allo stato di semplice ipotesi ricostruttiva basata essenzialmente sull’esemplare di Amplero 31, sono riferibili (fig. 12):
Fig. 11 Elementi in osso pertinenti al letto funerario della Tomba 11. Foto E. Montanelli.
30 Talamo 1987–1988, 58 – 60, fig. 70 (B 3 –5) e 80, fig. 115 (in basso a sinistra); Letta 1984, 98, n. 43.31 Letta 1984, 76 –78.
Letti funerari da Aquinum 51
Fig. 12 Ipotesi ricostruttiva della gamba del letto funebre della Tomba 100. Disegno S. L. Trigona.
Giovanna Rita Bellini – Simon Luca Trigona52
A.1. Puntale troncoconico con base modanata.
A. 2 e A. 3. N. 92 placchette trapezoidali lisce, il cui numero elevato lascia supporre il loro utilizzo in almeno due porzioni della gamba, ipoteticamente nella campana che sovrasta il puntale e, immediatamente al disopra, nella base del tamburo liscio.
A.4. N. 70 placchette quadrangolari lisce (dimensioni largh. 2, alt. 2, 2 / 2, 6 cm) con ogni pro-babilità di rivestimento del tamburo A. 3–A. 5;
A.5. N. 52 placchette trapezoidali a doppio listello, il cui numero può ipotizzare il loro utilizzo a chiusura del tamburo liscio (ca. 13 elementi per singola modanatura).
A.6. N. 6 placchette trapezoidali lisce con sagomatura per incastro sulla base inferiore, perti-nenti forse ad un elemento tronco piramidale di raccordo.
A.7. N. 20 placchette trapezoidali a singolo listello posizionabili alla base del cilindro figurato.
A.8. Cilindro figurato, di cui non si sono conservati elementi figurati significativi.
A.9. N. 23 placchette trapezoidali a singolo listello, collocabili a chiusura del cilindro figurato.
A.10 e A.11. N. 16 e N. 20 placchette trapezoidali riferibili all’elemento di chiusura superiore della gamba (c. d. “capitello a calice svasato”).
Telaio. A questa sezione sono pertinenti una ventina di piastre e di frammenti di piastre qua-drangolari in bronzo (dimensioni 12 × 5 cm) con piccoli fori angolari per chiodini di fissaggio, anch’essi in bronzo con calotta emisferica, e ben 139 lastrine in osso lisce alte 1, 2 /1, 8 cm, alcune con lati brevi tagliati a 45°; le piastre in bronzo costituivano quindi una fascia continua incorniciata su tutti i lati da una cornice liscia in osso (fig. 13).
Fulcra. A questa sezione sono pertinenti alcuni frammenti dei medaglioni e numerose lastrine sagomate frammentarie (n. 22) che costituivano la cornice del settore centrale e defi-niscono chiaramente la tipologia del letto, appartenente alla serie che imita i modelli bronzei. Il medaglione, realizzato in tre elementi distinti e sovrapposti, rappresenta una testa probabilmente femminile con alta acconciatura montata su due elementi semilunati che completano sui lati la resa ad altorilievo del volto, mentre il profondo incavo oculare presuppone l’inserzione di paste vitree (fig. 14) 32.
4. 5 I letti di Aquinum
Il gruppo dei letti in osso della necropoli occidentale di Aquinum, a cui si aggiunge il vecchio rinvenimento della necropoli settentrionale 33, costituisce l’insieme numericamente più rile-vante rinvenuto nel territorio del Latium Vetus e del Latium Adiectum, ove sono conosciuti esclusivamente rinvenimenti isolati, assegnabili ad un arco cronologico compreso tra il II sec. a. C. e l’età augustea o, al più, giulio-claudia.
Il complesso dei rinvenimenti può essere riferito – sulla base del luogo di rinvenimento – a due grandi areali: il Lazio costiero e il Lazio interno. Gli scavi archeologici, per lo più legati alla realizzazione di opere pubbliche, hanno infatti restituito reperti singoli da necropoli sia dalla fascia costiera o prossima alla costa (Roma, Acilia, Palestrina, Marino), sia dal territorio più interno e montano (Aquinum, Sezze e Leonessa). Ad essi si aggiungono i numerosi elementi
32 Questo elemento del fulcrum può essere associato al tipo 5 del Letta (1984, 90) e trova un confronto stilistico in ambito laziale con il letto di Marino, cfr. Ghini 2008.
33 Per gli elementi in osso combusti relativi ad un quarto letto, oggetto di vecchi rinvenimenti fortuiti, v. Giannetti 1975 e Nicosia 2006, 67– 69.
Letti funerari da Aquinum 53
Fig. 13 Porzione del rivestimento in osso e bronzo del telaio del letto funebre della Tomba 100. Foto S. L. Trigona.
34 v. Gianfrotta 1986 a e Diana 2008.35 Ghini 2008.36 Pellegrino 2008.37 Cassieri 2008.38 Il letto ligneo di Leonessa presenta decorazioni in terracotta derivate da modelli bronzei, costituite da due
medaglioni con teste maschili di prospetto e due protomi equine pertinenti ai fulcra, v. Giummarra 2008.
(ben 322) provenienti dal relitto delle “Grottelle” di Ventotene, recuperati nel 1983, importante testimonianza di commercio o comunque di trasporto di questi manufatti 34.
Le modalità di rinvenimento (il relitto di Ventotene) o il predominante rito dell’incinera-zione (per cui il defunto era posto sul rogo e cremato insieme al letto funebre) rendono spesso difficile la ricostruzione, oltre che del letto, anche degli schemi decorativi; un esempio signi-ficativo risulta a questo proposito l’esemplare di Marino 35, rinvenuto nel 1990, ove con diffi-coltà tra i frammenti interamente combusti e deformati si riescono ad individuare due volti, alcune zampe caprine, due piedi e frammenti di ali.
Le iconografie dei singoli elementi tuttavia riconducono ancora al mondo dionisiaco, con scene di thiasos in cui campeggiano nereidi, menadi, satiri, eroti e volti maschili barbati, pur con la presenza di nuovi temi come le corazze per il letto di Sezze o i trofei del cilindro del letto della tomba 137 di Acilia 36, la cui raffinatezza ha fatto ipotizzare, come per il letto dell’Esqui-lino, una produzione di origine alessandrina 37. Un unicum risulta ad oggi il letto di Leonessa (il solo pertinente ad inumazione) che trova confronti in area umbra, campana e cisalpina 38.
Nel panorama archeologico della tarda età repubblicana e della prima età imperiale Aquinum emerge quindi tra le città dell’area campano-laziale proprio per la concentrazione all’in-terno delle necropoli extraurbane di questo particolare oggetto, il letto con rivestimento in osso,
Giovanna Rita Bellini – Simon Luca Trigona54
39 Diebner 1982, 72 –74.40 Per la produzione artistica locale, essenzialmente legata alle esigenze funerarie, Bellini – Trigona 2011 b.
elemento privilegiato del cor-redo che accompagna alcuni personaggi dell’elite urbana in tutte le fasi del rituale fune-raio, dall’esposizione all’interno del la domus fino al momento cul minante della sepoltura (in-cinerazione sul rogo funebre, o inumazione all’interno della camera funeraria).
Anche per i letti di Aquinum non è facile, pur in presenza di manufatti acquisiti nell’ambito di scavo archeologico e non attraverso rinvenimenti fortu-iti, arrivare alla definizione di attribuzioni cronologiche pre-cise. La ricezione in ambito locale di una nuova cultura fu-neraria, che vede simultanea-
mente all’acquisizione del letto funerario l’ampia diffusione nei ceti meno abbienti di una par-ticolare tipologia di cinerari con terminazione ad omphalos 39, si connette evidentemente con la fase di grande trasformazione legata al periodo triumvirale, e in particolare alla deduzione coloniale. Ma se i letti combusti della tomba 11 e della tomba 100 della necropoli occidentale e il letto combusto della necropoli settentrionale sembrano rimandare – pur nella loro frammen-tarietà – al quadro di adeguamento ai modelli culturali ellenistici recepiti dai vertici dell’elite romana, il letto della tomba 6 – sia per la volontà di conservazione dei simboli che per l’ado-zione del rituale dell’inumazione – si pone come emblematico prodotto di arte italica e come espressione di conservatorismo politico-religioso da parte dell’elite municipale autoctona 40.
Deutsches Resümee
Vor wenigen Jahren sind in Aquinum (Südlatium) einige beinerne (bzw. aus Bronze und Bein gefertigte) Totenbetten gefunden worden. Der größte Teil davon stammt aus Gräbern mit Brandbestattungen; eine Ausnahme bildet das fast komplett erhaltene Exemplar aus einem Kammergrab (Grab 6); es ist einer weiblichen Toten zuzuschreiben. Die vier Beine dieses Bettes standen bei der Auffindung noch in vertikaler Position, und die dekorativen Elemente waren äußerst gut erhalten; auch die fulcra und das Bettgestell ließen sich aufgrund ihrer guten Konservierung rekonstruieren.
Dieser Zufallsfund stellt einen Glücksfall für das Studium der Formen und der Dekoratio-nen dieser speziellen Gattung von Gegenständen des Totenkultes dar. Trotz zahlreicher wich-tiger Untersuchungen sind in diesem Bereich noch viele Fragen offen, einerseits im Hinblick auf die kulturellen wie die künstlerischen Vorbilder, andererseits bezüglich der Interpretation
Fig. 14 Particolare del medaglione del letto funebre della Tomba 100. Foto E. Montanelli.
Letti funerari da Aquinum 55
der komplexen Dekorationen. Auch der Aspekt der zeitlichen Einordnung und das damit ver-bundene Problem des kulturhistorischen Umfeldes, das diese ‚Mode‘ im Bestattungswesen begünstigt hat, verdienen eine nähere Betrachtung.
Die Funde aus Aquinum lassen sich in einen fest umrissenen kulturgeographischen Kontext einordnen: In der spätrepublikanischen und der frühkaiserzeitlichen Epoche werden innerhalb der zentralitalischen Adelsschichten – und nicht nur bei diesen – hellenistische Bestattungs-modelle übernommen, deren herausragendstes Element das Totenbett ist. Diese Übernahme einer neuen Grabkultur auf lokaler Ebene läßt sich ganz offensichtlich mit den bedeutenden Umwälzungen während der Epoche des Triumvirats in Verbindung bringen, insbesondere mit den Koloniegründungen. Während jedoch die Elemente der Totenbetten aus den Brandgräbern anscheinend die Anpassung an Vorbilder aus dem Umfeld der stadtrömischen Elite widerspie-geln, bezeugt das Exemplar aus Grab 6, einerseits aufgrund der Beibehaltung der Symbolik, andererseits wegen der Bestattungsart, seine Zuordnung zum italischen Kultur- und Kunst-kreis; darüber hinaus ist es Ausdruck eines politisch-religiösen Konservatismus der autoch-thonen Elite der Landstädte.
Bibliografia
Bellini 1988 G. R. Bellini, Monumenti funerari della Valle di Comino, in: Ar-cheologia Laziale 9. Nono Incontro di Studio del Comitato per l’Archeologia Laziale, Roma dal 27 al 29 novembre 1987 (Qua-derni del Centro di Studio per l’Archeologia Etrusco-Italica 16, Roma 1988) 261– 269.
Bellini 2007 G. R. Bellini, La necropoli occidentale di Aquinum, in: G. Ghini (ed.), Lazio e Sabina 4. Quarto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina. Atti del Convegno, Roma 29 –31 maggio 2006 (Lavori e Studi della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 4, Roma 2007) 245 – 250.
Bellini 2008 G. R. Bellini, Un nuovo rinvenimento da Aquinum: il letto in osso della tomba 6, in: Sapelli Ragni 2008, 39 – 48.
Bellini – Lauria 2009 G. R. Bellini – M. Lauria, Materiali arcaici da uno scarico votivo presso Aquinum. Contesto, tipologia ed elementi cultu(r)ali, in: G. Ghini (ed.), Lazio e Sabina 5. Quinto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina. Atti del Convegno, Roma, 3 –5 dicembre 2007 (Lavori e Studi della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 5, Roma 2009) 263 – 273.
Bellini – Trigona 2010 G. R. Bellini – S. L. Trigona, L’ager di Aquinum. L’attività di ricerca e tutela nel 2007 e 2008, in: G. Ghini (ed.), Lazio e Sabina 6. Sesto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina. Atti del Conve-gno, Roma 4 – 6 marzo 2009 (Lavori e Studi della Soprintenden-za per i Beni Archeologici del Lazio 6, Roma 2010) 475 – 479.
Bellini – Trigona 2011 a G. R. Bellini – S. L. Trigona, La necropoli occidentale di Aqui-num: IV sec. a. C. – IV sec. d. C., in: G. Ghini (ed.), Lazio e Sabina 7. Settimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina. Atti del Convegno, Roma 9 –11 marzo 2010 (Lavori e Studi della So-printendenza per i Beni Archeologici del Lazio 7, Roma 2011) 479 – 492.
Giovanna Rita Bellini – Simon Luca Trigona56
Bellini – Trigona 2011 b G. R. Bellini – S. L. Trigona, Un’ara funeraria con maschere tra-giche dai pressi della chiesa di San Tommaso sulla via Latina fuo-ri porta San Lorenzo, Fasti Online Documents & Research. The Journal of Fasti Online, www.fastionline.org/docs/FOLDER-it- 2011-222.pdf.
Bellini – Trigona – Murro 2012 G. R. Bellini – S. L. Trigona – G. Murro, L’ager di Aquinum: la centuriazione, in: G. Ghini – Z. Mari (eds.), Lazio e Sabina 8. Otta-vo Incontro di Studi sul Lazio e Sabina. Atti del Convegno, Roma 30 –31 marzo, 1 aprile 2011 (Lavori e Studi della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 8, Roma 2012) 573 –581.
Béraud – Gébara 1986 I. Béraud – Ch. Gébara, Les lits funéraires de la nécropole gallo-romaine de Saint-Lambert (Fréjus), RANarb 19, 1986, 183 – 210.
Bianchi 2000 C. Bianchi, I letti funerari in osso dalla necropoli di S. Lorenzo, Cremona in età romana (Milano 2000).
Bianchi 2008 C. Bianchi, Letti funerari in osso di età romana: aspetti della pro-duzione e diffusione alla luce di alcuni rinvenimenti in Lombar-dia. Presentazione preliminare di un letto da Cerveteri (Roma), in: I. Bertrand (ed.), Le travail de l’os, du bois de cerf et de la corne à l’époque romaine: un artisanat en marge?, Monographies Instrumentum 34 (Montagnac 2008) 311– 334.
Bianchi 2010 C. Bianchi, I letti con rivestimento in osso e avorio: analisi dei rinvenimenti dai contesti di abitato e funerari, Lanx. Rivi-sta elettronica della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Milano 5, 2010, 39 – 106.
Caravale 1994 A. Caravale, Museo Nazionale Romano VI 1. Avori ed ossi (Roma 1994).
Carcieri – Montanelli 2008 M. Carcieri – E. Montanelli, Tracce di lavorazione sugli elementi in osso della tomba 6 di Aquinum. Dal contesto alla ricostruzio-ne, in: Sapelli Ragni 2008, 75 – 80.
Cassieri 2008 N. Cassieri, Un letto funerario con decorazioni in osso. Sezze (Latina), in: Sapelli Ragni 2008, 102 – 103.
Coarelli 1996 M. Coarelli, Fregellae, Arpinum, Aquinum: lana e fullonicae nel Lazio meridionale, in: M. Cébeillac-Gervasoni (ed), Les élites municipales de l’Italie péninsulaire des Gracques à Néron. Actes de la table-ronde de Clermont-Ferrand 28 –30 novembre 1991, Collection de l’EFR 215 (Collection Centre Jean Bérard 13, Na-poli – Roma 1996) 199 – 205.
Compatangelo-Soussignan 1999 R. Compatangelo-Soussignan, Sur les routes d’Hannibal. Paysa-ges de Campanie et d’Apulie (Paris 1999).
d’Ercole – Copersino 2003 V. d’Ercole – M. R. Copersino, La necropoli di Fossa IV. L’età ellenistico-romana (Pescara 2003).
Diana 2008 V. Diana, Decorazioni di klinai, in: Sapelli Ragni 2008, 104 – 105.Diebner 1983 S. Diebner, Un gruppo di cinerari romani nel Lazio meridionale,
DialA ser. 3, 5/1, 1983, 65 –78.Faust 1989 S. Faust, Fulcra. Figürlicher und ornamentaler Schmuck an anti-
ken Betten, RM Ergh. 30 (1989).Ghedini 2008 E. F. Ghedini, I letti in avorio e osso: tipologia e apparato deco-
rativo, in Sapelli Ragni 2008, 15–25.Ghini 2008 G. Ghini, Letto in osso da Marino, in: Sapelli Ragni 2008,
106 – 107.
Letti funerari da Aquinum 57
Gianfrotta 2007 a P. A. Gianfrotta, Rinvenimenti archeologici sottomarini, in: G. Guidotti (ed.), Le Isole Pontine attraverso i tempi (Roma 2007) 213 –222.
Gianfrotta 2007 b P. A. Gianfrotta, I vasetti di Rullius, di Caesius e la porpora di Aquinum, in: Spigolature Aquinati (c. s., v. Ceraudo 2007) 49 – 58.
Giannetti 1975 A. Giannetti, Suppellettile sepolcrale e votiva proveniente dall’agro di Aquinum (contrade S. Pietro Vetere e Mèfete), Rend Linc 8, 30 (1975) 211– 222.
Giummarra 2008 E. Giummarra, Leonessa. Tomba in località Valle Fana (Rieti), in: Sapelli Ragni 2008, 110 – 111.
Letta 1984 C. Letta, Due letti funerari in osso dal centro italico – romano della valle d’Amplero (Abruzzo), MonAnt 52 Ser. Misc. III 3, 1984, 67– 114.
Monacchi – Frenguelli 1994 D. Monacchi – G. Frenguelli, Acquasparta (Terni). Loc. Croci-fisso. Scavo di un’area funeraria romana nel territorio carsulano con rinvenimento di letti in osso, NSc ser. 9, 1/2 (1990 – 1991) 87– 149.
Nicholls 1979 R. V. Nicholls, A Roman Couch in Cambridge, Archaeologia 106 (Jan. 1979) 1– 31.
Nicosia 2006 A. Nicosia, Museo della città e del territorio. Aquino (Roma 2006).
Pellegrino 2008 A. Pellegrino, Frammenti di decorazione di tre letti funerari. Ne-cropoli Acilia (Roma), in: Sapelli Ragni 2008, 108 – 109.
Pracchia – Carcieri 2008 S. Pracchia – M. Carcieri, Elementi in osso dalla tomba 6 della necropoli di Aquinum. Dal contesto alla ricostruzione, in: Sapelli Ragni 2008, 49 – 58.
Rizzello 1995 M. Rizzello, Nuovi reperti romani della Ciociaria meridionale (Broccostella, Sora, Pontecorvo, Castrocielo), Terra dei Volsci, Miscellanea 1, 1995, 49 – 61.
Sapelli Ragni 2008 M. Sapelli Ragni (a cura di), Tra luce e tenebre. Letti funerari in osso da Lazio e Abruzzo. Cat. della mostra Tivoli, Villa Adriana, Antiquarium del Canopo, 24 aprile – 2 novembre 2008 (Milano 2008).
Talamo 1987–1988 E. Talamo, Un letto funerario da una tomba dell’Esquilino, BCom 92, 1987/88, 17–102.
Trigona 2007 S. L. Trigona, La necropoli occidentale di Aquinum. I corredi, in Lazio e Sabina 4 (c. s., v. Bellini 2007) 251– 256.
Trigona 2008 S. L. Trigona, La necropoli occidentale di Aquinum. La tomba 6. I corredi, in: Sapelli Ragni 2008, 98 – 99.
Trigona 2012 S. L. Trigona, L’ager di Aquinum: l’area funeraria arcaica in loc. Campo Cavaliere, in: Lazio e Sabina 8 (c. s., v. Bellini – Trigo-na – Murro 2012) 561–572.
Vargiu et al. 2009 R. Vargiu et alii, Condizioni di vita e stato di salute della comu-nità di Aquinum (Castrocielo, Frosinone), in: Lazio e Sabina 5. Quinto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina. Atti del Convegno, Roma, 3 –5 dicembre 2007 (Lavori e Studi della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 5, Roma 2009) 475 – 481.