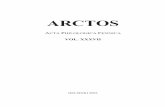Il culto di Mithra ad Ostia nelle fonti epigrafiche: un riesame di CIL, XIV 58 e 59 dal Mitreo del...
Transcript of Il culto di Mithra ad Ostia nelle fonti epigrafiche: un riesame di CIL, XIV 58 e 59 dal Mitreo del...
IL CULTO DI MITHRA AD OSTIA NELLE FONTI EPIGRAFICHE 419
SMSR 79 (2/2013) 419-439
RAFFAELLA MARCHESINI
Il culto di Mithra ad Ostia nelle fonti epigrafiche Un riesame di CIL, XIV 58 e 59 dal Mitreo del cd. Palazzo Imperiale*
Il culto di Mithra nella colonia romana di Ostia ha da sempre susci-tato grande interesse in virtù della larga diffusione dei luoghi di culto, distribuiti in tutti i quartieri della città, e dell�importanza del materiale epigrafico e scultoreo rinvenuto1. Fu soprattutto grazie ai grandi scavi di G. Calza degli anni Trenta-Quaranta del secolo scorso che la maggior parte degli edifici mitriaci sono stati riportati alla luce2 e nell�immediato dopoguerra G. Becatti dedicò il secondo volume della serie degli Scavi di Ostia a questi particolari luoghi di culto3. In questo lavoro lo studioso dall�analisi dei luoghi di culto e delle testimonianze materiali evidenziò una cronologia delle attestazioni concentrata tra gli anni Sessanta del II sec. d.C. e la seconda metà del III sec. d.C. È necessario tuttavia pun-tualizzare come nella maggior parte dei casi queste datazioni si basino soltanto su elementi indiziari, i quali, anche se certamente non trascu-rabili, rimangono piuttosto incerti. Poco affidabile del resto è l�analisi delle murature, soggetta a larghe oscillazioni cronologiche e spesso non supportata dall�evidenza di bolli laterizi. Ugualmente poco determinante è l�analisi stilistica del materiale scultoreo: nella quasi totalità dei casi si tratta di produzioni locali di modelli iconografici comuni e diffusi in tutto l�Impero nel corso della metà del II sec. d.C. con esempi anche nel III sec. d.C.
* I miei più sinceri ringraziamenti vanno ai professori M.L. Caldelli, F. Zevi, S. Panciera e F. Van Haeperen per i preziosi consigli. Ringrazio inoltre il Dott. G. Filippi e la Dott.ssa C. Valeri, che hanno reso possibile i miei sopralluoghi ai Musei Vaticani, e la Dott.ssa P. Germoni della Soprintendenza di Ostia.
1 Ad oggi si contano ben quattordici mitrei certi, a cui se ne potrebbero aggiungere due di cui si ha notizia dagli scavi di inizi Ottocento, per i quali non è da escludersi la possibile identità con quelli già individuati: si tratta del Mitreo Fagan e del Mitreo Petrini, testimoniati da rinvenimenti scultorei ed epigrafici di notevole interesse, che si conservano ai Musei Vaticani. Di altri due è dubbia l�effettiva pertinenza al culto mitriaco: si tratta del Sacello delle Tre Navate e del cd. Sabazeo; la tipologia architettonica richiama quella tipica dei mitrei anche se nessun elemento archeologico rinvenuto è determinante per l�attribuzione del culto al dio Mithra. Non si esclude comunque l�esistenza di altri mitrei in quanto solo i due terzi della città all�interno delle mura sono stati indagati.
2 G. Becatti et al. (eds.), Scavi di Ostia I. Topografia generale, Libreria dello Stato, Roma 1953.
3 G. Becatti (ed.), Scavi di Ostia II. I mitrei, Libreria dello Stato, Roma 1954.
07.TS Marchesini.indd 419 26/11/2013 17.29.14
420 RAFFAELLA MARCHESINI
Nonostante l�opera di Becatti rimanga ancora oggi punto di riferi-mento fondamentale sull�argomento, è necessario sottolineare come que-sta sia il prodotto della strategia di scavo che ha guidato gli archeologi fino al secondo dopoguerra, la quale si limitava alla messa in evidenza di una fase più o meno omogenea e coeva delle strutture, che per i mi-trei era rappresentata soprattutto dall�uso del mosaico per la decorazione degli elementi architettonici interni, come i podi e le pavimentazioni. La mancanza di ulteriori indagini al di sotto di tali facies note ha limitato per oltre mezzo secolo la conoscenza e la comprensione di questi particola-ri ambienti di culto, condizionandone gli studi successivi. Se da un lato si auspicano nuove indagini archeologiche, dall�altro si rende necessaria una revisione dell�intero patrimonio archeologico mitriaco ostiense, lo studio del quale è rimasto anch�esso pressoché fermo agli anni Cinquan-ta/Sessanta del secolo scorso.
Nell�ultimo decennio la definizione della categoria cumontiana dei «culti orientali» è stata messa in discussione alla luce di un nuovo ap-proccio che privilegia le modalità di integrazione e aggregazione di que-sti culti stranieri, propriamente sacra peregrina, nelle comunità romane valutandone le conseguenze sul sistema religioso esistente4. Su questa base si è ritenuto opportuno riesaminare il materiale relativo a tali cul-ti e di conseguenza si è impostata l�indagine che segue, con particolare attenzione all�analisi del materiale epigrafico ostiense. La revisione del documento epigrafico risulta in questo caso utile sia per una migliore conoscenza degli attori del culto e del loro ruolo all�interno dell�organiz-zazione cultuale e cittadina, sia per una sua ricontestualizzazione topo-grafica e cronologica.
In particolare, il caso che vorrei presentare in questa sede riguarda una coppia di piccole basi di statua di Cautes e Cautopates, pubblicate rispettivamente in CIL, XIV 58 e 59. Le basi con le relative statue sono state rinvenute durante gli scavi condotti negli anni Sessanta dell�Otto-cento da Carlo Ludovico Visconti nel Mitreo del cd. Palazzo Imperiale5,
4 Cfr. W. Van Andringa - F. Van Haeperen, Le Romain et l�étranger: formes d�intégration des cultes étrangers dans les cités de l�Empire romain, in C. Bonnet - V. Pirenne-Delforge - D. Praet (eds.), Les religions orientales dans le monde romain: cent ans après Cumont (1906-2006), Bilan historique et historiographique; Colloque de Rome, 16-18 novembre 2006, Bru-xelles-Rome 2009, Belgisch Historisch Instituut te Rome, Brussel - Rome 2009, pp. 23-42; J. Rüpke - C. Bonnet - P. Scarpi (eds.), Religions orientales, culti misterici: neue Perspektiven � nouvelles perspectives � prospettive nuove, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2006; l�introduzione alla riedizione dell�opera di F. Cumont, Les religions orientales dans le paganism romain, C. Bonnet - F. Van Haeperen (eds.), con la collaborazione di B. Toune, Torino 2006.
5 Lo scavo fu pubblicato da C.L. Visconti, Del mitreo annesso alle terme ostiensi di An-tonino Pio, in «Annali dell�Istituto di corrispondenza archeologica» 6 (1864), pp. 147-183. Ugualmente ne diede breve notizia P.E. Visconti, in «Atti della Pontificia Accademia romana di archeologia» 15 (1864), pp. CXXXVI-CXXXVIII. Prima di approdare alla fondamentale opera di G. Becatti, I mitrei, cit., del 1954 (il Mitreo del cd. Palazzo Imperiale alle pp. 53-57) il Mitreo
07.TS Marchesini.indd 420 26/11/2013 17.29.14
IL CULTO DI MITHRA AD OSTIA NELLE FONTI EPIGRAFICHE 421
probabilmente nelle absidi dei podi6, dei quali attualmente non riman-gono tracce. Il mitreo, che occupa un ambiente rettangolare ad ovest del complesso edilizio da cui prende il nome, sorge in un quartiere lungo via della Foce al di fuori dell�attuale area scavata, nei pressi del Tevere. L�ambiente è adiacente alla palestra delle terme che si sono impiantate nell�area centrale all�epoca di Antonino Pio, tra il 140 e il 150 d.C.7 [fig. 1], ed è pavimentato a mosaico con fondo bianco incorniciato da fasce nere e con iscrizione duplicata lungo i podi con la dedica di L. Agrius Calendio, CIL, XIV 568 [figg. 2-3]. Sul fondo del mitreo si trova l�edicola a gradini al centro della quale è collocato l�altare in marmo cipollino con iscrizione, CIL, XIV 57, posto da C. Caelius Hermeros, ancora oggi in situ9 [fig. 4]. Gli scavi ottocenteschi hanno inoltre messo in luce una serie di materiali scultorei e ceramici che si conservano nei Musei Vaticani nel settore ostiense del Museo Gregoriano Profano10.
ed il materiale rinvenuto trovarono pubblicazione nell�opera di F. Cumont, Textes et Monu-ments figurés relatifs aux Mystères de Mithra, H. Lamertin, Bruxelles 1896-1899, vol. 1, pp. 116, 240-243 (di seguito abbreviato in MMM) e di L. Paschetto, Ostia colonia romana. Storia e monumenti, Tipografia poliglotta Vaticana, Roma 1912, pp. 389-394, i quali hanno ripreso sostanzialmente le considerazioni esposte da Visconti.
6 C.L. Visconti, Del mitreo annesso alle terme ostiensi, cit., p. 161. Ugualmente in P.E. Vi-sconti, op. cit., p. CXXXVII, anche se a p. CXXXVIII le ritiene rinvenute presso l�edicola di culto.
7 L. Paschetto, Ostia colonia romana, cit., pp. 546-559. L�impianto termale è stato datato grazie ai bolli laterizi (cfr. G. Becatti et al. [eds.], I mitrei, cit., pp. 225-226) e sulla base della fistula acquaria con il bollo di MATIDIAE AUG. F. (CIL, XV 7737 = CIL, XIV 1978 + 2005), identificata con Vibia Matidia, cognata di Adriano (cfr. anche Becatti, I mitrei, cit., p. 57, e in ultimo J.M. Spurza, The building history of the Palazzo Imperiale at Ostia: evolution of an in-sula on the banks of the Tiber river, in «Mededeelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome» 58 (1999), pp. 133-134.
8 Soli Invict(o) Mit(hrae) d(ono) d(edit) L(ucius) Agrius Calendio. Cfr. C.L. Visconti, Del mitreo annesso alle terme ostiensi, cit., p. 158; MMM, vol. 2, p. 116 nr. 131 e pp. 240-243 nr. 83; L. Paschetto, Ostia colonia romana, cit., p. 390; G. Becatti, I mitrei, cit., p. 54; M.J. Ver-maseren, Corpus inscriptionum et monumentorum religionis mithriacae, Martinus Nijhoff, The Hague 1956-1960, vol. I, n. 251 (di seguito abbreviato in CIMRM); G. Becatti, Scavi di Ostia IV. Mosaici e pavimenti marmorei, Libreria dello Stato, Roma 1961, p. 167 n. 309; M. Floria-ni Squarciapino, I culti orientali a Ostia (�Etudes préliminaires aux religions orientales dans l�Empire romain�, 3), Brill, Leiden 1962, p. 45; R. Meiggs, Roman Ostia, Clarendon Press, Oxford 19732, p. 374 nota 3.
9 C(aius) Caelius Hermaeros (!), / antistes huius loci, / fecit / `sua pec(unia)´. C.L. Vi-sconti, Del mitreo annesso alle terme ostiensi, cit., p. 160; MMM, vol. 2, p. 116 n. 132 (p. 242 n. 83g); L. Paschetto, Ostia colonia romana, cit., p. 391; G. Becatti, I mitrei, cit., p. 54; CIMRM, vol. 1, n. 259; M. Floriani Squarciapino, I culti orientali a Ostia, cit., p. 45; R. Meiggs, Roman Ostia, cit., p. 374 nota 3.
10 Si tratta di una testa marmorea in marmo greco di Mithra o dadoforo del I sec. d.C. rilavorata nella seconda metà del II (cfr. O. Benndorf - R. Schoene, Die antiken Bildwerke des lateranensischen Museums, Breitkopf, Leipzig 1867, p. 383 n. 547; G. Becatti, I mitrei, cit., p. 56, tav. 32.3; CIMRM, vol. 1, n. 257 a; M. Xagorari Gleißner, in F. Sinn (ed.), Vatikanische Mu-seen, Museo Gregoriano Profano ex Lateranense. Katalog der Skulpturen. Reliefgeschmückte Gattungen römischer Lebenskultur. Griechische Originalskulptur. Monumente orientalischer Kulte, vol. 3, Reichert Verlag, Wiesbaden 2006, n. 189); una testa marmorea di Helios-Mithra o di dadoforo in marmo bianco, datata inizialmente negli anni 180-190 d.C. (cfr. O. Benn-
07.TS Marchesini.indd 421 26/11/2013 17.29.15
422 RAFFAELLA MARCHESINI
Attualmente le due basi CIL, XIV 58 e 59 con le relative statue si tro-vano anch�esse conservate nei Musei Vaticani dove ho avuto la possibilità di esaminarle. L�autopsia ha evidenziato tracce di una loro precedente fase di utilizzo ed in particolar modo ha consentito di stabilire che il testo delle iscrizioni sulla fronte è stato inciso su erasione precedente. Questa scoperta ha posto nuovi interrogativi per quanto riguarda la cronologia delle basi stesse e di conseguenza dell�impianto del mitreo.
1. 58 (= 4201 b) [figg. 5-8]: basetta in marmo bianco, rotta nell�angolo superiore destro. La base ha zoccolo e coronamento modanati con cornice a listello e gola su tre lati. La fronte è liscia e reca al centro l�immagine a rilievo di Cautes; l�iscrizione corre al di sotto della figura su un piano leggermente ribassato e lavorato a gradina fine. Il retro è costituito da accenni di una modanatura inferiore che è stata lavorata a gradina, come a gradina è l�intera superficie, della quale è stata rispar-miata soltanto una piccola fascia liscia lungo i margini destro e sinistro che incornicia il tutto; rottura lungo il margine superiore sinistro. Il fianco destro presenta, come già accennato, una rottura che coinvolge l�angolo superiore della modanatura superiore e parte del margine del corpo cen-trale della base, costituito lungo i margini superiore, inferiore e sinistro da una piccola fascia piatta che incornicia la superficie lavorata a gradina e decorata al centro da una patera. Il fianco sinistro presenta una rottura dell�angolo superiore del coronamento modanato; la fascia piatta a bor-dura del corpo centrale si presenta lungo i margini superiore, inferiore e destro; la superficie è lavorata a gradina con urceus al centro; nella metà inferiore del corpo centrale è incisa un�iscrizione. La superficie superiore della base presenta un incavo centrale per facilitare l�alloggiamento della
dorf - R. Schoene, Die antiken Bildwerke, cit., p. 383 n. 548; G. Becatti, I mitrei, cit., p. 56, tav. 32.1-2; CIMRM, vol. 1, n. 257 b), recentemente non oltre il secondo quarto del III d.C (cfr. Ch. Vorster [ed.], Vatikanische Museen, Museo Gregoriano Profano ex Lateranense. Katalog der Skulpturen. Römische Skulpturen des späten Hellenismus und der Kaiserzeit. Werke nach Vorlagen und Bildformel hellenistischer Zeit sowie die Skulpturen in den Magazinen, vol. 2.2: Reichert, Wiesbaden 2004, n. 62); una statua marmorea di Cautopates degli inizi III d.C. (cfr. O. Benndorf - R. Schoene, Die antiken Bildwerke, cit., p. 399 n. 586; G. Becatti, I mitrei, cit., p. 55, tav. 37.2; CIMRM, vol. 1, n. 256; M. Xagorari Gleißner, Vatikanische Museen, cit., n. 182); altri frammenti scultorei e architettonici in marmo che sappiamo essere confluiti nell�antica Collezione Lateranense e che sono attualmente da re-identificare (cfr. CIMRM, vol. 1, nn. 258, 260, 261). Per quanto riguarda però i materiali ceramici si tratta per lo più di lucerne tardoanti-che (cfr. CIMRM, vol. 1, n. 262.2); da sottolineare il ritrovamento di una lucerna a dodici becchi con bollo di Annio Serapiodoro di II-III d.C (CIL, XV 6295 = CIMRM, I, nr. 262, 2), confluita nella collezione Lateranense, attualmente irreperibile. Erroneamente il Visconti leggeva Serapiodo-ri Inny (C.L.Visconti, Del mitreo annesso alle terme ostiensi, cit., p. 158). Sulla produzione tipicamente ostiense di queste lucerne a soggetto isiaco cfr. C. Pavolini - M.A. Tomei, Iside e Serapide nel Palazzo. Lucerne isiache dalla Domus Tiberiana, in L. Ball et al. (eds.), Rome Pa-pers: The Baths of Trajan Decius, Iside e Serapide nel Palazzo, a Late Domus on the Palatine, and Nero�s Golden House, s.n., Ann Arbor 1994, pp. 106, 121 e da ultimo anche J.-L. Podvin, Luminaire et cultes isiaques, M. Mergoil, Montagnac 2010, p. 264.
07.TS Marchesini.indd 422 26/11/2013 17.29.15
IL CULTO DI MITHRA AD OSTIA NELLE FONTI EPIGRAFICHE 423
statua marmorea raffigurante Cautes in ambiente roccioso. La testa è rotta alla base del collo e il volto presenta diverse fratture a livello del naso, della bocca, del mento; rotta la fiaccola che tiene tra le mani, mancante della fiamma che vi era inserita grazie ad un piccolo puntello. All�epoca del rinvenimento si apprezzavano ampie tracce di doratura, ora perdu-te. La superficie inferiore della base presenta una leggera rastremazio-ne troncoconica, verosimilmente creata per facilitarne l�incasso entro un piano di appoggio. La base misura 44,6 x 23,5 x 18,3 cm; la statua 43,3 x 16,5 x 11,5 cm; lo specchio epigrafico 33,5 x 21 cm. Le lettere dell�iscri-zione sulla fronte misurano 1,4-2,5 cm; quelle dell�iscrizione sul fianco sinistro 1-1,8 cm.
Statua e base sono state rinvenute nel mitreo del cd. Palazzo Impe-riale nel 1858-59. Attualmente si conservano nei Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, settore di Ostia, in vetrina. Inv. 10741 a-b. Esame autoptico 201111.
In fronte:
C(aius) Caelius(H)ermeros ant=istes huius lo=
ci fecit sua5 pec(unia).
Sul lato sinistro:
Posit(a)e XV k(alendas) Febr(u)arias Q(uinto) Iunio Rus= tico,5 L(ucio) co(n)s(ulibus).
Il testo sulla fronte non ha rivelato difformità di lettura rispetto alle precedenti, mentre è stato appurato che questo testo è inciso in litura.
11 C.L. Visconti, Del mitreo annesso alle terme ostiensi, cit., p. 161-163, fig. LM, 2; P.E. Visconti, op. cit., p. CXXXVIII; O. Benndorf - R. Schöne, Die antiken Bildwerke, cit., pp. 359-360 n. 502; MMM, vol. 2, p. 116 n. 133 (p. 243 n. 83 k, fig. 74); L. Paschetto, Ostia colonia romana, cit., p. 392 e nota 3, fig. 118.; G. Becatti, I mitrei, cit., p. 54, tav. XXXV, 2; CIMRM, vol. 1, pp. 126-127 nn. 254, 255; M. Floriani Squarciapino, I culti orientali a Ostia, cit., p. 45; R. Meiggs, Roman Ostia, cit., p. 374 nota 3; R. Vollkommer, s.v. �Mithras�, in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, vol. 6, Zürich-München 1992, p. 615 n. 500, con fig., p. 619 n. 607 con fig.; M. Xagorari Gleißner, Vatikanische Museen, cit., vol. 3, pp. 303-305 n. 180, tav. 104, 1-4.
07.TS Marchesini.indd 423 26/11/2013 17.29.15
424 RAFFAELLA MARCHESINI
Piccole correzioni di trascrizione hanno coinvolto il testo inciso sul lato sinistro, dove a r. 1 sembra doversi leggere posit(a)e al posto di positi. A r. 5 sembra leggersi per intero il nome Plautio in luogo di Plaut[io], anche se più incerta è la lettura della lettera O, che sarebbe stata incisa in picco-lo sulla fascia piatta lungo il margine del corpo della base. Così a r. 6 di Aquilino, anziché Aquilin[o] con la O incisa a carattere più piccolo sulla fascia piatta lavorata lungo il margine del corpo della base. A r. 7 è stato possibile riconoscere il tratto della S di co(n)s(ulibus) (precedentemente co[(n)s(ulibus)]).
2. 59 (= 4201 a) [figg. 9-13]: basetta in marmo bianco, con zoccolo e coronamento modanati su tre lati eccetto il retro. Rotta è la modanatura superiore del lato sinistro. La fronte è liscia e reca al centro l�immagine a rilievo di Cautopates. Al di sotto il piano è stato ribassato e reca incisa l�iscrizione. Le superfici laterali e quella del retro sono la-vorate a gradina con una fascia piatta lungo i bordi. Al centro delle facce laterali sono scolpiti un urceus, a sinistra, ed una patera, a destra. La metà superiore del fianco destro, dal bordo fino alla patera, presenta una lavorazione a scalpello con lo scopo di eliminare una precedente iscrizio-ne (sembrano riconoscersi, seppur dubitativamente, tracce di lettere). La superficie superiore della base presenta un incavo centrale per facilitare l�alloggiamento della statuetta marmorea raffigurante Cautopates, stan-te, in ambiente roccioso. La testa è rotta alla base del collo; mancano l�avambraccio destro e parte della fiaccola che tiene tra le mani. Come per CIL, XIV 58, all�epoca del rinvenimento si apprezzavano ampie tracce di doratura, ora perdute. La superficie inferiore presenta una leggera ra-stremazione troncoconica, verosimilmente creata per facilitarne l�incasso entro un piano di appoggio. La base misura 45,5 x 23,3 x 17,5 cm; la statua 42 x 17 x 11,5 cm; lo specchio epigrafico 32 x 20 cm. Le lettere misurano 1,2-2 cm.
Statua e base sono state rinvenute, insieme alle gemelle donate a Cau-tes (CIL, XIV 58), nel mitreo del cd. Palazzo Imperiale nel 1858-59. At-tualmente si conservano nei Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, settore di Ostia, in vetrina. Inv. 10744 a-b. Esame autoptico 201112.
12 C.L. Visconti, Del mitreo annesso alle terme ostiensi, cit., p. 162, fig. LM, 1; P.E. Vi-sconti, op. cit., p. CXXXVIII; O. Benndorf - R. Schöne, Die antiken Bildwerke, cit., pp. 360-361 n. 504; MMM, vol. 2, p. 116 n. 133 (p. 243 n. 83 k, fig. 72); L. Paschetto, Ostia colonia romana, cit., p. 392 e nota 3, fig. 118.; G. Becatti, I mitrei, cit., p. 54, tav. XXXV, 1; CIMRM, vol. 1, pp. 126-127 nn. 254, 255; M. Floriani Squarciapino, I culti orientali a Ostia, cit., p. 45; R. Meiggs, Roman Ostia, cit., p. 374 nota 3; R. Vollkommer, s.v. �Mithras�, cit., p. 615 n. 500, con fig., p. 616 n. 529 con fig.; M. Xagorari Gleißner, Vatikanische Museen, cit., vol. 3, pp. 305-306 n. 181, tav. 105, 1-4.
07.TS Marchesini.indd 424 26/11/2013 17.29.15
IL CULTO DI MITHRA AD OSTIA NELLE FONTI EPIGRAFICHE 425
C(aius) Caelius(H)ermeros ant=istes huius lo=
ci fecit sua5 pec(unia).
Il testo sulla fronte non ha rivelato differenze rispetto alla lettura tra-dizionale, mentre, come per l�iscrizione precedente CIL, XIV 58, si è nota-to come sia stato inciso in litura. A r. 1 la S finale di Caelius è nana.
Entrambi i documenti epigrafici CIL, XIV 58 e 59 presentano sulle rispettive fronti il medesimo testo inciso. Questo occupa la parte inferiore dello specchio epigrafico e presenta un ductus non perfettamente regolare con calcolo degli spazi piuttosto impreciso, come si può notare soprattut-to in CIL, XIV 59 alle rr. 1 e 4. Le lettere sono bene incise, di forma qua-drata, con apicature dai tratti sinuosi, e presentano una rubricatura frutto di moderni restauri. Alla r. 1 il testo si interrompe al centro per seguire l�andamento del panneggio dei mantelli di Cautes e Cautopates scolpiti a rilievo e raffigurati in posizione stante, appoggiati su una roccia, vestiti all�orientale con la fiaccola accesa tra le mani rivolta rispettivamente ver-so l�alto e verso il basso.
Il testo ricorda un intervento a proprie spese da parte di C. Caelius Hermeros, in qualità di antistes huius loci. L�oggetto dell�intervento non è menzionato ma sembra chiaramente da riferirsi al posizionamento delle due basi con statue. Nonostante il personaggio non indichi la sua condi-zione giuridica, il cognome grecanico potrebbe suggerire trattarsi di un liberto o di un discendente di liberti.13 Ciò che invece si è premurato di specificare è l�indicazione del suo ruolo al momento della dedica, antistes huius loci.
Il termine antistes, raramente attestato, si trova documentato in epi-grafia a partire dal II sec. d.C. in rapporto ad iscrizioni pagane relative al culto di divinità straniere, specialmente Mithra14. Le attestazioni del
13 Il gentilizio Caelius è piuttosto diffuso a Roma e nel Latium vetus, compresa Ostia, nella maggioranza dei casi in connessione con il prenome Caius (cfr. CIL, VI, Pars VI, Fasc. I, Index nominum, ed. M. Bang, Berolini 1926 [1974], pp. 42). Cfr. W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Weidmann, Berlin 1933 (ed. orig. 1904), p. 561, anche se i gentilizi derivati dai nomi di luoghi non sono ordinari. Il cognome Hermeros, di origine greca, è attesta-to soprattutto tra personaggi di bassa estrazione sociale, schiavi e liberti. L�analisi onomastica intrapresa da Solin per la città di Roma, particolarmente favorevole per la quantità del materiale disponibile e per la vicinanza con la realtà ostiense, ha permesso di notare che quasi la metà delle testimonianze raccolte si riferiscono a schiavi e liberti, seppur altrettante a personaggi con status giuridico incerto. H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom, de Gruyter, Berlin 2003, pp. 55-56.
14 E. Forcellini (G. Furlanetto, ed.), s.v. �Antistes�, in Lexicon Totius Latinitatis, vol. 1, Lipsiae - Londini 1839 (ed. orig. 1771), p. 192: «Antistes, qui ante alios stat, qui aliis praeest, et imperat. [...] Frequentissimae dicitur de iis, qui sacris praesunt, et in templis sacrificia, alios-
07.TS Marchesini.indd 425 26/11/2013 17.29.15
426 RAFFAELLA MARCHESINI
termine presenti nelle fonti letterarie sono scarse, concentrandosi tra l�età tardo Repubblicana e Augustea15: in queste il termine è utilizzato come sinonimo di sacerdote o sommo sacerdote. Etimologicamente antistes è costituito dall�unione di ante e sto, letteralmente «stare davanti», da cui in senso lato «essere superiore», «eccellere», ed è probabilmente con que-sta accezione che è venuto ad indicare il più importante dei sacerdoti. In ambito mitriaco antistes è stato utilizzato come sinonimo di sacerdos16.
Merito di F. Mitthof è stato quello di aprire un dibattito sulla questio-ne17. Analizzando l�occorrenza dei termini utilizzati nelle testimonianze epigrafiche relative al culto di Mithra egli ha notato che in alcuni testi sa-cerdos e antistes vengono utilizzati contemporaneamente in riferimento ad uno stesso personaggio, mostrando come si tratti di due parole seman-ticamente diverse indicanti funzioni distinte18. Mitthof ha inoltre eviden-ziato come il termine antistes si trovi comunemente associato all�espres-sione huius loci, venendo a sottolineare lo stretto legame che la carica doveva avere in rapporto al luogo specifico in cui questa veniva eserci-tata19. Si rende quindi necessario riconsiderare l�etimologia tradizionale di antistes riconoscendo alla preposizione ante un�accezione locativo-
que religiosos ritus administrant». Così anche E. De Ruggiero, s.v. �Antistes�, in Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, vol. 1, Roma 1895, p. 496; s.v. �Antistes�, in Thesaurus Lin-guae Latinae, vol. 2, Lipsiae 1900-1904, coll. 184-186; A.Ernout - A. Meillet (eds.), s.v. �Sto�, Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine, Klincksieck, Paris 1959, p. 653. Il termine fu mutuato in seguito dall�ambiente cristiano per indicare una precisa carica sacerdotale (cfr. A.F. Pauly - G. Wissowa, s.v. �Antistes�, in Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissen-schaft, vol. 1.2, J.B. Metzler, Stuttgart 1894, coll. 2536-2537).
15 Cicerone, de domo sua, 1,2; 39,104. Tito Livio, ab Urbe condita, 23,11; 23,24,12. Vale-rio Massimo, Facta et dicta memorabilia, 1,1,1.
16 F. Cumont, Le mystères de Mithra, H. Lamertin, Bruxelles 19132, p. 151; L. Paschetto, Ostia colonia romana, cit., p. 170; A.D. Nock, The Genius of Mithraism, in «Journal of Roman Studies» 27 (1937), pp. 108-113; R. Meiggs, Roman Ostia, cit., p. 373; M. Floriani Squarciapi-no, I culti orientali a Ostia, cit., p. 45.
17 F. Mitthof, Der Vorstand der Kultgemeinden des Mithras. Eine Sammlung und Untersu-chung der inschriftlichen Zeugnisse, in «Klio» 74 (1992), pp. 275-290. Lo studio non si limita alla riconsiderazione della carica di antistes, ma si estende alla totatlità delle cariche attestate in rapporto al culto di Mithra (sacerdos, pater, prosidens ecc.). Sulla scia di Mitthof anche Á. Sabó, Der �locus� von Apulum, in L. Ruscu - I. Piso (eds.), Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Nereamia Napocae, Cluj - Napoca 2004, pp. 787-801.
18 Ad Ostia, in CIL, XIV 4313, frammentaria (il testo è integrato) lo stesso personaggio sem-bra essere ricordato contemporaneamente come sacerdos e antistes. In un altro caso ostiense lo stesso personaggio è ricordato in un�iscrizione come sacerdos (CIL, XIV 65), in un�altra come pater et antistes (CIL, XIV 66), in una terza come sacerdos (CIL, XIV 64). In altri casi, ad esempio a Roma, CIL, VI 716 e ad Ostia, CIL, XIV 70, nella stessa iscrizione sono ricordati sia un sacerdos che un antistes, indicando - come sembra - due cariche differenti. Per un elenco dettagliato del-le attestazioni cfr. F. Mitthof, Der Vorstand der Kultgemeinden des Mithras, cit., pp. 279-281.
19 Esistono poche attestazioni in cui l�espressione huius loci è legata ad altri termini: in due casi a pater (AE 1980, 49 e 50); in tre casi a sacerdos (CIL, VI 738; CIL, VI 417 = 30762; AE 1964, 97); in un caso a isiacus (CIL, XIV 352); in due casi a patronus (AE 1938, 61 = AE 1940, 75; AE 1940, 76).
07.TS Marchesini.indd 426 26/11/2013 17.29.15
IL CULTO DI MITHRA AD OSTIA NELLE FONTI EPIGRAFICHE 427
temporale (colui che sta davanti, che sta prima e quindi che vigila, che sovrintende) piuttosto che qualitativa (colui che eccelle, che predomina e quindi il capo dei sacerdoti). La funzione dell�antistes verrebbe quindi a diversificarsi da quella del sacerdos, che attenderebbe propriamente allo svolgimento degli specifici atti cultuali. L�antistes potrebbe invece rico-prire un ruolo più �laico� all�interno della comunità, legato alla gestione del luogo di culto: una sorta di direttore dell�istituzione religiosa20.
Il particolare legame che questa carica stringe con un definito ambito spaziale solleva due interessanti questioni legate tra loro, che mi limito in questa sede soltanto a presentare: l�eventualità che la medesima perso-na abbia potuto rivestire la stessa carica in più mitrei diversi e la durata dell�incarico. Ritornando infatti a C. Caelius Hermeros, va menzionato che questo personaggio è ricordato ad Ostia anche in un�iscrizione rinve-nuta nel Mitreo delle Pareti Dipinte21, in cui figura sempre come antistes huius loci22. La stretta somiglianza paleografica di questa iscrizione con CIL, XIV 57, 58 e 59 induce a ritenerle opera del medesimo scalpellino at-testandone la contemporaneità, da cui ne conseguirebbe la concomitanza degli incarichi23 [fig. 14].
20 Cfr. F. Mitthof, Der Vorstand der Kultgemeinden des Mithras, cit., p. 284, Á. Sabó, Der �locus� von Apulum, cit., pp. 793-974. In questo senso l�antistes non costituirebbe sinonimo di aedituus, in greco (come C.L. Visconti, Del mitreo annesso alle terme ostiensi, cit., p. 160, per il quale, ipotizzata una differenza di ruoli tra l�antistes ed il sacerdos, l�antistes era piut-tosto sinonimo di aedituus), il quale propriamente era definito custode del tempio, delle suppel-lettili sacre, dei doni votivi e del tesoro del tempio (A.F. Pauly - G. Wissowa, s.v. �Aedituus�, in Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, vol. 1.1, Stuttgart 1894, coll. 465-466; A.F. Pauly - G. Wissowa, s.v. �Neokoroi�, in Real-Encyclopädie der classischen Altertumswis-senschaft, vol. 16.2, J.B. Metzler, Stuttgart 1935, coll. 2422-2428). Osservando il panorama delle comunità religiose, soprattutto quelle relative a culti di origine orientale, come Iside, Serapide, per esempio, non ho riscontrato all�interno dell�organizzazione una carica che possa essere avvi-cinabile a quella dell�antistes, nella sua nuova accezione. Ciò dipende dalla conoscenza piuttosto incompleta della struttura di queste organizzazioni, dovuta soprattutto alla lacunosità della docu-mentazione antica conservata. Una migliore conoscenza abbiamo soltanto dell�organizzazione della prima comunità ebraica, ma anche qui pare non trovarsi una carica che rispecchi nel ruolo quella dell�antistes (cfr. H.L. Leon, The Jews of ancient Rome, Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1960; D. Noy, Jewish Inscriptions of West Europe, Italy (excluding the city of Rome), Spain and Gaul, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge 1993).
21 CIMRM, I, n. 269: C(aius) Cae/lius (H)e[r]/meros, / tes h[ui] [i] / fecit /s(ua) p(ecunia). Cfr. G. Becatti, I mitrei, cit., pp. 59-68; M. Floriani Squarciapino, I culti orientali a Ostia, cit., pp. 46-47.
22 Ad Ostia potrebbe esistere un altro caso di un personaggio attivo in due mitrei diversi, sempre che i documenti non siano appartenuti originariamente ad un medesimo contesto cul-tuale, o che non si tratti di un caso di omonimia: M. Caerellius Hieronimus, ricordato come sacerdos in un�iscrizione rinvenuta nelle vicinanze del Mitreo della Casa di Diana e ritenuta ad esso pertinente (CIL, XIV 4313), e pater e sacerdos in un�iscrizione rinvenuta nelle vicinanze del Mitreo degli Animali (CIL, XIV 70).
23 Si potrebbe anche ipotizzare la non pertinenza originaria di CIMRM, I, n. 269 al Mitreo delle Pareti Dipinte, ma questa eventualità risulta di difficile dimostrazione sollevando una questione ancora più spinosa che riguarda lo spostamento, e quindi il riutilizzo, di materiali pertinenti ad un determinato luogo di culto.
07.TS Marchesini.indd 427 26/11/2013 17.29.15
428 RAFFAELLA MARCHESINI
L�iscrizione sul fianco sinistro di CIL, XIV 58, in cattivo stato di con-servazione, presenta un ductus irregolare [figg. 7-8]. Nella metà destra dello specchio i tratti delle lettere sono meno definiti, la superficie pre-sentandosi dilavata. Le lettere sono incise senza particolare cura al di sopra della superficie pesantemente e grossolanamente lavorata a gradina e le rr. 4-7 seguono il contorno dell�urceus scolpito a rilievo24. Il testo ricorda il posizionamento delle basi il 18 gennaio del 162 d.C., anno del consolato di Q. Iunius Rusticus e L. Titius Plautius Aquilinus25. La lettura tradizionale di positi a r. 1 solleva delle questioni di non poco conto. Già Visconti infatti si era mostrato dubbioso circa la lettura della parte finale di questa parola, incerto se si trattasse di una I o una A, e propendendo infine per la prima. Egli ha così pensato che il plurale maschile alludesse a cippi26, ossia alle due basi (compresa quella di Cautopates, CIL, XIV 59), anche se è da notare l�uso improprio di cippus come sinonimo di ara o base, laddove il termine rinvia propriamente alla specifica funzione di delimitare uno spazio27. A cosa si dovesse riferire positi restava quindi difficile da comprendere, anche se forse avrebbe potuto indicare le due divinità, gli Dei Cautes e Cautopates, come vengono apostrofati in al-cuni, seppur rari, casi28. Il recente calco del testo, come si è accennato, sembra mettere in luce le tracce di due tratti orizzontali della lettera finale della parola inducendo a leggervi una E: posit(a)e. Se così fosse, il testo risulterebbe meglio comprensibile, il suffisso del nominativo femminile plurale suggerendo arae, statuae, bases. Questa ipotesi implicherebbe la presenza del fenomeno della monottongazione, se non si tratta di un erro-re del lapicida. La conservazione delle lettere risulta comunque piuttosto compromessa, confondendosi i tratti con quelli della gradina, e suggeren-do di considerare comunque con cautela questa interpretazione di lettura. D�altra parte si noti a r. 2 la mancanza della V di februarias, probabilmente una variante fonetica piuttosto che un errore di scrittura.
Un�attenta analisi della superficie iscritta delle basi ha mostrato che lo specchio epigrafico risulta essere stato ribassato, testimoniando la pre-senza di un�iscrizione precedente, erasa, della quale si possono rintrac-ciare ancora brevi tratti di lettere [fig. 11]. I limiti di questo ribassamento
24 Diversamente C.L. Visconti, Del mitreo annesso alle terme ostiensi, cit., p. CXXXVII la riteneva �cancellata con il pensiero di abolirla�.
25 Cfr. A. Degrassi, I Fasti consolari dell�impero romano dal 30 avanti Cristo al 630 sopo Cristo, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1952, p. 46.
26 O meno probabilmente a genii o ministri, C.L. Visconti, Del mitreo annesso alle terme ostiensi, cit., p. 163. In alternativa aveva suggerito trattarsi di un errore del lapicida per posita, in questo caso sottintendendo signa.
27 s.v. �Cippus�, in Thesaurus Linguae Latinae, vol. 3, B.G. Teubner, Lipsiae 1906-1912, col. 1078. Cfr. I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista: guida alla schedatura del mate-riale epigrafico lapideo, Quasar, Roma 1987, p. 89.
28 Cfr. CIL, V 1809 = CIMRM, II, nr. 759b. CIL, VI 86 = CIMRM, I, nr. 336. CIL, XII 1811 = CIMRM, I, nr. 903. CIL, XIII 11791 a, b = CIMRM, II, nr. 1214-15. CIMRM, I, nr. 875.
07.TS Marchesini.indd 428 26/11/2013 17.29.16
IL CULTO DI MITHRA AD OSTIA NELLE FONTI EPIGRAFICHE 429
sono chiaramente individuabili in quanto seguono il profilo dei piedi dei dadofori ed in CIL, XIV 58 tagliano orizzontalmente parte del panneggio inferiore del mantello di Cautes.
Sul fianco destro della base CIL, XIV 59 è presente una lavorazione a scalpello nello spazio incluso tra il bordo superiore e la patera [fig. 12]. Con molta incertezza sembrano individuabili brevi segni incisi in cui sembrano riconoscersi delle lettere, tanto che si potrebbe ipotizzare anche in questo caso la presenza di un�iscrizione precedente, erasa. La lavorazione della parte restante del fianco è a gradina con una sorta di fascia piatta lungo i bordi che si riscontra identica sul fianco sinistro e sul retro. Una tale lavorazione si presenta allo stesso modo anche sui lati di CIL, XIV 58, cosa che induce a ritenere sia stata realizzata in origine con-testualmente ai rilievi sulla fronte di entrambe le basette.
Per quanto riguarda le statue a tutto tondo di Cautes e Cautopates collocate sopra le basi, è stato possibile notare come gli alloggiamenti superiori ad esse destinati non sembrino accoglierne bene i plinti, facendo ipotizzare che gli incassi siano frutto di un lavoro successivo, grossolano e poco curato, realizzato soltanto in occasione del posizionamento delle opere a tutto tondo29 [fig. 13]. A favore dell�ipotesi di una non pertinenza originaria delle statue alle basi può contribuire lo stile delle opere a tutto tondo che sembra discostarsi da quello dei rilievi scolpiti sulla fronte30. Ciò implicherebbe quindi un cambio di funzione dei due supporti che in origine sarebbero stati piuttosto concepiti come altari figurati (sulla fron-te dei quali erano scolpiti i rispettivi rilievi mitriaci)31. Non si può esclu-dere comunque la possibilità che l�incavo fosse originariamente esistito ma destinato ad accogliere altri signa mitriaci, andati perduti32.
29 Già C.L. Visconti, Del mitreo annesso alle terme ostiensi, cit., p. 164 era di quest�avviso.30 Tuttavia l�analisi stilistica dei rilievi e delle statue non si dimostra determinante: si tratta
infatti di piccole produzioni locali che rientrano in una tipologia iconografica comune e am-piamente diffusa in tutto l�impero nel corso della metà del II sec. d.C. con esempi anche nel III d.C. M. Xagorari Gleißner, Vatikanische Museen, cit., III, p. 304, che ultima ha schedato questi materiali ha datato le statue al 162 d.C. sulla base dell�iscrizione sul lato di CIL, XIV 58, senza tuttavia proporre opportuni confronti stilistici � anche se a ragione le sculture a tutto tondo ed i rilievi sarebbero per lei produzioni locali della stessa bottega, come dimostrano le somiglianze del volto e del panneggio delle vesti, ma che hanno visto la partecipazione di altri scalpellini: mani diverse sembrano infatti notarsi nel trattamento delle superfici.
31 Si noti tuttavia che la presenza contestuale di statua e rilievo di un medesimo soggetto iconografico non è per niente comune e comunque risulta piuttosto ridondante. Sono noti tut-tavia alcuni rari casi, cfr. O. Dräger, Religionem significare. Studien zu reich verzierten römi-schen Altären und Basen aus Marmor, P. von Zabern, Mainz 1994, pp. 53-61 e E. Simon, in Thesaurus Cultus et rituum antiquorum, vol. 1.2.d, J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2004, pp. 388-389: possono confondersi con le are, ma se ne differenziano per la presenza sulla su-perficie superiore di un plinto su cui veniva posizionata la statua. Nel caso delle basi mitriache qui analizzate l�assenza di queste caratteristiche sulla superficie superiore confermerebbe il loro originario concepimento come are.
32 Per confermare l�una o l�altra ipotesi sarebbe auspicabile distaccare le statue dalle basi alle quali sono state ingessate per motivi statico-conservativi.
07.TS Marchesini.indd 429 26/11/2013 17.29.16
430 RAFFAELLA MARCHESINI
L�autopsia del materiale ha quindi permesso di rivelare due distinte fasi di utilizzo delle are/basi, mostrando come si tratti di un reimpiego di oggetti già pertinenti al culto mitriaco. Si può dunque ipotizzare che in un primo momento questi oggetti siano stati realizzati come altari, modanati sui tre lati, decorati al centro delle facce laterali lavorate a gradina con urceus e patera, sulle fronti con le figure di Cautes e Cautopates a rilievo in campo liscio. Su entrambe le facce frontali al di sotto dell�iscrizione di Hermeros avrebbe dovuto essercene una precedente, probabilmente con l�indicazione del nome dell�originario dedicante. In un momento succes-sivo le are sarebbero state riutilizzate, si sarebbe provveduto ad eradere le iscrizioni sulla fronte incidendovi quella di C. Caelius Hermeros e sulla superficie superiore sarebbero state collocate le statue dei dadofori.
Il riscontro di queste due fasi solleva un�importante questione ineren-te la cronologia degli interventi, in particolare se ammettere la contempo-raneità della datazione consolare del 162 d.C., incisa sul fianco sinistro della base di CIL, XIV 58, all�intervento di Hermeros � come tradizional-mente ipotizzato �, ovvero a quello precedente, eraso.
Se la datazione dell�intervento di Hermeros fosse da riferire al 162 d.C. questo implicherebbe una revisione verso l�alto della cronologia del-la prima fase d�uso delle are mitriache, riflettendosi a sua volta su quella dell�impianto del mitreo. La tradizionale datazione proposta da G. Becatti si basava infatti sull�analisi delle tecniche murarie33,evidenziando come il luogo di culto si inserisse all�interno di un intervento edilizio posteriore al complesso termale di età antonina, che avrebbe coinvolto anche gli ambienti annessi a sud e ad ovest prospicienti via della Foce. Questa cro-nologia sarebbe stata ulteriormente confermata proprio dal ritrovamento in situ della base con la datazione del 162 d.C.
Negli ultimi anni del secolo scorso J.M. Spurza, riesaminando il com-plesso edilizio nella sua totalità, ha rimesso in discussione la datazione tradizionale dell�impianto del mitreo abbassandone la cronologia agli anni finali del regno di Commodo e alla prima età severiana, con rifacimenti nel III d.C.34 L�analisi tipologica delle cortine laterizie in sottili mattoni rossi avrebbe evidenziato analogie con le murature del restauro del teatro di Ostia, iniziato sotto Commodo e terminato da Settimio Severo, come
33 Egli lamentava tuttavia come l�assenza di bolli laterizi non avesse permesso di determi-nare una precisa cronologia per le murature (cfr. Becatti, I mitrei, cit., p. 57). Si ricordi il ritro-vamento di un bollo laterizio del 154 d.C. (CIL, XV 1072) che tuttavia non avrebbe potuto essere di per sé utilizzabile ai fini della datazione dell�impianto in quanto scoperto �fuori luogo�, come riferito da H. Bloch, I bolli laterizi e la storia edilizia romana: contributi all�archeologia e alla storia romana, �L�Erma� di Bretschneider, Roma 1947, p. 278 n. 1072.
34 La studiosa ha reinterpretato l�intero complesso come caseggiato abitativo, probabil-mente a destinazione collegiale. Sulle fasi del complesso cfr. J. Spurza, The building history, cit., pp. 129-142; Ead., A new Study of Palazzo Imperiale at Ostia, diss., Ann Arbor 1999, dove l�analisi delle strutture severiane e del mitreo è trattata alle pp. 162-165 e pp. 239-259.
07.TS Marchesini.indd 430 26/11/2013 17.29.16
IL CULTO DI MITHRA AD OSTIA NELLE FONTI EPIGRAFICHE 431
accertano i bolli laterizi e l�iscrizione marmorea CIL, XIV 114 con la dedi-ca dell�imperatore del 195 d.C. Tuttavia questa nuova datazione si pone maggiormente in contrasto con quella del 162 d.C. A Spurza non era sfug-gita questa difficoltà, limitandosi però soltanto a sollevare il problema.
Negli anni 1964 e 1967 il Mitreo del cd. Palazzo Imperiale è stato interessato da una campagna di indagini archeologiche condotta dalla So-printendenza di Ostia35. Questi sondaggi hanno permesso di evidenziare la presenza di fasi precedenti dell�ambiente cultuale: basti ricordare la scoperta di due fasi pavimentali in semplice terra battuta anteriori alla pavimentazione musiva di Calendio (CIL, XIV 56); precedenti podi laterali con due protuberanze al centro in luogo delle absidi riscontrate nell�Ot-tocento da C.L. Visconti; una precedente conformazione dell�edicola con avancorpo centrale e scalette laterali rivestite di lastre di marmo, tra cui un�iscrizione in reimpiego, inedita36, che il mosaico ha successivamente obliterato. Allo stato attuale la mancanza di uno studio di questi saggi e del relativo materiale rinvenuto non permette di stabilire sicure cronolo-gie per questi interventi precedenti. È possibile invece constatare senza alcun dubbio come il pavimento musivo di Calendio abbia costituito l�ul-timo intervento di una certa importanza nell�ambito dell�evoluzione del mitreo. Lo stile del mosaico, da quanto si può apprezzare da una recen-te riproduzione fotografica, malgrado il cattivo stato di conservazione37, suggerisce una datazione tra la fine del II sec. d.C. e i primi decenni del III d.C.38, assicurando un terminus ante quem per le fasi pavimentali prece-denti e quindi anche per la costruzione del mitreo [fig. 3].
Alla luce di questi nuovi elementi la proposta di Spurza di una data-zione del mitreo nell�ultimo decennio del II sec. d.C. lascia dubbiosi: per mantenere la datazione dell�impianto alla cronologia da lei proposta, la studiosa, che era a conoscenza di questi dati di scavo, aveva infatti do-vuto necessariamente dispiegare le diverse fasi archeologiche precedenti dell�ambiente cultuale all�interno di un arco cronologico molto ristretto. La tradizionale datazione dell�impianto del mitreo alla prima età di Mar-
35 GdS 1961-1965, vol. 33, anno 1964 e GdS 1966-1968, vol. 36, anno 1967. A quanto mi è dato sapere si tratta della sola indagine archeologica posteriore ai grandi scavi Calza della fine degli anni Trenta del Novecento, che abbia interessato l�intero panorama dei mitrei ostiensi. Gli scavi ed il materiale rinvenuto non sono stati a tutt�oggi pubblicati e pertanto farò riferimento ad essi in modo molto generale. Nel prossimo futuro è in programma da parte di chi scrive lo studio e la pubblicazione di questi scavi.
36 Inv. 7174. 37 Il mosaico è attualmente coperto da una fitta vegetazione.38 La tecnica è piuttosto semplice, con tessere piuttosto grandi (2 cm) e la presenza delle
fasce nere rimanda a lavori di III sec. d.C. La paleografia ricorda quella delle iscrizioni dei mosaici del Piazzale delle Corporazioni, databili in età severiana anche se l�intervento qui realizzato sembra più curato (il tratto della G è ancora verticale). Cfr. Becatti, I mosaici, cit., pp. 64-85; M. Cébeillac Gervasoni in M. Cébeillac Gervasoni - M.L. Caldelli - F. Zevi (eds.), Epigrafia latina. Ostia: cento iscrizioni in contesto, Quasar, Roma 2010, pp. 253-259.
07.TS Marchesini.indd 431 26/11/2013 17.29.16
432 RAFFAELLA MARCHESINI
co Aurelio parrebbe quindi preferibile, in linea con la datazione del 162 d.C. e sembra spiegarsi meglio alla luce delle fasi precedenti dell�am-biente cultuale, come hanno individuato i sondaggi del 1964 e del 196739.
Tornando a CIL, XIV 58, la datazione consolare del 162 d.C. verrebbe quindi a riferirsi meglio alle iscrizioni erase piuttosto che a quelle relative ad Hermeros, il quale invece sarebbe intervenuto in un momento succes-sivo a questa data, riutilizzando i precedenti altari mitriaci, trasforman-doli in basi con l�aggiunta delle relative statue. Hermeros avrebbe eraso le iscrizioni sulle fronti di CIL, XIV 58 e 59 e quella sul lato destro di CIL, XIV 59, lasciando invece quella con la datazione sul lato sinistro di CIL, XIV 5840. A sostegno di questa ipotesi sembra venire in aiuto l�iscrizione inedita, precedentemente citata, rinvenuta durante i sondaggi del 1964, reimpiegata come lastra di rivestimento del primo gradino dell�edicola cultuale, successivamente coperto dal pavimento di Calendio, CIL, XIV 56 [fig. 15]. La lastra è di marmo bianco a vene grigie, con cornice a listello e gola. La superficie superiore si presenta liscia, il retro scalpellato. La lastra misura 29 x 44 x 3-3,5 cm; lo specchio epigrafico 22,5 x 36cm. Le lettere misurano 2,2-3,3 cm. Attualmente si conserva nei depositi della Soprintendenza di Ostia. Inv. 7174. Esame autoptico 2011.
+
votum animo libens5 d(ono) d(edit).
Il ductus si presenta regolare con tracce di linee guida. La forma delle lettere tende al corsivo (soprattutto nei tratti obliqui della A, della N e della M, e nella resta della B). Le prime due righe sono frutto di un sapiente la-voro di erasione che esclude ogni possibile tentativo di restituzione del te-sto; si intravede soltanto il tratto verticale della prima lettera a r. 1. La resa della cornice non è particolarmente accurata e i tratti non sono in squadra.
Si tratta di una dedica votiva posta ad una divinità ignota da parte di un personaggio ricordato nelle prime due righe erase, forse per damnatio memoriae. Non esistono elementi sicuri di una pertinenza dell�iscrizio-ne al medesimo contesto mitriaco41, ma la particolare presenza in questo
39 Soltanto una ripresa delle indagini e lo studio dei materiali rinvenuti durante questi son-daggi potrebbero aiutare a definire meglio la cronologia delle fasi del mitreo e la loro relazione con quelle degli ambienti vicini e dell�impianto termale di età antonina.
40 Questa scelta potrebbe giustificarsi alla luce della collocazione stessa delle basi all�in-terno delle piccole absidi ricavate al centro dei podi del mitreo, che l�avrebbe in ogni caso tolta alla vista (situazione nient�affatto infrequente in epigrafia).
41 Il reimpiego di iscrizioni per rifacimenti interni ai mitrei, siano state queste originaria-
07.TS Marchesini.indd 432 26/11/2013 17.29.16
IL CULTO DI MITHRA AD OSTIA NELLE FONTI EPIGRAFICHE 433
stesso contesto di un ulteriore caso di erasione e conseguente reimpiego potrebbe suggerire l�identità della circostanza.
L�analisi comparata dei testi epigrafici sembra rivelare una stretta connessione tra questa iscrizione e quella sul fianco di CIL, XIV 58 con la datazione del 162 d.C. I tratti delle lettere, come la T, la E, il tratto obli-quo della A e della V sembrano molto simili e tendono al corsivo. Il mo-dulo delle lettere dei due testi ricorre inoltre costantemente in un rapporto di 1:142. L�iscrizione sul fianco di CIL, XIV 58 verrebbe in questo caso a datare non solo l�iscrizione inedita ma anche le iscrizioni erase sulle fron-ti delle basi; i testi avrebbero potuto ricordare uno stesso personaggio, il cui nome è stato eraso per una ragione a noi sconosciuta, il quale avrebbe posto nel mitreo le due primitive are mitriache, CIL, XIV 58 e 59, e la lastra votiva inedita, confermando la pertinenza originaria di questi materiali al mitreo e spigandone il reimpiego nello stesso contesto.
Diversamente nelle iscrizioni di Hermeros incise sulle fronti della basi il modulo presenta un rapporto maggiore, nell�ordine di 1:1,5 e in alcuni casi di 1:2. Questi elementi sembrano orientare verso una posterio-rità di quest�ultimo intervento di scrittura. Tuttavia per quanto riguarda la datazione dell�intervento di Hermeros non esistono sicuri indizi cro-nologici. Dal punto di vista paleografico le lettere risentono dell�influsso della capitale quadrata di età traianea, cominciano ad allungarsi ma non sono ancora paragonabili a quelle rettangolari tipiche dell�età severiana: esempi paleografici simili si ritrovano nella seconda metà del II sec. d.C. fino all�età commodiana e raramente in età severiana43. Gli interventi di Hermeros potrebbero perciò meglio collocarsi in un momento imprecisa-to tra il 162 d.C., anno in cui verrebbero a datarsi le iscrizioni precedenti, erase, e i primi anni dell�età severiana, senza superare il II secolo44.
mente pertinenti o meno al culto, si riscontrano in altri mitrei Ostiensi, quali per esempio nel Mitreo delle Pareti Dipinte, nel Mitreo della Planta Pedis, nel Mitreo della Casa di Diana.
42 Esempi di una simile scrittura si riscontrano nel corso del II sec. d.C., concentrandosi negli anni intorno alla metà del II d.C., tra il 120 e il 160 d.C. circa Cfr. A.E. Gordon - J.S. Gor-don, Album of Dated Latin Inscriptions, University of California Press, Berkeley 1958-1962, vol. 2, tav. 78, n. 177, tav. 82, n. 184, tav. 96, n. 213, tav. 97, n. 210.
43 Cfr. le tavole di A.E. Gordon - J.S. Gordon, Album of Dated Latin Inscriptions, cit., vol. 2, tav. 110, n. 238; tav. 116, n. 250; tav. 120, n. 257; III, tav. 123, n. 262. Iscrizioni con lettere che risentono ancora del modulo quadrato in CIL, VI 213 (181 d.C.); VI 3550 (180-192 d.C.); XIV 252 (200 d.C.). La paleografia delle lettere è confrontabile anche con CIL, XIV 2 (197 d.C.).
44 Questa datazione sembra convincere soprattutto se si tiene presente come dal Mitreo delle Pareti Dipinte provenga la già accennata basetta di statua, CIMRM, vol. 1, n. 269, che l�analisi pa-leografica ha confermato essere contemporanea a quelle di CIL, XIV 57, 58 e 59, e come l�impian-
domus di età repubblicana II sec. d.C.,
probabilmente al tardo periodo antoniniano per lo stile delle pitture conservate. Cfr. G. Becatti, I mitrei, cit., pp. 59-68; M. Floriani Squarciapino, I culti orientali a Ostia, cit., pp. 46-47.
07.TS Marchesini.indd 433 26/11/2013 17.29.16
434 RAFFAELLA MARCHESINI
Fig. 1: Pianta del complesso del cd. Palazzo Imperiale. Il mitreo è indicato con il nr. 75; la palestra delle terme di età Antonina con il nr. 73. Da J.M. Spurza, The building history of the Palazzo Imperiale at Ostia: evolution of an insula on the banks of the Tiber river, in
07.TS Marchesini.indd 434 26/11/2013 17.29.16
IL CULTO DI MITHRA AD OSTIA NELLE FONTI EPIGRAFICHE 435
Fig. 2: Pianta del Mitreo del cd. Palazzo Imperiale con iscrizione musiva CIL, XIV 56. Da G. Becatti, Scavi di Ostia II. I mitrei
Fig. 3: CIL, XIV 56, iscrizione musiva di L. Agrius Calendio. Dal sito di J.Th. Bakker <http://www.ostia-antica.org/> (06/12).
07.TS Marchesini.indd 435 26/11/2013 17.29.18
436 RAFFAELLA MARCHESINI
Fig. 4: Altare CIL, XIV 57. Foto au-trice 2011.
Fig. 5: CIL, XIV 58. Da F. Sinn (ed.), Vatikanische Museen, Museo Gregoria-no Profano ex Lateranense. Katalog der Skulpturen. Reliefgeschmückte Gat-tungen römischer Lebenskultur. Grie-chische Originalskulptur. Monumente orientalischer Kulte, vol. 3, Wiesbaden 2006, tav. 104.4.
Fig. 6: Statua di Cautes per-tinente a CIL, XIV 58. Da F. Sinn (ed.), Vatikanische Mu-seen, cit., tav. 104.1.
Fig. 7: CIL, XIV -co sin. Foto autrice 2012, per gentile con cessione dei Musei Vaticani.
07.TS Marchesini.indd 436 26/11/2013 17.29.19
IL CULTO DI MITHRA AD OSTIA NELLE FONTI EPIGRAFICHE 437
Fig. 8: CIL, XIV 58, calco del l�i-
autrice 2012.
Fig. 9: CIL, XIV 59. Da F. Sinn (ed.), Va ti kanische Museen, cit., tav. 105.4.
Fig. 10: Statua di Cautopates pertinente a CIL, XIV 59. Da F. Sinn (ed.), Vatikanische Muse-en, cit., tav. 105.2.
Fig. 11: CIL, XIV 59, particolare. Foto autrice 2012, per gentile concessione dei Musei Vaticani.
07.TS Marchesini.indd 437 26/11/2013 17.29.19
438 RAFFAELLA MARCHESINI
Fig. 12: CIL, XIV
dx. Calco autrice 2012.
Fig. 13: CIL, XIV 59, particolare dell�at-
della base. Foto autrice 2012, per gentile concessione dei Musei Vaticani.
Fig. 14: Iscrizione di C. Cae-lius Hermeros dal Mitreo del-le Pareti Dipinte CIMRM, Vol. 1, nr. 269. Inv. 11542. Foto autrice 2011.
Fig. 15: Inv. 7174. Foto autrice 2011.
07.TS Marchesini.indd 438 26/11/2013 17.29.20
IL CULTO DI MITHRA AD OSTIA NELLE FONTI EPIGRAFICHE 439
ABSTRACT
Il riesame di due piccole basi di statua gemelle CIL, XIV 58 e 59, ri-spettivamente poste a Cautes e Cautopates, rinvenute negli scavi otto-centeschi del Mitreo del cd. Palazzo Imperiale di Ostia e attualmente conservate ai Musei Vaticani, ha consentito di stabilire che il testo delle iscrizioni sulla fronte è stato inciso su erasione precedente. Questa sco-perta ha posto nuovi interrogativi per quanto riguarda la cronologia del-le basi stesse e dell�impianto del mitreo.
The re-examination of two small twin statue bases CIL, XIV 58 and 59, respectively dedicated to Cautes and Cautopates, found during the excavation of the Mithraeum of the so-called Imperial Palace in Ostia in the nineteenth century, (now in the collection of the Vatican Museum), has determined that the text on the front of the bases was engraved on a previous erasure. This discovery has raised new questions concerning the chronology of the bases and of the Mithraeum complex.
KEYWORDS
Culti cd. Orientali, Mithra, Ostia, epigrafia, attori del culto
So-called Oriental Cults, Mithra, Ostia, epigraphy, agents of Cults
07.TS Marchesini.indd 439 26/11/2013 17.29.20