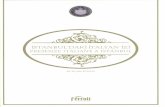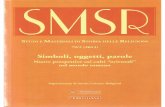TANASI D., Per un riesame degli elementi di tipo miceneo nella cultura di Pantalica Nord, in V. La...
Transcript of TANASI D., Per un riesame degli elementi di tipo miceneo nella cultura di Pantalica Nord, in V. La...
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI (SIRACUSA)
Le presenze tnicenee nel territorio siracusano
I Simposio Siracusano di Preistoria Siciliana in memoria di Paolo Orsi
Siracusa, 15 -1 6 dicembre 2003
Palazzo l mpellizzeri
Museo A rcheologico Regionale <<Paolo Orsi»
a cura di Vincenzo La Rosa
BOTIEGA D'ERASMO 83E'P AlDO AUSJllO EDITORE IN PADOVA
2004
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! DI TIPO MICENEO NELLA CULTURA DI PANTALICA NORD
Il problema della presenza di elemenri di derivazione micenea nella cultura di Pantalica Nord 1, cosl evidenti in tutte le sue manifestazioni eppure cosl diversi rispetto aile importazioni e aile tholoi del centro costiero di Thapsos, l'altro centro che aveva restituito tracce di frequentazione da parte di genti d 'oltremare, crucciava l'Orsi g ia all'indomani dell 'esplorazione delle necropoli d i Panralica (jig. 1 ). Ponendo a confronro le evidenze dei due siti scriveva: «11 d ivario parziale si deve alla coltura micenea che agisce poderosa sulle coste, meno inrensa sulle monragne» 2 sottolineando le differenze peculiari nelle manifestazioni miceneizzanri dei due siti , pili evidence e sostenuta da importazioni di oggetti e modelli architettonici quella di Thapsos, meno intensa rna pili d iffusa quella di Panralica, caratterizzata da imitazioni , da rielaborazioni di concerti archirertonici, d i oggetti avvolti da un'aria di famiglia micenea.
Allo scopo di fornire nuovi spunri ai termini del problema del conratto tra le popolazioni indigene della Sicilia e le genri micenee, in un momenro in cui i commerci pili che esaurirsi sembrano ridimensionarsi o meglio riconfigurarsi, nelle modalira della scambio e del conratto, e opportuno in questa sede tentare di ridefinire le influenze micenee manifestate dal centro eponimo della cultura, arroccato nell 'entroterra montana, della vicina Siracusa.
I- Ceramica Effertuando una ricognizione di tutte le forme ceramiche documentate per
la cultura di Panralica Nord, basandosi su una documenrazione provenience in maniera quasi esclusiva da contesti funerari, e stato possibile circoscrivere il
1 In generate sull'argomenro si veda: LEIGH
TON 1985, pp. 399- 407; Io. 1996, pp. 105-11 5; CuLTRARO 1998, pp. 301-308. In derra
glio: BERNABO BREA 195 3 -19 54, pp. 194-195; TAYLOUR 1958, pp. 74- 75 ; BIETTI SESTIERI
1979 , p. 609, n. 19; LA RosA 1993- 1994 , pp. 26 -27 (ceramica); ToMASHI.o 1996, pp. 113-140 (archirertura domesrica); VAGNETn 1986,
p . 207; D 'AGATA 1986, pp. 105-110; Lo Scii!A
vo 1983, p. 289 (merallurg ia); MILITELLO 1991, pp. 18-19, n . 12; NICOLErri 1997 , p. 53 1-533 (g ioiellerie); sugli srudi piLl recemi cfr. T ANASI
1999a, pp. 331-336; In. 1999 b , pp. 193- 257;
Jo. 2000, pp. 1-88; TANASI 2004, pp. 399-445. 2 0 RSI 1899 a, col. 112.
338 DAVIDE TANASI
patrimonio formale intorno ad un g ruppo composto da 22 vasi 3; era di essi e possibile disting uere due classi di forme di derivazione micenea:
Forme di derivazione micenea mutuate dalla cultura di Thapsos, ora innovate sul piano tecnico (la pisside cilindrica, la teiera a beccuccio, la razza con ansa ad anello sormontante e la brocca askoide)4.
Forme di derivazione micenea di «nuova introduzione» (jig. 4)- l'anfora cuoriforme, l'askos, la teiera a crivello , la patera, l' hydria quadriansata, il coperchio a campana -\ cui si aggiungono i rari esemplari di anfora biansata 6
ed askos a ciambella7, assenti nel repertario thapsiano. A questa periodo
dovrebbe logicamente risalire anche l'introduzione del tipo del rython coni co 8 ,
attestato pili tardi nell 'esemplare di Sabucina 9 (graf 5). Il fatto che circa la meta del complesso formale sia composta da vasi di
imitazione micenea da la misura di come i contatti con le genti micenee siano, per la ceramica almena, il maggior ind icatare per la cultura di Pantalica Nord. Ciononostante, nel sito eponimo, che dovrebbe riassumerne le caratteristiche peculiari , solo una piccola parte di tali forme e documentata. Fenomeno questa che pone maggiormente l'accento sul problema del rapporto era Pantalica e l'altro centro p ili importante, Montagna di Caltagirone, e su quello della diversa interazione era Pantalica e le genti micenee da una parte e l'eredita culturale di Thapsos dall 'alcra.
Focalizzando la discussione solo su sei delle forme di derivazione micenea, quelle di nuova introduzione e maggiormente documentate, l'anfora cuoriforme (FS 58) 10
, l'askos con bottane sommicale (FS 195)11, l'hydria quadriansaca
1 TANASI 2000, pp. 5-6. 1TANASI 2004, p. 429, tab. 1; p. 4 32, fig. 6 B.
l BERNABO BREA 1953-1954, pp. 194-195;
TAYLOUR 1958, pp. 74-75; BIETll SESTIERJ 1979,
p. 609, n. 19; LA RosA 1993-1994, pp. 26 -27;
TANASI 1999a, pp. 33 1-335, Io. 2000, pp. 1-88. 6 II ri po dell 'anfora biansara ricond ucibile
alia forma Furumark 69 (FURUMARK 194 1a, pp.
35, 595, fig . 7; Io. 1941b, p . 22; FuRUMARK
1992, pl. 183) arresrato gia a Madre Chiesa di
Gaffe (CASTELLANA 2000, pp. 94, 129-130, fig.
23, rav. V), a Srrerro-Partanna (MANNINO 1994,
p. 161, fig. 15 d) e, un po' piu tardi, a Sanr'An
gelo Muxaro (FATTA 1983, p. 57 , ravv. 15:190-
195; PALERMO 1996, p. 150, fig . 3:9; ID. 2002,
p. 25) per i conresri omologhi alia cul rura d i
Panralica Nord nella Sicilia occidentale si veda
anche TANASI 2000, pp. 6-10. 7 Sul ripo dell 'askos a c iambella arresrato a
Sanr'Angelo M uxaro cfr.: PALERMO 1996, p.
150, fig . 3:4; cfr. anche LA RosA 2000, p. 131.
La corrispondenre forma micenea sarebbe FS
196: (fURUMARK 194 1a, pp. 66, 617, fig. 20;
Io. 194 1b, p. 25; FuRUMARK 1992, p l. 11 4). 8 La corrispondenre forma micenea sarebbe
FS 199: (FURUMARK 194la, p . 67, fig. 6 18; I o.
194 1b, p. 2 5 ; l o. 1992, p l. 1 16). 9 LA RosA 1989, pp. 62 - 63, fig . 84. 1° FuRUMARK 194 1 a, pp. 36, 595, fig. 8;
Io. 194 1b, p. 22; T AYLOUR 1958, p. 74; BrErrr
SESTIERI 1979, p. 609, n. 19; K ILIAN 1983 , p.
95, figg. 15- 16; Mo uNTJOY 1986, p. 161, fig.
202; Fu RUMARK 1992, pis. 38, 182; LEIGHTON,
1996, p. 11 5; Cui:I"HARO 1998, p . 30 5, T ANASI
1999a, pp. 33 1- 336 ; Io. 2000, pp. 6 - 10.
" fURUMARK 1941a, pp. 4 1,617 , fig . 11 ;
Io.194lb,p. 25; ID. 1992 , pll . 113, 188; TANASI 1999a, pp. 33 1-336; lo. 2000 , pp. 10 -12.
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! Dl TIPO MICENEO 339
(FS 64) 12 il coperchio a campana (FS 335) 13, la patera (FS 208) 14 e la teiera a crivello (FS 155) 15 e collocando temporalmente la diffusione dei prorotipi nell 'Egeo, e possibile constatare che essi iniziano a svilupparsi a partire dal TE IIIB , con un floruit a partire dal TE IIIB2 (post 1270 a.C.), e che soltanro alcuni perdurano nel TE III C raggiungendo piena affermazione, mentre altri scompaiono del tutto (graff 1-2)16
.
Rientra invece nel quadro, piuttosto esiguo, dei mareriali ceramici di tipo miceneo del periodo TE III C in Sicilia, la famosa brocchetta proveniente dalla romba 133 Nord d i Pantalica (jig. 3 ) 17 che si pone in una posizione problemarica tra le imitazioni locali e le importazioni micenee. Accanro alle forme gia proposte come confronto, secondo una nostra ipotesi, la brocchetta della rom ba 13 3 N richiamerebbe in maniera d iretta la forma FS 114 ed in particolare e possibile citare come confronto un esemplare proveniente da H alyki databile al TE III A2 1
H; il motivo decorativo e verisimilmente confrontabile con FM 19:52 databile al TE IIIC1 19• Certamente rilevante e la discrepanza cronologica fra la forma attesrata a partire da una fase piu antica ed il morivo decorativo, che si afferma in un momento piu tardo. In mancanza di specifiche indagini di laboratorio e studi sistematici sul repertorio formale della precedente facies di Thapsos, la possibilica che la forma FS 11 4 fosse stata introdotta in ambiente indigeno in un momento piu anti co- tra il TE III A2 ed il TE III B - e riprodotta local mente in esemplari privi di decorazione e che solo in seg uiro, nel corso del TE IIIC, questi ultimi venissero decorati secondo il nuovo sti le delle ceramiche neo-introdotte, resta una lectio difficilior per spiegare la discrasia era forma e decorazione. L'altro elemento significativo e che il motivo decorativo, hook shaped single row, rispetro agli esemplari rinvenuti in ambience egeo, si presenta, su quesro vaso, capovolro; negli altri esempi micenei noti il g irale del cirro e rivolro verso l'ansa, mentre nella brocchetta 133 N di Pantalica esso guarda dalla parte opposta. Questo daro potrebbe essere inter-
12 FURUMARK 1941a, pp. 37, 594-595, fig. 9; Io. 1941b, p. 22; B ER NABO BREA 195 3-
1954 , pp. 194 -1 95; TAYLOUR 1958, pp. 74 -7 5; B1En 1 SESTIERI 1979 , p. 609, n. 19; FuRUMAR K
1992, pll . 40, 18 3; CULTRARO 1998, p. 305 ;
MOUNTJOY 1999, p. 944, fig. 385:18; TANASI 1999a, pp. 33 1-336; Io. 2000, pp. 14-17 .
ll f uRUMARK 194la, p . 643 ; Io. 194l b , p.
27; TAYI.OUR 1958, p. 75; F uRUMAR K 1992, pl.
179; TANASI 1999a, pp. 331-336; l D. 2000 ,
pp. 33-34 . 11 f URUMARK 194 1a, p. 48, 6 19, fig . 16 (FS
207); lo. 1941b, p. 25; Io. 199 2, pls. 120 ,
188 (FS 208); TANASI 1999a, pp. 33 1-336; Io. 2000, pp. 27- 28.
I ) FuRUMARK 1941a, pp. 31, 608-609, fig. 6 ;
Io. 194 1b , p. 24; TAYLOUR 195 8, p. 76; LEIGH
TON 198 1 pp. 280-291 ; FuRUMARK 1992, pll. 87,
187; T ANASJ 1999a, pp. 331-336; Io. 2000,
pp. 19-24 .
'6 Per un inquadramenro cronologico dei pro
rotipi micenei cfr. TANASJ 2000, pp. 53 - 54.
'7 0RSJ 1899, coli. 66 -67; VAGNEni 1968 ,
p. 132, n. 3. IH FuRUMARK 1992, p l. 64. 19 f URUMARK 194 1a, p . 298, fig. 47 .
340 DAVIDE TANASI
pretato come il risultato di. una copiatura erronea di una decorazione originate su di un prodotro locale 20
; inoltre l'arg illa d i color rossiccio-violaceo, semifine e con molti piccoli inclusi, ad un esame autoptico, non ricorda la classe fine della ceramica micenea. In assenza di specifiche analisi di laboratorio, l'ipotesi di una fabbricazione locale non sarebbe del tutto da escludere 2 1 se si considerano numerosi esempi offertici da siti della Sicilia, Sardegna ed Italia meridionale di ceramica micenea prodotta in loco 22
•
Oltre all 'aspetto tipologico-formale, due fattori che denotano !'influenza micenea sulla cultura di Pantalica Nord sono rappresentati dalla tecnica e dal tipo di decorazione della ceramica. Dal punto di vista della tecnica, il dato piu importante e rappresentato dall' introduzione del tornio 23
' utilizzato principalmente per le forme piu caratteristiche della cultura, non necessariamente decorate a stralucido rosso (jig. 2). Per cia che riguarda il tipo di tornio utilizzato e possibile disti nguerne due varianti : il tornio a cinghia lenta e quello propriamente detto. L'ipotesi di un'introduzione micenea del tornio nella cultura di Pantalica Nord recentemente proposca, trova supporto nella scoperta di una classe non decorata di ceramica rorni ta nella Penisola Iberica 24 , in associazione a materiale miceneo del TE IIIB2, interpretata come un 'importazione micenea che avrebbe raggiunco il Mediterraneo occidentale su una rotta passante per la Sicilia. L'alto livello tecnico raggiunto nella produzione di tale classe ceramica sarebbe testimoniato anche dall 'uso, attestato in pochi esemplari proprio a Pantalica, di potter's marks sui fondo dei vasi per indicare prodotti di qualira superiore 25
.
20 Altri esem pi di una medesima copiatura
erronea del mocivo decoracivo hook shaped single row su ceramica micenea prodotta in loco e rico
noscibile su due vasi provenienti da Creta
(Efescia e Perivolia): cfr. G RECO- PRIVITERA c.d.s. 21 Sull' iporesi di una pwduzione locale si
veda anche CuT:rRARO 1998, pp. 301 -302; AUlA
NESE PROCELL! 2002, p. 82; LA RosA 2002, p. 38. 22 Per I' an fo ra della tholos B d i M ilena: cfr.
j ONES- VAGNETTI 1991 , p . 135; sug li esempla
ri provenienti dalla Sardegna: cfr. ibid. , pp.
132-1 34; U GAS 1996, pp. 1603- 1607 . Sug li
esemplari p rovenienri dall 'lralia meridionale:
cfr. BENZI - GRAZIADIO 1996, pp. 126 -1 32; sul
le recenti scoperre di Torre Mordillo: cfr.
j ONES 2001 , pp. 33 1- 337. 1
' Sui problema dell'introduzione del cornio
si veda CuLTRARO 1998, p. 304, nora 29. Sulle
recniche di cornirura della ceramica cfr. RYE
1981, PP· 64-65; VANDER LEEUW 1984, p . 56. 11 A proposico dei rinvenimenti d i Llanete del
Los Moras-Cordoba, Turre -Almeria, Cues ta del
N egro-Gra11ada, Carmona-Seville cfr. ALMAGRO
GORBEA- FONTES 1997 ' pp. 347- 3 56; MARTIN DE
LA CRUZ 1996, pp. 15 5 1- 15 60; M EDEROS-MARTIN
1999, p. 248. 1
) ALBANESE PROCELL! 2000a, p. 177, n. 40.
II caso d i un potter's mark a forma di ancora sui
fonda di un'anfora di Pantalica (Museo d i
Siracusa, inv. 2059, rinvenura sporadicamente
nel 1885) e riporraro in LEIGHTON 1996, p.
106, fig. 3d , p. 115. Un segno a forma di P
r icorre sui fonda di un'anfora a scralucido cosso dalla t. 15 3 SC di Panralica: cfr. 0RSI 19 12,
col. 320. Una croce inscritta si crova sui fonda
dell'hydria a scralucido rosso, conservara a! Mu
seo d i Siracusa, inv. 2 1257, facenre parte di un
g ruppo di materiali sequesrrari alia Rocca Gras-
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENTI Dl TIPO MICENEO 341
Accanto al perdurare della detorazione incisa di rradizione rhapsiana 26 si afferma con grande fortuna la recnica dello srralucido rosso, che si presenta come uno dei fossili guida della culrura di Pantalica Nord 27
. Questa ripo di decorazione, maggiormente arresrata sui vasi di ripo fine e rorniro, non ha una grande disrribuzione sul terrirorio. Nella Sicilia sud-orientale solo Pantalica, Montagna di Caltagirone e Monte Dessueri, hanno resriruiro una norevole quantira di mareriale a srralucido.
L'iporesi di una derivazione egea della ceramica a srralucido rosso fu per la prima volta proposra dalla Sandars28 che ne arrribuiva la presenza piurtosro diffusa nel Medirerraneo alle migrazioni dei popoli del mare. Se da un laro la diffusione della cosiddetra Red Lustrous Whee/made Ware nel Medirerraneo centro-orientale, rra il XV e l'XI a.C., cosl simile alla ceramica di Pantalica Nord per recnica, rna cararrerizzata da un limitaro e specialisrico gruppo di forme differenti, porrebbe rimandare l'origine di questa innovazione recnico-stilistica al Levance 29
, rurravia la scoperra di ceramiche cornice con superficie a srralucido rosso segnalare nell'Egeo serrenrrionale 30
, la definizione a Rodi e Kos di una red-yellowish bttrnished ware all'inrerno della produzione del TE III 3' ed il rinvenimenro a Midea 32, in conresri del TE III B2, di ceramiche rosse lustre, consenrono di dare maggior supporro all' iporesi di una derivazione micenea della decorazione a stralucido rosso, che sarebbe giunra in Sicilia assieme al tornio e alle sei forme ispirare a prororipi micenei, che compaiono per la prima volta nel reperrorio della culrura di Panralica Nord. In tal caso quella a srralucido rosso si configurerebbe come una classe di ceramica micenea maggiormenre diffusa nei conresri periferici di quel mondo, paragonabile alla ceramica fine a superficie grigia dei conresri italici33 o alla wheel-made non decorated ware della penisola iberica' 4
, entrambe classi ceramiche associate a materiali del TE III B e ritenure esempi «alrernarivi» di ceramica micenea d'imporrazwne.
so di Monragna di Caltag irone: cfr. TANASI 2004, p. 402, nota 23. Sui marchi da vasaio vedi anche ALBANESE 2001, pp. 65-67.
26 TANASI 2004, p. 403. 2
' Scarse avvisaglie della comparsa di questa innovariva tipologia decorariva si hanno pure nel periodo precedence, come il caso delle due «grandi anfore>> a scralucido rosso dalla comba di Caldare (0RSI 1897, p. 8, tav. II, 3-4) o come il frammenro di ansa a piastra bifida a superficie rossa lustra, MC 93/20, rinvenuro, in conresti thapsiani, a Madre Chiesa di Gaffe
(CASTELLANA 2000, pp. 114-115, fig. 44c). 2RSANDARS 1978, p. 112. 29 ERIKSSON 1993; GRAZIADIO 1998, pp. 114-
117. 1°CULTRARO 1998, p. 305. ll Per Rodi cfr. MoRRICONE 1972-1973, p.
386. Per Kos: PAPAIANNOPOULOU 1985, p. 87; BENZ! 1996, pp. 956-966.
12 DEMAKOPOULOU - DIVARJ -VALAKOU- WALBERG 1994, pp. 27-29, fig. 23.
33 VAGNE1TI 2001, pp. 328-329. 11 Cfr. s11pra, nora 24.
342 DAVIDE TANASI
II- Spade Nella documentazione relativa all'attivira metallurgica, la significativa as
senza nelle necropoli di Pantalica delle tipiche spade di derivazione micenea, il tipo ibrido A/B Sandars 35 caratteristico del momenta finale del periodo TE III B, largamente attestate nel centro coevo di Montagna di Caltagirone 36
, lascerebbe supporre una minore presa delle influenze micenee sulla produzione metallurg ica bellica. Mala scoperta di una spada miniaturistica (t. 48 N) confrontabile con la produzione della pili evoluta classe F Sandars (jig. 5 c) 37
, databile al tardo XIII secolo, e di una spada (t. 68 N) ed un pugnale (t. 8 N) con l'elsa configurata a testa d'anatra, sia in bronzo che in avorio, tipici del TE IIIC (jig. 5 a-b) 38, non solo smentisce ogni possibile «chi usura» del centro di Pantalica aile influenze micenee in questa settore produttivo, rna offre l'evidenza della presenza di un nucleo di influssi inquadrabili proprio nel TE III C. Forse non del rutto casuale e l'attestazione dei pili tardi esempi di metallurg ia miceneizzanti nel solo g ruppo Nord , fra le necropoli di Pantalica.
III - Specchi U n ' altra classe di materiali della produzione metallurgica che fornisce
esempi della c.d. miceneizzazione e quella degli specchi bronzei, per altro documentati nella sola Pantalica. Daile necropoli provengono 5 esemplari circolari , di cui , pur non potendo stabili re se siano stati imitati o importati, si riconosce unanimemente la fi liazione micenea. Tre di essi sono del tipo senza codolo (tangless), circolari , e con due o tre fori per l'alloggiamento dei perni che fissavano il manico in legno o avorio e due del t ipo con codolo bronzeo (fanged) . G li esemplari siciliani senza codolo, 3 N , 37 N (jig. 7a) e 23 N039 ,
sono riconducibili a dei prototipi micenei, corrispondenti al tipo I della classificazione Catling40
, che hanna diffusione tra il TE III A1-T E IIIB1 (jig. 7b); quelli con codolo, 140 N (jig. 9a) e 173 S0 41 sono confrontabili con esem plari, di tipo II Carling, at testati nell 'Egeo dal TE III B2 al TE IIICl (jig. 9b). Da cio consegue che i cinque esemplari di Pantalica non sarebbero arrivati nella stesso momenta: i tre del tipo tangless sarebbero stati importati nel TE III B o poco dopo, mentre g li esemplari 140 N e 173 SO, di tipo tanged, dovrebbe-
35 SANDARS 1961 , p . 25 ; EAD. 1963, p. 137;
LEIGHTON 1985, p . 400. 36 TANASI 2004, pp. 40 3- 406. 37 0 Rsl 1899a, col. 57, cav. V II: l 6; SANDARS
1963, pp. 138-138, pll. 25:41,43,28:68,69. 38 0RSI 1899a, coli . 53, 6 2, cav. VII: 9, 15.
Cfr. un esem p iare anaiogo dalla romba 12 d i
Peraci (BouzEK 1985, pp. 14 7 -148, fig. 74). 39 0RSI 1899a, coil. 47, 53, 56 tav. VIII, 14 . 4°CATI.I NG 1964, pp. 224 -227 . 4 ' 0 Rsi 19 12, coil. 322, 33 1; LoSCHIAVO
M ACNAMARA -VAGNETTI 1985, pp. 28 - 30, fig. 11 .
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! Dl TIPO MICENEO 343
ro essere arrivati dopa il TE III B·, nel corso del TE III C, momenta a cui si riconducono la decorazione della brocchetta 133 N e le g ia citate armi con manico a testa d'oca.
IV- Fibule Per cio che concerne le fibule bronzee, sia il tipo pili antico ad area di vio
lino che il pili recente ad arco semplice (jig. 8a), accanto all 'idea tradizionale di una derivazione italica dei modelli 4\ si fa srrada la nuova ipotesi di una derivazione micenea, sostenuta dall' evidenza della to mba 61 di Micene (jig. 8 b)43, da cui proviene una fibula bronzea ad area di violino, inquadrata cronologicamente nel momenta finale del TE IIIB, considerata uno degli esemplari micenei pili anrichi e precursore dei tipi ad area semplice che hanna grande diffusione nel continence nel TE IIIC e nel Submiceneo 44
.
Pur nella consapevolezza che anche quest'antico esemplare miceneo potrebbe essere di derivazione italica, significativa si rivelerebbe l'associazione cronologica tra specchi bronzei senza codolo e fibule ad area di violino nel TE III B e di specchi con codolo e fibule ad area semplice nel TE III C, sia in Sicilia che in Egeo, considerando che entrambi i tipi di oggetti appartengono alla classe dei beni di prestigio, che erano utilizzati come indicarori di status dalle elites indigene miceneizzate. In quesro caso la controversa fibula ad area di violino della tomba IX di Cozza del Pantano 45 rappresenterebbe uno dei primi portati della culrura di Pantalica Nord o degli ultimi della facies di Thapsos, in un momenta a cavallo trail TE IIIB1 e IIIB2, in cui alla chiusura dell 'esperienza thapsiana corrispondeva l'inizio dell'ascesa di Pantalica. U n lasso di tempo breve, in cui Thapsos-emporio era probabilmenre g ia in disarmo, i centri costieri in via di spopolamento e quelli di Pantalica e Montagna di Caltagirone erano stati g ia occupati, un lasso di tempo tuttavia di cui ci sono indizi archeolog ici significativi. Come l'evidenza attestata dalle deposizioni misce di vasi grigi tipo Thapsos e rossi lustri , nella tomba 133 N di Pantalica 46
o nella tomba 52 Rocca Bassa di Montagna di Caltagirone 47, inquadrabili
entrambe in un momenta iniziale della facies di Pantalica Nord , e la compresenza di tombe con deposizione di ceramica di tipo Thapsos e di tipo Pantalica in due necropoli contigue del territorio di Buscemi 4s.
41 B1r:rrr Sr:sn r:RI 1997, p. 484. 13 XENAKJ -SAKHLARIOU 1985, pp. 186 -1 87,
rav. 80 :2808. 41 Per ri fe rimenc i bibliografici specifi ci
sull 'argomento e sull'esemplare recensiore dal
Teychos D ymaion (jig. be) cfr. PAPADOPOULOS
1979 , pp. 138-139, figg. 279a, 334a- b.
4$0 RSI 1893, coli. 12-14, rav. I: 6.
'16 AUlANESE P ROCELL! 2003, p. 82. 47 Taccuino Orsi n. 55 del 19 giugno 1903. 18 ln 0RSI 1898, p . 164 si rrova il riferimen-
to ad una tomba in conrrada Gerame presso
Buscemi che aveva resrirui ro mareriale relarivo
a que! periodo: << ... q ualche perla d'ambra, una
344 DAVIDE TANASI
V - Gioiellerie Gli stessi problemi interpretativi che si pongono per la produzione metal
lurg ica si ripresentano nell'analisi delle gioiellerie. Seppur non molto numerose, le testimonianze offerte dalle necropoli di Pantalica si confermano estremamente significative. L'introduzione degli oggetti preziosi in argento, metallo «sconosciutO>> in Sicilia fino a questo memento, come gli anelli a fascetta e l'armilla della tomba 37 N; le tre perlette d'oro e la lamina aurea con impressioni dalla medesima 3 7 N , gli anelli aurei a fascetta delle tom be 62 N e 121 SE e la comparsa di piccole armi rituali in oro o con dementi aurei, come il pugnale con chiodetto d'oro della tomba 23 NO e la discussa «Stellina di mezza porcellana>> della tomba 74 N, ritenutafayence di importazione micenea, sono alcuni degli dementi principali che rievocano una sostanziale influenza micenea sulla produzione o sulla circolazione degli oggetti di prestig io dotati di valore intrinseco 49
• Ma il dato piu importante e fornito dal rinvenimento dei tre anelli aurei con castone configurato, indiscutibili indicatori di status 50 dei maggiorenti indigeni, rispettivamente, l'anello col motive dell 'occhio radiante dalla t. 142 SC (jig. 11 a) 51
, quello col motive della triplice treccia (jig. 11 b) 52 e quello controverso con la raffigurazione di un pesce recuperate da una to mba non precisata del settore N 0 53
•
Sull 'origine allogena di questi, come di altri, oggetti della facies di Pantalica Nord, non ci sono mai stati dubbi, dato che anche g li unici esempi piu antichi di manufatti in oro, quelli della romba D di Thapsos 54 , sono da considerate importazioni micenee. Malgrado si riconosca in questi oggetti un'aria di famiglia micenea, non e stato possibile fino ad ora individuate dei confronti puntuali che permettessero di inquadrare l'area di provenienza e la cronologia dei modelli 55 •
piccola fibula ad arco semplice rigonfio cordonato, un pug nalerto in bronze lanceolato, e tra
i pochi avanzi ceramici un vaso a cribro ... >> .
Compresenza di mareriali del tipo Thapsos e d i quello Panralica Nord e attesrato anche nelle grotte di Barriera esplorate dall'Orsi: 0RSI
1907, pp. 73 e sgg., figg. 16 e 32. 49 MILITELLO 1991, pp. 18-19 e nora 12;
CuLTRARo 1998, p. 302. '
0 Gli oggetti esorici, quei luxury goods acquisiti spesso tram ire il meccanismo dello scam
bio dei doni , che arricchiscono i sepolcri genri
lizi di Pantalica, vengono utilizzati come espressioni di rango superiore in seno a precise srrareg ie sociali actuate dalle elites per affermare-mantenere il !oro porere. Cfr. su questo argomenro WRIGHT 1995, pp. 66 -69; DIETI.ER 1999, pp.
145-146, nota 10. l
1 Catalogo Prima Sicilia , n. V 83, p. 195. 520RSI 1906, p. 12, fig. 4. 53 G ENTILI 1956, p. 165, fig. lb. Per que
sr'esemplare e Stato indicato dalla Vagnetti
come modello l'esemplare cipriora dalla romba 18 d i Enkomi, cronologicamente pii:1 anti
eo: cfr. VAGNETTI 1972 , n. 53 . La resa stilisrica della figura del pesce, secondo alrri stud iosi, tradirebbe una cronolog ia molro piu rarda,
relativa all' era bizanrina.
'4 VOZA 1972, pp. 30-5 2.
" L'esemplare dalla t . 142 SC di Panralica
e chiaramenre confronrabi le con l'anello ad oc
chio radiance (Museo di Siracusa, inv. 2 3 312 gruppo Di Bernardo) da Montagna di Caltagi
rone, sebbene ci sia tra i due una cerra diffe-
PER UN RIESAME DEGU ELEMENT! Dl TIPO MICENEO 345
VI - Altri oggetti Relativamente ad altre classi di materiali, resta ipotetica l'identificazione
del disco di piombo della tomba 9 N 0 56 come un'unira ponderale di derivazione micenea, seppure g ia nella facies di Thapsos, pili convincenti esempi di unira di peso di tipo miceneo siano stati presi in esame 57
.
VII - Architettura domestica Il vuoto documentario relativo all'architettura domestica e colmato in
parte dal pili emblematico, nonche unico , esempio di architetrura palatina miceneizzante della Sicilia della Tarda Eta del Bronzo, quella «strana anomalia>> nel povero quadro delle architetture indigene che l'Orsi attribuiva al «principe di questa barbarica citta>>, l'anaktoron d i Pantalica (jig. 6) 58
.
Malgrado i rimaneggiamenti di epoca bizantina59 e possibile distinguere come il nucleo p rincipale dell'edificio sia costituito dal gruppo di 6 vani C -H, di eguali dimensioni e non comunicanti tra loro, salvo il caso degli ambienti G e H, per cui il misero stato di conservazione ha impedito di comprendere se si trattasse di due vani isolati o comunicanti o di un unico locale. In un secondo momenta sarebbe sorto il grande vano A e quelli B e L che si config urerebbero come l'aethusa principale dell 'anaktoron . Dopo questa modifica sostanziale sarebbe possibile fare una distinzione tra il nucleo A , B , C, D, L di spazi intercomunicanti fra loro, forse con una funzione prett am ente residenziale, e quello E, F, G, H di vani accessibili solo dall ' esterno e destinati presumibilmente all'immagazzinamento 60
. La filiazione dell 'anaktoron di Pantalica dai Complessi A e B di Thapsos, logica e p lausib ile visti g li strerti rapporti che lega-
renza nella tecnica di esecuzione e nel quanti tativa di mecallo prezioso (0,73 grammi complessivi il pri mo e 0,31 g rammi il secondo), e con u no analogo (t. 79 Fascuccheria) da Monte Dessueri (0Rsl 1912, co l. 373, tav. XVII:l O); il motivo a fascia d i linee formante spirali con occhio al cencro e comune ad un esemplare del Museo di Siracusa, inv. 23331 (t . 1 Rocca Alta) da Montagna di Caltagirone, anche se nel prima caso le spirali formate sono 4 e ne] Secondo 6 e guest 'u[timo e anche di dimensioni minori (5 g rammi).
~6 0RS I 1899a, col. 45; CutTRARO 1998, p. 30 2.
\ 7 I 2 1 dischecri di bronzo (tt. 6 e 14) rinvenut i daii 'Orsi e da lui stesso interpretati come pesi (0Rsl 1895, col. 101) e le 2 verghe di ferro
a sezione guadra (t. 48) (ibid. col. 127) porrebbero essere inrerpretari come unira di misura ponderali di derivazione egea. A tal proposito si veda GIARDINO 1997, p. 408; PAR ISE 1986, pp. 303- 3 15; l D. 1999, pp. 35 1-353; ALBERTI 1999, pp. 339- 346. Riguardo agli ox-hide ingots rinvenuti a Thapsos e a Cannatello (GIARDINO 1995, p. 408) e alia !oro funzione monetale o ponderale nel commercia miceneo del rame si veda PARISE 1968, pp. 11 7 -1 33; CuTRON I T usA 1997, p. 568.
)H Per le prime notizie orsiane sull'anaktoron di Panralica cfr. LA RosA 2004, pp. 394-395 .
\ 9 Non ha rrovato riscontro l'ipotesi del Messina che l'anaktoron fosse un kastelfion bizantino: cfr. MESSINA 1993, p. 6 1.
60 BERNAB0 BREA 1990 , pp. 73-77 .
346 DAVTDE TANASI
no i due cenrri e le relative culture, sostenuta dall'evidenza archeologica della frequentazione, nel periodo di Thapsos, nel sito in cui sarebbe sorto l'edificio, ha ormai rrovaro conferma anche da un punto di vista metrico col riconoscimento di un medesimo modulo base, verosimilmenre di derivazione micenea, di 30,5 7 em applicato nei corpi di fabbrica principali delle due strutrure 6 1
• La sua progettazione e messa in opera deve essere ricondotta all'attivira di quell'imprenditoria di technopoioi micenei itineranti che al servizio dei potentati indigeni, realizzavano tho!oi e magazzini marittimi prima e sepolcri gentilizi e anaktora poi 62
• In particolare, una maggiore analogia progetruale e ravvisabile era i complessi thapsiani e la fase iniziale dell'edificio di Pantalica , cioe il momenta dell 'esavani, in cui alle similirudini planimetriche corrispondono anche quelle di destinazione funzionale degli ambienti, cioe l'immagazzinamento.
Con tutti i rischi del caso, basandosi sulla ricostruzione ipotetica elaborata da Bernabo Brea, per cui la fondazione di Pantalica e quindi la costruzione dell'anaktoron sarebbe avvenuta ad opera delle genti di Thapsos, volendo ascrivere il momenta dell 'esavani agli inizi della culrura di Pantalica Nord, si potrebbe forse ipotizzare che l'aggiunta del vano A e la conseguente modifica in senso palaziale dell 'edificio, sarebbero da collocare in una fase piu avanzata dellafacies di Pantalica Nord. In un momenta in cui la rescissione del cordone ombelicale con Thapsos, l'aumenro delle influenze micenee originali e la conseguente evoluzione in senso piramidale della sociera. indigena, avevano reso il terreno fertile per la nascita di un edificio p rincipesco. I rinvenimenti fatti dall'Orsi all 'interno del vano A pongono ulteriormente l'accento sul sig nificate della sua aggiunta alla pianta originaria. Le cinque matrici d i fusio ne, due delle quali pertinenti ad asce p iatte e i pezzi di accette ad occhio, la spiraletta, la barra trapezia ed i g rossi frammenti «rotti intenzionalmente per essere rifusi>> 6
\ sono indici di un'attivira metallurgica all 'interno dell 'ambiente , in un momenta in cui la tesaurizzazione dei metalli e la loro fusione erano appannaggio delle elites emergenti. E proprio la realizzazione di un vano come questa, con le sue dimensioni maestose da grande sala (68 m 2
) e con la funzione di deposito dei bronzi e di laboratorio-fonderia, connesso con la sistemazione di un ingresso piu monumentale a Nord, a far entrare in qualche modo l'ed ificio nella dimensione degli anaktora di tipo miceneo.
6 1 Sulle analog ie p rogerruali rra le Case A e B di T hapsos e l'anaktoron d i Panralica cfr. ToMASELLO 1996, p p. 1595 - 160 2.
62 T OMASELLO 1995- 1996, pp. 257-265; Io. 2001 , p. 325. Rig uardo all 'arrivira di mae-
srranze archirerron iche m icenee specializzare nella Sicilia delle facie.r di T hapsos e Panralica Nord si veda soprattutto TOMASELLO 2004.
610 RSI 1899a, coli. 78-79; ALBANESE P ROCEL
L! 2000b, pp. 83 - 85.
PER UN RJESAME DEGLJ ELEMENT! DJ TJPO MJCENEO 347
Inoltre la maggiore specializzazione, manifestata dalle maestranze nella realizzazione del muro meridionale del vano A , riconducibile come tecnica muraria ad ambienti metropolitani micenei , dovura all'impiego di personale esecurivo di cultura micenea (scalpellini) oltre che direttivo (architetto), dimostra un nuovo apporto culturale concomitante alla costruzione del vano A, non riconoscibile in precedenza ne nella realizzazione dell'esavani, ne nell'ed ificazione delle Case A e B di Thapsos 64•
Naturalmente la possibilira di collocare cronologicamente 1' imp ian to originario della struttura ed il momenta dell'agg iunta del vano A, attualmente si basa su argumenta ex silentio, soprattutto per alcuni punti oscuri nella pubblicazione specifica del Bernabo Brea del 1990. Turtavia proprio il riesame dei taccuini Bernabo Brea dei saggi effettuati all'interno dell'anaktoron nel 1962 potrebbe aggiungere nuovi dati sig nificaci vi 65
•
VIII - Architettura funeraria Passando dall'architettura palatina a quella funeraria, entriamo nel meri
to di un problema fondamentale per la comprensione della natura delle influenze micenee a Pantalica, ovvero il sig nificato dell'assenza del tipo della tomba a tholos nelle sue necropoli 66
• La mancanza dell'indicatore di miceneizzazione per eccellenza nel siro eponimo della cult ura, che manifesta, at t raverso le evidenze che stiamo presentando, una caratterizzante presenza dell'elemento miceneo, lascia supporre che Pantalica possa aver reagito in maniera diversa alle influenze micenee rispetto agli al tri due centri di Caltagirone e Monte D essueri, in cui il tipo della tomba a camera tholoide e ampiamente documentato, pur essendo tutti e tre i poli «tributari» della cultura di Thapsos, che rappresenta il momenta di prima introduzione del modello. Diverse ipotesi sono state avanzate a g iustificazione di questa evidenza: 1. Pantalica sarebbe rimasta isolata dal «processo fi logenetiCO>> Thapsos/Montag na di Caltagirone ed avrebbe iniziaro precocemente un recupero della tradizione indigena che si sarebbe concretizzato nell 'applicazione del tipo della tomba ipogeica semplice 67
•
2. Pantalica sarebbe stata investita da precoci influenze di derivazione peninsulare, responsabi li dell' introduzione delle t ipologie rombali del camerone e della romba a camera multipla, che avrebbero sostitui to le influenze micenee 68
.
Una terza ipotesi , maggiormente suffragata dall 'evidenza archeologica, potrebbe essere quella che Pantalica sarebbe stata oggetto d'influenze micenee, qua-
61 T O MASHLO 2004, pp. 197-202. 65 B ERN ABO B REA 1990, pp. 77-83. 66 Speci ficamente sull'argomenro si veda T A-
NA~ 1999 b, pp. 193 -2 57. 67 T USA 1999, pp . 567- 569. 6" M AN!SC;\LCO 1985 -1986, pp. 255-256.
348 DAVIDE TANASI
litativamente oltre che cronologicamente differenti rispetto a quelle di Thapsos, e quindi porcacrici di elementi culcurali diversi, forse rappresentate dalle tipolog ie tombali che, caratteristiche della sola Pantalica, si sosticuiscono alla tholos, ovvero la tomba a camerone e la comba a camera multipla 69.
Una novita tipologica, per la Sicilia dell'eta del Bronzo Tardo, rappresentano i g randi cameroni rettangolari scavati nella roccia della necropoli Nord Ovest di Pancalica - NO 22 (jig. 17), NO 38 e NO s.n. (jig. 16) - 70
, alcuni dei quali eccezionalmente grandi 7 1
• Per forma, dimensioni , e corredi rinvenuci, queste combe sono state idencificate come sepolcri gencilizi di famiglie abbienci , in posizione preminence nella societa indigena. Non a caso due dei piu grandi bacini su alto piede provengono da queste tombe, mentre un terzo analogo era conservato nell'anaktoron 72
• Anche la disposizione topografica di queste sepolture, tutte concentrate nella sressa area della necropoli Nord-Ovest, isolate dalle altre, e indicativa del loro verisimile carattere elitario. 11 tipo del << Camerone» non e esclusivo della necropoli di Pancalica: poche altre combe di questo tipo si trovano anche in altri siti che hanno restituito testimonianze della culcura omonima73 •
La scoperca di combe a camera di g randi dimensioni in numerosi contesti tardoelladici della Grecia micenea continentale ed insulare 74 d imostra come, pur non esistendo una precisa connotazione geografica nella sua discribuzione, e degli standards costruttivi, la tomba a camerone, si configurerebbe, al pari della tholos, come una tipologia funeraria di chiara derivazione micenea 7\ adottata verisimilmente, nel centro moncano, da famiglie di alto rango che volevano rimarcare la preminenza del loro status sociale, emulando le consuetudini funebri recepite nei rapporci intrattenuti con le genci micenee.
69 MANISCALCO 198 5-1 986, pp. 255 -260. ' 0 Per l'iporesi che alia nascira della ripo
logia rombale plurima possano aver concorso influenze provenienri dall 'Egeo cfr. LA RosA 1993- 1994, p. 26; Io. 1999, pp. 169 -1 70. Inreressanri analogie formali era le ripolog ie rombali siciliane del Bronzo Tardo e modelli egei sono sraci evidenziaci dal Culcraro in margine ad un suo conrribuco di caraccere generate sui rapporri era Ia culrura di Panralica Nord ed il mondo egeo: Cur.:rRARO 1998, pp. 303- 304, nn. 22-25 .
71 T. 22 N O (0 RSI 1899a, col. 46, fig. 5); t . 38 NO (0 RSI 1899a, coli. 49 - 5 1); t . s.n. N O (O RSI l 899a, col. 43, fig. 3).
72 MAN ISCALCO 1985 - 1986, p. 244. 22 NO:
3, 15 x 2,52 m (7,9 3 m 2), lunghezza dromos
3,10 m; 38 N O : 3,77 x 3,80 m (1 4,32 m 2),
lung hezza dromos 3,30 m ; S.N. NO: 6,10 x 3,52 m (21,47 m 2), lunghezza dromos 3,80 m.
73 LA RosA 1989, p. 12. 74 La «cavira ipogeica>> di Screrro-Parranna
di 6,67 m2, fo rn ira d i due piccole nicchie (MANNINO 1994, p . 131, figg. 6 -7) e Ia romba 5 d i Conrrada Calanca (1 ,83 m 2
), in terriroriodi Ferla (lTALI A 1983,p.1 2, fig . 7:a, b).
n Nella necropoli di Ialisos a Rodi so no p resenci in gran numero delle rom be a camera, a pianra reccangolare, con dimensioni variabili era i 7 ed i 15 m2 inquadrabili cronologicamence era il TE II B ed il TE III C: ct. 17, 31, 50 (TE IIB-TE IIIA1 ); tt. 3, 12, 52, 59, 60
PER UN RIESAME DEGU ELEMENT! Dl TIPO MICENEO 349
Un'altra tipologia tombale documenrabile nella necropoli di Pantalica, e sporadicamente anche in altri conresti coevi 76
, e quella delle rom be a camera pluricellulare (jigg. 12 -15). Si tratta di un complesso di camerette, in numero variabile da 2 ad 11, di forma circolare, ellittica o rettangolare, che si affacciano su un camerone o su un ingresso/galleria di raccordo; nei casi in cui e presenre un numero elevaro di celle, esse possono essere disposte su due livelli . Gli ambienti annessi agli spazi funerari principali vengono sempre urilizzati per inumazioni primarie di singoli individui o d i piccoli g ruppi ; in qualche caso, ospitano sepolture infanrili, rna sempre con corredo distinto. Tali rombe, tutte concentrate in un'area circoscritta della necropoli Nord, allimite con quella Nord Ovest 77
, ad eccezione di alcune piu tarde del gruppo Sud 7H, denotano un grande sforzo di
(TE IIIA2); tt. 5, 38 (TE IIIB); ct. 32, 61, 67, 80, 87 (TE IIIC); tt. 2 , 43 (non dacabili). La comba 43 e Ia p ii:t g rande di tucta Ia necropoli con un'area d i 15 ,70 m1
: cfr. BENZ! 1992, pp. 227-23 1). Laconia, Argolide e Beozia presentano combe a camera molto g randi , come Ia g igancesca comba 2 di Pellanes (86 m2) , Ia comba 1:2 di Asine, le combe 2, 6 , 8 e 9 di Dendra, le mmbe 15, 53 e 82 di Micene, Ia comba di Megalo Kascelli (80,5 m 2) e le rombe 4, 9, 14, 15, 25 e 28 della necropoli di Kolonaki a Tebe. Di dimensioni ragguardevoli sono le mmbe D , E, H , J , M ed 0 di Kalli chea (Acaia), una mmba di Pacrasso (25 m2
) e Ia comba B del Kla11s Cemetery come pure alcune rombe di Alpochori, Palaiokascro e Ia monumencale romba d i Olimpia (50 m2
), in Elide. Superiori ai 21 m2 di superfic ie sono le tombe del ripo Cave Dormitory, diffuse era il TE IIIB e TE III C, nelle necropoli di Mazarakaca, Mecaxata (ct. A, D , E, St), Lakkicra (tt. A, B) e Diakara (t.1) nelle isole Ionie; combe a camera con una esrensione superiore ai 9 m 2 sono atrestate nelle necropoli di Eleona e Langada a Kos (per Ia bibliografia specifi ca: cfr. KONTORLI PAPAOOPOULOU 1987, p. 147 e n. 20; CAVANAGH 1987, pp. 16 1- 169; CAVANAGH- M EE 1998, pp. 66-69). N el TE IIIC l'impoverimenco che caracceriaa Ia sfera morcuaria si riflette anche nella riduzione della spazio funerario; Ia t ipolog ia delle g randi combe a camera scompare
del cutto e nella necropoli meglio conosciuca d i questa periodo, quella di Perati , le combe a camera di nuova escavazione non superano i 6 mecri quadrati (CAVANAGH- MEE 1998, p. 93).
' 6 Di diverso avviso e il Leighton, che ritiene i cameroni di orig ine indigena: LEIGHTON 1999, p. 168.
77 Una comba a camera con un annesso proviene dal Timpone Pontillo in rerrimrio di Santa Ninfa (MANNINO 1974 , pp. 39-44, fig. 2); nella necropoli d i Riveccazzo, all'interno della sfera di influenza terricoriale di Panralica, e presence sia Ia cipologia della doppia camera, come nel caso della romba XXIV, sia Ia ripologia della mmba a camera ellitcica forn ira di nicchie come nella XVI (ORSI 1903, p . 24 e sgg., rav. Il :1,6 ; TOMASELLO 1995-1996, pp. 163- 165, fig . 93); ancora esempi di mmbe a camera a p ianra ellittico-circolare con nicchie provengono dalla necropoli della Pinica d i Akrai (BERNABO BREA 1956, pp. 11-12, fig. 4; TOMASELLO 1995-1996, pp. 181-182, fig. 103); singolare, infine, risulra Ia mmba 7 di SrrettoParcanna a pianca elli ttica, con nicchia annessa di forma rettangolare regolare (MANNINO 1994, pp. 130-131, figg. 4-5).
' sTombe a camera multipla: T. 24 (ORSI 1899 a, col. 47, fig. 6); rr. 32 - 34 NO (0RSI 1899a, col. 48, fig . 7); tt . 1-2 NO (hALIA 1975 - 1976, pp. 13- 17 , fig. 3); Ct. 12-16 N (ORsi 1899a, coil. 53 - 55, fig. 10); rc. 20 -23 N
350 DAVID£ TANASI
progettazione e di realizzaz·ione, data l'ampiezza e la complessica delle piante di alcune di esse, che crova una giustificazione in precise scrateg ie sociali , prescrizioni rituali e come vedremo meccanismi di emulazione.
La tendenza ad aumentare lo spazio funerario attraverso la moltiplicazione pluricellulare delle camere ipogeiche, affonda le sue radici nelle scoria piu remota delle popolazioni indigene di Sicilia. L'ipogeo di Calaforno 79 e le tombe a g rappolo di Malpasso 80 insieme con le com be di Cava Secchiera 81
, di Cava della Signora 82, del Predio Reale 83 e della Muculufa 84 sana gli esempi pili eclatanti di pluricellularismo per l'Eneolitico e l'Era del Bronzo Antico, period i in cui la tendenza al megalitismo ipogeico e la sperimentazione d i sistemi di ampliamento della spazio funebre venivano sviluppati in diverse aree del Mediterraneo centrale, dalla Grecia, a Malta, alla Sardegna 8~ .
Nel corso della facies di Thapsos, la tradizionale tendenza al pluricellularismo, inteso come moltiplicazione della spazio atcraverso l'annessione di nicchie o camere, viene applicata anche al tipo allogeno della comba a camera tholoide di derivazione micenea 86. In questa periodo, piu che in passaco, la fortuna dell'architettura funeraria di tipo pluricellulare si fonda su solide basi sociopolitiche.
Nel rico dell'inumazione collettiva, tipico della cultura di Thapsos, e possibile ravvisare il desiderio che g li individui uniti in vita da legami parentela-
(0 RsJ 1899a, col. 55); t. 27 N (0 1\SI 1899a, col. 55); r. 29 N (0 RSI L899a, col. 55); t. 56 N (il ben noto camerone rrapezoidale accessibile da un grande protiro, su cui si affacciano 11 celle, 6 a! piano del suolo e 5 piu alto: O Rsi l899a, col i. 58-59, fig. 12); tt. 101-105 N (0 Rsi 1899a,coll. 63 - 64,fig.17); tt.146- l 48 N (0RSI, 1912, coil. 33 1-332, fig. XVIII) ; n. 236 -239 SC (0RSI 1912, col. 328); t. s.n. Filiporro (0 RSI 1899a, col. 69, fig. 23); t . s.n. Cavetta (0Rst 1899a, col. 72, figg. 24-25).
79 Tombe con ambience annesso, di forma variabile (dall'ell ittico a! quadrangolare), alia camera principale tramire corridoio: t. 223 SC (0 RSI 1912, col. 326); t. 224 SC (0RSI 1912, col. 326); t. 80 SE (0RSI 1912, coli. 316 -317).
80 GUZZARDI 1980, pp. 67-94; ID. 1984, pp. 315-317. A proposi to del coevo ipogeo di Torre Mazzaronello cfr.: G uzzARDI 1984, pp. 3 17- 318; 1D. 1996,p. 19,fig. 9.
XI Tt. E2, E3, E6, E7: ALBANESE 1988-1989 , pp. 161 e sgg., fig. 5.
82 Tt. 14 e 15: 0RSI1893a,pp. 11- 13, tav. 3. 83 Tt. 10, 21, 22, 23: 0RSI 1892, pp. 20,
27- 34, rav. I. 84 T. Ilia: 0 RSI 1889, pp. 212 -217, ravv.
VI:Ia, Ilia, IVa. "
5 Tt. 206, 326,201,209,232-233: PARKER 1985,pp. 9-30,figg. 8,9, 19, 14, 15.
"6 A proposiro delle assonanze era l'ipogei
smo siciliano e g li esempi maltesi e sardi si veda: ALBANESE 1988-1989, pp. 186 -1 88, nn. 14 -1 5; BERNAU6 BREA 1976-1 977, pp. 33 -92; per un'analisi comparata degli esempi d i ipogeismo nelle isole del Mediterraneo occidentale si veda: Lu.uu 1998, pp. 123-157; riguardo alia Grecia cfr. WooLSEY H EERMANCE LORD 1897, pp. 313-332, fig. 1-2; CULTRARO 2000, p. 475.
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! Dl TIPO MICENEO 351
ri o <<Socio-politici», lo fossero anche dopo la morte. Il gruppo sociale che sceglie di essere inumato insieme in una tomba ipogeica, sia di tradizione indigena che di derivazione micenea, dimostra di non avere all 'interno ancora una chiara stratificazione socio-politica in senso verticale; la presenza di nicchie o camere annesse ad una tomba ipogeica deve essere intesa, con molta probabilira, come Ia volonta di disting uere all 'interno del gruppo, come se si volesse rispecchiare, nella casa dei morti , una nuova situazione emergente nel mondo dei vivi 87
• I fruitori di questa tipo di tombe potrebbero identificarsi con un gruppo sociale di tipo clanico in cui g li individui, uniti da legami di sang ue, pili o meno stretti, scelgono di essere sepolti insieme nello stesso spazio funerario, con un corredo comune, composto dal set di vasi per il banchetto funebre posto in posizione centrale, ed un corredo personale, che contraddistingue il singolo defunto; nella g rande camera centrale si scavano delle nicchie in cui si collocano, probabilmente, i membri pili importanti. Nella presenza delle nicchie e di due corredi sta la traduzione materiale di un cambiamento nel gruppo sociale, caratterizzato dalla formazione di una nuova aggregazione e dalla distinzione dei membri che lo compongono. Sarebbe questa un effetto evidente della mutazione che l'agglomerato sociale avrebbe subito con la formazione di piccoli g ruppi che iniziavano a disting uersi verisimilmente in base al d iversificarsi delle attivita productive, divenute specialistiche grazie agli apporti culturali micenei in campo architettonico, funerario, metallurg ico e della produzione ceramica 88
.
Nella facies di Pantalica Nord, la concezione del pluricellularismo si sviluppa ulteriormente e da nicchie annesse alla camera p rincipale si passa a vere e proprie camerette indipendenti interconnesse con l'ambiente funerario principale, sempre come espressione d i una necessita-volonta d i tenere g li inumati uniti , ma distinti. Questa mutazione structurale dei sepolcri e parte d i un processo evolutivo che comprende la personalizzazione del corredo 89, e l' abbandono della pratica del riuso generazionale 90
, d ementi questi che indicano come
87 Sicilia wd orientale: T hapsos (tt. 6, 32, 38, 48, D, E, Cavallari 1, 2): CAVALLARI 1880, pp. 12 1- 137, figg. 1,3; 0 RSI 1895, coil. 101, 118, 123, 126, figg. 6 , 27, 32, 38; T oMASELLO 1995-1996, pp. 155 -156, 158-160, figg. 88, 90; Cozzo del Pantano (tt. 7, 23): 0 Rsl 1893 b, coil. 20 -25; Plemmirio (t t . 2, 3, 12, 22): 0 Rsr 1891, pp. 118-119, 125, 13 1-132, tav. X; Molinello di Augusta, Petraro di Melilli , Cugno Carrube, Sant'Eligio: ToMASELLO 1995-1996, pp. 160-163, 167-172, figg. 92, 95, 97, 98; Milocca-Matrensa: 0 Rsr 1889, p. 2 12.
Sicilia centro occidentale: Anguilla di Ribera: PANYIN! 1986, p. 114, fig . 8; Sant'Angelo Muxaro: TOMASELLO 1995-1996, pp. 48, 59, 80, 9 3, figg. 23, 47; Milena (territorio): LA RosA 1979 , pp. 153-158, figg. 7b, 8 b, 9b; ToMASELLO 1995 -1996, pp. 136 e 142, figg. 77 e 8 1.
88 Secondo Cazzella il pluricellularismo sarebbe l'espressione di una maggiore diversificazione orizzontale del gruppo sociale: CAZZELLA
1992, p. 335. 89 TANASI 1999b, pp. 278-287 . ~' MANISCALCO 1985 - 1986, p. 258.
352 DAVIDE TANASI
da un aggregato sociale allargato, di tipo clanico, si e passati verso un nucleo composto da meno individui , rna piu coeso, all 'incerno del quale le qualita, le abilica e lo status del singolo vengono curari e riconosciuci: la famiglia. E da queste famiglie, che provengono gli incerlocmori delle genci micenee, quei big men che sull'esclusivita delloro rapporto con gli stranieri e sulla manifestazione costance di essa, fondano le radici del loro pot ere all' incerno del chiefdom 91
.
In tale temperie culturale impregnata di elemenci di derivazione micenea, l'assenza della tomba a tholos a Pancalica suona come una voce fuori dal coro, tantO piu se si considera la massiccia presenza della tipologia tholoide a Moncagna di Caltagirone che con la sua evidenza costituisce una componente imprescindibile della cultura di Pantalica Nord 92
• Tale problematica ancinomia, comba a tholosltomba a camera pluricellulare , che emerge dall 'evidenza di cencri che pure hanna un force denominatore culturale comune di origine micenea, come Pancalica e Thapsos su un piano diacronico e Pancalica e Montagna di Caltagirone su quello sincronico, ancora una volta si chiarisce rivolgendo lo sguardo all 'Egeo.
L'indagine capillare delle evidenze egee fornisce un quadro di coesistenza, gia a partire dal TE I-II, era il tipo della tholos e quello della camera ipogeica, dovuco alla fusione di due filoni culturali , quello della tholos che fa la sua comparsa gia dal periodo ME, verisimilmence per derivazione cretese e quello della tomba a camera che ha le sue radici nella tradizionale tomba elladica scavata nella roccia, attestata sin dagli inizi del periodo Antico Elladico 93. A partire dal TE IliA, nel momento di massima fioritura per l'architettura tholoide, inizia a svilupparsi, su larga scala nelle rombe a camera ipogeica, la tendenza al pluricellularismo in molte regioni della Grecia continentale, con esiti parallelizzabili a quelli siciliani 94 . Dietro al binomio tholosltomba a camera del periodo Tardo Elladico, probabilmence si cela l'ancinomia royal families - high rank families, che porta ad ipotizzare nella socieca micenea una stratificazione verricale che collocava gruppi sociali differenci a diversi livelli di pocere , talvolta subalterno l'uno dell'altro, talvolta indipendence. Nei fruitori delle tombe a camera pluricellulare andrebbe riconoscima, secondo alcuni srudiosi, quella chamber tomb class 95 costituita da elites locali regionali che detenevano grandi fette di potere o in posizione subalterna o in posizione preminence, su vaste zone di periferia rispetto al potere centrale o a volte, avevano il concrollo asso-
~ I L EIGHTON 1996, p . 105. 92 TANASI l 999b, pp. 287- 289. 91 T ANASI 2004, pp. 409-4 20. 91 Peri termini del problema: cfr. PELON 1976,
pp. 442-448; DICKINSON 1994, pp. 224 -227. ?) Tipologie funerarie pluricellulari tardoel-
ladiche nell'Egeo continentale ed insulare: ArnCA - Aliki Glyphadas (tt. A, G, D), TE lilA IIIB (PAPADIMITRIOU 1955, pp. 78 - 99, fig . 1); Atene, Agora (c. XIV), TE IliA 1- A2 (IMMER
WAIIR 197 1, pp. 201-203, pl. 83); Perati (ct. 15, 24, 33,52,57, 122, 130), TEIIIC(IAKOVI-
PER UN R IESAME DEGLI ELEMENT! DI TIPO MICENEO 353
luto di aree centrali 96 . Questa consuetudine dell'inumazione plurima indicherebbe che l'entita sociale in questione si basava su legami di sangue. Dall'analisi dell'evidenza funeraria, il dato piu interessante che emerge e l'aumento, in generale, delle tombe a camera multipla, soprattutto con funzione di inumazione primaria, proprio a partite dal TE IliA. Questa dato non aiuta a capire
DES 1969, figg. 73, 84, 99, 141, 15 1, 139, 152); Spata (t. 2), TE JIB- IIIB (KouMANOUDIS - KA
STORCHIS 1877, pp. 169-172, tav. Z); Varkiza (t.
I, scavi Theocharis 1953, tt. 2-3, scavi Vavritsas
1968), TE IliA- IIIB (TEOCHAR!S 1960, p . 266;
POLYCHRONAKOU- SGOURITSA 1988, pp. 1-106;
VAVRJTSAS 1968 pp. 110 -11 2). Ac:AJA- Aighion (t. 5), TE IIB- IIIA1 (PAPAOOPOULOS 1976, pp.
13-21, p l. 41); Brusari Kalabryton (t t. 1-2),
TEIIIA-IIIB (?), (PAPAPOSTOLOU 1978, pp. 10 1-
102, fig. 6). ARGOLIDE- Aidonia (ct. 3, 6, 7), TE
IIIA-IIIB, (K RISTALLJ -VOTSI 1996, pp. 21 -30);
Argo, Deiras (t. 11, 12, 13, 16, 34, 36), TE
IIIA-IIIB (D ESHAYES 1966, pp. 28 -50, 101-
11 2, pll. I, II, VII); As ine (tt. I: 1, I: 3), TE I-TE
III (FRODIN - PERSSON 1938, pp. 154-161, figg.
134 -1 35); Dendra (tt. 6, 8), TE III, (PERSSON
1942, pp. 20-42, figg. 20 , 37; KoNTORLI PAPA
DOPOULOU 1987, p. 148); Kokla (ct. VI, VII, IX), TE IIIA - IIIB (D EMAKOPOULOU 1982, pp.
83-85 , fig . 1); Micene (tt. 27, 43, 47, 91 (Lo
phou Panag hias), 70, 8 3 (Kalkani), 513, 518
(Kalkani - south hank); t . 5 Asprocamatos
Agriosykia), TE IliA- B (TsoUNTAS 1888, pp.
97, 137, 15 1; lo . 1896, p. 1; WACE 1932, pp.
45-58, 75-87, figg . 2 1, 29; XENAKI
SAKELLARIOU 1985, pp. 59 -60, 92 - 94, 115-116,
119-12 1, 254 - 256, 236, 201- 202, p l. XII; CAVANAGH- M EE 1988, n. 40 a proposito delle
tombe 15, 79, 82 e 99); Prosymna (tt. 3, 25,
26, 33, 36), TE I-III (BLEGEN 1937, pp. 86-92,
93 - 98, 104 -110, 119 -1 23, 180 -1 85, pis. 14,
15, 18, 22, 40; KONTORL! PAPADOPOULOU 1987,
p. 148); 1irinto (t. 8), TE IliA- IIIB (RuooLPH
1973, pp. 55 -59, fig. 7); B erbati, Mo nasti
raki , Nafplion (CAVANAGH -MEE 1998, p . 65, n.
40). BwzrA - Teb e, Kolonaki (tt. 4 , 9, 12, 14,
26, 28), TE IIIA -IIIB (KERAMOPOULLOU 191 7,
pp. 129-136, 141-146, pp. 148-149, 150-159,
194- 203, pp. 204 -208, fig. 89). CJCLADIEllenika, Kimolos ( t. s.n. ), middle LBA? (ScHAJ.UN 1993, p. 99, fig. 40); Phylakopi,
Melos (t. s.n.), middle LBA? (SCHALLIN 1993, p.
104, fig. 49); Kamini , Naxos (t. G ), TE IIIB
IIIC (ZAPHEIROPOULOS 1960, pp. 329 - 340, fig.
3; ScHALLIN 1993, p. 100, fig. 44). CRETA-Mav rospilio (tt. 5, 7, 9), MMIII - TM IliA
(f ORSDYKE 1926 - 27, pp. 256 -269, figg. 8, 15,
19). Eum-Aghia Triada (tt. 1, 6, 7, 21, 32),
TE IIIA - nrc (VrKArou 1999, PP· 237- 251, fig . 3). KYTHERA - K ythera (tt. A, H , E. e t. s.n.),
MM IIIB - TM IB (CmosTREAM - H uxLEY 1972,
pp. 221-252, figg. 62, 73, 78; Im. 1987, pp.
137-148, fig. 33; 0NASOGLOU 1990, pp. 81-83,
fig. 2). LACONIA -Epidauros Limera (tt. 1, 2,
3), TE I- TE IliA-C (D EMAKOPOULOU 1968, p .
145); Lioni (t. B), TE IliA (WATERHOUSE
SIMPSON 1961, fig. 17); Mavrovouni (tt. 3, 5), TE III (WATERHOUSE- SIMPSON 1961, pp. 114-
118, fig. 4); Monemvasia (tt. A-B), TE IIIB
(CHRISTOU 1956, pp. 207-210, figg. 1-2); Sykea
(t. s .n .), TE IIB-IIIA (STAiNCHAOUER 1973-
1974, pp. 294 -295, fig . 6). MESSENIA - Kepha
lov risso (tt. 5-7), TE IIIA (0RLANDOS 1965, pp. 76-92, fig. 91); Volimidhia (tt. 5, 7, 9), TE III
(MARINATOS 1953, pp. 238- 250, fig. 1, 6); Pylos
(T. E6), TE IIIA2 - IIIB (BLEGEN - R AWSON
TAYLOUR-DONOVAN 1973, pp. 184-187, fig.
339); Ellenika, Tsangli (t. 4), TE IIIA1 (Ko u
MOUZELIS 1996, pp. 1221-1228, fig. 4). Rom
Pylona (tt. 2, 5), TE IIIA2 - IIIB (K ARANTZ.ALI
1998, pp. 87-99, fig . 3; KARANILALI -PONTING
2000, pp. 2 19-238, figg. 1-2). A proposito di
Cipro: cfr. TANASI 1999b, pp. 310-311. %ALDEN 1981, p . 321.
354 DAVIDE TANASI
se di tribu, clan o famiglia si trattasse o meno, rna evidenzia comunque come, a partite da questo periodo, in seno al gruppo si sia sviluppata una volonra di distinguere alcuni membri, pur tenendoli assieme agli altri consanguinei. Cio rispecchierebbe una relativa affermazione del singolo entro il macro gruppo sociale, tradendo una spinta evoluriva verso forme di aggregazioni allo stesso tempo piu piccole e piu complesse. Sintomatico resta il fatto che questa tendenza al pluricellularismo, attestata ampiamente per le tombe a camera, non sia riscontrabile per le tholoi vere e proprie, rna solo per le tombe a camera a profilo tholoide 97
. Cio potrebbe voler dire che le «oligarchie» delle tholoi erano estranee a quel percorso evolutivo essendo esse organizzate in maniera rigidamente piramidale in modo che un solo individuo potesse elevarsi al di sopra degli altri, negando qualsiasi desiderio di egalitarismo crescente negli altri gruppi sociali.
Il quadro conclusive ci offre l'evidenza di una massiccia affermazione del pluricellularismo applicate aile tombe a camera tra il TE IliA ed il TE IIIB (graf 3), tombe nelle quali g li spazi funerari accessori sono nella maggior parte dei casi destinati ad inumazioni primarie (jigg. 18 -23). Nel TE IIIC, e possibi le invece osservare una flessione nello sviluppo di questa tipolog ia funeraria, concomitante con 1' impoverimento delle necropoli e la semplificazione e standardizzazione delle sepolture che caratterizzavano t ale periodo. Come la tomba a camerone, cos'i anche la tomba a camera pluricellulare si configura quale tipologia funeraria tipicamente micenea, regolata da precise variabili cronologiche, regionali e sociali. L'utilizzo di essa nell 'Egeo, da parte di elites emergenti che co-governavano rispetto ad un potere centrale, ci consente di riconoscere in tale tipologia sepolcrale la stessa pregnanza semantico-culturale che sino ad oggi ha avuto la tholos.
Ritornando all 'evidenza di Pantalica, alla luce di questi dati, e innegabile che quella sospetta inversione di tendenza, rispetto alla crescita del fenomeno della c.d. miceneizzazione, relativa all'assenza delle tombe a tholos, si rivela senza fondamento. Nelle sue necropoli sono, dunque , attestate , in alternativa alla tholos, ben due tipolog ie funerarie di derivazione micenea, fatto questo che diventa peculiare nel quadro delle influenze micenee che investono il si to.
Per giustificare, quindi, il fenomeno dell 'assenza delle tombe a tholos ed in particolare della presenza delle piu attestate tombe a camera multipla di Pantalica e possibile formulate due ipotesi: A. 11 centro di Pantalica si sarebbe mostrato ricettivo verso «sorgenti diverse» rispetto a queUe che avrebbero «imposto» il tipo della tomba a tholos in
97 CAvANAGH - M EE 1984, p. 49; Ioo. 1990, pp. 55-57; Vou TsAKr 1995, p. 62.
PER UN RIESAME DEGU ELEMENT! DI TIPO MICENEO 355
Sicilia, iporesi supportata dalla presenza, di una ripologia funeraria micenea alternariva - il camerone - che resrimonierebbe il coinvolgimento di alrre enrica portacrici di differenti inputs culturali. Nella ricerca di tali sorgenti si pocrebbero forse prendere a presriro i modelli commerciali basari sull'attivira dei freelancers, che inquadrerebbero le genri micenee in rapporto con Pantalica come classi di mercanti semi indipendenri, al di fuori delle logiche e delle seraregie commerciali del porere centrale 98
.
B . Un'iporesi alrernariva potrebbe essere invece che la presenza-assenza delle due tipologie rombali in Sicilia dipenda da una diversira cronologica dei modelli. Infarci , un daro importance che emerge dalla noscra analisi, illuminance per la comprensione dell'antinomia tra di esse nell'Egeo, e la consracazione che le due ripologie funerarie - romba a tholos e romba a camera pluricellulare -, pur conremporanee, era il TE III A e III B, possono essere ricondorre chiaramenre a due momenri cronologici differenti: la diffusione del cipo della romba a tholos essenzialmenre al periodo TE IliA (1425 -1 300 a. C.), e quella della romba a camera, semplice o mulripla, solo a partite dal TE IIIB (1300-1230 a.C.), in concomiranza con l'esaurirsi della cosrruzione di nuove tholoi o del riuso di quelle piu antiche. Da un punta di vista cronologico, l'introduzione in Sicilia della romba a camera pluricellulare, nuova ripologia funeraria di derivazione micenea, dovrebbe essere avvenura nel corso del periodo TE IIIB, momenta in cui nell'Egeo il fenomeno del pluricellularismo raggiungeva il suo massimo sviluppo, ovvero in concomitanza con la fase iniziale della cultura di Pantalica Nord. Con lo sresso meccanismo per cui la ricezione dell'idea della tholos sarebbe srata facilitata, nella facies di Thapsos, dalla forte rradizione fossoria indigena, cos! nel momenro di Panralica Nord, la ricezione-applicazione del modello della romba a camera pluricellulare verrebbe accelerata dal recupero della rradizionale rendenza al pluricellularismo. Dunque alla base della fortuna delle due ripologie funerarie di derivazione micenea nella Sicilia indigena srarebbe sempre la possibilira di rirrovare nel concerto allogeno importato l'eco di un elemento culrurale ben radicaro nella tradizione, che con opportuni restyling produrrebbe i ripi originali a noi noti della tomba a camera tholoide e della tomba a camera pluricellulare.
9H Rig uardo a! pluricellularismo delle rom
be a camera tholoide cfr. TOMASELLO 1995-1996, figg.llO, 112,116,117, 123 .L'unicoesem
pio di aumenro o duplicazione dello spazio funerario arresraro per le tholoi e il caso della <<Camera del resoro», riccamente decorata, che pub riproporre Ia forma dell 'ambiente funera-
rio di base o che a volre ospita l'inumazione prin
cipale, o delle nicchie o ambienri annessi lungo
il dromos con funzioni di ossari. A p roposiro delle camere annesse nel Tesoro di At reo, nel Tesoro di Minias e nella tholos A di Archanes cfr. W ACE
192 1- 1923, pp. 283-402; ( AVANNAGH-MEE
1999. p. 63.
356 DAVIDE TANASI
IX - Conclusioni La conclusione di questa lunga disamina ci porta a delineate un quadro in
cui la stragrande maggioranza degli elementi di derivazione micenea che permeano la cultura di Pantalica Nord si rivela del tutto originale, ovvero non mediata dalla tradizione thapsiana. Cio ci consente di ipotizzare che Pantalica sia stata investita da una seconda ondata di influenze micenee, diversa nelle forme e nei modi rispetto alia prima che raggiunse Thapsos. Recenti ricerche condotte riguardo alia riconsiderazione dell'impatto miceneo sulla cultura di Thapsos, hanna evidenziato come il momenta del massiccio contatto iniziale dei gruppi micenei con la costa orientale siciliana, la cosiddetta prima ondata, possa essere datato trail periodo TE IIIA1 e il TE IIIB1 (1430- 1270 a.C.), sulla base di uno studio ragionato dei materiali d i importazione e di un'analisi delle influenze sulle architetture99 . Rag ion per cui la seconda ondata che ha investito Pantalica non pub che essere collocata a partire dal TE IIIB2 (1270-1230 a.C.), momenta in cui Thapsos come emporia era in pieno declino. Ma all 'inrerno degli elemenri di derivazione micenea propri della cultura di Pantalica Nord e ancora possibile fare una distinzione tra quelli che si addensano intorno al TE III B 2 ed un piccolo gruppo, riferibile genericamente al TE III C (1230-1050 a.C.) che si configura come il prodotto di una terza ondata di miceneizzazione (tabb. 1, 2).
In tal modo dimostrando che a partire dal 1270 a.C., Pantalica, fondata per effetto di una filiazione thapsiana, prende il posto della stessa Thapsos, nel ruolo di reference locale delle genti micenee, assorbendo influenze micenee del tutto nuove fino alia fine dell 'XI secolo, l'ipotesi a suo tempo proposta da Bernabo Brea rroverebbe nuovo supporto 100
•
In ultima analisi e inevitabile confrontarsi con due ordini d i problemi:
1. 11 problema della mediazione costiera di questi nuovi elementi di derivazione micenea per il centro montana d i Pantalica, centro che si configura, al pari di Thapsos nel periodo precedence, il partner pili cospicuo delle genti micenee che frequentavano la Sicilia sud-orientale. 2. 11 problema della natura della frequenrazione micenea di seconda e terza ondata.
Nell'era del Bronzo Media, il centro di Thapsos, si e rivelato, in effetti , come il polo principale d i attrazione delle influenze micenee, olt re che il sito che ha resti tui to il maggior numero di oggetti d i importazione. Ma ulteriori elementi d i derivazione micenea, talvolta del tutto nuovi rispetto a quelli documentati a Thapsos, fanno tuttavia la lora contemporanea comparsa nei
99 WARREN 1991 , pp. 295 -299; LIVERANI
1986, pp. 410-41 1; KILLEN 1988, pp. 265-270; MARAZZI 1989, pp. 85 - 86; L EPORE 1986,
pp. 315- 322; cfr. ora anche MILJTELLO 2004. IOU ALBERTI 2004 , pp . 140- 14 1.
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! DI TIPO MICEN EO 357
centri dell 'area costiera presso Ia · moderna Siracusa. lntend.iamo riferirci a Cozzo del Pantano, Plemmirio, Marrensa e Siracusa. La romba a tholos <<progredita» con scodellino a calotta pendula all'apice (Plemmirio) 101
, i vasi di importazione micenea (Plemmir.io, Cozzo del Pantano, Matrensa e Siracusa) 102
,
Ia g rand e spada d.i tipo Sandars B evoluro e .il pettine d'avorio (Plemm.ir.io) 103
e il sig illo di tipo levanro-cipriota (romba dell 'Ara d i Ierone II a Siracusa) 104,
dimostrano come intorno all 'area costiera alia foce dell 'Anapo s.i addensasse un altro polo d'attrazione delle influenze m.icenee, ver.isimilmente minore rispetto a Thapsos, per il quale si potrebbe ipotizzare Ia presenza di un piccolo approdo portuale proprio nel Porto Grande di Siracusa, in posizione «gerarchicamente» inferiore, nella scala d 'importanza commerciale e strateg ica, rispet to al g rande emporia di Thapsos. L' ipotesi di un approdo siracusano potrebbe spiegare Ia polarizzazione in quest 'area di elementi di derivazione micenea diversi rispetto a quelli di Thapsos e g iustificare allo stesso tempo Ia penetrazione delle influenze micenee nell 'entroterra montana degli Iblei, aile sorgenti dell 'Anapo. La tomba di contrada Maiorana d i Buscemi 105
, a 900 m di quota sui mass iccio del Lauro, che ha restituito un'anfora a Staffa micenea del TE III B 1 finale e ceram ic he di t ipo Thapsos, potrebbe essere il r.isultaro della penet razione montana delle influenze micenee propagates! dall 'app rodo siracusano, lungo Ia via fluviale dell 'Anapo. L'altra ipotesi della locali zzazione di uno scalo marittimo, che potesse fungere da trait-union tra le genti d 'oltremare ed il centro di Pan talica, alla foce del vicino fiume Marcellino, nella cui media valle, come e noro, sono stat e scoperte rombe con mater.iale di tipo precoloniale datab.ile a! secondo quarto dell 'VIII secolo a. C. , senza il fondam ento di nuove esplorazione archeolog iche, si rivela allo staro at tuale meno valida 106
•
L'altro nodo problematico e costituito dall 'interpretazione della natura dei contatti di seconda ondata tra le genti micenee e g li indigeni d.i Pantalica 107
.
L' ipotesi piu plausibile e che Ia frequentazione fosse sempre di t ipo commerciale, rna sviluppata su una scala completamente ridimensionata nei tempi e nei modi. 11 commercia miceneo, alia base della seconda ondata, che a magg ior rag.ione all 'indomani della caduta dei palazzi, e verisimilmente organizzato e gestito da gruppi di ricchi entrepreneurs, legati alle aristocraz.ie regionali o aile stesse famig lie reali ormai in declino. L' abbandono dei centri costieri della facies di Thapsos e il popolamento delle montagne, si config ura, come e nota, come il fatro salience del momenta di passaggio tra Ia Media e Ia Tarda era del Bronzo, ascrivib ile forse alia paura di un'incombente minaccia provenience dall 'esterno
101 B ERNAIJC) B REA 1990 , p . 4 1.
10 2 0RSI 1899b, p . 27, fig . 1. 10 1 LA RosA 1993- 1994, p. 24. 104 0RSI 1899b, pp . 31- 32 , figg. 7, 9.
wsLA RosA 1993 -1 994, p . 24 , nora 68 . 10r. 0RSI 1898, p. 164 . 10 7 A ral proposiro: cfr. F RASCA 1996, p. 143;
A LllAN ESE - P ROCELLI 1996, p. 168 .
358 DAVIDE TANASI
e necessariamente concomitante col processo di evoluzione socio-politica di polarizzazione dei piccoli insediamenri in g randi cenrri montani ben difesi.
Tale fenomeno e la riduzione in scala del commercia miceneo, potrebbero aver determinato la scelta, da parte dei partners d'oltremare, di utilizzare come scalo quell'approdo siracusano, gia in uso dal periodo precedenre, che garanriva la penetrazione lungo l'Anapo fino a Pantalica, dove g li indigeni si erano arroccati. Veniva in tal modo scartata del tutto la penisola di Magnisi (probabilmenre spopolata) i cui vanraggi log istici non si rivelavano sfruttabili nella nuova situazione venutasi a creare da ambo le parti. In questo senso, sintomatica sarebbe la presenza di almeno due necropoli certamenre ascrivibili alla facies di Panralica Nord in conrrada Gerame e Gufara di Buscemi 108
, in zone limitrofe alla cootrada Maiorana, oltre che l'attestazione di livelli di frequentazione , nella stesso periodo, ad Ortigia 109
, rispettivamenre alle sorgenti e alla foce, quindi, dell'Anapo. La g rande quantita d i elemenri d i derivazione micenea, nuovi rispetto a quelli di Thapsos, che caratterizzano la cultura di Paotalica Nord, possono dunque aver investito in maniera diretta il centro di Pantalica solo ammettendo la possibi lica, in questa periodo, di un terminale marit t imo, cui il sito montana poteva fare riferimenro, probabilmente localizzato nelle aree ind iziate per g li approdi nel periodo precedence. Attraverso quegli stessi canali di approvvig ionamenro, le sparute influenze micenee della successiva, ed ultima, terza ondata, riferibile al TE III C, raggiungono ancora Paotalica, sancendo la fine delle relazioni micenee con l 'Isola e l 'inizio di quei centuries of darkness che precedono la frequentazione pre-coloniale della Sicilia.
L'ultimo daro che si porrebbe tenrare di mettere in evidenza, alla fine di questo riesame complessivo degli elemenri d i derivazione micenea reg isrrabili a Paotalica, come sito guida della cultura eponima, sarebbe quello relativo alla definizione delle aree di partenza delle influeoze di seconda e terza ondata. Basandosi, con tutti i risch i del caso, sulla localizzazione dei confronti per la ceramica, i bronzi e l 'archi tettura funeraria (graf 4) ed aggiungendovi i risultati di una ricerca parallela effettuata per le influenze di prima ondata, si ottiene come work in progress il seguente risultato 110
•
Da questa schematizzazione, necessariamente parziale, si evince come le regioni che si candiderebbero magg iormente al ruolo di interlocutori micenei deg li indigeni della Sicilia sud orientale, siano 1' Argolide e la Messenia, eotrambe sedi del potere palaziale miceneo, seguite dall 'Elide e dall 'Acaia, cui si aggiunge Cipro , per il periodo relativo alla prima ondata. La seconda ondata vedrebbe ancora il coinvolg imento in primo piano dell 'Argolide e della
'"" 0 RSI 1898, p . 164 . 110 T ANASI 2000, pp. 58-59. 109 V 01.A 1999, p . 23, fig . 13.
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! DI TIPO MICENEO 359
Messenia, cui si sarebbe aggiunta· la Laconia, seguita dall'Attica e da Rodi, quest'ultima destinata a diventare una delle future basi di partenza dei mercanti freelancers micenei.
In concomitanza con la terza ondata, in un momenta in cui le ultime autorid palaziali sono ormai in completo declino, il ruolo di maggiore rilievo sarebbe g iocata dall'Attica, non a caso la regione che ha restituita l'evidenza della piu importante necropoli del TE IIIC, quella di Perati, e nella quale forse meno dovette accusarsi il trauma del tracollo palatino, e da Rodi dove molti gruppi micenei dovettero trovare rifugio dopo la cad uta dei palazzi (tab. 3).
In conclusione, i risultati delle ricerche da noi condotte sinora hanno dimostrato come quel forte interesse che le genti egee avevano da sempre manifestato per la Sicilia, soprattutto orientale, sin dall'era del bronzo antico, non sia per nulla diminuito al tempo di Pantalica Nord. E questa il momenta in cui un potente centro indigeno, alle soglie dell'esperienza urbana, sede di una ranked society culturalmente miceneizzata, per eredita e per rinnovata e reiterata contatto sempre mediata da un terminale costiero, raccolse g li ultimi echi della civilra micenea e forse, parafrasando il titalo di un lavoro di Benzi e Graziadio 11
\ offri ospitalira anche a quei Last Mycenaeans in Sicily che ormai alia fine della parabola politico-commerciale - in madrepatria e sui mari -rifluivano come profughi nelle periferie di quello che un tempo era stata illoro grande impero marittimo.
DAVIDE TANASI
I ll B ENZ! - G RAZIADIO 1996, pp. 95 -138.
360 DAVIDE TANASI
TE IIIB2 TE IIIC
Anfora cuoriforme (FS 58) Broccherta 133 N Askos con botrone sommitale (FS 195) Armi di tipo F Sandars
H ydria quadriansata (FS 64) Armi con manico a testa d'oca Coperchio a campana (FS 335) Specchi con codolo
Patera (FS 208) Fibula ad arco sem plice Teiera a crivello (FS 15 5)
Armi di tipo ibrido A/B Sandars Specchi senza codolo
Fibula ad area di violino Tom be a camera pluricellulare
Anelli d 'oro Anaktoron (esavani)
Anaktoron (aggiu nra vani A, B, L)
TAB ELL,\ 1 - ELEMENT![)[ DERIVAZIONE MJCEN EA RELATIVJ ALLA SECONDA E ALLA TERZA ONDATA.
Prima Ondata Thapsos TE IliA 1 - TE IIIB 1
Seconda Ondata Panralica TE IIIB 2
Terza Ondata Pantalica TE me
T ABELLA 2 - RIEPILOCO CRONOLOGICO DELLE ONDATE.
Prima ondaca Argolide, Messenia, Elide, Acaia, Cipro (TE IliA 1 - IIIB2)
Seconda ondata Argolide, Messenia, Laconia, Att ica, Rodi (TE IIIB2)
Terza ondaca Attica, Rodi, Cipro? (TE IIIC)
T ABELI.A 3 - AR EE DELL' EGEO POTEN ZIALMENTE COfNVOLTE NEI RA PPORT! CON LA SICILIA SUD-ORIENTALE.
PER UN IUESAME DEGLI ELEMENT! DI TIPO MICENEO
fiG. 1 - f oTO AREA DELL' AREA ARCHEOLOGJCA Dl P ANTALICA CON INDICAZIONE DELL'ANAKTORON
E DEl GRUPP! Dl NECROPOLI (DA VOZA 1980).
361
FIG . 2 - VASI A STRAI.UCIDO ROSSO DELLA CUI.TURA Dl PANTA
I.ICA NoRD DAL Musw P AoLo ORsJ DJ SIRACUSA.
FIG. 3 - BROCCHETTA DELLA TOMIJA 133 N
01 PANTALJCA (DA L A R osA 1989).
362 DAVIDE TANASl
6
8
11 12
fiG. 4 - TAVOLA COMPARATIVA T RA LE SEI PR INCIPAL! FORME Dl DERIVAZ IONE MICENEA DELLA CULTURA Dl
PANTALICA NoRD, IN ORDINE A SINISTRA: ANFORA INV. 2 1263 (M. SR .), HYDRIA INV. 23199 (M. SR.),
TEJERA A CRIVELLO INV. 233 14 (M. SR.), PATERA (0RSI 1912), ASKOS !NV. 23313 (M. SR.), COPERCHIO
A CAMPANA INV. 23320 (M. SR.), ED I CORRISPONDENTI PROTOTIPI MICENEI, A DEST RA IN ORDINE: fS 58, FS 64, FS 155 ( D OH!. 1973), F S 208, FS 195, FS 335 ( F URUMARK 1992).
PER UN RIESAME DEGU ELEMENT! Dl TIPO MICENEO 363
FIG. 5 - A) SPADA DALLA T. 68 N (0Rsl 1 899A); B ) PuGN ALE DALLA T. 8 N ( O RSI 1899A);
C) SPADA MINIATURISTICA DI CLASSE F SANDARS DALLA T. 48 N ( ORSI 1899A).
D
0 1 2 ,
l..! I. :.... I
F IG. 6- P IANTA DELL'ANAKTORON Dl PANTA
U CA CON l: lNDICAZIONE DELLE DUE PRI NCIPAL)
FASI EDILJZIE ( DA B ERNABO BREA 1 990).
364 DAV!DE TANASI
F IG . 7 A - SPECCHIO llRONZEO DALLA T. 3 7 N Dl P ANTALICA (DA P IU!Ili\ S IUUt\) .
F IG. 7B- S PECCHIO llRONZEO DALLA T. 7 Dl D ENDRA
( D EMAKOPOULOU 1988, P. 244).
a F IG. 8 A - FIBULA AD ARCO Dl VIOL! NO
CON NODULI DALLA T. 3 7 Dr P ANTALICA
(DA PRlt\1!\ S JCILII\).
a 'i
o· ·~-F IG. 8B-C - (IN AUO) FIBULA AD ARCO OJ VIOLINO DALLA T. 61 Dl
MKENE (XENAKI- SAKELLARiou 1985); (IN BASSO) F m uLA AD
ARCO Dl VIO!.INO DAL T EICI IOS D YMAION ( PAPADOPOULOS 1979).
' .. - ~-
FIG. 9 A - SPECCHIO DAI.LA T.
1 4 0 N 01 P AKTALICA (Lo
SCH IAVO - MACNAMARA -
FIG. 913 - SPECCHIO DALLA T. F IG. LOA-IJ - ( IN AI.:ID ) FIBULA AD ARCO
VAGNETTI 1985 ) .
61/2 1 Dl l ALJSOS(B ENZI 1992). SEMPLICE DALLA T. 3 N Dl P ANTAU CA (DA
P111AIA SIC/Uti); (IN BASSO) F IBULA AD ARCO
SEMPLICE DALLA T. 1 2 N Dl ALONAKI -
ELATEIA (DEMAKOPOUI.OU 1988).
FIG. i l A-Il - (A SIN ) . A NELLO AUREO DALLA T. 142
s [)I PANTALICA (DA P!ilt\IA SICILIA); (A DEST.) A NELLO
A UREO DALLA NECROPOLI NoRD Dl PANTA LICA
(BERNAIIC) BREA 1 9 5 8) .
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! DI TIPO MICENEO 365
F IG. 12 - P ANTAL!CA, 'IT. 101-105 N (DA 0 RSI 1899).
FIG. 14- P ANTALICA, T. 56 N ( DA 0RSI 1899).
FIG. 16 - PANTALICA, T. S.N. NO (DA 0RSI 1899).
FIG. 13 - P ANTALICA, T. S. N. C AVETTA
( DA 0 RSI 1899).
FIG. 15 - PANTALJCA, IT. 12-16 N (DA 0 RSI 1899).
FIG. 17 - P ANTALICA, T. 22 NO ( DA 0RSI 1899).
366 DAVIDE TANASI
FJG. 18- PROSYMNA, T. 25 ( DA B LEGEN 1937).
fiG . 20 - PYLONA, T. 2 (DA
KARANTZALT 1998).
F IG. 22 - M AVROSPILJO, r . 9 (DA F o RSDYKE
1926 - 1927 ).
F IG. 19 - K YTHERA, T. E ( DA COLDSTREAM
H uxLEY 1972).
..-·"""·····
i i
\ .. ·
f iG . 21 - K YTHERA, T. S.N. (DA 0NASOGLOU 1990).
F IG. 23 - A SINE, T. 1.1 ( DA FRODIN
P ERSSON 1938).
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
~ ~ -~ ~ ~ ~ -~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ '?-c; o~ ...... ~ (J'- !Qo . ~~ <;J '-~ 0<-" . 0~ ~'I> ~'-' ~ ~o
'?-~ '\>' ~~ qj &" v ~ ~~ ~~ ~'I> < (J {-'~> +-"'~
o"' ~'l> ~o"' ~'l> o"' o"' ~ ~'l> &o ~ c,O ~q; '?>q; ~'?>-'<' ~~ <J::-0 '?>'?>~ 0~
'v'l> ~"'" ":) -<.. "'"
GRAF. 1 - D IFFUSIONE DEl PROTOTIPI DELLE SEI FORME Dl DERIVAZIONE MICENEA NELL'EGEO NEL CORSO DEL TE Ill B.
• Fs 58 OFS 64
OFS 155
lliiFS 195 fSFS 208 [] FS 335
"" m ;.:>
~ ;.:>
~ i:: m
~ C) t:: m
I S2 ....; :a 0 i:: Pi m z m 0
\j.)
0\ -...J
23
22
21
20
19
18
17 16
15
14
13
12
11
10
9
8 7 6
5 4
3 2 1
0
~ ~ -~ -~ ~ -~ -~ ~ -~ -~ ~ ~ ~ ~ '?-<J o' .._..:5 (f 'llo . ~..:5 <(J ,.J> 06- . 0..:5 ~'li {:'<::< ~ ~o
"?-~ "?- ~o; ~ o'"' "" « «..:5 ~ ~1> ' c; *-1> *-'llq
+o"' ~~ }..o"' ~~ o"' o"' 0"tY ~~ &o (Jo ~e; ~e; ~~-+' ~-t ~ .,~o; oq
v'li ~'ll" C:l -<-'ll"
GRAF. 2 - D IFFUSIONE DEl PROTOTIPI DELLE SEI FORME Dl DERIVAZIONE MICENEA NELL'E GEO NEL CORSO DEL T E Ill C.
• Fs 58 OFS 64
OFS 155
151 FS 195
~FS 208
!TIIFS 335
<..» ~ 00
0 > ~ 0 t":1
:;;l z > ~
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! OJ TIPO MICENEO 369
80
71 70
60
so
40
30
21 20
10
0 MEIMC TE 1-11 /MM 1118 - TMIB TEIIIA-B TE Ill C
GRAF!CO 3 - T OMllE A CAl\{ERA Dl 'llPO PLURICELLULARE TRA IL MEDIO ELLADICO E IL TAROO ELLADICO III A-B-C.
25
22
20
15
10
5
0
0~ <;:·,0'1(- ~«, ~~ {)" ~0 ~«, 0$ #' ~'
ov ~0 o0v 0~ «,Y ..p">v; ~0 '?' "(- ~0 ~ '1(-c
y
G RAFICO 4 - D tFFUSIONE DELLE TOMBE A CAMERA Dl TIPO PLURICELLULARE NELLE REGION! DELL'Ec;EO CONTL'IENTALE ED
INSULARE E A CtPRO TRA IL TE III A E IL TE III B.
Cultura di Thapsos Cultura di Pantalica Nord
6 ve FS 149 FS 45 FS 114
G a g FS 84 FS 94 FS85
~ FS 220 9 Q ~
FS 219 FS256 FS 263
9 ~ c5 FS284 FS236 FS 171
/Q. ~ @~~
FS 87 FS 156 FS 238
Forme di derivazione micenea comuni aile
\ due culture
oOO FS 58 FS64 FS 69
'6~ FS 155 FS 195
v~ @ '
~ FS 196 FS 199
Forme di derivazione (imitazione) micenea
FS208
Forme di derivazione (importazione /o imitazione) micenea
relative alia prima ondata di miceneizzazione relative alia seconda ondata di miceneizzazione
)
GRIIFICO 5 - D IIIGRIIMMII COMPII RIITIVO TRII LE FORME DI DERIVIIZIONE MICENEA DELLA FACIES Dl T HAPSOS E QUEUE Dl P ANTALICA N ORD CON INDICAZIONE
DELLE TIPOLOGIE FORM/ILl COMUNI ALLE DUE CULTURE.
\.» -...J 0
0 ~ 8 m
~ > ~
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! OJ TIPO MJCENEO 371
BIBLIOGRAFIA
ALBANESE 1988-1989 = R .M. ALBANESE, Calascibetta (Enna) - Le necropoli di Malpasso, Calcarella e Valle Coniglio, in NSc sr. 8, suppl. 7, XLII-XLIII, 1988-1989, pp. 161-398.
ALBANESE PROCELL! 1996 = R.M. ALBANESE PROCELLI, Greeks and indigenous people in eastern Sicily, in R . LEIGHTON (ed.), Early Societies in Sicily. New developments in archaeological research, London 1996, pp. 167-176.
ALBANESE PROCELL! 2000a = R.M. ALBANESE PROCELL!, Il repertorio vascolare della necropoli di Madonna del Piano presso Grammichele (Catania), in SicArch XXXIII, 2000, pp. 167-180.
ALBANESE PROCELLI 2000b = R.M. ALBANESE PROCELL!, Bronze metallurgy in protohistoric Sicily. The stone moulds, in D. RIDGWAY- F.R. SERRA RIDGWAY, M. PEARCE, E. HERRING - R.D. WHITEHOUSE -J.B.WILKINS (edd.), A ncient Italy in its Mediterranean Setting. Studies in honour of Ellen Macnamara, London 2000, pp. 75-90.
ALBANESE PROCELL! 2001 = R.M. ALBANESE PRocEw, L'agro netino nella protostoria: economia e organizzazione sociale, in F. BALSAMO - V. LA RosA edd., Contributi alia geografia storica dell'agro netino (Nato, 20-31 maggio 1998), Rosolini 2001, pp. 5 5-72.
ALBANESE PROCELL! 2003 = R .M. ALBANESE PROCELL!, Sicani, Siculi, Elimi. Forme di identita, modi di contatto e processi di trasformazione, Milano 2003.
ALBERTI 1999 = M.E. ALBERTI, Il sistema ponderale egeo tra ornogeneita e flessibilita: conrinuita e disconrinuita tra il mondo minoico e quello miceneo, in Epl ponton plazomenoi, pp. 339-35 1.
ALBERTI 2004 = G. ALBERTI, Contributo alla seriazione delle necropoli siracusane, in Atti del Primo simposio siracusano di preistoria siciliana (Siracusa, 15-16 dicembre 2003), Padova 2004, pp. 99-170.
ALDEN 1981 = M.J. ALDEN, Bronze Age Population Fluctuations in the Argolid from the Evidence of Mycenaean Tombs (SIMA pocket book, 15), Goteborg 1981.
ALMAGRO GORBEA- FoNTES, 1997 = M. ALMAGRO GoRBEA - F. FoNTES, The introduction of wheel-made pottery in the Iberian peninsula: Mycenaeans or Pre-Orientalizing contacts?, in OJA XVI, 1997 , pp. 345-361.
Atti e Memorie I = Atti e Mernorie del Primo Congresso Internazionale di Micenologia (Rorna, 27 settembre- 3 ottobre 1967), Roma 1968.
Atti e Memorie II = Atti e Memorie del Secondo Congresso Internazionale di Micenologia (Roma-Napoli, 14-20 ottobre 1991), Rorna 1996.
BENZ! 1992 = M. BENZ!, Rodi e Ia civilta micenea, I-II, Roma 1992.
BENZ! 1996 = M. BENZ!, Problems of the Mycenaean expansion in the southeastern Aegean, in Attie Memorie II , pp. 947-979.
372 DAVIDE TANASI
BENzr- GRAZIADIO 1996 = M. BENZI-G. GRAZIADIO, Last Mycenaeans in Italy?, in SMEA 38, 1996, pp. 95-138.
BERN ABO BREA 195 3-1954 = L. BERN ABO BREA, La Sicilia prehistorica y sus relaciones con Oriente y con la Peninsula Iberica, in Ampurias XIV-XV, 1953-1954, pp. 137-235.
BERNABO BREA 1956 = L. BERNABO BREA, Akrai, Catania 1956.
BERNABO BREA 1958 = L. BERNABO BREA, La Sicilia prima dei G reci, Milano 1958.
BERNABO BREA 1976-1977 = L. BERNABO BREA, Eolie, Sicilia e Malta nell 'era del bronzo, in Kokalos XXII-XXIII , 1976-1977, pp. 33-39.
BERNABO BREA 1990 = L. BERNABO BREA, Pantalica. R icerche intorno all'anaktoron, (Cahiers du centre j ean Berard, XIV), Napoli 1990.
BIErrr SESTIERI 1979 = A.M. BIETII SESTIERI, I processi storici nella Sicilia orientale fra la tarda era del bronzo e g li inizi dell' era del ferro sulla base dei dati archeologici, in A tti XXI Riunione Scientifica I.I.P.P. , Firenze 1979, pp. 599-630.
BrETII SESTIERI 1997 = A.M. BrETII SESTIERI, Sviluppi culturali e socio-politici differenziati nella tarda era del bronzo della Sicilia, in Prima Sicilia, pp. 473-491.
BLEGEN 1937 = C.W. BLEGEN, Prosymna, Cambridge 1937.
BLEGEN -RAWSON- TAYLOUR-DONOVAN 1973 = C.W. BLEGEN- M. RAWSON- W. TAYLOUR- W. P. DoNOVAN, The Palace of Nestor at Pylos in Western M essenia, III, Princeton 197 3.
BouzEK 1985, = ). BouzEK, T he A egean, A natolia and Europe: cultural interrelations in the second millennium B.C. (SIMA , 29), Goteborg 1985.
CASTELLANA 2000 = G. CASTELLANA, La cultura del M edio Bronzo nell'agrigentino ed i rapporti con if mondo miceneo, Agrigento 2000.
CATLING 1964 = H .W. CATLING, Cypriot Bronzework in the Mycenaean world, Oxford 1964.
CAVALLARI 1880 = F.S. CAVALLARI , Thapsos, in ArchStorSic V, 1880, pp. 121-137 .
CAVANAGH 1987 = W. CAVANAGH, Cluster Analysis of Mycenaean chamber tombs, in R. LAFFINEUR (ed .), Thanatos. L es coutumes funiraires en Egie a l 'age du Bronze, Aegaeum 1, 1987, pp. 161-169.
CAVANAGH- MEE 1984 = W. CAVANAGH- C. MEE, Mycenaean tombs as evidence for social and political organisation , in O]A, 3, 1984, pp. 45-64.
CAVANAGH- MEE 1990 = W CAVANAGH -C. MEE, T he Locations of Mycenaean Chamber Tombs in rhe Argolid, in R. H AGG- G .C. NoRDQUIST (edd.), Celebrations in Death and D ivinity in the Bronze A ge Argolid, Proceedings of the Sixth International Symposium at the Swedish Institute at A thens, 11 -13 J une 1998, Stockholm 1990, pp. 55-64.
CAVANAGH - MEE 1998 = W. CAVANAGH - C. MEE, A Private Place: Death in Prehistoric Greece (SIMA, 125), Jonsered 1998.
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! DI TIPO MICENEO 373
CAZZELLA 1992 = A. CAZZELLA, Usi funerari nell'Italia meridionale e in Sicilia nel corso dell ' era del bronzo: una riconsiderazione, in La Sardegna nel Mediterraneo tra if bronzo medio e if bronzo recente (XVI-XIII sec. a. C.), Atti de/Ill Convegno di studi «Un millennia di relazioni fra Ia Sardegna e i Paesi del Mediterraneo » (SelargiusCagliari, 19-22 novembre 1987), Cagliari 1992, pp. 331-341.
CHRISTOU 1956 = CI-1. CHRISTou, Anaskaphi en Monembasia, in Prakt 1956, pp. 207-210.
CoLOSTREAM- H UXLEY 1972 = J.N. CowsTREAM- G.L. H uXLEY (edd.), Kythera, Excavations and Studies, London 1972.
CoLDSTREAM- H uXLEY 1987 = J.N. CowsTREAM- G.L. H uXLEY, Die Minoer auf Kythera, in H.G. BucHHOLZ (ed.), Agiiische Bronzezeit, Darmstadt 1987.
CuLTRARO 1998 = M. CULTRARO, La cultura di Pantalica Nord in Sicilia nei suoi rapporti con il mondo egeo, in Protovillanoviani elo Protoetruschi: ricerche e scavi, Atti de/ III incontro di Studi (Manciano-Firenze, 12-14 maggio 1995), Firenze 1998, pp. 301-312.
CULTRARO 2000 = M. CULTRARO, 11 tipo di tomba ipogeica a grotticella artificiale, in ambito egeo: alcune osservazioni, in Atti del Congresso l nternazionale «L'ipogeismo nel Mediterraneo» (Sassari-Oristano, 23-28 Maggio 1994), Sassari 2000, pp. 473-499.
CuTRONI T usA 1997 = A. CuTRONI T usA, I ripostig li di bronzo e la loro funzione pre o paramonetale, in Prima Sicilia, pp. 567-58 1.
D'AGATA 1986 = A.L. D 'AGATA, Considerazioni su alcune spade siciliane della mediae tarda era del bronzo, in Traffici Micenei nel Mediterraneo, pp. 105-110.
D EMAKOPOULOU 1968 = K. D EMAKOPOULOU, Mykinaika agghia ek thalamoidon taphon periochis Aghiou Ioannou Monembasias, in ArchDelt 23, 1968, pp. 145-194.
DEMAKOPOULOU 1982 = K. DEMAKOPOULOu, Kokla, in A rchDelt 37, B1 , 1982, pp. 83-85.
DEMAKOPOULOU 1988 = K. DEMAKOPOULOU (ed.), The Mycenaean World. Five centuries of early greek culture 1600-1000 BC, Athens 1988.
DEMAKOPOULOU- DIVARI-V ALAKOU- WALBERG 1994 = K. DEMAKOPouwu - N. DIVARI VALAKOU- G. WALBERG, Excavations and restoration work in Midea 1990-1992, in OpAth XX.2, 1994, pp. 19-41.
D ESHAYES 1966 = ]. DESHAYES, A rgos les Fouilles de Ia Deiras, Paris 1966.
DICKINSON 1994 = O.T.P.K. DICKINSON, The A egean Bronze A ge, Cambridge 1994.
DIETLER 1999 = M. DIETLER , Rituals of commensality and the politics of state formation in the <<princely» societies of early Iron age Europe, in P . RuBY (ed.), Les Princes de Ia Protohistoire et /'Emergence de l'Etat (N apoli, 27-29 ottobre 1994), Napoli-Roma 1999, pp. 135-152.
DaHL 1973 = H . Da HL, ! ria: D ie Ergebnisse der A usgrabungen 1939 (Tyrins, VI) , Mainz 1973.
374 DAVIDE TANASI
Epi ponton plaz6menoi = V. LA RosA- D. PALERMO- L VAGNETTI (edd.), Epi ponton plaz6menoi, Simposio italiano di studi egei in onore di L. Bernabo Brea e G. Pugliese Carratelli (Roma, 18-20 febbraio 1998), Roma 1999.
ERIKSSON 1993 = K. ERIKSSON, Red Lustrous Wheel-made Ware (SIMA, 103), Jonsered 1993.
FArrA 1983 = V. FATTA, La ceramica geometrica diS. Angelo Muxaro, Palermo 1983.
FoRSDYKE 1926-1927 = E.). FoRSDYKE, The Mavrospelio Cemetery at Knossos, in BSA 28, 1926-27, pp. 243-296.
FRASCA 1996 = M. FRASCA, Iron Age settlements and cemeteries in southeastern Sicily: an introductory survey, in R. LEIGHTON (ed.), Early Societies in Sicily. New developments in archaeological research, London 1996, pp. 139-145.
FRODIN- PERSSON 1938 = 0. FRODIN -A. W. PERSSON, Asine. Results of the Swedish Excavations 1922-1930, Stockholm 1938.
FuRUMARK 1941a = A. FuRUMARK, Mycenaean pottery I: Analysis and classification (Skrifter utgivna av Svenska Institute! i Athen, 4°, XX:1), Stockholm 1941.
FuRUMARK 1941b = A. FuRUMARK, Mycenaean pottery II: Chronology (Skrifter utgivna av Svenska Institute! i A then, 4°, XX:2), Srockholm 1941.
FuRUMARK 1992 = A. FuRUMARK, Mycenaean Pottery: III Plates, (Skrifter utgivna av Svenska Institute! i Athen, 4°, XX:3), P. AsTROM-R. H AGG - G . WALBERG (edd.), Stockholm 1992.
GENTILI 1965 = G. GENTILI, Pantalica, in NSc 1956, p. 165.
GIARDINO 1995 = C. GIARDINO, II Mediterraneo Occidentale fra XIV ed VIII secolo a. C. Cerchie minerarie e metallurgiche (BAR, 612), Gbteborg 1995.
GIARDINO 1997 = C. GIARDINO, La metallotecnica nella Sicilia pre-protostorica, in Prima Sicilia, pp. 405-414.
GRAZIADIO 1998 = G. GRAZIADIO, Cipro nell'eta del bronzo, Pisa 1998.
GRECO - PRIVITERA c.d.s. = E. GRECO- S. PRIVITERA, La presenza micenea nelle isole dell'Egeo Nord-Orientale: da Chios a Lemnos, in L GoDART- E. GREco- M. MARAZZI R. LAFFINEUR- A. SACCONI (edd.), Emporia. Aegeans in Central and Eastern Mediterranean. Proceedings of the 1 O'h International Aegean Conference (Athens, 14-18 april2004), in c.d.s.
GuzzARDI 1980 = L GuzzARDI, Un ipogeo preistorico a Calaforno e il suo contesto topografico, in SicArch 42, 1980, pp. 67-94.
GuzzARDI 1984 = L GuzZARDI, Architetrura funeraria pluricellulare della Sicilia sud-orientale tra la tarda era del rame e la prima era del bronzo, in Preistoria d'Italia IV, 1984, pp. 315-322.
GuzzARDI 1986 = L GuzzARDI, Elementi di tradizione nell'architettura funeraria calabrese, in Traffici micenei nel Mediterraneo, pp. 71 -78.
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! DI TIPO MICENEO 375
GuZZARDI 1996 = L. GuzzARDI, L'area degli Iblei fra l'era del bronzo e la prima era del ferro, in Civilta indigene e citta greche nella regione Iblea, Ragusa 1996, pp. 30-42.
IAKOVIDES 1969 = S.E. IAKOVIDES, Peratt. To nekrotaphion, Arhina 1969.
lMMERWAHR 1971 = S. lMMERWAHR, The Neolithic and Bronze Ages (The Athenian Agora XIII), Princeron 197 1.
ITALIA 1975-1 976 = G. ITALIA, Saggio di scavo a Pantalica, in ArchStorSir I , 1975-1976, pp. 13-19.
h ALIA 1983 = G . lTALIA, R irrovam enti archeologici in contrada Calanca, in A rchStorSir III, 1, 1983, pp. 7 -1 8.
] ONES 2001 = R.E. ] ONES, A Provenance Study of the Aegean-type and other Poteery by Chemical Analysis, in Torre Mordillo 1987- 1990. Le relazioni egee di una comunita protostorica della Sibaritide, Roma 2001 , pp. 331-33 7.
j oNES- VAGNETTI 1991 = R .E. J oNES- L. VAGNETTI, Traders and Craftsmen in the Central Mediterranean: Archaeological evidence and archaeometric research , in N.H. GALE (ed.), Bronze Age Trade in the Mediterranean (SIMA, 90), Jonsered 1991, pp. 127-147.
KARANTZALI 1998 = E. KARANTZALI, A N ew Pictorial Rhyton from Rhodes, in Eastern Mediterranean: Cyprus-Dodecanese-Crete 16'h- 6'h cent. B.C. , Proceedings of the International Symposium (Rethymnon, 13-16 May 1997), Athens 1998, pp . 87-99.
KARANTZALI- PaNTING 2000 = E. KARANTZALI - M.J. PaNTING, ICP-AES Analysis of some Mycenaean vases from the cemetery at Pylona, Rhodes, in BSA 95, 2000, pp. 219-238.
KERAMOPOULLOU 1917 = A.D. KERAMOPouuou, Z' Mykinaiki taphi Kolonakiou Agh. Iannis, in ArchDelt 3, 19 17, pp. 123-209.
KILIAN 1983 = K. KILIAN, Civilra micenea in Grecia: Nuovi aspetti scorici ed interculturali , in Magna Grecia e Mondo Miceneo, Atti del XXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 7-11 on obre 1982), TarantO 1983, pp. 53-96.
KrLLEN 1988 = J. KILLEN, The linear B Tablets and the Mycenaean Economy, in Linear B: A 1984 survey, Louvain-la-Neuve 1988, pp. 265-270.
KoNTORLI-PAPADOPouwu 1987 = L. KoNTORLI - PAPADOPOULOU, Some aspects concerning local peculiarities of the Mycenaean Chamber Tombs, in R. LAFFINEUR (ed.), Thanatos. Les coutumes funeraires en Egee a /'age du Bronze, in Aegaeum 1, 1987, pp. 145- 160.
KouMANOUDIS- KASTORCHIS 1877 = S. KouMANOUDIS - E. KASTORCHIS, I en Spata t is Att ikls archei taphi ke ta en aftis anevrethenta, in Athenaion VI , 1877, pp. 169-172.
KouMOUZELIS 1996 = M. KouMOUZEUS, A Monumental Chamber Tomb at Ellenika, Messenia, in Atti e Memorie II , pp. 1221-1228.
376 DAVIDE TANASI
KRISTALLI-VOTSI 1996 = K. ·KRISTALLI-VOTSI, The Excavations of the Mycenaean Cemetery at Aidonia, in The Aidonia Treasure, Athens 1996.
LA RosA 1979 = V. LA RosA, Sopralluoghi e ricerche attorno a Milena nella media valle del Platani, in CronCatania 18, 1979, pp. 76-103.
LA RosA 1985 = V. LA RosA, Sopravvivenze egee nella Sikania, in Scavi e ricerche archeologiche degli anni 1976-1979 (Quaderni de La Ricerca Scientifica C.N.R. 112, II),
Roma 1985, pp. 167-179.
LA RosA 1989 = V. LA RosA, Le popolazioni della Sicilia: Sicani, Siculi, Elimi, in Italia omnium terrarum parens, Milano 1989, pp. 3-110.
LA RosA 1993-1994 = V. LA RosA, Influenze di tipo egeo e paleogreco in Sicilia, in Kokalos XXXIX-XL, 1993-1994, pp. 9-66.
LA RosA 1999 = V. LA RosA, Processi di formazione e di identificazione culturale ed etnica delle popolazioni locali in Sicilia dal medio-tardo bronzo all'era del ferro, in M. BARRA BAGNASCO - E. DE MIRO- A. PrNZONE (edd.), Magna Grecia e Sicilia. Stato degli studi e prospettive di ricerca, Progetto strategico C.N.R. II sistema mediterraneo: Origine e incontri di cultura nell'antichita. Atti dell'Incontro di studi (Messina, 2-4 dicembre 1996), Soveria Mannelli 1999, pp. 159-185.
LA RosA 2000 = V. LA RosA, Riconsiderazioni sulla media e tarda edt del bronzo nella media valle del Platani, in QuadMess n. 1, 1, 2000, pp. 125-138.
LA RosA 2004 = V. LA RosA, Appendice. La prima escursione di Paolo Orsi a Pantalica, in Atti del Primo simposio siracusano di preistoria siciliana (Siracusa, 15-16 dicembre 2003), Padova 2004, pp. 384-397.
LEIGHTON 1981 = R. LEIGHTON, Strainer-spouted jugs and the problem of the earliest Phoenician influence in Sicily, in}MAA I, 1981, pp. 280-291.
LEIGHTON 1985 = R. LEIGHTON, Evidence, extent and effects of Mycenaean contacts with South East Sicily during the Late Bronze Age, in Papers in Italian Archaeology IV (BAR IS, 245), Oxford 1985, pp. 399-412.
LEIGHTON 1996 = R . LEIGHTON, From chiefdom to tribe? Social organisation and change in later prehistory, in R. LEIGHTON (ed.), Early Societies in Sicily. New developments in archaeological research, London 1996, pp. 101-116.
LEPORE 1986 = E. LEPORE, Modo di produzione egeo in relazione al Mediterraneo occidentale, in Tra/fici micenei nel Mediterraneo, pp. 315-3 2 3.
LILLiu 1998 = G. Lrwu, Aspetti e problemi dell'ipogeismo mediterraneo, in Memlinc 10, 1998, pp. 123-157.
LIVERANI 1986 = M. LrvERANI, La ceramica e i testi: commercia miceneo e poli tica orientale, in Traffici Micenei nel Mediterraneo, pp. 405-41 3.
Lo ScHIAVO 1983 = F. LoScHIAVO, Le componenti egea e cipriota nella m etallurgia della tarda era del bronzo in Italia, in Magna Grecia e Mondo Miceneo, Atti del
PER UN RIESAME DEGU ELEMENT! DI TIPO MICENEO 377
XXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 7-11 ottobre 1982), Taranto 1983, pp. 285-320.
Lo SCHIAVO - M ACNAMARA - VAGNETTI 1985 = F. Lo ScHIAVO- E. MACNAMARA - L. VAGNETTI, Late Cypriot Imports to Italy and their Influence on Local Bronzework, in Papers of the British School at Rome LIII, 1985, pp. 1-71.
MANISCALCO 1985-1986 = L. MANISCALCO, Tipologie funerarie nella Sicilia del tardo bronzo: Pantalica, Dessueri, Caltagirone, in ASSO LXXXI-LXXXII , 1985-1986, pp. 241-265.
MANNINO 1974 = G. MANNINO, Seg nalazioni archeologiche in territorio di Santa Ninfa, in SicArch 24-2 5, 1974, pp. 39-44.
MANNINO 1994 = G. MANNINO, Ricerche preistoriche nel territorio di Partanna, in La preistoria del Basso Be/ice e della Sicilia meridionale nel quadro della preistoria siciliana e mediterranea, Palermo 1994, pp. 125-176.
MARAZZI 1989 = M. MARAZZI, Comributi allo studio della «Sociera Micenea», III: documentazione e valore dei primi traffici d'oltremare, in Contributi allo studio della «Societa Micenea», Roma 1989, pp. 95-104.
MARINATOS 1953 = S. MARINATOS, Anaskaphl en Pyla, in Prakt 1953, pp. 238-250.
MARTIN DE LA CRuz 1996 =].C. MARTIN DE LA CRUz, Nuevas ceramicas de importacion en Andalucia (Espana): Sus implicaciones culturales, in Attie Memorie II , pp. 1551-1561.
MEDEROS- MARTIN 1999 =A. MEDEROS -MARTIN, Ex Occidente lux. El commercia Micenico en el Meditemineo central y occidental (1625-1100 a.C.), in Complutum 10, 1999, pp. 229-266.
MESSINA 1993 = A. MESSINA, Tre edifici del medioevo siciliano, in SicArch 26, 1993, pp. 61-65.
MILITELLO 1991 = P. MILITELLO, Due anelli d'oro dalle pendici sud-ovest di Monte Campanella, in QuadMess 6, 1991, pp. 17-21.
MILITELLO 2004 = P. MILITELLO, Commercianti, arch itetti ed artigiani, Riflessioni sulla presenza micenea nell' area iblea, in A tti del Primo simposio siracusano di preistoria siciliana (Siracusa, 15-16 dicembre 2003), Padova 2004, pp. 295-335 .
MoRRICONE 1972-1973 = L. MoRruCONE, Scavi e scoperte nel «Serraglio» e in localita minori (1935-1943), in ASAtene L-LI , 1972-1973, pp. 139-396.
MouNTJOY 1986 = P.A. MouNTJOY, Mycenaean decorated pottery: a guide to identification (SIMA , 83), Goteborg 1986.
MouNTJOY 1999 = P.A. MouNTJOY, Regional Mycenaean pottery, Raden 1999.
NrcOLETn 1997 = F. NrcoLETir, L'impronta egea nelle g ioiellerie preelleniche, in Prima Sicilia, pp. 531-533.
378 DAVID£ TANASI
ONASOGLOU 1990 =A. O NASOGLOu, Kythera, in ArchDelt 45, 1990, B1, pp. 81-83.
0 RLANDOS 1965 = A. K. 0 RLANDOS, Pylas, in Ergon 1965, pp. 76-92.
0 Rsr 1889 = P. 0RSI, Contributi all'archeologia preellenica sicula. Scavi e scoperte a Pantalica, in BPI XV, 1889, pp. 158-188 e 197-23 1.
0 Rsr 1891 = P. 0 Rsr, La necropoli sicula del Plemmirio (Siracusa), in BPI XVII, 1891 , pp. 115-139.
0 Rsr 1892 = P. 0 Rsr, La necropoli sicula di Castelluccio (Siracusa), in BPI XVIII, 1892, pp. 1-34 e 67-84.
0 RSI 1893a= P. 0 RSI, Di due sepolcreti siculi nel territorio di Siracusa, in ArchStorSic XVIII, 1893, pp. 308-325 .
0Rsr 1893b = P. 0Rsr, N ecropoli Sicula presso Siracusa con vasi e bronzi micenei (Cozza del Pantano), in MonAnt II, 1893, coll. 5-36.
0Rsr 1895 = P. 0Rsr, Thapsos, in M onA nt VI, 1895, coll. 89-1 50.
0 RSI 1897 = P. 0 Rst, Nuovi materiali siculi del territorio di Girgenti, in BPI XXIII, 1897, pp. 1-15 e 105-122.
0Rsr 1898 = P. 0Rsr, Necropoli sicule di Buscemi, in BPI XXIV, 1898, p. 164.
0Rsr 1899a = P. O RSr, Pantalica e Cassibile, in MonAnt IX, 1899, coll. 33-146.
ORSr 1899b = P. ORSr, Nuove esplorazioni nel Plemmyrium, in NSc 1899, pp. 26-34.
0 Rsi 1900 = P. 0RSI, Siculi e Greci in Leontinoi , in RM, 14, 1900, pp. 62-98.
0RSI 1902 = P. 0RSI, Molinello presso Aug usta, in NSc 1902, pp. 4 11-420.
0Rsr 1903 = P. 0Rsr, N ecropoli e stazioni sicule di transizione III-IV. La necropoli di Rivettazzo (Siracusa), in BPI XXIX, 1903, pp. 23-28.
0RSI 1904 = P. 0Rsr, Siculi e Greci a Caltagirone, in NSc 1904, pp. 65-98.
0Rsr 1906 = P. 0Rsr, Nuovi documenti, della civildi. premicenea e micenea in Italia, in Ausonia I, 1906, pp. 5-12.
0RSI 1907 = P. 0Rsr, Necropoli e Stazioni sicule di t ransizione, VII. Caverne di abitazione a Barriera presso Catania, in BPI XXXIII, 1907 , pp. 4 -99.
0Rsr 191 2 = P. 0Rsr, Le necropoli sicule di Pantalica e Monte Dessueri, in MonAnt XXI, 19 12, call. 301- 406.
PALERMO 1996 = D. PALERMO, Tradizione indigena e apporti greci neUe culture della Sicilia centro-meridionale: il caso di Sant'Angelo Muxaro, in R. LEIGHTON (ed.), Early Societies in Sicily. New developments in archaeological research, London 1996, pp. 147-1 54.
PALERMO 2002 = D. PALERMO, Caratteri e sviluppo della necropoli e del centro antieo d i Sant'Angelo Muxaro, in AA.Vv., Sant'Angelo M uxaro. Scavi diP. Orsi e U. Zanotti Bianco nella necropoli meridionale (193 1- 1932) , Catania 2002, pp. 1- 42 estr.
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! Dl TIPO MICENEO 379
PANVINI 1986 = R. PANVINI, La necropoli preisrorica di contrada Anguilla di Ribera, in Traffici Micenei nel M editerraneo, pp. 113-122.
PAPADIMITRIOU 1955 = I. PAPADIMITRrou, Mykinaiki taphi Alykis Glyphadas, in Prakt 1955, pp. 78-99.
PAPADOPOULOS 1979 = T.J. PAPADOPOULOS, Mycenaean A chaea (SIMA, 55), Gateborg 1979.
PAPAIANNOPOULOU 1985 = A. PAPAIANNOPOULou, Were the S.E. Aegean islands deserted in MBA?, in AnatSt 35, 1985, pp. 85-92.
PAPAPOSTOLOU 1978 = I. PAPAPOSTOLOu, Aghios Gheorghios, in ArchDelt 33, B1, 1978, pp. 101-102.
PARISE 1968 = N.F. PARISE, I Pani di rame del II millennia a.C. Considerazioni preliminari, in Atti e M emorie I , pp. 117-13 3.
PARISE 1999 = N.F. PARISE, Alla ricerca dei fondamenti «micenei» delle misure ponderali g reche, in Epl ponton plazomenoi, pp. 3 51-3 55.
PARKER 1985 = G.S . PARKER, The Early Bronze Age Chamber Tombs at La Muculufa, in RALouvain XVIII, 1985, pp. 9-33.
PELON 1976 = 0 . PELON, Tholoi, tumuli et cercles funeraires, Paris 1976.
PERSSON 1942 = A.W. PERSSON, New Tombs at Dendra near M idea, (Skrifter utgivna av Kung/. Humanistika Vetenskapssamfundet I, XXXIV), Lund 1942.
PoLYCHRONAKou- SGOURITSA 1988 = N. PoLYCHRONAKOU- SGOURITSA , To Mykinaik6 nekrotafio tis Varkizas/Varis, in ArchDelt 43, 1988, pp. 1-106.
Prima Sicilia = S. T usA (ed.), Prima Sicilia, aile origini della societa siciliana, Palermo, 18 ottobre-22 dicembre 1997, Palermo 1997.
RUDOLPH 197 3 = W. RuDOLPH, Die Nekropole am Prophitis Elias bei Tyrins (Tyrins, VI), Mainz 1973 .
RYE 198 1 = O.S. RYE, Pottery Technology. Principles and Reconstruction, Washington 1981.
SANDARS 1961 = N.K. SANDARS, The First Aegean Swords and Their Ancestry, in AJA 65 , 1961 , pp. 17-29.
SANDARS 1963 = N .K. SANDARS, Later Aegean Bronze Swords, in A]A 67, 1963, pp. 117-153.
SANDARS 1978 = N.K. SANDARS, The Sea Peoples, london 1978.
ScHALLIN 1993 = A.L. ScHALLIN, Islands under influence. The Cyclades in the Late Bronze age and the nature of Mycenaean presence, SIMA 111 , Jonsered 1993.
STAINCHAOUER 1973-1 974 = G. STAINCHAOUER, Sykea, in A rchDelt 29, B2 , 1973 -1974, pp. 294-295.
380 DAVIDE TANASI
TANASI 1999a = D. TANASJ, Mycenaean influences on the pottery ofNorth Pantalica culture (Sicily), Acts of 2"d International Interdisciplinary Colloquium «The Periphery of the Mycenaean World» (Lamia, 26-30 September 1999), Lamia 2004, pp. 331-336.
TANASI 1999b = D. TANASI, L'architettura funeraria pluricellulare in Sicilia tra la media e la tarda era del bronzo: le tombe a camera multipla delle necropoli di Pantalica, in ASSO XCV, 1999, pp. 193-257.
TANASJ 2000 = D. TANAsr, Considerazioni sulle influenze micenee nella cultura di Pantalica Nord: la produzione ceramica, in ASSO XCVI, 2000, pp. 1-88 estr.
TANASJ 2004 = D. TANASJ, Per una rilettura delle necropoli sulla Montagna di Caltagirone, in Atti del primo simposio siracusano di preistoria siciliana (Siracusa, 15-16 dicembre 2003), Padova 2004, pp. 399-445.
TAYLOUR 1958 = W . TAYLOUR, Mycenaean pottery in Italy and adjacent areas, Cambridge 1958.
TEOCHARJS 1960 = M.D. TEOCHARJS, A Knossian vase from Attica, in A ntiquity XXXIV, 1960, pp. 266-269.
ToMASELLO 1995-1996 = F. ToMASELLO, Le tombe a tholos della Sicilia centro meridionale, (CronCatania 34- 35, 1995- 1996).
ToMASELLO 1996 = F. TOMASELLO, Un caso di progettazione «micenea» in Sicilia: l'anaktoron di Pantalica, in Atti e Memorie II, pp. 1595-1602.
ToMASELLO 2001 = F. ToMASELLO, Nuove tombe tholoidi dell 'era del Bronzo a Mustanzello di Milena, in M.C. MARTINELLI- U . SPIGO (edd.), Studi di Preistoria e Protostoria in onore di Luigi Bernabo Brea, (Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano <<Luigi Bernabo Brea», suppl. I), Messina 2001, pp. 305-315.
ToMASELLO 2004 = F. ToMASELLO, L'architettura «micenea>> nel Siracusano, in Atti del primo simposio siracusano di preistoria sici!iana (Siracusa, 15-16 dicembre 2003), Padova 2004, pp. 183-210.
TsouNTAS 1888 = CH.D. TsouNTAS, Anaskaph! taphon en Mykinais, in ArchEph 1888, pp. 119-196.
TsouNTAS 1896 = CH.D. TsouNTAS, Grapht! stili ek Mykinon, in ArchEph 1896, p. 131.
Traffici Micenei nel Mediterraneo = M. MARAZZJ- S. TusA- L. VAGNETTI (edd.), Traffici Micenei nel Mediterraneo. Problemi storici e documentazione archeologica, Taranto 1986.
TusA 1999 = S. T usA, La Sicilia nella preistoria, Palermo 1999.
UGAS 1996 = G. UGAS, Relazioni tra la Sardegna e l'Egeo attraverso l'architettura e le fonti letterarie, in A tti e Memorie II , pp. 1603-1622.
VAGNETTI 1968a = L. VAGNETTI, Un vaso miceneo da Pantalica, in SMEA V, 1968, pp. 132-135.
VAGNETIJ 197 2 = L. VAGNETII, Un anello del Museo Archeologico di Firenze e le orificerie di Sant 'Angelo Muxaro, in SMEA XV, 1972, pp. 189-201.
PER UN RIESAME DEGLI ELEMENT! DI TIPO MICENEO 381
VAGNETTI 1986 = L. VAGNETTI, Cypriot Elements beyond the Aegean in the Bronze Age, in V. KARAGEORGHIS (ed.), Acts of the International Archaeological Symposium «Cyprus between the Orient and the Occident» (Nicosia, 8-14 september 1985), Nicosia 1986, pp. 201-216.
VAGNETTI 2001 = L. VAGNETTI, La ceramica tornita a pasta grigia con superficie nera, in Torre Mordillo 1987-1990. Le relazioni egee di una comunita protostorica della Sibaritide, Roma 2001, pp. 329-330.
VAN DER LEEUW 1984 = S.E. VANDER LEEUW, Pottery Manufacture: Some Complications for the Study of Trade, in P.M. RICE (ed.), Pots and Potters. Current Approaches in Ceramic Archaeology, Los Angeles 1984, pp. 5 5-70.
VAVRITSAS 1968 = A. VAVRITSAS, Anaskaph'i trion Mykinaikon taphon is Kamini Varkizis, in AAA 1968, pp. 110-112.
VIKATOU 1999 = 0. VIKATOU, To mikinaiko nekrotaphio tis Ag hias Triadas N. !lias, in Acts of the 1" Int. Inter. Symp. <<The Periphery of the Mycenaean World» (Lamia 25-29 September 1994), Lamia 1999, pp. 237-256.
VozA 1972 = G. VoZA, Thapsos, primi risultati delle pili recenti ricerche, in Atti della XIV Riunione Scientifica l.I.P.P. in Puglia (13-16 ottobre 1970), Firenze 1972, pp. 175-205.
VoZA 1980 = G. VozA, La problematica archeologica, in Sicilia Antica, I, 1, (a cura diE. GABBA - G. VALLET), Napoli 1980, pp. 5-43.
VoZA 1999 = G. VoZA, Siracusa 1999. Lo scavo archeologico in Piazza Duomo, PalermoSiracusa 1999.
VouTSAKI 1995 = S. VouTSAKI, Social and Political Processes in the Mycenaean Argolid: the Evidence from Mortuary Practises, in R. LAFFINEUR- W. D. NIEMEIER (edd.), Politeia. Society and State in the Aegean Bronze Age (Aegaeum, 12), 1995, pp. 55-67.
WACE 1932 = A.J.B. WACE, Chamber Tombs at Mycenae (Archaeologia, 82), Oxford 1932.
WARREN 1991 = P.M. WARREN, A Merchant Class in Bronze Age Crete?, in N.H. GALE (ed.), Bronze Age Trade in Mediterranean (SIMA, 110), Jonsered 1991.
WATERHOUSE- SIMPSON 1961 = H. WATERHOUSE- R.H. SIMPSON, Prehistoric Laconia: Part II, in BSA 56, 1961 , pp. 114-175.
WOOLSEY H EERMANCE-LORD 1897 = T. WOOLSEY HEERMANCE- D. LoRD, Pre-Mycenaean graves in Corinth, in A]A 1897, pp. 313-332.
WRIGHT 1995 =].C. WRIGHT, From chief to king in Mycenaean Society, in P. REHAK (ed.), The role of the ruler in the prehistoric Aegean ( Aegaeum, 11 ), 1995, pp. 63-80.
XENAKI- SAKELLARiou 1985 = A. XENAKJ- SAKELLARIOU, Oi thalamoti taphi ton Mykinon, Paris 1985.
ZAPHEIROPOULOS 1960 = N.S. ZAPHEIROPOULOS, Anaskaphl Naxou , in Prakt 1960, pp. 329-340.