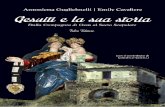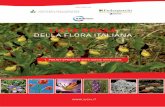La scienza impura. Note sul concetto di demarcazione fra scienza e altre forme di conoscenza
2008_ Presenze sbarbariane in Caproni (e altre osservazioni stilistiche)
Transcript of 2008_ Presenze sbarbariane in Caproni (e altre osservazioni stilistiche)
PIETRO BENZONI
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI(E ALTRE OSSERVAZIONI STILISTICHE)*
[...] e freschinel sangue i miei rancoribruciavano, come amori.
Giorgio Caproni
I. A partire da alcuni interventi trasmessi dall’Approdo radiofonico allafine del 1954, e poi in una serie di articoli apparsi tra il 1956 e il 1959,Caproni teorizzò l’esistenza di una linea ligure nella poesia italiana: unacorrente ligustica che muoverebbe da Ceccardo Roccatagliata, e attraversoNovaro, Boine e Sbarbaro, troverebbe un suo compimento in Montale, e
* Si pubblica qui una versione ampliata di uno studio che, con diverso titolo (Forme escenari di perdizione nella poesia di Sbarbaro e Caproni) e taglio, era stato presentato alConvegno internazionale La Liguria. Romanzieri, poeti e artisti dal Cinquecento ai giornid’oggi, tenutosi a Nizza e a San Remo dal 12 al 14 aprile 2007. Ringrazio Vittorio Colettie François Livi per le stimolanti osservazioni in occasione del convegno; Luca Zuliani peri supporti informatici gentilmente messi a mia disposizione; Fabio Magro ed EnricoRoggia per i preziosi suggerimenti.
Sigle. OVP = C. Sbarbaro, L’opera in versi e in prosa [1985], a cura di G. Lagorio e V. Schei-willer, Milano,Garzanti,19993; PI = Pianissimo 1914 (i cui singoli componimenti saranno indi-viduati da un numero romano corrispondente alla posizione occupata nella raccolta); OV =G. Caproni, L’opera in versi, ed. critica a cura di L. Zuliani, intr. di P.V. Mengaldo, Milano,Mondadori, 1996 (da qui si citano in particolare le seguenti raccolte: PE = Il passaggio d’Enea;SP = Il seme del piangere; CVC = Congedo del viaggiatore cerimonioso; MT = Il muro della terra).
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
da qui ulteriori sviluppi con Barile e Grande.1 Certo, la categoria criticaè quantomeno discutibile: Montale, ad esempio, non la riconobbe («lalinea ligure è stata inventata [...] esiste una poesia fatta da liguri»); eCaproni stesso in seguito ebbe a relativizzarla in maniera piuttosto drasti-ca («la “linea ligustica” la inventai io, ma ha poco fondamento.Alludevo acerte affinità di cultura, di reazione al paesaggio, di sentire»).2 Ora, però,l’ipotesi storiografica di Caproni ci interessa proprio perché, nella suadubbia validità, lascia meglio trasparire il forte coinvolgimento personaledel critico-poeta. Infatti, l’impressione è che, nell’additare tale tradizione,Caproni abbia soprattutto definito le proprie radici e il proprio gusto, fis-sando suggestivamente una propria peculiare sensibilità e inclinazione difronte agli scenari liguri (genovesi in particolare) e alle loro trasposizioniletterarie. Basta leggere i seguenti due brani (tratti dalle prime battute diCaproni 1956a) per vedere come, nelle ampie volute e nell’accesometaforeggiare di queste sue prose “ligustiche”, tendano ad annidarsiimmagini e spunti che erano già stati, o saranno rielaborati anche nell’o-pera in versi:
Punto focale del concavo specchio ustorio della regione,Genova coi suoi com-merci e le sue industrie, l’ansito dei cantieri e del porto, e i mirabolanti luoghid’esaltazione e di perdizione;Genova tutta verticale dagli aerei giardini delle sue ter-razze ai profondi budelli intestinali dei vicoli, dove in un afror di droghe e dipostriboli si va compiendo la digestione delle mercanzie che si tramutano in lucri;Genova stessa non fa che confermare, in termini di linguaggio illustre, la rixa;
dove, con il latinismo rixa, si designa quella lotta strenua tra un istinto didissoluzione e un bisogno di fermezza che, secondo Caproni, si agitereb-be perennemente nell’animo ligure:
PIETRO BENZONI288
1. Cfr. le quattro puntate di Caproni 1956a e la serie di articoli pubblicati nel 1959, concadenza per lo più settimanale, sul «Corriere mercantile»:Genova: denaro e poesia, 22 luglio;Roccatagliata Ceccardi, 28 luglio;Mario Novaro, 4 agosto; Sono qui in cerca di amore e di vita...Boine la voce più vigorosa del «gruppo ligure», 11 agosto; Sbarbaro, amaro amore, 18 agosto; Ladolce fede di Barile, 25 agosto; Adriano Grande «erba tra le macerie», 1 settembre; Montale: laLiguria e il nostro tempo, 8 settembre; Due voci in tono minore, 22 settembre; Girasoli, ortid’autunno, api in grondaia, 29 settembre; Vita, morte e grida di ragazzi, 6 ottobre; Enea aGenova, in Piazza Bandiera, 31 ottobre; serie da intregrare poi con Nelle chiese di Genova ilrumore del mare, uscito invece il 25 febbraio 1960.
2. Cfr., rispettivamente, l’intervista a Montale in Alzona 1967 e Insana 1975. Per meglioinquadrare la questione v. comunque Dei 1992, 94-98, Dei 2003, 61-73 e Zoboli 2006.
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
[quel] contrasto tra i trasalimenti e i rapimenti della luce estatica, e il ritmo fittodi una vita che invece tende tutta, con minuzioso accanimento, alle cose solidee ferme, ai beni stabili, alla pietrificazione, per così dire, degli introiti ricavati dallemercature, appunto perché il ligure deve difendersi [...] dalla continua tentazio-ne di dissolvimento ch’è in quella luce mediterranea, resa più corrosiva ancora dalpulviscolo salino che la compone, [...] quel perpetuo dibattito ch’è nell’animoligure per non lasciarsi incantare dalle sirene della luce e del sale.3
Inevitabile richiamare qui alcuni luoghi di PE, Stornello («Le case cosìsalde nei colori / a fresco in piena aria, / è dalle case tue che invanoimpara, / sospese nella brezza / salina, una fermezza / la mia vita preca-ria»), PE, Litania («Genova verticale, / vertigine, aria, scale»; etc.), PE, Sirena(«Genova mia di mare tutta scale / e su dal porto, risucchi di vita / viva...»), e CVC, Lamento (o boria) del preticello deriso («Che traffici e che mercan-zie / (che lucri, e che profezie [...] La Genova mercantile / dei vicoli –l’intestinale / tenebra...»). Ma, oltre che per simili evidenti fenomeni diintertestualità interna, i brani sopra citati sono per noi significativi perchépaiono alimentarsi anche, più nascostamente, di suggestioni sbarbariane:ravvisabili non tanto nelle più generiche tangenze con la celebre poesiadedicata alla Liguria, Scarsa lingua di terra («...morsa / dal sale [...]; percos-sa dalla fersa», etc.), quanto nei più puntuali affioramenti di un vocabola-rio che – in un simile contesto e nel suo fare sistema – risulta davverosegnato. Compare infatti qui una parola, perdizione, che, con questa acce-zione, inutilmente cercheremmo nella poesia di Caproni,4 ma che inPianissimo troviamo addirittura ipostatizzata con la maiuscola;5 quindiansito (anch’essa mai utilizzata in OV), per cui si confronti E la vita sapessia me che fu, 18 (dai Versi a Dina): «M’affaticava la città col suo / ànsito»dove la parola in questione è rilevata metricamente dall’enjambement e dalfatto di costituire un verso a sé; e infine sirena, con un uso figurato per cui
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 289
3. Cfr. la prima puntata di Caproni 1956a (tutti i corsivi sono miei, tranne rixa).4. Nell’unica occorrenza di OV, infatti, il vocabolo è usato in una più inusuale locu-
zione avverbiale: cfr. MT,Acciaio, 11, «La luna, a perdizione / allucinava alta / la neve», il cuisenso pare volutamente ambiguo: ‘a perdita d’occhio’ ma anche ‘fino a perdersi’.
5. Un artificio che, come ha evidenziato Mengaldo, è tipicamente simbolistico e deltutto consono ad una poesia intensamente sostantivale qual è quella sbarbariana (cfr.Mengaldo 1986, 127).
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
si potrà richiamare Pianissimo I, 22-23 «Perduta ha la sua voce / la sirenadel mondo»,6 ricordando magari, nel contempo, i versi danteschi posti inepigrafe al Seme del piangere (Purgatorio XXXI, 45-46 «... udendo le sirenesie più forte, pon giù il seme del piangere»).7 Un’ulteriore conferma verràpoi, più indirettamente, constatando come in quello che forse è il piùincisivo tra i non pochi scritti che Caproni ha dedicato a Sbarbaro,L’amarezza di Camillo Sbarbaro (1960), ritornino lessico e concetti analo-ghi («la radice [dell’amarezza sbarbariana] affonda nell’uomo che nonvuole e non sa più cedere ai sogni e ai rapimenti; alle sirene della mediterra-nea luce; l’uomo troppo cresciuto [...] che nella rixa tra sè e gli oggettiinnocenti [...] impersona e soffre il male d’esistere»),8 e Genova vengaegualmente colta, attraverso un periodare largo e stratificato (certo nellecorde di chi qualche anno prima aveva egregiamente tradotto Proust),9
nella sua duplice natura, divisa tra luce e tenebra, tra verticalità e sprofon-damento, tra fervore commerciale e cupa degradazione:
Ma è che la voce di Sbarbaro, a differenza di quella degli altri liguri, è quasisempre tesa sul più raumiliato versante della città genovese: di quella Genovabifronte come il Giano messo in guardia ai giardini, la quale se sali con la funi-colare sino al proustiano Albergo Pagoda del Righi, là può offrirti, dopo il buiomaieutico di un tunnel, e oltre il fremito degli ulivi di San Nicola (oltre il frul-lo dei passeri sui tetti di lavagna delle Sepolte vive), il panorama più allegorico,e più veritiero, della sua (della nostra) «anima divisa»: il panorama di una cittàspaccata in due tra la luce e l’ombra, la quale, sonora di cantieri e di traffici, eincandescente di grigie fiamme marine sul versante portuale e rivierasco che dàtutto a Mezzogiorno, subito su quello opposto strapiomba, (sotto i secenteschibastioni) sul cupo e lichenoso greto del Bisagno, dove i parallelepipedi dei casa-menti grigi, in un dei quali Sbarbaro ha abitato a lungo, mostrano a nudo tuttol’affascinante squallore ch’è in quel fondo della città: una gola irta di slogatearchitetture e di folli prospettive stradali, stratificate l’una sull’altra, nel cui ampioseno hanno trovato asilo, tra gli spellati contrafforti di un preappennino che
PIETRO BENZONI290
6.A sua volta la metafora di Sbarbaro discende dal D’Annunzio di Maia, «o Diversità,sirena / del mondo» (come già ricorda Polato Pia. 1996, 84).
7. Nella poesia di Caproni la parola sirena figura più volte, ma usata per lo più in sensoinnanzitutto concreto: la prima occorrenza è in PE, Sirena, (di cui si vedano anche i versi10-11: «oh la sirena / marittima»); cfr. poi PE, Litania, 98, («Genova quarta corda / Sirenache non si scorda»), SP,Urlo, 4 («che urlo, tutte insieme, / del porto, le sirene») e CVC, Il fischio(parla il guardiacaccia), 54 («mentre vibrava / nei vetri la sirena / marittima dei vapori»).
8. Cfr. Caproni 1960, 129-30.
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
mostra l’ossa sotto il magro grigioverde dell’erba, tutte le urbane laidezze e tri-stezze: le ossificate trine cimiteriali di Staglieno, i depositi tranviari, i canili, iforni crematori della spazzatura, i mercati generali, gli scannatoi, il cementiziocampo sportivo e le Carceri di Marassi, il Gazometro.Di tale città (di tale anima [...]), Sbarbaro è il cronista disincantato; anzi,
potremmo dirlo il cantore, se tale sonora parola si addicesse in qualche modo allasua voce strozzata.10
Questa, certo, pur nella pertinenza di alcune catene associative,11 sembrapiù la Genova di Caproni che quella di Sbarbaro; ma è appunto la sovrap-posizione ad essere rivelatrice: sintomo di una prossimità che definiremomeglio poi, alla luce di riscontri intertestuali più sostanziosi. Prima, però,gioverà un rapidissimo ragguaglio dei rapporti intercorsi tra i due poeti.A Sbarbaro (1888-1967), il più giovane Caproni (1912-1990) ha dedi-
cato numerosi interventi, che si dispiegano in un arco di quasi 40 anni,dal 1949 al 1986: da I licheni di Sbarbaro, recensione ai Trucioli 1948, a –notare la similarità del titolo, che sembra quasi conferire una circolarefinitezza alla serie – Gli asparagi di Sbarbaro, rievocazione dell’amicoscomparso scritta in occasione della pubblicazione dell’Opera in versi e inprosa presso Scheiwiller (OVP).12 Sulla scia di questo interesse critico (inparticolare L’amarezza di Sbarbaro piacque molto all’interessato), e dopoche nel 1959 si conobbero a Spotorno (tramite Angelo Barile), tra i duenacque anche un’affettuosa amicizia, sia pure fatta più di scambi epistola-ri che di incontri.13
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 291
9. Cfr. Proust 1951 (versione che, per Coletti 1982, 202, sarebbe «l’esito più felice e laprova sicuramente (e non solo in virtù dell’originale) più resistente al tempo» di Capronitraduttore).
10. Caproni 1960, 131.11. Oltre all’ammiccamento allo Sbarbaro lichenologo («il lichenoso greto del
Bisagno»), si consideri anche come, per la definizione di simili scenari aspri e scarnificati(cfr. «gli spellati contrafforti di un preappennino che mostra l’ossa», abbia potuto agire lamemoria di Scarsa lingua di terra, 56-57, «le petraie ventose dei tuoi monti / l’ossame deituoi greti» (tutti i corsivi miei); notando però allora anche l’ulteriore guizzo metaforicodella prosa caproniana («le ossificate trine cimiteriali»).
12. Si vedano, nella bibliografia finale, Caproni 1949, 1956a, 1956b, 1958a, 1958b, 1959,1960, 1962 e 1996.
13. Come ricorderà lo stesso Caproni: «E sebbene ci siamo rivisti pochissimo, ho unacorrispondenza abbastanza folta. Mi scriveva spesso. Io non lo andavo a trovare perchésono sempre stato un po’ appartato: non per timidezza: per pudore», cfr. Cavalleri 1983.
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
Questi primi dati, poi, andranno integrati con alcune affermazioni diCaproni, il quale, parlando della propria formazione poetica, ha sottolinea-to l’importanza della lettura di Pianissimo e dei Versi a Dina:
Sia come sia è certo che l’ambiente ligure [...] ha influito molto nella mia for-mazione. [...] Ricordo ancora l’enorme impressione che mi fecero gli Ossi di sep-pia di Montale, un nome per me allora sconosciuto, nel ’30 quando me li com-prai [...]. Ma credo che soprattutto Pianissimo di Sbarbaro abbia influito su talemia formazione, per la virile disperazione che leggevo in quei versi, e per la dol-cezza che sentivo dentro la parola “aspra” e disadorna.14
Avevo [...] 19 anni giusti e un ventilato mattino di sole, a Genova, andai comecome ogni sabato a comprarmi l’«Italia letteraria» al solito chiosco d’angolo traCorso Buenos Aires e via Casaregis.Appesa al vetro del giornalaio c’era una rivi-sta nuova, d’un rosso tendente all’ocra o al carota, e visto che conteneva versi [...]me la presi. Era il primo numero di «Circoli»: gennaio-febbraio 1931. Seduto suuna verde panchina di ferro sotto i platani, i Versi a Dina (proprio fra Nervi eLoano, o addirittura fra Nervi e i Balzi Rossi rincorrevo i miei primi amori) misi stamparono per sempre nella mente.15
II. Nonostante queste premesse, quando però si cerchi di verificare e defi-nire sui testi l’eventuale influsso della poesia di Sbarbaro su quella diCaproni, ci si trova in difficoltà.Essa infatti non sembra avervi lasciato trac-ce ben riconoscibili, nel senso che uno studio volto ad accertare, attraver-so precisi riscontri linguistici e stilistici, echi o lasciti certi dà, almeno alleprime ricognizioni, magri frutti. E, d’altra parte, anche se, genericamente,nella disadorna pronuncia sbarbariana con i suoi endecasillabi dinoccolati eraumiliati,16 si può certo vedere un primo impulso di quell’avvicinamento
PIETRO BENZONI292
Ma, per ulteriori dettagli sulle relazioni tra i due autori, si vedano Dei 1982, ad vocem; laCronologia che la stessa Dei ha poi approntato per OV; e Caproni 2004, 92-98. Quanto allacorrispondenza, due lettere del settembre 1961 sono edite in Devoto 2002, 6-8 (e poioggetto dello studio di Zoboli 2006, 239-49); mentre 52 lettere indirizzate da Sbarbaro aCaproni fra il 1950 e il 1965 sono conservate nel Fondo Caproni del Gabinetto Vieusseuxdi Firenze (cfr. Zoboli 2006, 244).
14. Cfr. l’intervista in Camon 1965, 133.15. Caproni 1986, 3.16. L’aggettivazione è quella usata da Caproni 1960, 127;ma di endecasillabo umiliato per
Pianissimo aveva già parlato Solmi 1949,303 (definizione da cui prende le mosse Mengaldo2006, 262). Quanto alla variante caproniana, raumiliato, ‘riabbassato, avvilito’, si tratta di
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
alla prosa che caratterizzerà tanta poesia del Novecento e di Caproni inparticolare, tuttavia il sistema poetico di Sbarbaro, così compattamentemonologico, linguisticamente uniforme e monovalente, e tutto impregna-to di modelli ottocenteschi (Baudelaire, Rimbaud e Leopardi in primoluogo), sembra scoraggiare sul nascere accostamenti veri e propri conquello aperto e variegato (nei registri come nelle modalità della voce),diversissimo per tonalità e cadenze, di un autore pienamente novecente-sco (non tanto per la costellazione dei riferimenti quanto per le tecnichedi assimilazione), qual è Caproni. Sintomatico in tal senso il fatto che, se siè visto bene, studi volti ad indagare le presenze di Sbarbaro nella poesia diCaproni, non ce ne siano.17
Eppure, scavando in ambiti tematici ben determinati, si può comun-que trovare qualcosa di interessante. Si guardi dunque, innanzitutto, tra itesti in cui Caproni parla esplicitamente del padre,18 e si prenda in parti-colare PE, Albania,19 una poesia in cui, appunto, si intravede un io-figlioinerte e come annichilito di fronte al venir meno del genitore malato:
Quanti gabbiani chiari– bianchi, neri – a Bari!
Sul mare che pullulavadi polpi teneri, urlava(lungo la palizzata 5freddissima e soleggiata)
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 293
voce letteraria (cfr. GDLI) che, come si sarà notato in precedenza, era stata già usata in que-sto stesso articolo su Sbarbaro (cfr. il versante raumiliato di Caproni 1960, 131), quasi ad assu-mere una funzione connotante.
17. Segnalo solamente come, per l’immagine del «firmamento rovesciatosi sulla terra e sulmare», utilizzata da Caproni nella prosa Genova per descrivere lo scintillio dei notturnigenovesi (poi cantato anche in CVC, Il gibbone, 13-15), Zoboli abbia individuato la proba-bile fonte in uno dei primi Trucioli dove, in uno stesso contesto, figura appunto l’immaginedel firmamento capovolto (cfr. Zoboli 2006, 133-34).
18. Si tratta di un piccolo corpus costituito innanzitutto da quattro poesie (PE,Albania,SP, Treno – qui nel saggio citate per intero – MT, Il vetrone e MT, A mio figlio Attilio Mauroche ha il nome di mio padre), cui eventualmente si possono affiancare due prose ora raccol-te in OV: una intitolata Ai genitori che figurava nella prima edizione di Cronistoria (e poiesclusa dalle successive) e una seconda, mai data alle stampe da Caproni, e ora edita daLuca Zuliani nell’apparato introduttivo del Seme del piangere (cfr. OV 1098 e 1319).
19. Come chiosa lo stesso Caproni, la voce albania, è direttamente formata dal latinoalbus, ‘bianco lucente’, e «si riferisce al biancheggiare dei gabbiani; ma l’Albania geografi-ca non è lontana, appena oltre il mare» (cfr. OV 1275).
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
il cuore sbigottitoin un silenzio inaudito.
Mio padre era finitoe solo (a letto) a Bari. 10E s’io non muovevo un ditoper lui, gli autobus (rarisul lungomare) umaniavevano di quei gabbianigli squittii rotti – a Bari. 15
Assaporava molluschila guardia di finanza:guardava con gli occhi lustri
il collo d’una ragazza.
Ma io ero da me via, 20
e di passaggio, a Bari:piangevo in quell’albaniadi gabbiani – di ali.
Ebbene, si possono qui richiamare le grandi liriche di Pianissimo allamemoria del padre: PI VII, Padre se anche tu non fossi mio padre, e soprattut-to, PI XVII, Padre che muori tutti i giorni un poco (più, eventualmente, laseconda strofa di PI XI, Lacrime sotto sguardi curiosi). E il richiamo, contra-riamente a quanto forse poteva sembrare ad una prima lettura, sarà tutt’al-tro che vago: suffragato da una piccola trama di coincidenze semantico-lessicali (qui evidenziate: cfr. PI XVII, 41-45 «... pensando / che come glialtri uomini dovevi / morire pure tu, il nostro padre, / solo e zitto nel mioletto la notte / io di sbigottimento lacrimavo»), e dal riutilizzo, nella stro-fetta in cui si fissa icasticamente la lubricità del finanziere, di un sintagma,con gli occhi lustri, quasi firmato (cfr. l’incipit di PI XXVIII, «Magra dagliocchi lustri, dai pomelli / accesi...»).20 Alla luce di tali riscontri, siamopoi tentati di ravvisare una matrice sbarbariana anche nella postura dell’ioche denuncia con intransigenza (forse con punte di masochismo, più evi-
PIETRO BENZONI294
20. Ma cfr. anche, dalle Poesie di Cardarelli, Idillio, 25-26, «Gli occhi, infocati e lustri, /di gioventù brillavano»; e dalle Poesie (1927-1938) di Sandro Penna, «Trovato ho il mioangioletto / fra una losca platea. / Fumava un sigaretto / e gli occhi lustri avea».
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
denti poi in SP, Treno) le proprie mancanze e la propria condizione diassenza da sé (cfr. i versi 11, «E s’io non muovevo un dito... », e 19, «Ma ioero da me via»). E naturalmente tali convergenze daranno anche valore airilievi contrastivi. Si noterà allora, in particolare, che quanto era nitida-mente detto nei versi di Sbarbaro, con il loro solido impianto ragionativodi ascendenza leopardiana (la pietas impotente e il senso di colpa, il rimor-so e al tempo stesso l’impossibilità di credere alla sincerità del proprio sof-frire, etc.), risulta invece, in Caproni, meno dicibile, come allontanato inuna laconica sensorialità. Per cui, in Albania, l’inadeguatezza del figlio(Enea mancato, incapace di caricarsi sulla spalle il proprio Anchise)21
emerge anche, obliquamente, nel fatto che questi sia quasi tutto assorbitodalla registrazione di oggetti e dettagli che al dramma fanno da contornoe che ad esso, probabilmente, si sono andati associando nella memoria (ilbiancheggiare delle ali di gabbiani e le loro strida, il pullulare dei polpi, lapalizzata, l’atteggiamento del finanziere, etc.), mentre sul padre malato siappuntino solo due versi (i vv. 8-9) nudamente referenziali. I vocativi e leallocuzioni di Pianissimo hanno poi ceduto il posto a un discorso piùdistanziante, che per il padre prevede solo la terza persona.Al tempo stes-so, la virile disperazione che Caproni dice di aver amato in Sbarbaro sem-bra aver assunto forme più indifese e interiettive, e il soggetto lirico esserpiù disposto a mostrare, senza filtri, la propria fragilità: in Albania, in par-ticolare, vediamo l’io caproniano piangere come quello di Pianissimo, daadulto, dice di non aver più saputo fare (PI XVII, 35-39: «perdono non tichiedo con le lacrime / che mi sarebbe dolce piangere, / ma con quellepiù amare te lo chiedo / che non vogliono uscirmi dagli occhi»).22 Ma,di fondo, in entrambi gli autori, pare di poter cogliere una analoga intran-
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 295
21. Non si dimentichi come lo spunto per Il passaggio d’Enea sia venuto a Caproni«guardando il classico monumentino ad Enea [...] col padre sulle spalle e il figlioletto permano», che si trova a Genova in Piazza Bandiera (cfr. la Nota alla raccolta in OV, 180).Questa testimonianza poi ci invita a considerare come il diverso trattamento di uno deitemi che qui accomuna i due poeti (il dramma del divenire adulti) possa anche esserericondotto a una diversa situazione biografica di partenza: mentre Pianissimo è una rac-colta, non priva di enfasi giovanile, pubblicata da Sbarbaro a 26 anni, Il passaggio d’Enea,invece, è opera di una più reticente maturità, di un uomo (Caproni a 44 anni) che è figlioe padre insieme.
22. Cfr. anche dalle Cartoline in franchigia: «... io che non metto mai esclamativi ai mieiversi, che non potrei piangere in presenza di un altro, fosse mio padre» (OVP 547-48).
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
sigenza di fronte a se stessi e una analoga consapevolezza dell’impossibi-lità di un autentico sfogo; perché, come Sbarbaro ha enunciato a chiarelettere, e Caproni sembra qui avere appreso, la confessione è spesso soloun ipocrita tentativo di alleggerire la colpa e quindi, di fatto,un’aggravante («Io voglio confessarmi [...] di quanto fui vigliacco verso te./ Benché il rimorso mi si alleggerisca, / che più giusto sarebbe mi pesas-se / inconfessato sempre sopra il cuore»); né i pianti (le sciocche lacrime cheinvece colano in PI XX e XXI) possono arrecare alcun vero conforto.E chiaramente complementare ad Albania (v. l’accenno ad un prose-
guimento per Bari, scenario di Albania e città dove effettivamente il padreAttilio Caproni è morto nel 1956) è poi SP, Treno, che, pur non presen-tando echi sbarbariani così puntuali, risulta ancora più esplicita neldenunciare la latitanza dell’io, il figliolo per due volte esposto (in tutta lasua colpevolezza, verrebbe da dire) in apposizione e in clausola marcata(ai versi 6 e 12, ossia al centro esatto e alla fine del testo):
Ahi treno lungo e lento(nero) fino a Benevento.Mio padre piangeva sgomentod’essere così vecchio.
5 Piangeva in treno, solo,davanti a me, suo figliolo.Che sole nello scompartimentovuoto, fino a Benevento!
Io nulla gli avevo detto,10 standogli di rimpetto.
Per Bari proseguì solo:lo lasciai lì: io, suo figliolo.
Anche qui ritroviamo dunque quel senso di vitalità ammutolita, di iner-zia e d’impotenza di fronte alla sofferenza del padre (che piange «sgomen-to / di essere così vecchio») già fissati, pure lì in silenzio e con occhioasciutto, nei versi di PI XVII («Padre, che muori tutti i giorni un poco [...]e [se] poi ti guardo così come sei, / io mi torco in silenzio le mie mani»).23
PIETRO BENZONI296
23. In PI XVII, 27-29, invece, l’io sbarbariano, ormai adulto, confessa: «Io giovinetto,
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
Anche se ci sembra che quella peculiare unione di autenticità e ipocri-sia e quello sforzo di comprimere l’aggressività del sentimento, a suotempo individuati da Fortini come costitutivi della poesia di Sbarbaro edelle sue liriche per il padre in particolare, siano, in questo Caproni,decisamente venuti meno, sostituiti, appunto da un pathos più inerme.24
Ma se ora ci siamo un po’ attardati su queste poesie, non è solo perchéesse mostrano bene come una memoria e una sensibilità sbarbariane pos-sano riaffiorare in testi apparentemente così lontani – e così tipici di uncerto Caproni nel loro far coesistere una materia straziante con metri faci-li e cantabili (con le rime baciate e i ritmi di canzonetta). È anche perchéAlbania e Treno sono variamente implicate, come si vedrà meglio tra poco,con quelle che per comodità chiamerò le “liriche della perdizione”, checostituiscono il terreno più fertile per la nostra indagine. Perdizione quiconsiderata soprattutto come stato di annullamento e abbandono associa-to al bisogno e allo sfogo sessuale. I temi però, si sa, tendono a definirsi nonisolatamente, bensì come fasci, come grappoli (come grumi, sarebbe forsepiù appropriato dire in questo caso). E ora, con questo così definito dellaperdizione, ci sarà tutto un corollario di motivi torbidi, cari tanto al natu-ralismo quanto al maledettismo decadente, dell’inquieto nottambulismo,della discesa nei bassifondi, della prostituzione, dell’adescamento, del tor-mento e della nausea sessuale, della ricerca di una fraternità nella dereli-zione, etc. (si potrebbe parlare di postribolazioni, volendo mutuare un ter-mine che, coniato da Joyce quando traduceva in italiano alcuni passi delFinnegan’s, presenta un meccanismo di formazione assai simile a quello chesarà utilizzato dall’ultimo Caproni per le sue asparizioni).Nell’opera di Camillo Sbarbaro, perdizione e lussuria sono, com’è
noto, temi dichiarati (bastino i seguenti incipit: PI IV, «Esco dalla lussuria.
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 297
imberbe, t’ho guardato / con ira, padre, per la tua vecchiezza. / Stizza contro te vecchiomi prendeva».
24. Più precisamente, scrive Fortini: «[in Sbarbaro] c’è una unione, non ironizzata, népirandellianamente concettualizzata, di autenticità e ipocrisia: emana una sorta di ranco-re morale; è la colpa che, scomparsa ogni fede, si traveste da risentimento [...]. Ci sem-bra che le poesie sentimentali di Pianissimo – ad esempio le liriche alla memoria delpadre – per essere quelle dove più sensibile è la contraddizione di cui abbiamo parlato,siano le più autentiche: vivono nello sforzo stilistico di comprimere con l’angoscia di unarappresentazione dimessa un’energia, un’enfasi e un pathos persino aggressivi» (cfr.Fortini 1988, 16-17).
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
/ M’incammino / per lastrici sonori nella notte», PI XIV, «Adesso che pla-cata è la lussuria / io son rimasto coi miei sensi vuoti»; PI XXV «Iot’aspetto allo svolto di ogni via, / Perdizione.Ti cerco dentro gli occhi /di ogni donna che passa») che informano in particolare, non senza qual-che punta di ostentato maledettismo (v. ad es. PI XXII, 13-16: «trasalgono[...] le mie nari che fiutano il Delitto»), la seconda parte della raccoltaPianissimo (e, in prosa, i primi Trucioli, con le loro relative accensioni lin-guistiche). Gli scenari sono per lo più urbani, notturni, bassi ed equivo-ci; riecheggiano le voci di Baudelaire, Rimbaud e D’Annunzio.25 MaSbarbaro, senza appiattirsi nella rivisitazione di tali antecedenti letterari,ha saputo fare di questa nuova saison en enfer, un elemento funzionale aquanto di più peculiare c’è nella sua esperienza poetica: l’implacabile easciutto referto degli stati di atonia, pietrificazione, aridità e bloccatocerebralismo di volta in volta stilato dall’io lirico. Un io che, spinto piùda forze inerziali che da una qualche volontà, cammina assente e indiffe-rente per una città ostile e astratta, percepita come deserto, e comunqueteatro di solitudine ed estraneazione, se dalle sue folle il soggetto si lasciaurtare come cosa inanimata. Un io che si presenta ora come un sonnam-bulo, ora come un puro semplice occhio, ora come uno specchio rassegna-to, ora come un automa, etc., sempre comunque come un essere dimi-diato, deprivato dei sensi e della facoltà più propriamente umane, essic-cato di molte sue linfe o pulsioni vitali, se non reificato tout court. E la tri-ste sazietà dell’uomo che ha placato la lussuria ed è rimasto coi sensi vuotidiventa dunque, qui, una condizione privilegiata di questa assenza da sé edalla vita: la condizione di un uomo rimasto «senza pensiero / e senzadesiderio», «sordo e opaco», «fatto pietra», cui è negata anche la consola-zione del dolore, alla quale d’altra parte non può più onestamente crede-re («ogni pensiero di dolore adesso / mi sembrerebbe suscitato a arte»).Ma qui c’è una nutrita e solida bibliografia,26 per cui, senza dilungar-
ci oltre, veniamo a Caproni e a quanto di nuovo può scaturire dal con-fronto. Com’era lecito attendersi, per lui, perdizione e lussuria sono miti
PIETRO BENZONI298
25. Bàrberi Squarotti, in particolare, ha mostrato come la città sbarbariana sia situabiletra le vieilles capitales delle Fleurs du mal e le città terribili diMaia (cfr. Bàrberi Squarotti 1974,139-158). Ma in proposito v. anche Torchio 1970 e Sanna 2003.
26. Si vedano principalmente Polato 1969, Bàrberi Squarotti 1971, Coletti 1997 ePolato Pia. 1996.
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
letterari ormai spenti (sintomatico d’altro canto che queste due voci, cosìcome cupidigia e voluttà, non figurino mai nella sua opera in versi). Nonc’è appunto la voluttà di scendere più in basso: il maledettismo, sia puresprovvisto di ogni titanismo quale lo si ritrova in Sbarbaro, non esercitaalcun richiamo diretto su di lui, agendo, semmai, solo in termini di spun-to germinale per la definizione di quegli scenari dalle tonalità infere equotidiane insieme che caratterizzano il Passaggio d’Enea (come si vedràmeglio poi).Tuttavia si può circoscrivere un piccolo corpus, coagulato dal ritorno
di analoghe tematiche (pulsione sessuale e cupio dissolvi, derive notturne eprostituzione, etc.), che può esser fatto proficuamente reagire con il pre-cedente sbarbariano (eventualmente considerato assieme ai Canti Orfici diDino Campana). I testi incriminati sono essenzialmente la Didascalia el’Epilogo di All Alone, ossia le ante laterali dell’eponimo poemetto a trit-tico (che nell’assetto definitivo del Passaggio di Enea, segue Sirena nellasezione Le Stanze); SP, Il becolino e CVC, Lamento (o boria) del preticello deri-so.27Tutti testi apparsi tra il 1954 e il 1961 (ossia negli stessi anni in cui siconcentrano gli articoli sulla corrente ligustica e gran parte di quelli suSbarbaro),28 e che tra loro sono variamente imparentati anche per via deinumerosi e puntuali richiami intertestuali; con legami particolarmenteforti e vistosi tra Epilogo e Il becolino, caso sul quale vale la pena indugia-re.29 I due testi sono, infatti, decisamente assimilabili l’uno all’altro, sia pertemi, situazioni e atmosfere, che per metro, sistema rimico, tecnica narra-
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 299
27. Che si tratti di testi contigui, lo confermerebbe anche una scelta di Caproni che,nel 1968, in occasione della pubblicazione de Il terzo libro e altre cose, sentì l’esigenza diincludere anche Il becolino e Il lamento del preticello («perché inerenti e integranti») nelPassaggio d’Enea, rispettivamente nelle sezioni Sul cantino e Altre cose. Le due poesie,comunque, ritroveranno la loro sede originaria (SP e CVC) a partire dall’edizione com-plessiva di Tutte le poesie, uscita per Garzanti nel 1983 (cfr. OV 1459 e 1520).
28. Più precisamente: All Alone, prima della sua pubblicazione in volume nella sezio-ne Le Stanze del Passaggio d’Enea (Vallecchi, 1956) apparve su «Botteghe oscure», XIV,luglio-dicembre 1954 (e nel 1955, il suo Epilogo, presentato con il titolo La piccola porta,vinse il Premio Lerici); Il becolino fu pubblicato per la prima volta in volume nel Seme delpiangere (Garzanti, 1959); mentre il Lamento (o boria) del preticello deriso, prima che nelCongedo del viaggiatore cerimonioso (Garzanti, 1965), uscì su «Palatina», V, 19, luglio-settem-bre 1961 (cfr. i relativi apparati in OV).
29. Per uno studio a largo raggio, su intertesto e narratività in OV, v. invece Bozzola1993.
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
tiva, modalità del discorso e scelte lessicali (per queste ultime, le coinci-denze più rilevanti sono qui sotto rilevate dalla grafica):
All Alone 3. Epilogo
Era una piccola porta(verde) da poco tinta.Bussando sentivo una spintaindicibile, e a aprirmiveniva sempre (impurae agra) una figuradi donna lunga e magranella sua veste discinta.
La notte con me entrava,subito, nella cinta.Salivo di lavagnarosicata una scala,né ho mai saputo se era,a spengere la candela,il nero umidore del mareo il fiato della mia compagna.
Avevo infatti una cagna(randagia) che mi seguiva.L’intero giorno dormiva,disfatta, fra i limoni,ma nottetempo (carponie madida) mi seguivabagnandomi, con la saliva,la punta delle dita.
Forse era la mia vitaintera, che mi lambiva.Ma entrato oltre la portaverde, mai con più remoram’era accaduto che Genova(da me lasciata),mortaio già piangessi, e sepolta,nel tonfo di quella porta.
Eppure io piansi Genova,l’ultima volta, entrato.
PIETRO BENZONI300
Il becolino
Piangevo in un’incerta casapiena di stanze amorfe.La luce che sulle portebatteva, era di lunae nuvola (era di maree barca), e penetravanel cuore che si straziava– vano – per la sua sorte.
Sentivo ondate mortefrangersi sulla rena.Sentivo alla catenaabbaiare più fortela cagna, e sbigottitanel petto sentivo la vitamia intera palpitarecome dovesse arrivarenon so che remo dal mare.
Tremava nel portonela lampadina a carbone.Scuotevano le impannate,violente, le ventate,ma che altro poteva annunziare,se non l’umidore del mare,la tromba delle scaleche s’era messa a suonare?
Piangevo in una grande casa,di notte, in lutto e in follia.Piangevo la patria miadisertata, ed anchepiangevo la donna dalle ancheladre, che dalla seraalla mattina andavasu e giù pel molo, e palpava(mentre una nave salpavafitta di lumi) i guardiani
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
Il giorno non era natoancora, e campanea gloria (forse era festad’anima, e di resurrezione)m’empivano la testacol vento della costernazione.
Salita della Tossescandivano ragazze rosse.Ragazze che in ciabattee senza calze (morseal calcagno e alla nucadimagrita dal dentedi quell’ora impellente),andavano, percorseda un brivido, sulla salitache anch’io facevo, solo,già al canto d’un usignolo.
Genova di tutta la vitanasceva in quella salita.Seguivo i polpacci bianchie infreddoliti, e invitiveementi, su dal portoche si sgranchiva, nettisalivano dal carbone,che già azzurro di brinabrillava, sulla banchina.
Entrai, non so dir come,spinto da quel carbone.Ma a un tratto mi sentii senzapiù padre (senza più madree famiglia, e vittoria),e solo nella trombadelle scale, indietromi ritorsi, la tombariaprendo della portagià scattatami dietro.
Che fresco odore di vitami punse sulla salita!Ragazze ormai aperte e verein vivi abiti chiari
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 301
che, con tre scudi, alle manidi lei, contratti in viso,cedevano il paradisocui non credevano,mortida secoli tra i cordamiattorcigliati, e sepolti.
Piangevo in costernazioneil giorno della trasmutazione.Piangeva la latteriadove con lei la miaanima debole (strettafra quelle anche), in fretta(il vento era di ciclone,ed abbassò la tensione)perdette con la giacchetta,lasciata a un chiodo, il solosuo infagottato tesoro.
Piangevo senza saper direil seme del mio morire.Sentivo che nel buio c’eraqualcuno, ad origliare,ma mai avrei potuto tentared’aprire, e guardarelei che in capelli e impura(l’orecchio alla serraturae il fiato spesso) aspettava,mentre il vento soffiava,un segno della mia paura.
Sapevo che col giornosarei tornato a Livorno.Sapevo che avrei trovatopioggia e vento al mercato,e che (tra pesci e verdura,e odore d’acqua e d’ariasfatta) un bambinodi nuovo sarebbe corso,sfuggito di mano, sul Fossoper mettersi a singhiozzare(bagnato dal vento di mare)sul nero becolinolungo, e sul suo scivolare.
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
(ragazze come bandiere,già estive, balneari),sbracciate fino alle ascellescendevano, d’arsellee di cipria un odoremuovendo a mescolarel’aria, dal Righi al mare.
Avevano le braccia bianchee le pupille nere.Con me un carabinierecome le stava a guardare!
Mi misi anch’io a scendereseguendo lo sciamaregiovane, e se di tende,bianche fino a accecare,già sentivo schioccarela tela, ahi in me sul marele lacrime – ahi le campanedure d’acqua stormentenel mio orecchio, e in menteancora la piccola porta(verde, e da poco morta),cui più con tanta spintapotevo nel ventilaredel giorno, ormai, bussare.
Entrambi, dunque, sono testi piuttosto lunghi (rispettivamente di 99e 76 versi) con misure versali per lo più oscillanti tra il settenario e ilnovenario, ritmi da canzonetta poggianti su una fitta successione dirime (o quasi rime) spesso baciate, scanditi da imperfetti onirico-narra-tivi, che rievocano, per squarci e intermittenze, episodi un po’ torbidi,in cui l’io narrante soffre una situazione di perdita ed esproprio di sé, ein cui l’urgere dell’istinto sessuale si palesa anche come richiamo dimorte. Dove l’iteratività del dettato e la forte strutturazione anaforicadicono poi efficacemente la spinta ossessivo-compulsiva che sembraguidare le mosse e i cedimenti di quest’io, smarrito entro scenari equi-voci che sono al tempo stesso reali e accessibili al mito.30 Sono testi
PIETRO BENZONI302
30. Cfr. quanto Mengaldo 1998, 178, ha scritto a proposito del Passaggio d’Enea: «usan-
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
però non del tutto decifrabili, densi di cose e immagini concrete, mapoveri di azioni compiutamente riferite e logicamente concatenate. Ildiscorso, infatti, si presenta, ossimoricamente, come una confessioneimpudica e riluttante insieme: come una rievocazione inceppata cheillumina vividamente alcuni particolari, lasciando però lacunoso il qua-dro e piuttosto allentato il vincolo interpretativo. Si intuisce un tralic-cio, un nocciolo narrativo: in Epilogo, un antro di perdizione cui l’iobussa, e da cui si lascia momentaneamente inghiottire, per poi infineriemergerne; nel Becolino, sullo sfondo di sordidi amori mercenari, unio che si dispera e piange una perdita irrimediabile.Una fabula che però,appunto, non è messa a giorno e affiora, solo a tratti, a fitte e a bran-delli, verrebbe da dire. La vicenda, evidentemente traumatica, e nonpriva di suggestioni orfiche e iniziatiche (v. in particolare come l’io, inAll Alone, Didascalia, varchi una porta stretta,31 per accedere a un anditobuio che si trasfigurerà poi, in Epilogo, in luogo tombale cui sottrarsi),32
è stata fissata, cioè, solo in alcuni suoi acuminati dettagli, e in una tramadi correlativi oggettivi i cui codici sono però in buona misura criptati,se non negati al lettore.L’interpretazione, comunque, almeno per Il becolino, potrà essere age-
volata da quanto lo stesso Caproni ha rivelato, non senza reticenze (v.come l’affermazione iniziale sia poi virata in ipotesi) in un’intervista del
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 303
do il termine con molta cautela, si può dire che qui inizia il “realismo” di Caproni: [...] èuna realtà, o sono segni dell’esistenza, che si mutano in modo incessante in mito, aperta-mente. Più precisamente: passaggio da una realtà già impregnata di mito a un mito ches’appoggia, anche ingannevolmente, alla realtà.Ma non si pensi a una freccia unica: gli slit-tamenti e i mutui impregnamenti fra realtà (esistenza) e mito sono continui, e non neces-sariamente nella direzione del secondo».
31. Il sintagma, poi, in questo contesto, sembra gravido di memoria letteraria: si con-siderino, oltre alla possibile eco evangelica, il titolo del romanzo di Gide, La porte étroite(1909) e i versi 31-37 della montaliana Ballata scritta in una clinica (pubblicata già nel 1945su rivista e poi inclusa nel 1956 nella Bufera), «Hai messo sul comodino / il bulldog dilegno, la sveglia […] il nulla che basta a chi vuole / forzare la porta stretta»
32. Nella raccolta del Passaggio d’Enea, d’altra parte, spesso è adombrata una dimen-sione orfica nella realtà più quotidiana; e non solo genericamente: basti pensare al tramche «apre e richiude in eterno le deserte sue porte» di Alba, ai «magri bar dove in Ereboè il passo» e alla Proserpina nella latteria dell’ultima delle Stanze della funicolare; al «richia-mo d’Averno» e ai «campi dei Cimmeri» nella terza strofa dei Versi del Passaggio d’Enea, etc.
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
1988 (rilasciata cioè circa 30 anni dopo la stesura della poesia), nel corsodi un programma radiofonico:
«[Il becolino] è una strana poesia, sull’iniziazione, come dicono oggi, in questabella lingua che si parla oggi, iniziazione sessuale [...]. Così ha detto un critico[…]. Può darsi, sebbene non mi piaccia molto l’espressione iniziazione sessuale[…]. Ma il lutto probabilmente c’è più che l’amore […], io l’iniziazione sessua-le ce la vedo fino a un certo punto, tutt’al più vedo... questa era... si può dire laparola... una puttana di porto. Io, bambino, vedevo, capivo tutto quello che com-binava. Naturalmente, con quella purezza che si ha da bambini, ne soffrivo, equindi mi faceva pensare più alla morte che all’amore, [...] è più un’iniziazionedi morte, se dobbiamo parlare d’iniziazione; infatti parlo del mio lungo morire.Insomma finiva l’innocenza per me, qualcosa moriva».33
E gli spunti qui condensati certo possono agevolare anche la lettura diEpilogo, a patto però di sottolinearne una diversità sostanziale. Epilogo,infatti, a differenza del più sconsolato Becolino, presenta un percorso indefinitiva euforico-salvifico: perché, proprio sull’orlo del baratro c’è loscatto vitale (vv. 66-70: «e solo nella tromba / delle scale, indietro / miritorsi, la tomba / riaprendo della porta / già scattatami dietro»), e la ricon-quista, nelle strofe conclusive, di uno spazio vivo, ventilato e luminoso chesi riflette non solo nella nuova enfasi delle esclamative (vv. 71-72 «Che fre-sco odore di vita / mi punse sulla salita!»), ma anche nella trama fonico-semantica: nelle rime ariose e marine dei vv. 73-76, «Ragazze ormai aper-te e vere / in vivi abiti chiari, / ragazze come bandiere / già estive, bal-neari...» (sequenze che sembrano anticipare le semplici e tintinnanti melo-die dei Versi livornesi dedicati alla madre da giovane, in virtù di quel sim-bolismo fonico poi professato nella metapoetica Per lei).Ma veniamo al dunque.Anche qui il richiamo del modello sbarbaria-
no, che data l’oggettiva diversità degli esiti e delle voci poteva risultareazzardato, all’indagine si rivela invece tutt’altro che infondato: confortatoda più indizi che, nell’insieme, ci sembrano assumere un carattere pro-bante. Infatti, non si tratta solo di vaghe consonanze di situazioni e sce-nari, ma del ritorno di uno stesso viluppo di temi e motivi caratteriz-zanti, che si accampano su un medesimo sfondo notturno, sostanzial-
PIETRO BENZONI304
33. Cfr. Caproni 2004, 66 e 73-75 (ma il passo è citato nelle sue linee essenziali già inOV 1458).
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
mente portuale e genovese (ci torneremo), dove agisce un io lirico per lopiù deficitario; il tutto corroborato da numerose coincidenze lessicali esintagmatiche.Più nel dettaglio. Una delle peculiarità di Pianissimo è la commistione
di limpidi affetti familiari, avvilenti commerci sessuali e proiezioni fune-ree, che si coglie non solo nella macrostruttura, ma anche nelle singoleliriche, e talvolta nel giro di pochi versi (PI XIV, 1-5, «Adesso che placataè la lussuria [...] Ignoro […] se il mio padre viva»; PI IV, 1-23, «Esco dallalussuria [...] Mi pare d’essere sordo ed opaco […] Ché il mio padre e lamia sorella sono / lontani, come morti da tanti anni, / come sepolti giànella memoria»; in PI XXVIII, 3-6, «la mia anima torbida che cerca / chi lesomigli / trova te che sull’uscio aspetti gli uomini. // Tu sei la mia sorel-la di quest’ora. [...] E coricarmi senza desiderio / nel tuo letto! /Cadavere vicino ad un cadavere [...] e tormentarti / domandandoti ilnome di tua madre...»; PI XIII, 24-25, «la tenerezza per la mia sorella / el’ingordo possesso della femmina», con parallelismo sintattico che sotto-linea il contrasto). Una commistione che Sbarbaro stesso, nella prefazio-ne scritta “a freddo”, nel 1954 (in occasione della riedizione diPianissimo), ha fissato con una capacità di autoanalisi così tersa da risulta-re quasi sospetta:34
Da alcuni anni durava la tregua, quando una notte che coi sensi sazi giacevoa letto “lungo disteso come in una bara”, mi venne da sé alle labbra la constata-zione: Taci anima stanca di godere e di soffrire... Prendevo coscienza di me; nascevail mio secondo libretto di versi: una specie di sconsolata confessione fatta a fiordi labbro a me stesso, dove sull’affiorare di torbidi istinti e di nausee sessualidominava il lutto, patito in anticipo, per la morte che vedevo prossima di miopadre [cfr. OVP 473].
Ebbene, anche alla radice dei testi caproniani sopra additati sembraesserci un analogo nodo, che stringe pulsioni libido-mortuarie e richia-mi familiari; anche se qui esso non viene composto in enunciazioni nettecome in Sbarbaro, ma si manifesta in forme più viscerali e drammatizza-te. Il passo più eloquente in tal senso è quello di Epilogo, 61-70: «Entrai,non so dir come, / spinto da quel carbone. / Ma a un tratto mi sentii
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 305
34. Coletti 1997, 9: «La sintesi è impeccabile e forse lo è anche troppo. Sembra quasiun condensato di psicanalisi manualistica...».
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
senza / più padre (senza più madre / e famiglia, e vittoria), / e solo nellatromba / delle scale, indietro / mi ritorsi, la tomba / riaprendo della porta/ già scattatami dietro». Ma significative saranno pure le strette connes-sioni che legano questi testi della perdizione a quelli in precedenza citatidel tormento filiale: si veda come l’anafora portante del Becolino sia quasiidentica a quella di Treno (Piangevo // Piangeva); come il carabiniere diEpilogo, 82-85, («Avevano le braccia bianche / e le pupille nere. / Con meun carabiniere / come le stava a guardare!») sembri trovare una sua ver-sione più caratterizzata nel finanziere di Albania, 16-19, («Assaporava mol-luschi / la guardia di finanza: / guardava con occhi lustri / il collo d’unaragazza»);35 e come le cornice di bianca disperazione di Albania e delLamento (o boria) del preticello deriso siano quasi sovrapponibili (cfr.Albaniaincipit e chiusa: «Quanti gabbiani chiari [...] Sul mare che pullulava [...]piangevo in quell’albania / di gabbiani, di ali», con Lamento..., 79-84,«All’alba me n’andai sul mare, / a piangere. Di disperazione. / Volavanobianchi d’ali / i gabbiani...»).36
Ci sembra poi che, nella definizione dei propri scenari di lascivia ederiva, Caproni abbia rimodulato numerosi spunti sbarbariani, che rie-mergono tanto in forma di nebulosa, quanto di riprese più puntuali. Inparticolare, ci sembra che Caproni tenda a individualizzare e a svilupparesecondo la propria peculiare attenzione per la consistenza (e la sensualità)della materia ciò che Sbarbaro designava con plurali liricamente indeter-minati: così, se in PI XXII si dice «…batto a porte sconosciute. Salgo / scaleconsunte…», in All alone si salirà invece una meglio determinata scala dirosicata lavagna (cfr. Epilogo, 11-12) e si busserà a un meglio determinato
PIETRO BENZONI306
35. Nel contempo, per il ravvicinato contrasto cromatico di Epilogo, 82-83 («le brac-cia bianche / e le pupille nere»), cfr.Albania, 1-2 «Quanti gabbiani chiari / – bianchi e neri– a Bari!».
36. Che il bianco abbia poi per Caproni una connotazione tragica, lo si può evincereanche dalla Nota d’autore che chiude il Passaggio d’Enea (cfr. OV 179) là dove si parla appun-to di bianca forsennata diperazione; e da un passo del racconto Il labirinto (pubblicato per laprima volta nel 1946): «L’alba mi è sempre stata odiosa... è l’ora bianca delle fucilazioni, quan-do si dice al condannato “Vieni, il plotone ti aspetta”. E nel petto del condannato nascecome un gran vento vorticoso che squassa e non trova direzione»; corsivi miei, cfr.Caproni 1992, 78. (Quanto al tema così caproniano dell’alba tragica, cfr. la disperata luce delmattino nell’explicit di PI XV, Svegliandomi il mattino...; a sua volta collocabile nella scia deLe crépuscule du matin di Baudelaire).
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
portone di scivolosa arenaria (cfr.Didascalia, 23-24).37 Non senza che si pos-sano comunque ravvisare delle riprese sintagmatiche più forti: cfr. innan-zitutto il già citato PI IV, Esco dalla lussuria, 22-23 «Ché il mio padre e lamia sorella sono / lontani, comemorti da tanti anni, / come sepolti giànella memoria», con Epilogo, 30-31, «Ma entrato oltre la porta / verde,maicon più remora / m’era accaduto che Genova / (da me lasciata),morta/ io già piangessi, e sepolta, / nel tonfo di quella porta», e Il becolino, 39-41, «cedevano il paradiso / cui non credevano,morti / da secoli tra i cor-dami38 / attorcigliati, e sepolti»; due luoghi, cioè, dove Caproni, accen-tuando un aspetto latente nei versi di Sbarbaro, rivitalizza il modo dire«morto e sepolto», distanziandone gli elementi.Ma per meglio cogliere portata e modalità dell’influsso sbarbariano,
rileggiamo nella sua integrità il testo di PI XXII:
Nel mio povero sangue qualche voltafermentano gli oscuri desideri,Vado per la città solo la notte:e l’odore dei fondaci al ricordovince l’odor dell’erba sotto il sole. 5
Rasento le miriadi degli esserisigillati in se stessi come tOMBE
E batto a porte sconosciute.Salgo scale consunte da generazioni.La femmina che aspetta sulla pORTA 10l’ubriaco che rece contro il muroguardo con occhi di fraternità.E certe volte subito trasalgono,nell’andito malcerto in capo a cuiocchi di sangue paiono i fanali, 15le mie NARI fiutano il Delitto.
Mi cresce dentro l’ansia di moriresenza avere il godibile godutosenza avere il soffribile soffERTO.La volontà mi prende di gettARE 20cOME un ingombro inutile il mio nOME.Con per compagna la PerdiziONE
a cuor leggero andarmene pel mondo.
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 307
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
37. E numerose poi sono le variazioni, nel Passaggio d’Enea in particolare, sul motivodel portone, i cui tonfi e gemiti di volta in volta paiono risvegliare o acuire pene e rimor-si: cfr. PE,Lamento IV, 2-5 «...Nel cupo colpo d’un portone / sbattuto, alle tue spalle ora unavoce / ben più dura ha la notte.. »; PE,Lamento VIII, 10-14 «... un altro nome / odo nei tonfiche al tuo abbandonato / passo, nel plenilunio bianco pone / come una colpa nel pettoun portone»; PE, 1944, 9-11«... O amore, amore / che disastro è nell’alba! Dai portoni / dovegeme una prima chiave...»; PE, Sirena, 10-14 «...oh la sirena / marittima, la notte quandoappena / l’occhio s’è chiuso, e nel cuore la pena / del futuro s’è aperta col bandone / scos-so di soprassalto da un portone»; e si vedano infine, in tutto il loro sviluppo, le prime duestrofe di PE,All Alone,Versi, dove tale motivo trova il suo più mirabile sviluppo.
38. Cfr. anche, dai Canti Orfici di Dino Campana,Genova, 128-129, «Mentre il porto inun dolce scricchiolìo / dei cordami s’addorme... »; richiamo lessicale giustificato dal con-testo tematicamente affine (cfr. in particolare i vv. 40-45, «... e per i vichi lubrici di fana-li il canto / instornellato de le prostitute [...] Per i vichi marini nell’ambigua / sera...», e137-38, «Nel seno della città percossa di suoni di navi e di carri / classica mediterraneafemina dei porti»).
39. Così come, d’altra parte, per l’umidore e l’angustia di questi luoghi caproniani, unapossibile suggestione è ravvisabile in Scarsa lingua di terra, 36-39, «Nei porti delle tue cittàcercai / nei fungai delle tue case, l’amore, / nelle fessure dei tuoi vichi».
Qui, già i primi due versi potrebbero di per sé fungere da sottotitoloper la vicenda delineata in Epilogo;39 e si osserverà poi come la femminache aspetta sulla porta possa trovare una sua più individuata incarnazionenella donna della prima strofa di Epilogo, o nella lei impura («che aspettava[...] un segno della mia paura») di Becolino, 55-63 (due delle tante figurefemminili «sospese tra miseria cittadina e al di là» che, come ha osservatoMengaldo 1998, 177, compaiono nel Passaggio d’Enea); così come i fanalidell’andito malcerto potranno essere assimilati alla lampada che oscilla nel-l’andito buio e salino di Didascalia, 9-10, o a quella che trema in Becolino,18-19. E l’elenco di simili coincidenze di motivi e campi semanticipotrebbe ramificarsi a dismisura. Si confrontino almeno i vv. 6-7 di Nelmio povero sangue..., (meglio se integrati da PI XXVI,Quando traverso la cittàla notte, 20-21, «Rasentando le case cautamente / io sento dietro le paretisorde»), con Didascalia, 4-7 «la cieca anima che aveva fretta / e, timida, per-lustrava / il muro, per non inciampare», dove appunto si concretizza inmotivi analoghi una stessa idea di chiusura, menomazione e brancola-mento. E di PI XXVI, cfr. anche i vv. 7-8, «Ombre umane informi / dietro ivetri nebbiosi dei caffè», che sembrano esser stati riplasmati e amplificatinei «nebbiosi bicchieri», nella ragazza «senza figura», e nelle anime che entra-no «a perdersi fra i vapori» della latteria di PE, Stanze della funicolare,
PIETRO BENZONI308
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
Interludio. Oppure si consideri come, anche per la caratterizzazione degliuomini miti deiVersi di All Alone (uomini miti che, strofa II, «salgono e sal-gono, che a tentoni […] trasalgono», che, strofa I, «scans[ano] con brevirincorse / i veicoli, e ancora parlottando / soli, di nottetempo nei porto-ni / neri dei loro vicoli la mano / mettono avanti a tastare i polmoni /umidi che li inghiottono», e che, strofa VI, «di soppiatto / scantonano40
dai vicoli...»), si possano ancora convocare alla memoria i notturni diPianissimo (e di alcuni Trucioli), con l’io che cammina solo, che trasale (cfr.PI XXII, 13-16), che rasenta muri e vite altrui, che si urta con una follaanonima e indifferente, che «va per la trita via / rimuginando povereparole» (cfr. da Rimanenze,Non sa che fu...).Ad avvalorare la trama di echi appena abbozzata, c’è poi il fatto che tutti
gli elementi di PI XXII sopra evidenziati, ritornino in All Alone e Becolino;con alcuni addensamenti particolarmente significativi (con il maiuscolet-to si segnalano le principali coincidenze nel tessuto fonico e rimico):
Entravo da una porta stretta,di nottetempo,...[...]Dal vicolo, all’oscillAREd’una lampada (biancaed in salita fino 10a strappare il cantinoal cuore[...]nell’andito buio e salino. 15[...]Era un portone in tenebra,di scivolosa areNARIa:era, nell’umida aria 25promiscua, il mio ingresso a Genova.(Didascalia, 1-26)
Era una piccola pORTA
(verde) da poco tinta.
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 309
40. Per l’uso di questo verbo cfr. anche il passo: «mi parve di colpo di scantonare dalmondo» (tratto da uno dei Trucioli più noti,Montegrosso; cfr. OVP 412). E in Lettera dall’o-steria, 12, «scantonato dal Tempo e dallo Spazio».
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
Bussando sentivo una spinta[...]La notte con me entrava,subito, nella cinta. 10Salivo di lavagnarosicata una scalané ho mai saputo se era,a spengere la candela,il nero umidore del mARE 15o il fiato della mia compagna(Epilogo 1-12)
Entrai, non so dir cOME,spinto da quel carbONE.Ma a un tratto mi sentii senzapiù padre (senza più mAdREe famiglia, e vittoria), 65e solo nella trOMBAdelle scale, indiETROmi ritorsi, la tOMBA
riaprendo della pORTA
(Epilogo 61-69)
Piangevo in un’incerta casapiena di stanze amorfe.La luce che sulle pORTE
batteva, era di lunae nuvola (era di mARE 5e barca), e penetravanel cuore....(Becolino, 1-7)
Il reticolo intertestuale risulta poi ancor più stringente, se si osservacome anche il componimento che immediatamente precede PI XXII, ossiaPiccolo, quando un canto d’ubriachi, risulti formato da un analogo insieme diparole piene che ricomparirà, lungo i versi del Becolino, là dove, nel con-tempo, si sviluppa un’idea d’altra parte già enucleabile nel testo sbarba-riano: quella di una perdita irrimediabile, legata alla fine dell’innocenzainfantile (cfr. il tesoro perso dall’anima in Becolino, 46-52 con il bene perdu-to in PI XXI, 26).
PIETRO BENZONI310
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
Si confrontino dunque più da vicino PI XXI, 1-27, «Piccolo, quando un cantod’ubriachi / giungevami all’orecchio nella notte / d’impeto su dai libri mi leva-vo [...] guardavo / la chiusa stanza e dopo lei la casa / dove già tutti i lumi eranospenti! / Più d’una volta sulla fredda ardesia / al vento che passava nei capelli /alla pioggia che m’inzuppava il viso / io piansi lacrime insensate. // [...] mi levocon sospeso / dall’improvvisa commozione il fiato, / e vado ancora a mettere lafaccia / nel vento che i capelli mi scompIGLI. / Rinnovare vorrei l’amaraebbrezza / e quel sottile brivido pel corpo, / e il ben perduto cui non credo più/ piangere come allora», e Becolino, 1-71, «Piangevo in un’incerta casa / piena distanze amorfe [...] mentre una nave salpava / fitta di lumi, i guardiani [...] con-tratti in viso, cedevano il paradiso cui non credevano [...] Sentivo che nel buioc’era / qualcuno, ad orIGLIare, / ma mai avrei potuto tentare / d’aprire, e guar-dare / lei che in capelli e impura / (l’orecchio alla serratura / e il fiato spesso)aspettava, / mentre il vento soffiava [...] Sapevo che avrei trovato / pioggia evento al mercato, / e che [...] un bambino / di nuovo sarebbe corso... ». E si tengapoi presente che molti di questi vocaboli di PI XXI figurano anche in Epilogo(canto, orecchio, notte, vento, capelli, lacrime, fiato e brivido e piangere, egualmenteconiugato in io piansi), nella cui chiusa si può pure cogliere una movenza sintat-tica (vv. 86-99, «...cui più ... ormai, bussare»), analoga a quella degli ultimi versidi PI XXI, (vv. 24-27, «...cui ... più / piangere come allora»).
Un’indagine più sistematica sulle occorrenze,41 inoltre, ci permette, diconstatare come le parole-motivo già sbarbariane rintracciabili anche inCaproni si concentrino proprio nei testi in questione, o in quelli situatinei loro paraggi. Per cui, ad esempio, nel caso di vicolo, si registrerà comedelle quattro occorrenze di OV, tre si trovino in PE, All Alone (cfr.Didascalia, 8;Versi, I, 6;Versi, VI, 8) e una in CVC, Lamento..., 40; oppure siconstaterà come solo nel Passaggio d’Enea figurino lastrico / -ato e fanale,in luoghi che possono esser fatti reagire, più o meno direttamente, con ilprecedente sbarbariano:
lastrico: per Sbarbaro, v.Primizie,Vo nella notte solo, 12, «su lastrici che caldo ventobagna», e PI IV, 2 e 34 «M’incammino / per lastrici sonori nella notte»; e cfr. conPE,Lamento IV, 10 «...O sarà il vento / vacuo dai lastrici...” e PE,Lamento VIII, 1 «Ahpadre i lastricati ancora scossi / dai tuoi passi notturni».fanale: per Sbarbaro, alle 3 occorrenze registrate in Savoca 1995, si potrebbero
aggiungere le numerose altre dei Trucioli (tra cui v. almeno quella del primo dei
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 311
41.Ci si avvalsi qui, da un lato, di Savoca 1995; dall’altro, per l’opera in versi di Caproni,della versione digitalizzata gentilmente fornitami da Luca Zuliani.
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
Trucioli 1914-18, «Mi esalta il fanale atroce a capo del vicolo chiuso»; cfr. OVP 129).In Caproni invece una sola occorrenza in PE, Notte, 5, «Nel barlume / torbo diquel fanale che si sfa», ma in versi variamente implicati con gli altri testi del cor-pus: v. come il verbo sfare ritorni in All alone,Didascalia, 17, «Con me, mentre uncerino / mi si sfaceva bagnato»; in Epilogo, 20 «L’intero giorno dormiva / disfat-ta...»; in Becolino, 70, «odore d’aria e d’acqua / sfatta...», e in Lamento.., 70, «Mela sentii crollare / addosso, sfatta creatura». Ma ci si soffermi anche sull’aggettivotorbo, che da un lato in OV conosce solo un’altra occorrenza, proprio nelLamento..., 111, «E so che fissando l’occhio / torbo di lei... », e dall’altro può essermesso in relazione con il più comune torbido usato da Sbarbaro (cfr. PI XXVIII, 3,«la mia anima torbida che cerca / chi le somigli...»).
Infine, si osserverà come anche il più tardo Lamento (o boria) del preti-cello deriso partecipi a questo sistema di richiami. Esso, infatti, è sicura-mente implicato con All Alone (Didascalia ed Epilogo) e Il becolino, sia invirtù delle evidenti contiguità tematiche, sia per la prossimità delle scel-te stilistiche e lessicali.42 E tale constatazione avvalora, sia pure indiretta-mente, l’impressione che nel Lamento si possa avvertire una presenzasbarbariana; suggerita anche da qualche spia linguistica. Ci sembra infat-ti che, anche qui, si possano scorgere tracce del testo che, come s’è vistosopra, pare aver maggiormente alimentato l’immaginario di questi testicaproniani, PI XXII,Nel mio povero sangue qualche volta;43 e, forse, come unimplicito omaggio a Sbarbaro, potrà essere interpretato il fatto che, pro-prio là dove il preticello racconta della propria attrazione per i torbiditraffici della Genova portuale, figuri un uso, del tutto eccezionale inCaproni, della maiuscola per l’astratto personificato (Lamento..., 37-48:
PIETRO BENZONI312
42. Oltre alla ripresa di voci quali gloria, petto, portone, paura, sfatto, singhiozzare, frangeree morire (che per lo più sono collocate a fine verso), si consideri il sistema rimico: cfr.Epilogo, 50-51, solo : usignolo con Lamento, 124-125, usignolo : solo; cfr. stretta : fretta, che figu-ra tanto in Didascalia, 1-3 quanto in Becolino, 46-47, con Lamento, 101-102, retta : stretta; o,più all’ingrosso, si vedano le sequenze di rime facili in -azione e in -are, presenti nelLamento così come già lo erano in Epilogo e nel Becolino.
43. Si osservino, in particolare, congiuntamente, i luoghi strategici dell’inizio (cfr. PIXXII, 1, «Nel mio povero sangue... », con Lamento..., 1 «Sono un povero prete») e dellafine (cfr. PI XXII, ultima strofa, «senza avere il godibile goduto / senza avere il soffribile soffer-to [...] a cuor leggero andarmene pel mondo», con Lamento..., 136-141 «e prego... / non,come accomoda dire / al mondo, perché Dio esiste: / ma come uso soffrire / io, perchéDio esista»), notando anche come gli incipit abbiano una stessa prosodia, e come, inentrambi i finali, ai ritorni lessicali si sommi una analoga insistenza su anafore e polittoti.
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
«Fors’era in me un sessuale / émpito il voler arricchire. / La Genovamercantile / dei vicoli [...] il Male / in me sembrava inculcare / con spa-simo quasi viscerale»). E tutto ciò dice come Il lamento del preticello sia untesto chiave nell’evoluzione di Caproni, non solo perchè – come solita-mente si osserva – esso costituisce uno dei primi e più organici tratta-menti del tema della ricerca di un Dio assente che tanta parte avrà nellesuccessive raccolte, ma anche perché lo fa ammiccando decisamente aiprecedenti testi della perdizione, quasi a rimarcare una continuità nellasvolta, e a suggerirci l’idea che l’ateologia dell’ultimo e più intellettuali-stico Caproni possa trovare il suo humus proprio nei più terragni smar-rimenti che l’hanno preceduta.
III. A questo punto, evidenziata la varia incidenza dell’immaginario edelle trame lessicali sbarbariane, possiamo procedere a un confronto piùserrato, con l’intento di fissare contrastivamente alcune peculiarità deidue autori.Iniziamo dalle modalità del discorso. Da un lato, nello Sbarbaro di
Pianissimo, la scena è dominata da un io sostanzialmente autobiografico,che resta uguale a se stesso lungo tutta la raccolta; e la cui voce, spogliama nitida, prosasticamente abbassata ma decisamente assertiva, si apre aconfessioni dirette. Dall’altro invece, in Caproni, e sempre più dalPassaggio d’Enea in poi, l’identità della voce poetante è complicata e incri-nata: disseminata nelle immagini parziali di un io che non sembra piùcredere alla propria unità,44 e il cui discorso sempre più è formulato perinterposta persona (v.Testa 1999), attraverso personaggi che si pongonoesplicitamente come altri (le famose prosopopee). Non senza ambiguità:nel caso del Lamento del preticello si osserverà in particolare come l’epigrafea Mézigue (‘a me stesso’, in argot)45 possa ricondurre il personaggio ad una
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 313
44. Così Caproni, a proposito della poesia Oh cari (dal Conte di Kevenhüller), ricordache è stata scritta quando gli «pareva di essere aggredito da tutti i mézigues, gli ‘io’, chesono stato in cinquant’anni di vita» (cfr. OV 1644); così, nella Nota che chiude il Congedodel viaggiatore cerimonioso, ci avvisa che forse questa raccolta è ancora incompiuta, «se il bru-sio che sent[e] nella mente è quello non di un solo altro mézigue».
45. Cfr. anche MT Palo, dedicato a Sezis e Mézigue (‘a Lei e a Me stesso’).
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
figura dell’io; forse lo stesso che soffre e piange in All Alone (Didascalia edEpilogo) e nel Becolino.Diversissimo, poi, risulta l’uso dei tempi verbali. I versi di Pianissimo
fissano momenti e stati d’animo ricorrenti (ne sono un segnale esplicitoi talora e gli a volte che spesso inquadrano il discorso); e il tempo domi-nante è un presente atemporale che tende a conferire loro un carattereemblematico, avvalorando l’impressione che le condizioni di aridità edesolazione di volta in volta registrate dall’io abbiano, nella loro ricorsi-vità, qualcosa di immedicabile (o, almeno, che come tali siano state espe-rite), e che nessuna reale opposizione dialettica sia possibile (Fortini:«Sbarbaro è subito al fondo; e di lì non si muove»).46 In questi testi diCaproni, invece, è ravvisabile una dimensione narrativa più tradizionaleche si appoggia ai tempi dell’imperfetto per definire lo sfondo contro cuipoi può stagliarsi, al passato remoto, l’azione decisiva. Naturalmente, ciòvale soprattutto per l’Epilogo e il Lamento del preticello, dove la caduta e ildegrado contemplano anche una dimensione (nemmeno ipotizzabile inPianissimo) di salvezza (di resurrezione e conversione si parla, rispettivamen-te, in Epilogo, 38 e Lamento, 52); e dove, appunto, c’è davvero una svoltasegnalata dall’irruzione del passato remoto (in entrambi i casi enfatizza-ta dalla congiunzione Eppure collocata ad inizio strofa): Epilogo, 33,«Eppure io piansi Genova / l’ultima volta, entrato [...] Entrai [...] Ma a untratto mi sentii [...] indietro mi ritorsi...»;Lamento..., 49, «Eppure, fu in quelportuale / caos ch’io mi potei salvare...». Mentre, nel Becolino, poesia chetestimonia di uno sconforto protratto e senza redenzione, gli imperfettiiterativi e di sfondo che strutturano il testo (v. le anafore portanti di pian-gevo, sentivo e sapevo) non paiono trovare sfoghi decisivi, e il passatoremoto fa solo capolino in una subordinata relativa e in una parentetica(cfr. vv. 44-50: «Piangeva la latteria / dove con lei la mia la mia / animadebole [...] (il vento era di ciclone ed abbassò la tensione) / perdette [...]»).Ferma restando, però, la necessità di rilevare il carattere ambiguo di taliimperfetti di sfondo, che strutturano sia All Alone (Didascalia ed Epilogo)che Becolino, dei quali non sempre possiamo stabilire con sicurezzal’aspetto, incerti se far prevalere i valori durativi e iterativi o invece quel-
PIETRO BENZONI314
46. Fortini 1988, 19.
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
li onirici;47 incerti cioè su quale grado di oggettività attribuire al discor-so. Infatti, questi testi, che riferiscono di un’esperienza traumatica, rivis-suta più volte, e quasi ritualizzata, non ci lasciano stabilire se tale reite-rarsi si ponga come un dato effettivo, come un’amplificazione dellamemoria o un indugio dell’immaginazione. Se si tratti di esperienzaconclusa o ancora fermentante.Quanto al metro, se, in Pianissimo, gli endecasillabi si distendono anti-
melodicamente in versi scanditi non tanto da rime quanto da parallelismie ripetizioni di parola, e si registra un uso moderato e mirato degli enjam-bements, i testi caproniani qui considerati, invece, consistono in versi piùbrevi, fittamente rimati, che danno vita a successioni tese di enjambementsentro un periodare complicato da incisi e parentetiche; tecnica d’altraparte consustanziale ad un discorso lirico che faticosamente scava entrodolorosi grovigli di sentimenti e percezioni, adombrando la ricerca di unaverità ulteriore che pure non sembra attingibile.D’altra parte, mentre Sbarbaro tende a raggelare il patetico che pure
preme – che inevitabilmente preme in una materia come quella che luipredilige trattare – e a fornire disanime asciutte della propria sofferenza,in Caproni invece (soprattutto nel Caproni del Passaggio d’Enea), le insor-genze del pathos esclamativo sono vistose e stilisticamente rilevanti, comevide subito un lettore del calibro di Pasolini.48
E, se il vocabolario di Pianissimo si presenta come un insieme ristretto,compatto e uniforme, fatto di pochi vocaboli, per lo più basici, univoci ead alto tasso di ricorrenza, in Caproni, invece, il panorama lessicale èampio, vario,mosso e travagliato: caratterizzato anche da sbalzi di registro,usi anomali e inventivi, oltre che da una ben più ampia accoglienza diparole (e cose) tradizionalmente evitate dalla lingua poetica.Altre divergenze significative, e per certi versi storicamente esempla-
ri, emergeranno dal diverso trattamento dello sfondo. Lo scenario geno-vese. In Pianissimo Genova non è mai nominata (tutt’al più, in PI III, siparla, genericamente, di un porto che «brilla / silenzioso coi suoi lumi»):la città della Perdizione in cui vagola e sprofonda l’io sbarbariano, oltreche dai modelli letterari, sarà certo stata ispirata anche dalla esperienza
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 315
47. Si accolgono qui le distinzioni e la terminologia di Serianni 1988, 394-96.48. Cfr. Pasolini, 1952, 465-70.
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
diretta della Genova dei carruggi e dell’angiporto, ma resta uno scenariovolutamente astratto e anonimo, caratterizzato da lastrici sonori¸ vie sim-metriche e deserte, o tozze, piazze vuote, fanali che divampano, case mute, pare-ti sorde, muri contro cui rasentare (diverso, ovviamente, sarebbe il discorsoper le prose dei Trucioli).Viceversa, nelle poesie di Caproni, com’è noto,Genova («Genova di tutta la vita / mia litania infinita», Litania, 176-177)è presenza pervasiva, variamente invocata: realtà individuatissima, scan-dagliata anche con precisione toponomastica (cfr. ad es. Lamento..., 63-68, «giù da Porta dei Vacca, / fino a Vico del Pelo [...] in pienaPortoria»), e al tempo stesso luogo mitizzato e trasfigurato.Un’ambivalenza che, d’altra parte, si percepisce bene anche qui,nell’Epilogo di All Alone, dove la Genova rimpianta dall’io nella dispera-zione si pone dapprima come simbolo di tutto quanto si sta perdendo(«io piansi Genova…», cfr. i vv. 27-33), per poi diventare scenario sen-sualmente gioioso e concreto di un ritorno alla vita (vv. 71-81, «Che fre-sco odore di vita / mi punse sulla salita! [...] muovendo a mescolare /l’aria, dal Righi al mare»). Quanto al Becolino, la cui ambientazione èesplicitamente livornese (v. l’ultima strofa), sarà interessante notare come,in una stesura provvisoria portata alla luce da Luca Zuliani, Caproniavesse scritto, invece del patria mia che si legge ora al v. 28, «Piangevo laGenova mia / disertata… » (cfr. OV, 1462); ad ulteriore conferma dellaprossimità con l’Epilogo, e delle possibili osmosi tra i due scenari.Analogamente, la Storia, assente in Pianissimo (resoconto in versi di un
io da se stesso estraneato e nel contempo incapace di uscire da se stesso),non solo grava cupamente su tutto il Passaggio d’Enea (basti rileggere lasezione Gli anni tedeschi o considerare la nota d’autore che accompagnala raccolta), ma anche, più specificamente, si pone come fondale tragico,quasi partecipe degli istinti di dissoluzione del preticello: cfr. Lamento...,vv. 81-92:
All’alba me n’andai sul mare,a piangere. Di disperazione.Volavano bianchi d’alii gabbiani, e i giornali,freschi ancora di piombo, 85urlavano, in tutto tondo,ch’era scoppiata la guerra
PIETRO BENZONI316
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
dappertutto, e la terra(ancora io non sapevo i luttiatroci: voi, i vostri frutti) 90pareva dovesse franare,sotto i piedi di tutti.
Così come, d’altra parte, quel nesso tra circolazione delle merci emercificazione dei corpi, che era solamente inferibile in Pianissimo,49
trova una precisa ambientazione e una più esplicita formulazione anco-ra nelle parole del preticello, la cui vicenda di degradazione e salvezza (sesalvezza c’è) sembra trovare nei traffici tra i vicoli della Genova portua-le non solo la propria cornice, ma anche una propria causa; si vedano,(affiancati magari da PE, Litania, 33-34, «Genova che mi struggi. /Intestini. Caruggi», e 113-114, «Genova di Sottoripa / Emporio. Sesso.Stipa») in particolare i versi seguenti, là dove tra l’altro si avverte unasignificativa eco dantesca:50
Fors’era in me un sessualeémpito il voler arricchire.La Genova mercantiledei vicoli – l’intestinale 40tenebra dov’anche il mare,se s’ode, pare insaccaredenaro nel rotoliodella risacca (ma io,
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 317
49. E che da Romanello in particolare è stato inferito: «la riduzione a cosa, di cui laprostituzione è figura esemplare, riassume il destino dell’individuo nella società contem-poranea [...]. L’economia di mercato che tutto riduce alla misura di valore di scambio eche a tutto dà un prezzo [...] è il vero Dio nascosto dell’universo sbarbariano, ove assumeperò [...] i tratti della Necessità, ipostasi mitologica di un processo storico [...] l’immaginestupenda della “città di pietra che nessuno / abiti, dove la Necessità / sola conduca i carrie suoni l’ore” diviene allegoria penetrante dell’essenza della metropoli, patria delle formedell’astrazione e del calcolo, che, nel garantire il funzionamento dell’economia di merca-to, prescindono del tutto dall’individuo, finendo anzi per dissolverlo» (cfr. Romanello1996, 240-41).
50. Cfr. i vv. 40-44 del Lamento, là dove si parla di una peccaminosa discesa in unatenebra intestinale in cui si insacca denaro, con l’uso dell’espressivo insaccare in Inf. VII, 16-18: «Così scendemmo ne la quarta lacca / pigliando più de la dolente ripa / che ’l malde l’universo tutto insacca»; valutando anche l’eventuale concorso di Inf. XXVIII, 26, làdove l’intestino viene perifrasticamente definito «... ’l tristo sacco / che merda fa di quelche si trangugia»).
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
scusate, non mi so spiegare 45troppo bene), il Malein me sembrava inculcarecon spasimo quasi viscerale.
Eppure, fu in quel portualecaos, ch’io mi potei salvare. 50Che dirvi, se la vera autricedella mia conversione(ma sì: non ho altra ragioneda addurre) fu una meretrice?
Ancora: se quella registrata nei referti di Pianissmo è una sessualità avvi-lita, meccanica, spersonalizzante, che pare esser stata consumata fredda-mente, senza gioia né dolore, e il dramma è tutto nella constatazione del-l’inappetenza vitale e dell’aridità che seguono, quella sofferta dagli iocaproniani si pone invece come esperienza lancinante, patita e straziata dirimorsi anche prima di essere vissuta: una pulsione che catalizza i traumipiù intimi e non sembra consentire nessun lucido resoconto (dondeappunto lo smozzicato narrare di cui si è detto). Da un lato cioè il dram-ma di un’assenza di sentimento e sensibilità, una triste sazietà post coitum,dall’altro il vacillare di fronte a un eccesso di sensazioni e sommovimen-ti interni. Da un lato un processo di svuotamento e distacco ormai com-piuto, dall’altro un drammatico rimescolio di dolori e umori che stannoper traboccare. E uso volutamente termini che si prestano al doppiosenso, perché peculiare di Caproni, soprattutto a questa altezza della suaproduzione, è il non prescindere mai dal senso proprio e dal dato con-creto, anche quando questi potrebbero essere oscurati dagli usi figurati.«Piangevo […] il seme del mio morire», dice l’io narrante nell’ultima oc-correnza (v. 54) del crescendo anaforico che caratterizza il Becolino. Ed èevidente che qui la parola seme, oltre che nel suo senso figurato di ‘origi-ne’, vada letta anche nella sua accezione più specifica e materica di ‘sper-ma’, del tutto plausibile in una poesia come questa, che tratta di lascivia einiziazioni (di “foia e thanatos”). E che poi questo sintagma, il seme del miomorire, suoni come una variazione del titolo dell’intera raccolta, Il seme delpiangere, conforta l’idea che in esso si debba cercare una allusività e unavischiosità particolari. D’altra parte, lo stesso Caproni sembra suggerire
PIETRO BENZONI318
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
simili letture quando, a proposito di uno dei suoi attacchi più noti, quellodi PE, Sirena, osserva:
«La mia città dagli amori in salita / Genova mia di mare tutta scale» [...], lungidall’esser metaforico o “spirituale”, è proprio realistico, anzi cronachistico. Aimiei tempi bisognava trovare una crosa deserta per appartarsi con una ragazza.Maquelle stradicciole erano ripide e perciò, con una certa fatica, si faceva letteral-mente l’amore in salita.51
Sintomatico, poi, che le zone di tangenza tra il vocabolario diPianissimo e quello della poesia di Caproni, non interessino sostanzial-mente né i sostantivi astratti, né le voci su cui maggiore era statol’investimento figurale di Sbarbaro (tipo automa o fantoccio), bensì parolereferenziali, quotidiane e concrete come anca, andito, ardesia, bicchiere, fana-le, fiato, fondaco, lino, orecchio, parete, porta, persiana, sale, scala o vicolo. Così, adesempio, è interessante notare come uno dei più tipici usi caproniani,quello del verbo commuovere in contesti che, attenuandone il più comunesenso figurato, ne attivano uno più propriamente fisico (cfr. PE,Rosario, 5-6, «ragazze a coppie / con il petto commosso»; SP, Piuma, 8 «dischiusa labocca commossa» e SP, Eppure, 54-57, «dondolando commosso / al saluto,rosso / tinniva il cornettino / di corallo, al polso»), quest’uso ambiguo chefa convivere latinismo e accezione più corrente, dicevamo, possa trovareuna sua prefigurazione nei versi di PI XX, 18-20, «Ché tutta la mia vita ènei miei occhi. / Ogni cosa che passa la commuove / come debole ventoun’acqua morta», là dove appunto il complemento del verbo è oral’astratto vita ora il concreto acqua. E un discorso un po’ più diffuso meri-tano le occorrenze della parola anima in OV. Caproni che, per cantare lagiovinezza della madre-fidanzata ha mirato ad una poesia fine e popolareinsieme, in queste liriche della perdizione sembra aver perseguito una
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 319
51. Cfr. OV 1230, integrando magari con Caproni 2004, 120 e 126, dove il concetto èribadito («... in città s’andava a cercare queste creuze... poi a Genova sono in salita e quin-di non era mica tanto facile, con la ragazza appoggiata al muro... per abbracciarla [...].Erano amori faticosi insomma, amori in salita») e si riporta un brano (tratto da Caproni1978), dedicato alle creuze: «Queste creuze sono parte integrante del mio essere genovese[...]. In genere si incassano, o si incassavano, tra due muri d’orto o fra ville anche di lusso;inaccessibili spesso ai veicoli, e quindi ideali in ogni ora del giorno, per gli amori furtivi,in un sottile odor di limoni o d’estate di fichi maturi, mentre sul campo sciamano, gri-gio-azzurri, i pesciolini delle foglie d’ulivo».
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
altrettanto ossimorica coesistenza di fisicità, anche nelle sue forme piùdegradate, e spirito (si veda anche il cortocircuito di Litania, 105-106,«Genova di mio fratello. / Cattedrale. Bordello», e 115-116, «Genova di PortaSoprana, / d’angelo e di puttana»). Con una tendenza a far cozzare l’astrattocon il materico che trova proprio in corrispondenza delle occorrenze dianima alcune delle sue realizzazioni più notevoli: cfr.Didascalia, 4-7, «... lacieca / anima che aveva fretta / e timida perlustrava / il muro, per noninciampare»;Becolino, 45-47, «...e la mia anima / debole (stretta / fra quel-le anche)»;52 cfr. Lamento (o boria)…, 76-80, «…ormai costretto / da unimpeto di liberazione, / sfogai, fino all’estenuazione, / l’anima, in un por-tone»; a suggerire davvero una consustanzialità tra i cedimenti dell’animae quelli della carne. Ora, anima è parola basica della lingua poetica sindalle origini, e asserire che queste soluzioni siano direttamente derivateda Sbarbaro sarebbe falsante.Tuttavia, non rinunciamo ad ipotizzare cheCaproni abbia comunque raccolto qualche stimolo dalla vigorosa perso-nalizzazione degli astratti che caratterizza Pianissimo (certo, sulla scorta delmodello baudelairiano); e che abbia dunque letto i versi di questa raccol-ta in tutta la loro potenziale fisicità, a cominciare dall’incipit assoluto: «Tacianima stanca di godere / e di soffrire...» (ma cfr. anche PI XXVIII, «la miaanima torbida che cerca / chi le somigli...»; PI XXIX «... sento l’anima ade-rire / ad ogni pietra della città sorda»). E l’ipotesi trova un valido appiglionella cronologia, dato che la prima occorrenza della parola anima, in OV,è proprio quella appena citata della Didascalia di All Alone, uno dei com-ponimenti in cui, come si è mostrato, la presenza di Sbarbaro è menosfuggente. Anche se, poi, non si dovrà trascurare nemmeno l’azione delmodello cavalcantiano, esplicitamente recuperato a partire dai Versi livor-nesi del Seme del piangere (cfr. in particolare le esortazioni alla propriaanima in Preghiera e Ultima preghiera), ed esso pure, d’altra parte, solleci-tante una concezione fisica dei moti spirituali.Insomma, è soprattutto in ambiti e tempi ben circoscritti (i testi della
perdizione e del tormento filiale, composti tra il 1954 e il 1961), e in deter-minati usi e trame lessicali, che si può avvertire l’eco sbarbariana. Fermo
PIETRO BENZONI320
52. Cfr. anche SP,Andando a scuola, 1-6 «Un prete in bicicletta, / all’alba, che fretta. //Con l’anima mia stretta / e abbottonata, anch’io / pedalando al mio dio / me n’andavo,in disdetta».
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
restando, però, che si tratterà, in definitiva, di un’eco dalle risonanze lonta-ne o affievolite, che non alterano certo il timbro e l’originalità della voce diCaproni, dal momento che i suoi recuperi, per quanto possano anche esse-re talvolta sostanziosi, comportano comunque dei decisi mutamenti disegno e connotazione. Ossia, Sbarbaro senza dubbio circola e traspare inalcune precise zone della poesia caproniana, ma anche qui come riassorbitoe rifuso, in funzione di un progetto lirico che resta irriducibilmente altro.
Riferimenti bibliografici
Alzona 1967 = M.A. (a cura di), Genova libro bianco, Genova, Sagep.Bàrberi Squarotti 1971 = G.B.S.,Camillo Sbarbaro, Milano, Mursia.Bàrberi Squarotti 1974 = G.B.S., La città di Sbarbaro, in Id., Gli inferi e il labirinto.Da Pascoli a Montale, Bologna, Cappelli, pp. 139-58.
Bozzola 1993 = Narratività e intertesto nella poesia di Caproni, «Studi novecente-schi», XX, 45-46, pp. 113-51.
Camon 1965 = F.C., Il mestiere di poeta, Milano, Lerici.Caproni 1949 = G.C., I licheni di Sbarbaro, «Mondo operaio», 16 aprile.Caproni 1956a = G.C., La corrente ligustica nella nostra poesia, «La Fiera letteraria»,
4, 11, 18 e 25 novembre [titoli delle singole puntate: 1. Il paesaggio non dipingi-bile; 2.Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e Mario Novaro; 3.Boine, Sbarbaro,Montale;4.Angelo Barile e Adriano Grande].
Caproni 1956b = G.C., Le «Rimanenze» e i «Fuochi fatui» di Sbarbaro, «La FieraLetteraria», 16 dicembre.
Caproni 1958a = G.C., Primizie di Sbarbaro, «La Fiera Letteraria», 1 febbraio.Caproni 1958b = G.C.,Versi d’oro dei pitagorici, «La Fiera Letteraria», 30 marzo.Caproni 1960 = G.C., L’Amarezza di Sbarbaro, in Caproni 1996, pp. 127-32.Caproni 1962 = G.C., Poesie di Sbarbaro, in Caproni 1996, pp. 138-42.Caproni 1978 = G.C.,Genova, «Weekend», X, 42, ottobre [poi parzialmente ripre-so come introduzione a Id., Genova di tutta la vita, Genova, San Marco deiGiustiniani, 1983].
Caproni 1986 = G.C.,Gli asparagi di Sbarbaro, «L’indice dei libri del mese», III, 3,pp. 5-6 [testo ripreso poi sia in «Risorse», II, 4, 1989, che in ‘tenero e disperato’Omaggio a Camillo Sbarbaro, Castelnuovo Sotto, Il Guado, 1989].
Caproni 1992 = G.C., Il labirinto, Milano, Garzanti.Caproni 1996 = G.C., La scatola nera, pref. di G. Raboni,Milano, Garzanti.Caproni 2004 = G.C., «Era così bello parlare». Conversazioni radiofoniche con GiorgioCaproni, pref. di L. Surdich, Genova, il melangolo.
PRESENZE SBARBARIANE IN CAPRONI 321
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO
Cavalleri 1983 = C.C. (a cura di), Un poeta in cerca dell’anima, «Studi cattolici»,XXVII, 272, pp. 603-06 [poi in «Cultura e libri», III 16-17, settembre-dicembre1986].
Coletti 1982 =V.C., Note su Caproni traduttore, in G. Devoto e S.Verdino (a curadi),Genova a Giorgio Caproni, Genova, Edizioni S. Marco dei Giustiniani, pp.187-202.
Coletti 1997 = V.C., Prove di un io minore. Lettura di Sbarbaro - «Pianissimo» 1914,Roma, Bulzoni.
Dei 1992 = A.D.,Giorgio Caproni, Milano, Mursia.Dei 2003 = A.D., Le carte incrociate. Sulla poesia di Giorgio Caproni, Genova, SanMarco dei Giustiniani.
Devoto 2002 = G.D. (a cura di),Giorgio Caproni. Quaderno bibliografico.Anno 2001,Genova, San Marco dei Giustiniani.
Fortini 1988 = F.F., I Poeti del Novecento, Roma-Bari, Laterza.Insana 1975 = J.I. (a cura di),Molti dottori nessun poeta nuovo.A colloquio con GiorgioCaproni, «La Fiera Letteraria», 19 gennaio.
Mengaldo 1986 = P.V.M., Sbarbaro: come uno specchio rassegnato, in Id., La tradizio-ne del Novecento.Terza serie,Torino, Einaudi, 1991, pp. 123-29.
Mengaldo 1998 = P.V.M., Per la poesia di Giorgio Caproni, in Id., La tradizione delNovecento. Quarta serie,Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 168-95.
Mengaldo 2006 = P.V.M.,Caratteri dell’endecasillabo di Sbarbaro, «Stilistica e metri-ca italiana», 6, pp. 262-69.
Pasolini 1952 = P.P.P.,Giorgio Caproni, in Id.,Passione e ideologia,Milano,Garzanti,1960, pp. 465-70.
Proust 1951 = M.P., Il tempo ritrovato, tr. di G. Caproni,Torino, Einaudi.Polato 1969 = Sbarbaro, Firenze, La Nuova Italia, 19742 [seconda edizione accre-sciuta].
Polato Pia. 1996 = L.P. (a cura di), C. Sbarbaro, Pianissimo,Venezia, Marsilio.Romanello 1996 = A.R., Introduzione a «Pianissimo». Il poeta nella grande città, LI,
1996, XLVIII, pp. 230-51.Sanna 2003 =A.S.,Un «filo magico»: Sbarbaro, le traduzioni e il legame con Baudelairee Rimbaud, «Otto/Novecento», XXVII, 3, pp. 179-92.
Savoca 1995 = G.S., Vocabolario della poesia italiana del Novecento, Bologna,Zanichelli.
Serianni 1988 = L.S.,Grammatica italiana,Torino, UTET.Solmi 1949 = S.S., I «Trucioli» di Sbarbaro, in Id., La letteratura italiana contempora-nea, t. I, Scrittori negli anni (Opere di Sergio Solmi, vol. III, t. I), a cura di G.Pacchiano, Milano,Adelphi, 1992, pp. 302-8.
Testa 1999 = E.T., Per interposta persona, Roma, Bulzoni.Torchio 1970 = C.T.,Rimbaud e Sbarbaro, «Studi francesi», XIV, 1970, pp. 23-52.Zoboli 2006 = P.Z., Linea ligure. Sbarbaro, Montale, Caproni, Novara, Interlinea.
PIETRO BENZONI322
SISM
EL-EDIZ
ION
I DEL
GALLUZZO