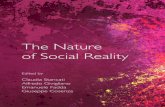Presenze archeologiche a Gesuiti (San Vincenzo La Costa, Cosenza).
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Presenze archeologiche a Gesuiti (San Vincenzo La Costa, Cosenza).
Antonietta Guglielmelli | Emily Cavaliere
Gesuiti e la sua storiaDalla Compagnia di Gesù al Sacro Scapolare
Con il Contributo di Carmelo Colelli
ISBN: 978-88-6829-107-5
© 2014 Falco EditorePiazza Duomo, 1987100 COSENZAtel. 0984.23137e-mail: [email protected]
Finito di stampare nel mese di novembre 2014da Grafica Pollino Srl – Castrovillari (CS)
per conto di Falco Editore
è vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico,con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata dall’Editore in ogni Paese
77
Presenze archeologiche a Gesuiti (San Vincenzo La Costa, Cosenza)
di Carmelo Colelli
Nel territorio di San Vincenzo La Costa, come nella quasi totalità delle aree interne della Calabria, le ricerche ar-
cheologiche si possono considerare scarse o nulle. Da sempre, infatti, l’interesse di studiosi e archeologici si è focalizzato prevalentemente, quando non esclusivamente, sulle grandi colonie magnogreche (Sybaris, Kroton, Lokroi, Kaulonìa, Reghion, in primo luogo) e sui siti archeologici di maggiori dimensioni (centri fortificati italici, ville romane, castelli medioevali…) si-tuati molto spesso lungo le coste o nelle immediate vicinanze di esse.
Fin dal XVI secolo, viaggiatori stranieri ed eruditi (locali e non) frequentarono la regione e, leggendo i racconti degli scrittori greci e latini che raccontavano le vicende delle po-leis della Megàle Hellàs, ripercorrevano il litorale del Mar Jonio alla ricerca di ruderi antichi, monete o iscrizioni che potesse-ro ricordare gli splendori di un tempo remoto e fantastico in cui, per questioni storiche e geografiche, la Calabria era ricca e prospera e rappresentava un centro (e non una periferia) della Grecità, come ricordato dai racconti degli autori antichi e dalle testimonianze archeologiche.
Molto meno interessante, purtroppo, è sembrata nei seco-li scorsi la storia “minore” della regione, cioè la storia riguar-
Gesuiti e la sua storia C. Colelli
78
dante il periodo preistorico, romano e medioevale e quella relativa alle aree interne, lontane (o non vicine) dalle colonie magno-greche.
In un quadro già di per sé segnato da questa generale as-senza (o almeno scarsezza) di interesse verso la storia che po-tremmo definire “altra” rispetto a quella della Magna Grecia, il disinteresse verso il passato nel territorio di San Vincenzo La Costa è segnato anche dal focalizzarsi, da parte di tutti gli studiosi, locali e non, sulla questione dei Valdesi e sulle note (e tristi) vicende del 1561 che, nei secoli, hanno reso “meno degno” di essere indagato e raccontato tutto quanto avvenu-to prima e dopo1.
Questa lacuna documentaria (che potremmo quasi defini-re atavica) è stata in parte colmata nelle aree che ruotavano intorno ai maggiori centri abitati dalla presenza di studiosi, appassionati ed eruditi locali ai quali si devono la maggior parte degli studi e delle segnalazioni di “presenze archeolo-giche” già a partire dal XIX secolo2. In numerosi centri del
1 Si veda per esempio il testo di Lenormant, archeologo, storico e numi-smatico francese che, nella seconda metà dell’Ottocento, passò mol-to tempo in la Calabria immortalandone la cultura e la storia, dando enfasi alle sue vicende di età antica. La sua opera più importante, il cui titolo La Grande Grèce rappresenta in maniera inequivocabile una manifestazione di intenti, si sofferma soprattutto sulla storia delle co-lonie magno greche. Nel monumentale lavoro (diviso in tre tomi), tro-vano spazio anche i principali eventi della storia romana, medioevale e moderna che interessano la Calabria; non sorprende, pertanto, che San Vincenzo insieme a San Sisto (allora villaggi dipendenti da Mon-talto) siano ricordati per la presenza dei Valdesi e per le note vicende del 1561 che portarono all’arrivo dei frati Gesuiti inviati da Papa Pio V (per una ricostruzione sintetica della vicenda, lenormant, 1881, pp. 237-239). Sull’argomento, si veda da ultimo il contributo di Antonietta Guglielmelli nel presente volume con riferimenti bibliografici.
2 Numerose sono le menzioni di rinvenimenti archeologici già nell’Ot-tocento; per restare all’interno della Media Valle del Crati, basti pensare all’opera del canonico Leopoldo Pagano, il quale nel 1857 ci informa delle numerose attestazioni archeologiche nel territorio di Bisignano (PaGano 1857, pp. 33-41). Sul ruolo che gli storici e gli eruditi locali hanno avuto nella ricerca archeologica si veda la marCa 1996, in
Appendice Presenze archeologiche a Gesuiti
79
Sud Italia, un grosso contributo alle prime e pioneristiche ri-cerche archeologiche si deve proprio alle personalità di spic-co locali (il medico, il farmacista, l’avvocato…), i quali, poiché erano in contatto diretto con la popolazione che frequentava i campi, ne ricevevano spesso, sotto forma di regalie, reperti archeologici rinvenuti nelle campagne durante lavori agri-coli o qualsivoglia altra attività. Proprio a persone illumina-te, anche se non sempre edotte negli studi storici, si devono le segnalazioni di numerosi oggetti antichi alla “comunità scientifica” che hanno successivamente portato alla cono-scenza dei siti archeologici e in qualche caso alla realizzazio-ne di interventi di scavo e ricerca programmatica.
Tale fenomeno, positivo nella sua accezione primaria, so-prattutto in determinati periodi storici (la fine dell’Ottocen-to, la seconda del XX secolo), ha però dato vita ad una delle principali piaghe che ancora oggi attanagliano il patrimonio culturale e il territorio italiano e calabrese: il “tombarolag-gio”. Allettati dalla presunta possibilità di facili guadagni, ricavabili dalla vendita sul mercato clandestino di reperti archeologici, soprattutto a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, loschi personaggi hanno iniziato a battere le campagne nottetempo armati di pale e picconi, alla ricerca di monete, oggetti d’oro o di altri metalli, vasi dipinti… I ri-sultati sono stati spesso sorprendenti grazie all’impiego di metal detectors sempre più sofisticati in grado di segnalare la presenza di oggetti metallici anche sotto terra. Necropo-li, santuari e altri siti archeologici sono stati in questo modo barbaramente depredati, e gli oggetti ivi rinvenuti, strappati al loro contesto originario e alla fruizione della collettività, sono finiti ad ornare raccolte private italiane e musei esteri3.
cui è posta un’attenzione particolare su Giuseppe Marchese, al quale si devono molte informazioni sul territorio di Luzzi e Rose.
3 In molte aree dell’Italia centrale e meridionale, tale fenomeno ha assunto, nel corso dei tempi, proporzioni mostruose e ha portato al costituirsi di vere e proprie squadre organizzate, la cui attività di so-stentamento principale era proprio questa triste forma di delinquen-
Gesuiti e la sua storia C. Colelli
80
Ad ogni modo, se nel bene e nel male le aree costiere o nel-le quali si conosceva la presenza di ricchi giacimenrti archeo-logici sono state oggetto di interesse, le aree interne, lontane dai centri maggiori, sono state completamente ignorate e di-menticate dalle attività di ricerca e di scavo (soprattutto da quelle legali).
Poste queste necessarie premesse, dunque, non desta meraviglia il fatto che il territorio di San Vincenzo La Costa compaia in letteratura archeologica solo grazie ad un teso-retto monetale rinvenuto in maniera fortuita oltre mezzo secolo fa.
Il 1° giugno del 1957, il signor Giuseppe Iantorno di Gesuiti
za. Fino a quando patti e accordi bilaterali fra i paesi mediterranei “esportatori” di beni culturali acquisiti illegalmente e i paesi “acqui-renti” non hanno posto fine a questi traffici con nuove leggi oggetti di pregio rinvenuti in Italia, Grecia e Turchia sono stati acquistati dai grandi musei Svizzeri, Nord Europei e Americani, dove spesso sono at-tualmente esposti attirando notevoli flussi turistici. Per dare un’idea della dimensione del fenomeno, basti qui ricordare che nel 2002 gra-zie all’attività della Soprintendenza Archeologia della Calabria e dei Carabinieri del Nucleo Tutela sono stati riportati al Museo Naziona-le della Sibaritide (e quindi restituiti alla collettività calabrese) oltre 2.000 reperti che (come si è riuscito a dimostrare grazie a fortunate coincidenze) provenivano da scavi illegali effettuati negli anni Set-tanta nel territorio di Francavilla Marittima ed erano finiti nei mu-sei di Berna, Copenaghen e Malibù (vista l’importanza della vicenda e degli oggetti, questi sono stati pubblicati in un volume Speciale del Bollettino d’Arte, strumento diretto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nell’introduzione viene riproposta anche una ricostruzione dettagliata delle vicende che hanno portato al recupero a cura di Van Der Wielen e Van Ommeren). Il lieto fine (purtroppo raro) di vicende come quella appena ricordata non deve tuttavia far dimenticare che, anche quando gli oggetti vengono recuperati, il danno alla colletti-vità e alla comunità scientifica rimane, poiché qualsiasi reperto, se privo del suo esatto contesto di rinvenimento, perde gran parte del suo potenziale informativo. La contestualizzazione dei manufatti si ottiene solo mediante uno “scavo stratigrafico” eseguito da archeolo-gi e codificato da regole ben precise (per una metodologia dello scavo archeologico e per l’importanza del contesto di rinvenimento, si veda: barker 1977 e Carandini 1981).
Appendice Presenze archeologiche a Gesuiti
81
trovò in un castagneto, in prossimità del centro abitato in cui risiedeva, un contenitore ceramico pieno di monete “vec-chie”4. L’insolita notizia fece scalpore in paese e in pochi gior-ni giunse all’orecchio delle autorità locali che prontamente provvidero a sequestrare il tesoretto. Una prima segnalazio-ne dell’importante rinvenimento risale al 1959 ad opera di Procopio5; seguirono altre menzioni6 fino alla pubblicazione (successiva al restauro) avvenuta negli anni Novanta del se-colo scorso ad opera di Mastelloni7. Il gruzzolo consta di 107 monete: 2 di zecca lucana, 90 battute dai Brettii, 4 che per lo stato di conservazione non possono essere identificate (luca-ne o brettie), 1 moneta di Siracusa, 6 romano repubblicane e 4 siculo-puniche [FiG. I].
Oltre a testimoniare una circolazione parallela di monete brettie e lucane, questo ritrovamento è importante poiché è uno dei tre tesoretti noti (unito a quello di Ricadi e a quello di Cutro) in cui sono state trovate monete brettie in bronzo. Da un punto di vista cronologico, il rinvenimento di Gesuiti è inquadrabile al periodo della seconda Guerra Punica (218-202 a.C.) che vide opposti i Cartaginesi ai Romani. La presenza delle quattro monete siculo-puniche, tutte mal conservate e che “forse presentano i segni di una coniazione affrettata”, farebbe proporre una datazione alle fasi finali del conflitto (dopo la battaglia del Metauro), quando ormai Cartagine sta-
4 Il luogo del rinvenimento non è localizzabile con precisione. Nel-la letteratura archeologica, è collocato in località piano di Capone, un’ampia area di castagneto situata a Sud-Ovest del moderno abitato di Gesuiti. Fonti orali, testimoni del ritrovamento e informati della scoperta direttamente dal signor Iantorno, riferiscono invece che “la pignata” fu recuperata poche decine di metri a Sud-Ovest rispetto alla sorgente cd. del Giovannuzzo nella proprietà Apa. Il racconto, che come immaginabile destò enorme scalpore nella piccola comunità, è ancora tramandato oralmente dagli anziani del posto. Una ricostruzione del-la vicenda è stata riproposta da tela (2012, p. 77).
5 ProCoPio 1959, p. 284.6 PFeiler 1964, pp. 34-36; Craword 1974, p. 67.7 mastelloni 1996, pp. 63-74.
Gesuiti e la sua storia C. Colelli
82
va per essere sconfitta8. Attualmente, il tesoretto è conser-vato presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria. Le diverse pubblicazioni, tuttavia, mancano dell’apparato fotografico dei singoli nominali, così come del tutto assenti sono le infor-mazioni relative al recipiente in ceramica che le conteneva9.
Il rinvenimento appena menzionato non è servito a risve-gliare l’interesse del mondo archeologico verso il territorio di San Vincenzo La Costa e più in generale del versante orien-tale della Catena Costiera immediatamente a Nord del Valico della Crocetta. La memoria di un antico passato, tuttavia, è rimasta nei racconti della popolazione di Gesuiti ed è molto spesso associata ad un antico “cimitero” rinvenuto in località Greceria (chiamata dagli abitanti del luogo anche Greggeria o Gregoria). Diverse sono le segnalazioni che ricordano, spesso con dovizia di particolari, il rinvenimento di sepolture e ma-teriali archeologici in una vasta area10.
Stando a quanto ricavabile da fonti orali, i primi ritro-vamenti avvennero nel 1947, quando, durante i lavori per l’impianto di una vigna, furono rinvenute ossa umane (par-ticolare impressione nella memoria dei testimoni riveste la presenza dei teschi), ceramica e “strani tegoloni” (proba-bilmente embrici, n.d.a.). Le attività agricole interessarono un’area in pendenza posta poco ad Ovest delle “Case Presta”, vecchi casolari di cui oggi restano poco più che i ruderi, an-cora abitate all’epoca dei fatti [FiG. XII, c]11.
8 mastelloni 1996, p. 74. 9 Informazioni su questo oggetto potrebbero fornire importanti dati
sul piano archeologico. Infatti, in questo caso la datazione delle mo-nete permetterebbe di ottenere indizi cronologici certi anche per il recipiente in ceramica di uso comune, classe per la quale le griglie cronologiche sono estremamente ampie, specialmente in un territo-rio, come quello in questione, in cui nulla si conosce del popolamento antico.
10 L’individuazione del sito è stata prontamente segnalata alla Soprin-tendenza archeologica della Calabria dall’allora segretario della Pro Loco di Gesuiti Carla Tela con lettera del 16/04/2012.
11 Informazione orale riportata a chi scrive dal Signor Francesco De Lio
Appendice Presenze archeologiche a Gesuiti
83
Un secondo filone di racconti ricorda che, intorno alla metà degli anni Settanta del secolo scorso (fra il 1976 e il 1977), durante i lavori per la realizzazione di un campo da cal-cio, in un’area semipianeggiante posta poco ad Ovest rispet-to a quella appena menzionata e compresa fra questa e l’at-tuale via Gregoria (proprietà Perri), furono rinvenute grosse lastre in terracotta associate ad ossa umane che vennero in gran parte distrutte nel corso dello sbancamento avvenuto con mezzo meccanico. Sono ancora testimonianze dirette a ricordare che, per rendere il campo semipianeggiante, fu ri-portato terreno per un’altezza media di ca. 50 cm. Quest’area è attualmente occupata da un fitto sottobosco, caratterizzato dalla presenza di felci che ricoprono integralmente il terreno rendendo di fatto pessima la visibilità; il vigneto impiantato nel 1947, invece, è stato sostituito da un castagneto ceduo; il terreno è completamente ricoperto da fitto fogliame e vege-tazione di sottobosco [FiG. II].
Complici l’assenza di ricerche sistematiche e la pessima visibilità, i racconti sopra menzionati, seppur ben vivi nel ri-cordo collettivo della comunità di Gesuiti, non erano fino ad oggi supportati da una reale presenza di materiale archeolo-gico. Una attenta analisi della memoria orale e una serie di sopralluoghi condotti ad opera di chi scrive e di Carla Tela, tuttavia, hanno recentemente portato al rinvenimento di una seppur labile traccia archeologica che conferma i rac-conti popolari12: durante una visita effettuata nell’aprile del 2012 in località Greggeria, sono stati rinvenuti alcuni fram-menti ceramici e laterizi databili ad età antica.
I pochi materiali giacevano dispersi nella porzione più set-tentrionale del castagneto, in prossimità del limite di un’a-rea semipianeggiante. Particolarmente interessante è la pre-
nel 2010, che ringrazio; nell’occasione, fu effettuato anche un sopral-luogo dell’area che però non portò a nessun risultato.
12 Nella tesi di laurea, compare una prima menzione a tali presenze (tela 2012, pp. 74-75).
Gesuiti e la sua storia C. Colelli
84
senza di frammenti di embrici reimpiegati all’interno di un lungo muretto realizzato in ciottoli fluviali che costituisce il limite fra due diversi lotti di terreno [FiGG. III, IV, V]. La mag-gior parte dei frammenti recuperati presentano uno stato di conservazione non ottimale e mostrano spesso segni eviden-ti di usura post-deposizionale. Interessanti a fornire delle in-dicazioni di carattere cronologico sono alcuni frammenti di orli in ceramica di uso comune [FiGG. VI, VII] e di embrici [FiG. VIII] che sembrano inquadrabili genericamente all’età ro-mana. Non si segnalano al momento frammenti attribuibili a classi fini, mentre sono stati recuperati frammenti pertinenti ad anfore da trasporto e una grossa scoria di ferro [FiG. X].
Poco più a Ovest, a monte della strada comunale via Gre-goria, ancora nella proprietà Perri [FiG. XII, d], si segnala la presenza di occasionali frammenti di ceramica d’impasto [FiG. XI] che rimandano ad un orizzonte cronologico decisa-mente più antico: questa classe ceramica, caratterizzata da un impasto grezzo, ricco di inclusi realizzati senza l’impiego del tornio, in Calabria è genericamente databile all’età prei-storica e protostorica13. La mancanza di elementi diagnostici
13 Nella Sibaritide, la produzione di ceramica d’impasto sembra inter-rompersi nel corso del VII secolo a.C. (Colelli-JaCobsen 2013). In alcu-ne aree interne dell’Italia meridionale, che certamente risentono di meno del contatto con il mondo greco, tuttavia, ci sono notevoli at-tardamenti nella produzione di questa ceramica che, pur evolvendosi nelle tecniche, nelle forme e nei tipi, resta in uso fino al IV secolo a.C. Si veda in proposito l’evidenza da Muro Tenente in Puglia, dove grandi vasi in impasto grossolano sembrano essere prodotti fino al 330/300 circa a.C. (yntema 1999, p. 83). La già menzionata assenza di dati relativi alla cultura materiale in ampi comprensori della Calabria rende impossibile stabilire se tale produzione si attardi, e di quanto, nelle aree interne della regione più lontane dal contatto con le po-leis magnogreche. Una osservazione generale delle caratteristiche tecniche dei frammenti in questione (assenza del tornio e notevole spessore delle pareti in primo luogo), purtroppo non supportata dal-la presenza di elementi diagnostici, tuttavia, sembrerebbe escludere che siano databili alla produzione tarda di età greca e suggerirebbero piuttosto una generica datazione ad età preistorica o protostorica.
Appendice Presenze archeologiche a Gesuiti
85
impedisce di proporre datazioni più precise. I materiali rac-colti sono attualmente custoditi presso i depositi del Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, mentre sono stati lasciati in situ i frammenti di embrici riutilizzati per la co-struzione del muretto a secco precedentemente ricordato14.
Il sito di contrada Greceria, situato su un piccolo pianoro leggermente digradante verso Est (ad una quota compresa fra 520 e 530 m ca. s.l.m.), che consente un controllo visivo su un’ampia porzione della Valle del Crati [FiG. Xiii], sembra dimostrare che questa fascia collinare immediatamente ai piedi della Catena Costiera doveva essere in qualche modo occupata anche se, forse, non in maniera intensiva. Il clima piovoso e fresco e la conseguente abbondanza di sorgenti rendevano semplice l’approvvigionamento idrico, mentre la massiccia presenza di boschi – che ancora oggi ricoprono am-pie porzioni del territorio circostante – garantiva legname in abbondanza15. La zona, inoltre, presenta una naturale voca-zione per la coltura di ulivi e fichi.
Troppo labili sono le testimonianze fino ad oggi emerse per tentare definizioni cronologiche; vale la pena comunque ricordare che, benché le presenze da contrada Greceria di-stino poche centinaia di metri dal luogo in cui è stato rin-venuto il tesoretto monetale databile all’età annibalica, una interconnessione diretta non è al momento dimostrabile: i frammenti ceramici rinvenuti potrebbero essere leggermen-te posteriori e inquadrabili, come già accennato, fra la fine
14 Dopo esser stati temporaneamente custoditi nella locale sede della Pro Loco, i reperti sono stati consegnati alla Soprintendenza Archeologi-ca della Calabria in data 9/06/2014. Colgo l’occasione per ringraziare il dott. Alessandro D’Alessio, Funzionario Archeologo della Soprinten-denza, per aver concesso a chi scrive l’autorizzazione a pubblicare que-sto piccolo ma significativo lotto di materiali.
15 Quella del legno è rimasta tradizionalmente l’industria principale a Gesuiti. Nella seconda metà del secolo scorso, fu attiva per qualche de-cennio una fabbrica chimica che consentiva l’estrazione del tannino dal legno di castagno.
Gesuiti e la sua storia C. Colelli
86
dell’età repubblicana e l’età imperiale romana. L’assenza di frammenti diagnostici (anfore o ceramiche fini), comunque, impedisce una esatta datazione dei reperti ritrovati.
Le testimonianze da Gesuiti, benché estremamente esigue, consentono di colmare un vuoto documentario di un’area della Calabria interna: non sono note, in letteratura archeo-logica, ulteriori presenze nella fascia pedemontana compresa fra San Fili e Montalto Uffugo, all’interno della quale ricade anche il territorio di San Vincenzo La Costa16.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, non è possibi-le aggiungere molto altro sul popolamento antico di questa area abbarbicata sul versante orientale della Catena Costie-ra; sembra plausibile, tuttavia, che nel corso dell’età romana l’area facesse parte del territorio di Consentia. La posizione di controllo sulla vallata e la relativa vicinanza al valico della Crocetta dovevano garantire una rapida comunicazione con l’importante arteria che collegava la Valle del Crati con la co-sta Tirrenica17.
16 Presenze archeologiche databili ad età imperiale romana (resti di strut-ture pertinenti ad unità abitativa, cisterna in muratura, frammenti di la-terizi e ceramica, blocchi squadrati) sono state individuate poco a Nord di Montalto, in località San Nicola, su una collina che domina il corso del Torrente Annea (sulla destra idrografica). Su questo sito, una segna-lazione compare negli archivi della Soprintendenza Archeologica della Calabria del 1929. Si veda anche Gallo 1990, p. 187 e Taliano Grasso 1994, p. 26, n. 99.
17 Il Valico della Crocetta costituisce l’unico punto in prossimità di Co-senza per oltrepassare la Catena Costiera al di sotto dei 1.000 m s.l.m. Le alternative per raggiungere il comprensorio del medio Tirreno Cosentino sono decisamente distanti e scomode: a Sud si può rag-giungere la Costa attraverso il Valico di Potame, meno agevole della Crocetta che consente l’arrivo sulla costa diverse decine di km più a Sud; a Settentrione l’unica via per arrivare agevolmente sulla costa tirrenica (si svalica a 740 m s.l.m.) è attraverso Passo dello Scalone, a circa 40 km a Nord rispetto al valico in questione, che collega gli attuali comprensori di Sant’Agata d’Esaro e di Belvedere. Molto meno pratici dovevano essere gli altri percorsi, poiché l’attraversamento delle montagne avviene ad una quota mai inferiore ai 1.000 m s.l.m.
Appendice Presenze archeologiche a Gesuiti
87
Non è certo quale fosse il percorso viario che univa i due comprensori: la strada più agevole è certamente quella che risale il corso del Fiume Emoli18, passa sotto l’odierno centro abitato di San Fili e prosegue verso Ovest, sempre lungo il fiume fino al valico in località Masseria Sant’Angelo di San Lucido, per poi ridiscendere verso la Costa Tirrenica.
Del resto, che la via più rapida per passare dalla Valle del Crati e da Cosenza alla Costa Tirrenica sfruttasse questo im-portante valico è indiziato anche dal tracciato della vecchia strada che congiunge San Lucido e Falconara Albanese a Co-senza, il cui tracciato passa proprio dal centro abitato di San Fili19. L’ipotesi che il punto di passaggio verso la Costa doves-se avvenire in prossimità della località San Angelo di San Lu-cido è fortemente suggerito dalla topografia e dalla orografia del territorio: solo in questo punto, situato a pochissima di-
rendendo più faticosa e lunga la percorrenza, soprattutto in inverno e nel caso di condizioni meteorologiche avverse.
18 Probabilmente il diverticolo doveva snodarsi non lontano dalla con-fluenza dell’Emoli nel Crati, nella zona di Quattromiglia. Del resto se è vero che in questa area non sembrano segnalate presenze ar-cheologiche (probabilmente anche a causa del selvaggio espansio-nismo edilizio che ha sconvolto irrimediabilmente il territorio) vale la pena ricordare che proprio il toponimo Quattromiglia è proba-bilmente antico e deve essere riconnesso alla distanza da Cosenza: 4 miglia romane (IV milia passuum) corrispondono a circa 6 km (1 passus romano equivale a 1,48 m) che è la distanza che separa l’anti-ca capitale dei Bruttii, Consentia, da questa località. Poco più a Nord, notevole è anche il toponimo Settimo che indica una distanza di VII m.p. da Consentia (quindi III m.p. da Quattromiglia). Sull’argomento, si veda anche: GiviGliano 1994, p. 309 e taliano Grasso 1994, p. 12.
19 L’importanza strategica che rivestiva il borgo di San Fili è quasi scon-tata vista la sua posizione topografica; a tal proposito, è significativo un passo del viaggiatore inglese George Gissing che alla fine del XIX secolo, dovendo raggiungere Cosenza da Paola, dopo aver attraversato la Catena Costiera in un incantevole scenario di pieno autunno, passa da San Fili dove si ferma per cambiare il “vecchio e pazzo carro” con cui aveva fino a quel momento viaggiato: We descended at a sharp place, all the way through a forest of chestnuts, the fruit already gathered, the golden leaves rusting in their fall. At the foot lies the village of San Fili, and her we left the crazy old cart which we are dragged so far (GissinG 1901, p. 13).
Gesuiti e la sua storia C. Colelli
88
stanza rispetto al già menzionato corso dell’Emoli, è possibile raggiungere il versante tirrenico valicando la Catena Costie-ra ad un quota mai superiore ai 910 m s.l.m. attraversando un piccolo pianoro circondato da due creste montuose che superano abbondantemente i 1.000 m s.l.m.
La discesa verso il mare poteva poi avvenire attraverso va-rie direzioni che consentivano di raggiungere la costa sia a Nord verso Paola e San Lucido, sia più a Sud fra San Lucido e Fiumefreddo Bruzio. Non bisogna dimenticare, del resto, che proprio l’area compresa fra Paola e San Lucido in età roma-na doveva avere grande importanza, come testimoniato dalla presenza di numerose villae situate a breve distanza fra loro (mediamente a 1 km di distanza l’una dall’altra)20.
è suggestivo ipotizzare che la ricchezza di questa fascia costiera fosse in parte legata proprio alla posizione strate-gica, in quanto ieri come oggi costituiva il naturale sbocco verso il mare della fertile Valle del Crati e dell’area pedemon-tana in cui ricade il territorio di Gesuiti.
20 Sull’argomento, cfr. sanGineto 2012, p. 61. Per un censimento delle vil-lae, si veda sanGineto 1994, ColiCelli 1995 e aCCardo 2000. Per maggiori dettagli sulle ville romane nella media valle del Crati, si veda anche Colelli 2011 con un focus in particolare sui rinvenimenti di Località Muricelle di Luzzi.
Appendice Presenze archeologiche a Gesuiti
89
Fig. I. Alcune monete pertinenti al tesoretto di età annibalica rinvenuto a Gesuiti (da Mastelloni 1996)
Fig. II. Gesuiti, località “Greggeria”: l’area interessata da dispersione di materiale archeologico
Gesuiti e la sua storia C. Colelli
90
Fig. III. Muretto a secco con embrici antichi reimpiegati (particolare)
Fig. IV. Muretto a secco con embrici antichi reimpiegati (particolare)
Appendice Presenze archeologiche a Gesuiti
91
Fig. V. Muretto a secco con embrici antichi reimpiegati (particolare)
Fig. VI. Frammento ceramico di forma chiusa databile ad età greco-romana
Gesuiti e la sua storia C. Colelli
92
Fig. VII. Orlo di bacino databile ad età greco-romana
Fig. VIII. Frammenti di embrici
Appendice Presenze archeologiche a Gesuiti
93
Fig. IX. Frammenti di pareti di ceramica di uso comune e di anfore di età romana
Fig. X. Scoria in ferro
Gesuiti e la sua storia C. Colelli
94
Fig. XI. Frammenti di ceramica ad impasto
Fig. XII. Presenze archeologiche nel territorio di Gesuiti: a. Area di rinvenimento del tesoretto monetale (ipotesi tradizionale);
b. Area di rinvenimento del tesoretto monetale (racconti orali); c. Area di dispersione di materiali di età classica;
d. Area di dispersione di frammenti di ceramica d’impasto (adattato da Google Hearth)
Appendice Presenze archeologiche a Gesuiti
95
Fig. XIII. La Valle del Crati vista da Località Grecceria; sullo sfondo i rilievi della Sila Grande
Fig. XIV. Area semipianeggiante in località Sant’Angelo (San Lucido)
Gesuiti e la sua storia C. Colelli
96
Fig. XV. La Catena Costiera;l’area cerchiata indica la zona in cui più agevole è l’attraversamento
(adattata da Google Hearth)
97
biblioGraFia
aCCardo S., Villae romane nell’ager Bruttius: il paesaggio rurale calabrese durante il dominio romano, L’Erma di Bretschneider, 2000.
barker P., Techniques of archaeological excavation, Batsford, 1977.
Carandini A., Storie dalla Terra, Manuale di scavo archeolo-gico, Einaudi, 1981.
Colelli C., JaCobsen J.k., The Iron age impasto pottery, in Exca-vation on the Timpone della Motta. Francavilla Marittima (1992-2004), Edipuglia, 2010.
Colelli C., Rinvenimenti ceramici di età imperiale romana da Mu-ricelle di Luzzi, in FalCone l., la marCa a. (a cura di), Archeologia e ceramica. Ceramica e attività produttive a Bisignano e in Calabria dalla protostoria ai giorni nostri, Grafosud, 2011.
ColiCelli A., Gli insediamenti di Età romana nei Bruttii: un nuovo censimento (1991-1995), Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia, 1995.
CrawFord M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge uni-versity press, 1974.
Gallo P., Topografia storica del territorio della Media Valle del Crati, Tesi di laurea, Università della Calabria, a.a. 1989-1990.
GissinG G., By the Ionian Sea. Notes of a ramble in Southern Italy, Chapman and Hall, 1901.
Gesuiti e la sua storia C. Colelli
98
GiviGliano G.P., Percorsi e strade, in settis s. (a cura di), Storia della Calabria antica. Età italica e romana, Gangemi, 1994.
istituto italiano di numismatiCa, Annali, Edizioni a cura dell’I-stituto, Voll. 5-6, 1959; Voll. 21-22, 1975.
la marCa A., Il ruolo degli studiosi locali, in «Calabria Lettera-ria», XLIV, (1996), nn. 1,2,3, pp. 43-46.
lenormant F., Littoral de la mer Ionienne, in id., La Grande Gre-ce, A. Levy, 1881.
mastelloni A.M., Ripostiglio monetale rinvenuto a Cutro (CZ) ed altri tesoretti di monete Brettie di bronzo, in Panvini rosati F. (a cura di), Ricerche sui materiali e studi tipologici. Quaderni di nu-mismatica antica, G. Bretschneider, 1996.
PaGano L., Bisignano, in Cirelli F., Storia del Regno delle Due Sicilie descritto ed illustrato, Vol. XI, Napoli 1857.
PaPadoPoulos J.k., The archaic votive metal objects, in aa.vv., La Dea di Sibari e il santuario ritrovato. Studi sui rinvenimenti dal Timpone Motta di Francavilla Marittima, volume speciale del Bollettino d’arte, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2003.
PFeiler H., Die Miinzpràgung der Brettier, Jahrbuch fur Numi-smatik und Geldgeschichte, n. 14, 1964.
sanGineto A.B., Per la ricostruzione dei paesaggi agrari delle Ca-labrie romane, in settis S. (a cura di), Storia della Calabria Antica, II, Gangemi, 1994.
id., Roma nei Bruttii. Città e campagne nelle Calabrie Romane, Ferrari, 2012.
Appendice Presenze archeologiche a Gesuiti
99
taliano Grasso a., Considerazioni Topografiche sulla via Annia tra Muranum e Valentia, in Atlante tematico di Topografia Antica, L’Erma di Bretschneider, 1994.
tela C., Evidenze Archeologiche nella Media Valle del Crati, Tesi di laurea, Università della Calabria, 2012.
wielen van ommeren F., Ceramiche d’importazione, di produzio-ne coloniale e indigena, in aa.vv., La Dea di Sibari e il santuario ritrovato. Studi sui rinvenimenti dal Timpone Motta di Francavilla Marittima, volume speciale del Bollettino d’arte, Istituto poli-grafico e Zecca dello Stato, 2006.
yntema D., Le ceramiche, in nitti A. (a cura di), Muro Tenen-te, Centro Messapico nel territorio di Mesagne. Le ricerche olandesi 1992-1997, Tiemme, 1999.