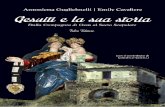Aurelio Luini. Martirio di San Vincenzo
Transcript of Aurelio Luini. Martirio di San Vincenzo
Bernardino Luini e i suoi figli
10 aprile 13 luglio 2014 Milano, Palazzo Reale
Palazzo Reale è stato restaurato grazie a
,r· ·,jfondqzione ·· . · c ar. p lo
partner istituz ionale
Sindaco Giuliano Pisapia
Assessore alla Cultura Filippo Del Corno
Direttore Centrale Cultura Giulia Amato
Partner istituzionali
EH::EB 90 ~IASTATAU
UNIV'ERSITÌ. DI:.GLISTl"IJI DI MILANO
inBrera Pinacoteca
WP\L \//OHI~ \l l. ._.
Direttore D01nenico Piraina
Coordinamento Mostra G iulia Sonnante
Responsabili Organizzazione e Amministrazione Giovanni Bernardi Simone Percacciolo
Conservatore Diego Silea
Organizzazione G iuliana All ievi Luisella Angiari Filomena Della Torre Christi na Schenk Roberta Ziglioli
Amministrazione Roberta Crucitti Laura Piermatrei Sonia Santagostino Luisa Vitiello
Coordinamento Eventi Anna Appratti
Responsabile Coordinamento Tecnico Paolo Arduini
Coordinamento Tecnico Luciano Madeo Lorenzo Monorchio Andrea Passoni
Responsabile Comunicazione e Promozione Luciano Cantarutti
Comunicazione e Promozione Francesca La Placa Antonietta Bucci
Ufficio Stampa Comune di Milano Elena Conenna
Comunicazione visiva ·Dalia Gallico Art Lab
Assistenza Operativa Palma Di Giacomo G iuseppe Premoli Luciana Sacchi
Servizio Custodia Corpo di guardia Palazzo Reale
Presidente Alfonso Dell'Erario
Amministratore Delegato Natalina Costa
Responsabile Ufficio Mostre Francesca Biagioli
Ufficio Mostre Francesca Calabretta Alberta Crestani Sara Lombardini Roberta Proserpio Elena Stella
con il contributo di Greta Bortolotti Francesca Rinaldi
Responsabile Ufficio Fund Raising, Eventi ed Iniziative speciali C hiara Giudice
Ufficio Fund Raising, Eventi ed Iniziative speciali Francesca Belli
con il contributo di Giulia Mordivoglia Matilde Pelucchi Letizia Rossi
Ufficio Sviluppo Paola Cappitelli
Ufficio Stampa e Social Media Elisa Lissoni
con il contributo di Mich.,la Beretta Stefania Coltro
Responsabile Operations Alessandro Volpi
~
Ufficio Operations Elena Colombini
con il contributo di Andrea Baraldi
ARTHEMISIA J group
Presidente e Amministratore Delegato Iole Siena
Rapporti Internazionali e Prestiti Katy Spurrell
Produzione e Comttnicazione Simona Serini
Ufficio Mostre Allegra Getzel Tiziana Parente
con Francesca Lon go
Registrar Ghislaine Pardo
Marketing e Comunicazione Giulia Moricca Marzia Rainone
Ufficio Stampa Adele D ella Sala
con Anastasia Marsella
Fund Raising Gaia F ranceschi
Sviluppo e A rea Contemporary Nicolas Ballario
con Francesco Barbuto
Controllo di Gestione Lorenzo Losi
Amministrazione Mara Targhetta
Segreteria Generale Federica Sancisi
MOSTRA
M ostra e catalogo a cura di Giovanni Agosti Jacopo Stoppa
Progetto espositivo Piero Lissoni Lissoni Associati
con Gianni Fiore Francesco Canesi Lissoni Miguel Ribeiro
e Elena Calvi Davide Cerini Marco Guerini Alberto Massi Mauri Alessandro Massi Ma uri Lorenzo V o! paro
Progetto di illuminazione Flos
Realizzazione allestimento Ci.Ti .Effe
Prodotti Cassina Cleaf Flos Glas Italia MPS Modern Promotion Service Pilkington NSG Group Sacchi Giuseppe S.p .a.
Immagine coordinata e grafica di allestimento Francesco Dondina Dondina Associati
con Giulia Semprini Diana Quarti Giacomo Drudi
Ufficio Stampa Comune di Milano, Elena Conenna Cosmi t, Raffaella Pollini Lissoni Associati, Donatella Brun Officina Libraria, Luana Solla Paolo Landi 24 Ore Cultura, Elisa Lissoni
Conservazione Opere Giovanni Rossi Ilaria Perticucci Marianna Cappellina Restauro e Conservazione di Beni Culturali
Restauri Carlotta Beccaria, Milano Luigi Parma, Milano Michela Piccolo e Maurizio Michelozzi, Opificio delle Pietre Dure, Firenze; direzione lavori Cecilia Frosinini, Francesca Rossi (per il ca t. 82, sul nuovo telaio è applicata una lastra protettiva Optium Museum Acrylic, offerta dalla ditta Tru Vue tramite il distributore italiano EOT) Stefano Scarpelli, Opificio delle Pierre Dure di Firenze Centro Conservazione e Restauro la Venaria Reale Isabella Villafranca Soissons, Open Care Milano (le foto dei cat. 5; 13; t6; 24;
xuv; 86; 9o; 93 sono in corso di restauro o prima dell'intervento)
Assicurazioni Lloy d's
Traspo.IJi--Liguigli Fine Arrs Service Arteria srl
Accrochage Liguigli Fine Arrs Service Arteria srl
Visite guidate Ad Artem
Audio guide Antenna Interllfrional
Sistema di biglietteria e circuito di prevendita MostraMi
Catalogo Officina Libraria
RINGRAZIAMENTI
Mariangela Agliati Ruggia, Silvio Alberio, Mauro Alberti, monsignor Giuseppe Angelini, Camilla Anselmi, Gianni Antonini, Rosellina Archinto, Alessandra Arosio, Lorenzo Arosio, Alberto Anioli , Elena Asero, Francesca Baiardi, Sandra Ballarin, Sandrina Bandera, Marco Bascapè, Maurizio Baseggio, Aldo Bassetti, Laura Basso, Anna Maria Bava, Carlotta Beccaria, Alberto Bentoglio, Simone Benelli, ing. G . Bianchi, prof. Luigi Bianchi, Luigi Bianchi, Adele Bianchi Robbiati, Paolo Biscottini, Davide Biscuola, Antonio Bocola, Cini Boeri, Stefano Boeri, Caterina Bon, Adina Bonelli, Davide Bonfarti, Giulio Bora, Bona e Vitaliano Borromeo, Lucia Borromeo, don Tarcisio Bave, Alessandra Brambilla, Marta Brivio Sforza, David Alan Brown, Ugo Bruschi, don Piero Bulla, Giampaolo Cagnin, Giorgio Canesin, Franco Capardoni, Fabio Caporizzi, Carlo Capponi, Andrea Carandini, Patrizia Caretta, Alessandro Carrara, Marco Carrara, Nadia Carrisi, Luciano Caspani, Daniele Cassinelli, Giorgio Cavaciuti, Federico Cavalieri, Carlo Cavalieri, Alice Chimenri, Antonella Chiodo, Mario Cicogna, Elena Ci uri, Anna Cacciali Mastroviti, Giulia Cogoli, Silvia Conte, Maria Chiara Corazza, Dominique Cordellier, Francesca Costaperaria e Ivano, G iulia Maria Crespi, Federico Cri mi, Antonella Crippa, Elisa Curti, Paolo Daffara, Emanuela Daffra, Luca d'Agostino, Andrea Daninos, Silvia Davoli, Vincent Delieuvin, Vannozza della Seta, Roberta Delmoro, Andrea Di Lorenzo, Serena D 'Italia, famiglia Enrico, Simone Facchinetti, Carla Falcone, padre Dimitri Fantini, Marco Fasu lo, Carlo Fcltrinclli, Ghitta Feltrinelli, Gianfranco Fiaccadori, Roberto Fighetti, Gabrio Figin i, Isabella Fiorentini, Giorgio Fiorese, Elena Fontana, Vincenzo Fontana, Francesco Frangi, Giovarmi Frangi, Giuseppe Frangi, Fiorella Frisoni, Arturo Galansino, madre Anna Galimberti, Gabriella Gallerani, Lavinia Galli, Corinna Tania Gallori, Piero Gandini, N icole Garnier, Guido Gentile, Giorgio Giacomoni, Claudio Giorgione, Vittorio G iulini, Francesca Gobbo, Silvia Gorlini, Tiziano Grassi, Va iter Guidetti, Paolo lnghilleri, Carla lurilli, Stefano Jacini, Franco Jellinek, Matteo Lampertico,
Valent ina Lapierre, Barbara Lehmann, Gloria Levoni, Silvio Leydi, Stefano L'Occaso, Angelo Loda, Letizia Lodi, Rachele Loffrcdo, Laura Lora, Claudio Luci, Mauro Maffeis, Rodolfo Maffeis, don Aldo Maggi, Mauro Magliani, Marco Magnifico, Alessandro Mal inverni, Federica Mano! i, Pietro Cesare Marani, Massimo Marelli, Paola Marini, Marcella Marongiu, Claudia Masala, Enzo Mastrandrea, Stefano Mazzotti , Enrica Melossi, Emmanuel Miche!, Donata Minonzio, Ruben Modiglianj , Monica Molinai, Marco Morandi, Alessandro Morandotti, Annalisa Morelli, Giovanna Mori, Cristina Moro, Milena Motta, Ettore Napione, Antonio Natali, Pietro Nocita, Sara Nosrati, don Claudio Nora, I vana Novani , Carlo Orsi, Francesco Orsi, Amal ia Pacia, Silvia Paoli, Luigi Panna, A lessandra Pattanaro, Annalisa Perissa, Fabio Perosa, Itala Petriccione, Alessandra Pfister, N adia Piccirillo, Chiara Pidarella, Lucia Pini, Isabel la Pirola, don Mario Poggi, mons. Gianfranco Poma, Marzia Pontone, Andrea Porro, Cesare Porro, Chiara Prevosti, Maria Cristina Quagliotti, Domenico Quartieri, Cristina Quattrini, Elena Rame, Daniele Rancilio, Sergio Rebora, Federica Remondini, Mario Remogna, Niccolò Reverdini, Federica Ridella, Nadia Righi, Maria Luisa Rizzini, Cristina Rodeschini , Vittoria Romani, Gianni Romano, Walter Rosa, Mario Rossetto, Doriana Riboni, Chiara Rizzarda, Sara Rizzo, Cristina Rodcschini, Vittoria Romani, Francesco Rossi, Francesca e Guido Rossi, Wanda Rotelli, Francis Russe! , Marco Sabetta, Rossana Sacchi, Giovanni Saibene, Toia Saibene, Xavier Salomon, Claudio Salsi, Aurora Scotti, Paolo Secchi, Lorenza Segato, Nicoletta Serio, Giuseppina Si m mi, Serena Sogno, Valentina Sommariva, Giulia Sonnante, Giuliana Spinelli, Paola Strada, Cari Strehlke, Marco Tanzi, Francesca Tasso, Francesco Tettamanti, Dominique Thiébaut, Claudia Torriani, Silvia Tosatti, Luisa Turati, Piero Turati, Alessandro Uccelli, Maria Utili, Luca Vago, Giovanni Valagussa, Alberto Vanelli , Edoardo Vedani, Giorgina Venosta, Carmela Vi lardo, Isabella Villafranca, Paolo Volpato, Fulvio Zaliani, Tiziana Zanetti, Annalisa Zanni, padre Stefano Zanolini, Chiara Zerbi, Fabio Ziccardi, Anna Rita Ziveri.
SPONSOR
Con il sostegno di
Salone d Mild~lMobile ~ ano
Con il contributo di
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA
Sponso.- tecnici
Cassina CLEAF thermo strudured surlace
Sommario
17 Il malinteso Luini Giovanni Agosti e J acopo Stoppa
29 Catalogo 3 I 1. Da ragazzo, a Milano 4I 2. Gli anni di vagabondaggio nel Veneto 65 3. Ritorno a Milano
IOI 4. La Pelucca I4 5 5. Le occasioni di Bernardino I 59 6. L'invenzione di una formula I 8 5 7. Santa Marta 203 8. Volti 223 9. Dopo Roma 2 55 1 O. Invecchiare con successo ·· 28 3 11. La Casa degli Atellani 295 12. Una complicata eredità
361 Regesto dei documenti Carlo Cairati
3rJ7 Bibliografia
428 Indice dei nomi ~
88. AuRELIO L VINI Milano, I 5 30- Milano, 6 agosto I 593
Martirio di San Vincenzo I585-I587 affresco trasportato su vetroresina- cm 347 x 239 Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte d'Arte Antica, inv. 44I
Provenienza: Milano, San Vincenzino alle monache, fino al I9o8; Milano, Società Generale Italiana Edison, dal I 908 al I 9 I I; Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte d'Arte Antica, dal I9II al I96o; Milano, Università degli Studi di Milano, Rettorato, dal I96o al 1987; Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte d'Arte Antica, dal I987.
Mostre: MILANO I993, n. I9.
L'affresco proviene da San Vincenzino alle monache, la chiesa dell'omonimo convento benedettino demolita, dopo travagliare vicende, nel I964. Riedificata a partire dal I 500 secondo lo schema tipico dei cenobi femminili lombardi, San Vincenzino presentava una navata unica, ripartita trasversalmente da una parete che separava le due aule: una esterna destinata ai fedeli e una interna riservata alle religiose. L'aula esterna era divisa in tre campate, delle quali le prime due dall'ingresso caratterizzate da pareti laterali leggermente concave. Proprio qui, tra il 1585 e il 1587, Aurelio Luini e Giovanni Pietro Gnocchi, «compagni pittori» (cfr. doc. 244), affrescano: sulle pareti laterali della prima campata, a sinistra l'Adorazione dei Magi e a destra la Crocifissione, della seconda campata, a sinistra il Martirio di Sant 'Orsaia e a destra la Salita al Calvario, della terza campata, a sinistra San Vincen zo davanti a Daziano e a destra San Vincenzo gettato in mare, mentre sulla parete di fondo, ai lati dell'altare maggiore, due scene del Martirio di San Vincenzo. La letteratura artistica milanese riferisce la Salita al Calvario e la Crocifissione - oggi quasi illeggibili - a Gnocchi, mentre il resto spetta ad Aurelio (cfr. S. Conte, F. M. Giani, in Bernardino Luini. Itinerari 2014, n. I8).
Prima attestazione e termine ante quem per la realizzazione degli affreschi in San Vincenzino è il sonetto Di Aurelio Lavino, nel quale Giovanni Paolo LoMAZZO (I587, p. III, n. 45; il pittore nel I 5 90 chiede di essere sepolto proprio in San Vincenzino: GIULIANI, SACCHI I998, p. p6) descrive con ammirazione <<I tormenti e la morte del
342 -12. UNA COMPLICATA EREDITÀ
gran santo l Che con la mola fu gettato in mare, l Nel tempio sacro a lui con dotte e rare l Maniere espresse al Castel Giove a canto l Il giovane Lavino; e seppe tanto l Co'l pennello adoprar, che viva appare l L'istoria, e'l màrtir sembra al cielo alzare l Gl'occhi e la voce in mezzo il duolo e'l pianto». Nello stesso sonetto, Lomazzo fornisce un termine post quem affermando, a proposito di Aurelio, che «Diverse altre opre prima egli dipinse, l Ma lodata fia sempre infra le prime l Quella vicina al Duomo, ove li Dei l E gl'Augusti con l'armi intorno finse, l Con tai riflessi e dintorni sì bei, l Che non trova l'invidia ove gli lime>>. L'allusione può essere collegata alla convocazione di Aurelio Luini - al fianco di Simone Peterzano e Alessandro Pobbia -a Palazzo Ducale, nei pressi del Duomo, il 20 febbraio I585 (doc. 234), presumibilmente per prendere parte alla vasta campagna decorativa della residenza dei governatori spagnoli diretta da Valeria Profondavalle tra il I 574 e il I 594 (MALAGUZZI VALER! I90I, pp. 327-335). Gli «Dei e gl'Augusti con l'armi intorno» potrebbero infatti concordare con «li dieci imperatori» e le armi affrescate nel «sallono sopra la stalla» entro il novembre I585 (ASMi, Autografi, Io6, fase. II, segnalato in BoRA I998c, p. 49; le armi dovevano essere affiancate da figure di divinità, analogamente a quelle dipinte entro il I 594, sempre sotto la direzione del Profonda\lalle, sulla facciata del «portico inferiore del giardino magiore»: MALAGUZZI VALER! I90I, pp. 335-336, nota 2).
A due anni dalla morte del pittore, tra le «rare pitture degne d'immortalità» realizzate da Aurelio a Milano, Paolo MoRIGIA (1 595, p. 278) ricorda esplicitamente solo «diverse historie» in San Vincenzino e il Martirio di Santa Tecla in Duomo (cat. 93). Il gruppo centrale del Martirio di San Vincenzo è riproposto nel I667 da un <<Antonio Crespi Comasco» sulla volta della navata centrale di San Lorenzo a Laino, in Val d'Intelvi (CAVALIERI 2000, p. I02; per i documenti: LAZZATT 2008, pp. 2-3).
Agostino SANTAGOSTINO (I67I, pp. 49-5 0) elenca, uno a uno, tutti gli episodi affrescati nell'aula esterna di San Vincenzino, riferendoli però al solo
Aurelio e identificando erroneamente una delle due scene del Martirio di San Vincenzo con un Martirio di Sant'Andrea. La guidistica successiva registra la presenza di Gnocchi al fianco di Aurelio, ma fornisce solo indicazioni generiche circa i soggetti degli affreschi (TORRE I674, p. 225; BIFFI I704-I705, p. I02; LATUADA I738, IV, pp. 458-459; SoRMANI I7jl-I7j2, III, p. 59; BARTOLI rn6, pp. 22I-222; BIANCONI I787, pp. 340-34I). Alla fine del Settecento i dipinti sono ancora oggetto di un certo interesse, almeno da parte delle monache: il I2 agosto I78I l'arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli concede «licenza che per una volta solamente la madre abbadessa del monastero di S. Vincenzo [ ... ] con tutte le sue religiose possa portarsi nella chiesa esteriore dello stesso monastero[ ... ] al fine d'osservarvi le belle pitture» (ASMi, Fondo di Religione, 2298).
Soppresso il convento, tra il I798 e il I8o2l'aula esterna della chiesa resta chiusa e inmilizzata perché «in essa vi sono gli altari, e diverse pitture, che diconsi meritare d'essere conservate, motivo per cui non è finora profanata detta chiesa» (ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, 2474; ASCMi, Località Milanesi, 42I). Tuttavia, nel giro di qualche anno lo stesso ambiente, che non si voleva dissacrare, è destinato a magazzino di mobili e granaglie (ASMi, Fondi Camerali p. m., 36). Il I 8 settembre I 8 I 4, prevedendo di alienare a privati sia la chiesa che il monastero, la Reggenza Provvisoria di Governo notifica l'esistenza degli affreschi alla direzione dell'Accademia di Brera, invitandola a «dare le opportune disposizioni perché una commissione accademica si rechi a visitare le dette pitture, e riferisca se siano degne d'essere levate, e deposte nella I. R. Pinacoteca». Il 22 settembre seguente Ignazio Fumagalli, segretario aggiunto dell'Accademia, riferisce che la commissione, «esaminate quelle pitture a fresco che erano visibili, stante l'ingombro prodotto da diversi mobili ivi esistenti, trovò che i due pezzi laterali all'altar maggiore della chiesa, rappresentanti due martirj meritano assolutamente d'essere trasportati e deposti nella I. R. Pinacoteca sia per la squisitezza di questo e facilità con cui sono dipinti, come per
r
Fig. I 56 Aurelio Luini, Martirio di San Vincenzo, I585 circa, New York, The Metropolitan Museum of Art
l'importante oggetto di completare possibilmente
la serie delle opere de' patrj artisti, essendo i detti
pezzi di mano di Aurelio Luino figlio del celebre
Bernardino, il di cui pennello è sconosciuto finora
nella Pinacoteca>> (ASMi, Fondi Camerali p . m.,
36). In ottobre l'Accademia incarica perciò Stefa
no Barezzi (cfr. ca t. I 3- I 9) di progettare lo stacco dei due affreschi: << trattavasi di segare i muri, e di
farne il trasporto secondo era stato praticato in si
mili capi, si è così fatta eseguire la perizia». Però
<<s opravvenuto l'inverno il Segretario d 'allora
[Giuseppe Zanoja] credette di sospendere le altre operazioni fino a che una stagione più opportuna
fornisse maggiori comodi con minor dispendio»
(ASMi, Studi p. m., 357, fase. 9). Il 27 dicembre I 8 I4 il Demanio del Dipartimento d'Olona ven
de al capomastro Gaetano Brioschi <<la maggior
porzione di locale dell'altre volte monastero delle benedettine di S. Vincenzo», nel quale <<esistono
delle dipinture, e massime nella chiesa esterna, le quali sarà facoltativo al Governo di farle levare
e trasportare nelle Reali Gallerie di Brera, od in
altro luogo, quando queste venissero dalla Com
missione di Pittura riconosciute degne di con
servarsi, ed il compratore non potrà opporsi, né
pretendere alcun compenso se ciò si effettuasse»
(ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione,
344 - 12. UNA COMPLICATA EREDITÀ
2474; ASMi, Fondi Camerali p. m., 36). Quando nel I82o l'ex-aula esterna è destinata a magazzi
no di legnami d'opera, Fumagalli, diventato nel frattempo segretario dell'Accademia, si preoccu
pa per la conservazione degli affreschi e propone
che Barezzi realizzi uno strappo <<col metodo suo,
che oltre ad essere in se stesso più economico e
più sbrigativo, non obbliga a dover fare piantare
ponti sì solidi come per il trasporto de' muri, e
servirebbe questa operazione di maggior guarentigia dell'esito dell'altra di cui è incaricato, quale
si è quella del trasporto del Cenacolo delle Gra
zie» (ASMi, Studi p . m., 3 57, fase. 9). Entro la fine dell 'anno Barezzi realizza lo stacco del M arti rio di San Vincenzo affrescato sulla parete divisoria,
a sinistra dell'altare maggiore, subito depositato
presso la Pinacoteca di Brera dove tuttora si trova
(ASAB, Carpi, A. VI, I9; ASMi, Studi p . m., 357, fase. 9; Reg. Cron. 69; fig. I 55). A causa dei costi, più elevati del previsto, e probabilmente anche in
seguito al deterioramento dei rapporti tra Barezzi
e l'Accademia, l'altro Martirio di San Vincenzo non viene strappato, restando sulla parete diviso
ria dell 'ex-chiesa.
Entro il 1825 Pelagio Palagi, affittuario dell'ex
aula interna dal I 8 I 8, ottiene da Brioschi di espan
dere il proprio studio all'ex-aula esterna (ASCMi,
Fondo ornato fabbriche, 1, cartella 49/ 3 - I827,
Brioschi Gaetano). Trasferitosi a Torino nel I83o,
Palagi continua a disporre di entrambe le ex-aule
come deposito delle proprie collezioni d 'arte, tra
sportate a Bologna dopo la morte del pittore nel
I86o (MEZZANOTTE, BASCAPÉ 1948, p . 348; MAZ
zoccA I989, pp. 42, 44). Successivamente Eleute
rio Pagliano, già proprietario di uno studio in via
della Guastalla ( r 8 p-1 868), affitta gli stessi locali
per realizzare le due grandi allegorie di Venezia e Napoli destinate alla vecchia Stazione Centrale di
Milano (I865, distrutte durante i bombardamenti
del I943; cfr. R. Maggio Serra, in Venezia I983,
p. I7, n . 3) e il cartone dell'Africa per la Galleria Vittorio Emanuele II ( I867; BdAMi, Fondo Bi
gnami, vol. xxi, p. 54; PIANTANIDA I969, p. 25o;
REBORA I998, P· I II; CERESOLI I999, P· 48). Nel I905 la Società Generale Italiana Edison
compra l'ex-chiesa e ottiene dal Comune di Mi
lano la licenza per installarvi un'officina elettri
ca (ASCMi, Fondo ornato fabbriche, rr, cartella
474- I9IO, Edison). Nelr9o8, prima di abbattere la parete divisoria per avviare i lavori, la Edison
incarica i fratelli Giuseppe e Antonio Annoni -
sotto la guida di Luigi Cavenaghi - di occuparsi della rimozione degli affreschi che la decorano.
Tra questi è compreso anche il Martirio di San Vincenzo qui discusso. Inizialmente gli affreschi
strappati sono depositati presso lo studio di An
tonio Annoni. Il I8 dicembre 19Io Angelo Ber
tini, direttore generale della Edison, comunica al Comune di Milano l'intenzione di donare gli af
freschi alle Civiche Raccolte d'Arte: il dono è ac
cettato il q gennaio I9I I dietro parere positivo di Luca Beltrami, Lodovico Pogliaghi e Guido Ca
gnola, che pure lamentano la mancata realizzazio
ne di fotografie e rilievi prima dello strappo delle
pitture e della demolizione della parete. Effettuate
le necessarie operazioni di voltaggio e trasporto
su tela, dopo numerosi solleciti scritti da parte
di Carlo Vicenzi, direttore dei Musei Civici, tra
il novembre I 9 I I e il dicembre 19 I 2 gli affreschi
entrano nelle collezioni comunali (ACRA, serie 1,
4, fase. I8-20). Immediatamente inserito nel per
corso espositivo e restaurato, in data imprecisata,
da M auro Pellicioli (ne resta documentazione al Photo Archive del Gctty Institute a Los Angeles :
Album 9, p . II), tra il I96o e il 1987 il Martirio di San Vincenzo abbandona le sale del Castello
Sforzesco per quelle del Rettorato dell'Università
degli Studi di Milano (ACRA, Opere in deposito uffici, fascicolo Università di Milano - via Festa
del Perdono, 7). Ricoverato nei depositi del Castello, l'affresco è restaurato da Paola Zanolini tra
il I992 e il I993 , esposto alla mostra Un museo da scoprire (M. T. Fiorio, in Un museo I993, p. 48, n.
I 9) e quindi definitivamente reintegrato nel nuo
vo percorso espositivo della Pinacoteca (cfr. L. Basso, in La Pinacoteca 2005, pp. 120-121, n. 85).
Nonostante il pendant di Brera sia sempre sta
to riferito ad Aurelio Luini (cfr. D. Pescarmona,
in Pinacoteca I989, pp. 300-301, n. 212), il Mar-tirio di San Vincenzo del Castello è pubblicato
da Carlo VICENZI (I 9 I 5, p . 55) come M arti rio di San Lorenzo di <<Scuola lombarda del XVI seco
lo». Successivamente, lo stesso VICENZI (1926, p.
48) ~ attribuisce a Giovanni Paolo Lomazzo, lasciandosi probabilmente fuorviare dalla firma di
Giovanni Lomazzo- cugino della moglie di Ber
nardino Luini -presente su uno degli altri affre
schi strappati provenienti da San Vincenzino (inv.
inv. 436-440, 442; cfr. F. Cavalieri, in Museo I997, pp. 309-3I5, nn. 209-2I4). Il nome di Lomazzo è ripetuto, ancora nel I98o, da Marco Bona Castel
lotti (in SANTAGOSTINO 1671, p. 50, nota 46). Giu
lio BoRA (1984, p . 31, nota 47) restituisce il Martirio ad Aurelio. Daniele PESCARMONA (I986, che
pubblica la prima fotografia in bianco e nero; D.
Pescarmona, in Disegni 1986, pp . 53-55, n. Io) è il primo ad accorgersi che gli affreschi di Brera e del
Castello formano una coppia di scene del Martirio di San Vincenzo, ma la sua intuizione non è regi
strata da Nancy WARD NEILSON (1987, che pub-
blica il disegno preparatorio, a matita nera, penna, acquerello marrone e biacca, quadrettato a matita rossa, conservato al Metropolitan Museum of Art di New York, inv. I986. I6; fig. I s6), Maria Teresa FIO RIO e Mercedes GARBERI (I987, p. 88, n. I I s), Fanny AuTELLI (I989, pp. r27-I28), Maria Teresa Fiorio (in Un museo I993, p. 48, n. I9) e Sandrina Bandera (in Le stanze I994, pp. 236-237) che continuano a riconoscere il Santo martire come Lorenzo. Federico Cavalieri (in Museo 1998, pp. roo-Io4, n. 319, che pubblica le prime riproduzioni a colori) ricostruisce le tappe fondamentali delle vicende materiali dell'affresco e ne ribadisce la paternità luinesca, chiarendo una volta per tut
te che il soggetto è il M arti rio di San Vincenzo. Giulio Bora (in Quadreria I999, pp. 25-26) continua tuttavia a identificare il Santo martire come
Lorenzo, mentre Jacqueline CERESOLI (1999, pp. 49-52) riporta entrambe le identificazioni senza esprimersi chiaramente in merito. Mauro FAVE
SI (2oio, p. r 50), pur avanzando una vacillante proposta di recupero di una figura del Martirio da parte di Caravaggio, registra correttamente il soggetto (cfr. M. Pavesi, in Museo 201 I, p. 378).
L'agiografia racconta come, all'epoca dell'imperatore Diocleziano, il diacono Vincenzo di Saragozza sia condotto davanti al proconsole Daziano e, rifiutando di abiurare la fede cristiana, venga sottoposto a diversi supplizi. Tra questi si ricordano solitamente la scarnificazione mediante rastrelli di ferro e la tortura della graticola, gli stessi rappresentati da Au- 'l
relio Luini ai lati dell'altare maggiore di San Vincenzino alle monache. Una volta morto Vincenzo, il suo corpo è esposto in un campo deserto alla mercé delle fiere selvagge, ma un corvo interviene per proteggerlo dalla profanazione. Successivamente, chiuso dentro un sacco e legato a una macina, il corpo è portato allargo e gettato in mare perché affondi: miracolosamente però, la salma galleggia sui flutti fino a essere trasportata a riva, dove è ritrovata dalla comunità dei fedeli e degnamente sepolta.
Aurelio ambienta il secondo episodio del Martirio di San Vincenzo in uno spazio aperto, dominato da un cielo nuvoloso e delimitato, sulla destra, da una quinta architettonica. La scena è vista attraverso una cornice prospettica, solo parzialmente conservata, con il margine sinistro tutto in ombra: a in-
dicare che la luce ongmariamente colpiva l'affresco da sinistra. In primo piano, San Vincenzo è steso sulla graticola, seminudo, con le braccia spalancate e lo sguardo rivolto al cielo. Ai lati due aguzzini si affaccendano per eseguire gli ordini impartiti da Daziano: quello di sinistra, inginocchiato e con una torcia in mano, cerca di tenere fermo Vincenzo, mentre l'altro, in piedi a destra, affonda una forca dal lungo manico nel ventre del diacono. Un soldato dalla barba grigia aiuta gli aguzzini attizzando il fuoco con un mantice mentre, alle estremità della composizione, due suoi commilitoni si limitano a osservare quanto accade: quello di sinistra - che regge un bandierone rosso e floscio -dall'alto della sua cavalcatura, quello di destra- giovanissimo- appoggiato alla propria spada. Alle spalle di San Vincenzo due figure sembrano impegnate in una discussione a mezza voce: un uomo anziano, che ha tutta l'aria del sacerdote pagano, e un soldato, che appoggia una mano sulla spalla di San Vincenzo come per impedirgli di scappare. Tra gli astanti, un uomo barbuto vestito di giallo con indosso un turbante bianco e rosso è forse da identificare con il proconsole Daziano. Questi compare due volte: la prima si trova in fondo alla folla, quasi nascosto dalla groppa del cavallo, e fissa con sguardo severo in direzione dell'osservatore, come a volere cogliere con prontezza e disprezzo il minimo moto di pietà verso il martire; la seconda si trova invece sulla destra, ed è colto nell'atto di rivolgere una supplica alla statua dorata che, con sguardo impassibile, domina la scena dall'alto. La statua rappreslfnta probabilmente il dio Apollo, caratterizzato dalla lira. In lontananza si staglia un edificio imponente, forse a pianta centrale, sormontato da una terrazza - dalla quale si affacciano alcune figure - con una cupola. La scena è coronata, anche narrativamente, da un angioletto che, aprendo uno squarcio luminoso nelle nubi, si appresta a scendere dal cielo per consegnare la palma del martirio a San Vincenzo.
Il michelangiolismo mediato e gli echi raffaelleschi chiamati in causa nelle analisi di questo affresco, per quanto incidenti, non eguagliano la profonda risonanza del Martirio di San Lorenzo di Tiziano (I 55 9 ), nella chiesa dei Gesuiti a Venezia, forse conosciuto da
Aurelio direttamente e non solo attraverso la precoce traduzione grafica di Cornelis Cort. Luini infatti sembra organizzare le linee generali della composizione, adottare la soluzione dell'apparizione luminosa dell'angelo, mettere in posa carnefici e soldati a partire da Tiziano. Aurelio non ricorre però al notturno: la sua regia delle luci non ricerca questi effetti, che pur a Milano incontravano, negli stessi anni, un vivo interesse da parte diAntonio Campi, il cui Martirio di San Lorenzo in San Paolo Converso (r58r; cat. un) rappresenta una prova di «illusionismo spietato», lontanissimo dall' «impressionismo magico >> di Tiziano (LoNGHI 1928-1929, p. 127).
FEDERico MARIA GrANI
12. UNA COMPLICATA EREDITÀ- 345