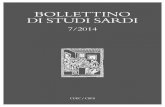Pietro Aretino, Vincenzo Borghini e l’iconografia del settore est del Giudizio Universale nella...
Transcript of Pietro Aretino, Vincenzo Borghini e l’iconografia del settore est del Giudizio Universale nella...
fontes è una pubblicazione semestrale
Condizioni di abbonamento: € 75,00
Costo di un numero (due fascicoli): € 80,00
Per gli abbonamenti e gli acquisti rivolgersi a:Licosa s.p.a.
Via Duca di Calabria 1/1I-50125 firenze
telefono +39(0)556483201 - fax +39(0)55641257e-mail: [email protected]
©2010 LUMIÈRes InteRnAtIonALesLugano
e-mail: [email protected]
proprietà artistica e letteraria riservata per tutti i paesiÈ vietata la traduzione, la memorizzazione elettronica, la riproduzione totale
e parziale, con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico
La Casa editrice, pur avendo richiesto tutti i permessi necessari, è comunque a disposizione degli Autori per le fonti iconografiche
eventualmente non identificate
Impaginazione e progetto grafico a cura di Polis ExPrEssE
Copertina a cura di Milena Bobba
Issn 1127-6851
fontes RIVIstA seMestRALe
DI fILoLoGIA, IConoGRAfIAe stoRIA DeLLA tRADIZIone CLAssICA
anni xi-xiiifascicoli 21-26/2008-2010
polis expresse
Direttore
Roberto Guerrini
Comitato scientifico
Ernesto Berti (Università di Udine)
Maurizio Bettini (Università di Siena)
Stefano Carrai (Università di Siena)
Gioachino Chiarini (Università di Siena)
Maria Monica Donato (Scuola Normale Superiore di Pisa)
Lucia Faedo (Università di Pisa)
Daniela Fausti (Università di Siena)
Ivan Garofalo (Università di Siena)
Roberto Guerrini (Università di Siena)
Pierre Laurens (Università Sorbona, parigi)
Alberto Olivetti (Università di Siena)
Marianne Pade (Università di Copenhagen)
Giuseppe Pucci (Università di Siena)
Salvatore Settis (Scuola Normale Superiore di Pisa)
Redazione
Marilena Caciorgna, sonia CavicchioliLuigina D’Anselmo, Giovanni Maria fara, Annarita ferranti, francesca Graziadio, Gianni Mazzoni, Marcella Marongiu,
Maddalena sanfilippo, susan scott
Per ogni corrispondenza, invio di libri e riviste, per omaggio o scambio,
indirizzare aLumières internationaLes
via soLdino 226903 Lugano-Besso (CH)
e-mail: [email protected]
VII
soMMARIo
contributi di iconografia e storia della tradizione classica
Marilena Caciorgna, exempla amantium. Scritte d’amore sullecortecce degli alberi e moduli elegiaci. Testo e immagine nella tradizione classica dall’Umanesimo all’epoca contemporanea 1
Annarita ferranti, Ricerche sugli epigrammi latini di Francesco Filelfo (Reggia dell’Arengo, Milano, 1450 ca.). Tre eroine appartenenti alla tradizione delle neuf preuses: Semiramide, Tomiride, Pentesilea 35
Luigina D’Anselmo, Le Argonautiche di Apollonio Rodio e la traduzione di Bartolomeo della Fonte (il Fonzio) nella pittura fiorentina del XV secolo. Il fidanzamento di Giasone e Medea di Biagio d’Antonio, Paris, Musée des Arts Décoratifs 55
stefano Pierguidi, Pietro Aretino, Vincenzio Borghini e l’iconografia del settore est del Giudizio Universale nella cupola di Santa Maria del Fiore 81
Raffaella fontanarossa, Introduzione ai cicli profani nell’opera di Giuseppe Galeotti (Firenze 1708-Genova 1778) 89
contributi di filologia
Luigi De Martino, Analisi di un frammento acciano (trag. 544 R.2) 109
materiali
Marilena Caciorgna, La storia di Coriolano in una spalliera di Francesco di Giorgio Martini 129
notiziario bibliografico
Biografia Dipinta. Plutarco e l’arte del Rinascimento (1400-1550), a cura di Roberto Guerrini, con scritti di Marilena Caciorgna, Cecilia filippini, Roberto Guerrini, La spezia, Agorà edizioni, 2002, 426 pagine, 97 tavole in bianco e nero (Maddalena Sanfilippo) 141
Marilena Caciorgna, Il naufragio felice. Studi di filologia e storia della tradizione classica nella cultura letteraria e figurativa senese. sarzana, Agorà edizioni, 2004, pp. XXIII+302, 2004, pp. XXIII+302, with 91 black and white plates (Petra Pertici, trad. di Susan Scott) 147
Ritratto e Biografia. Arte e cultura dal Rinascimento al Barocco, a cura di Roberto Guerrini, Maddalena sanfilippo e Paolo torriti, La spezia, Agorà edizioni, 2004, 360 pagine, 179 tavole in bianco e nero (Annarita Ferranti) 149
Valentina Conticelli, «Guardaroba di cose rare et preziose». Lo studiolo di Francesco I De’ Medici. Arte, storia e significati. Lugano, Agorà Publishing, 2007, 464 pagine, 115 tavole in bianco e nero, 39 tavole a colori, 14 planimetrie (Annarita Ferranti) 151
Marcella Marongiu, Currus Auriga Paterni. Il mito di Fetonte nel Rinascimento. Lugano, Agorà Publishing, 2008, 300 pagine, 115 tavole in bianco e nero (Annarita Ferranti) 152
indici
Index fontium (autori, luoghi, opere) 155 Indice dei nomi 163
IX
eLenCo DeLLe tAVoLe
MARILenA CACIoRGnAexempla amantium. Scritte d’amore sulle cortecce degli alberi e moduli elegiaci.
Testo e immagine nella tradizione classica, dall’Umanesimo all’epoca contemporanea
1. Maestro del Codice squarcialupi, Storia di Aconzio e Cidippe. Milano, Bi-blioteca Ambrosiana, s.P.13 bis, c. 85v. (foto della Biblioteca).
2. Maestro del Codice squarcialupi, Cidippe raccoglie la mela. Milano, Biblio-teca Ambrosiana, s.P.13 bis, c. 86r. (foto della Biblioteca).
3. Maestro del Codice squarcialupi, Cidippe è trafitta da una freccia di Cupido. Milano, Biblioteca Ambrosiana, s.P.13 bis, c. 91v. (foto della Biblioteca).
4. Incisore del XV secolo, Aconzio consegna la lettera a Cidippe. ovidio, He-roides [volgarizzamento di filippo Ceffi], napoli, francesco del tuppo, ca. 1480, i4r. siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, n. V. 31. (foto della Biblioteca).
5. Incisore del XV secolo, Cidippe consegna la lettera ad Aconzio. ovidio, He-roides [volgarizzamento di filippo Ceffi], napoli, francesco del tuppo, ca. 1480, i8v. siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, n. V. 31. (foto della Biblioteca).
6. Incisore del XVI secolo, Storie di Aconzio e Cidippe. Da ovidio, Epistole He-roides Ovidii… commentantibus Antonio Volsco et Ubertino Crescentinate…, Ve-netiis, per Bartholomeum de Zanis de Portensio, 1506, o6v. (foto della Biblioteca).
7. Incisore del XVI secolo, Storie di Aconzio e Cidippe. Da ovidio, Epistole He-roides Ovidii… commentantibus Antonio Volsco et Ubertino Crescentinate…, Ve-netiis, per Bartholomeum de Zanis de Portensio, 1506, p4v. (foto della Biblioteca).
8. Miniaturista francese del XVI secolo, Cidippe risponde ad Aconzio. Parigi, Biblio-thèque nationale de france, Richelieu Manuscrits français 873, c. 140v.
9. francesco di Giorgio Martini, Bianca Saracini. firenze, Biblioteca nazio-nale, ms. Palatino 211.
Elenco delle tavole
X
10. Bardella, Lucrezia si reca, accompagnata da due fanciulle e una vecchia, alla messa nella chiesa di Santa Maria in Betleem, incisione. Storia di due amanti di Enea Silvio Piccolomini dipoi Pio II Pontefice, Milano, G. Daelli e C. editori, 1864, p. 77.
11. Bardella, Pacoro lancia la palla di neve a Lucrezia, incisione. Storia di due amanti di Enea Silvio Piccolomini dipoi Pio II Pontefice, Milano, G. Daelli e C. editori, 1864, p. 81.
12. Incisore del XV-XVI secolo, Eurialo consegna la lettera a Lucrezia. enea sil-vio Piccolomini, Historia de duobus amantibus, trad. Alessandro Braccesi, firenze, Lorenzo Morgiani, ca. 1500, c. c2.
13. Autore del XV secolo, Cinzia e Properzio. Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 915, f. 1v.
14. Cuore trafitto da Madonna Giovanna. siena, Archivio di stato, Gabella 4, f. 34v.
15. Maestro del Codice squarcialupi, Paride incide il nome di Enone sulla cortec-cia di un faggio, particolare. Milano, Biblioteca Ambrosiana, s. P. 13 bis, c. 18r.
16. Miniaturista francese del XVI secolo, Storie di Enone. Al centro: Enone scri-ve a Paride. A sinistra: Sogno di Ecuba; Giudizio di Paride. sotto: Paride incide il nome di Enone sulla corteccia di un faggio. Parigi, Bibliothèque nationale de france, Richelieu Manuscrits français 873, c. 27v.
17. Miniaturista francese degli inizi del XVI secolo, Paride ed Enone nella fore-sta. Parigi, Bibliothèque nationale de france, Velins 2089.
18. tiziano, Ninfa e pastore. Vienna, Kunsthistorisches Museum.
19. Incisore del XVI secolo, Pazzia di Orlando. L. Ariosto, Orlando furioso, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ ferrari e fratelli, 1554, p. 108v.
20. santa Montefiore, L’albero degli Amanti Perduti, titolo originale Meet me un-der the ombu tree, traduzione di M. Pignatti e I. Ruggi, 2001, Milano, RCs Libri 20063.
21. flavio faganello, Scritta su faggio (Lavarone-Altopiano di Lavarone). Da L’albero dell’amore. Graffiti su faggio nelle fotografie di Flavio Faganello, cata-logo della mostra (trento, Museo tridentino di scienze naturali, 31 lu-glio-24 ottobre 2004), trento, esaexpo, 2004, p. 16.
LUIGInA D’AnseLMoLe Argonautiche di Apollonio Rodio e la traduzione di Bartolomeo della Fonte
(il Fonzio) nella pittura fiorentina del XV secolo. Il fidanzamento di Giasone e Medea di Biagio d’Antonio, Paris, Musée des Arts Décoratifs
22. Bartolomeo di Giovanni, Afrodite. Collezione privata.
Elenco delle tavole
XI
23. Bartolomeo di Giovanni, Apollo. Collezione privata.
24. Maestro del 1487, Partenza degli Argonauti. Ubicazione sconosciuta (già Città del Capo, collezione Labia).
25. Bartolomeo di Giovanni, Banchetto degli Argonauti in Colchide, Ubicazione sconosciuta (già Città del Capo, collezione Labia).
26. Biagio D’Antonio, Il Fidanzamento di Giasone e Medea. Paris, Musée des Arts Décoratifs, inv. Pe. 102. (foto del Museo).
27. Biagio D’Antonio, Il Fidanzamento di Giasone e Medea (particolare). Paris, Musée des Arts Décoratifs, inv. Pe. 102. (foto del Museo).
28. Biagio D’Antonio, Il Fidanzamento di Giasone e Medea (particolare). Paris, Musée des Arts Décoratifs, inv. Pe. 102. (foto del Museo).
29. Biagio D’Antonio, Il Fidanzamento di Giasone e Medea (particolare). Paris, Musée des Arts Décoratifs, inv. Pe. 102. (foto del Museo).
stefAno PIeRGUIDIIl Giudizio universale nella cupola di Santa Maria del Fiore
30. federico Zuccari, Allegoria della fine del Tempo (part. del Giudizio Universa-le), firenze, santa Maria del fiore, cupola, settore est.
RAffAeLLA fontAnARossAIntroduzione ai cicli profani nell’opera di Giuseppe Galeotti
(Firenze 1708-Genova 1778)
31. Giuseppe Galeotti, Giudizio di Paride (?). Chiavari (Genova), Palazzo fal-cone. (foto di Raffaella fontanarossa).
32. Giuseppe Galeotti, Trionfo della Sapienza e Punizione di Amore. Chiavari (Genova), Palazzo falcone. (foto di Raffaella fontanarossa).
33. Giuseppe Galeotti, Arianna risvegliata da Bacco. Chiavari (Genova), Palaz-zo falcone. (foto di Raffaella fontanarossa).
34. Giuseppe Galeotti, Aurora e Cefalo. Chiavari (Genova), Palazzo falcone. (foto di Raffaella fontanarossa).
35. Giuseppe Galeotti, Prometeo che anima la statua col fuoco rubato agli dei. Pon-tremoli (Massa Carrara), Palazzo Dosi. (foto di Raffaella fontanarossa).
36. Giuseppe Galeotti, Allegoria dell’amore coniugale. Pontremoli (Massa Carra-ra), Palazzo Dosi. (foto di Raffaella fontanarossa).
37. Cesare Ripa, Allegoria della benevolenza e dell’unione matrimoniale. (foto di Raffaella fontanarossa).
Elenco delle tavole
XII
38. Giuseppe Galeotti, Punizione di Amore. Pontremoli (Massa Carrara), Palazzo Dosi. (foto di Raffaella fontanarossa).
39. Giuseppe Galeotti, Ifigenia salvata da Diana. Genova, Palazzo saluzzo. (foto di Raffaella fontanarossa).
40. Giuseppe Galeotti, Pallade e Aracne. Genova, Palazzo saluzzo. (foto di Raf-faella fontanarossa).
41. Giuseppe Galeotti, Ippomene e Atalanta. Genova, Palazzo saluzzo. (foto di Raffaella fontanarossa).
42. Giuseppe Galeotti, Giunone condotta all’Olimpo (particolare). Borgotaro (Parma), Palazzo Bertucci. (foto di Raffaella fontanarossa).
MARILenA CACIoRGnALa storia di Coriolano in una spalliera di Francesco di Giorgio Martini
43. francesco di Giorgio Martini e ‘fiduciario di francesco’, Storia di Coriola-no. Castello di Gallico (siena), Collezione salini.
81
Pietro Aretino, Vincenzio Borghini e l’iconogrAfiA del settore est
del Giudizio universale nellA cuPolA di sAntA MAriA del fiore
stefano pierguidi
la fortuna riscossa nell’età della controriforma da alcuni testi di Pie-tro Aretino, lettere e prose varie, connessi alla sua volontà di interfe-rire nell’invenzione del Giudizio universale di Michelangelo permette forse di capire meglio una peculiare soluzione iconografica adottata da Vincenzio Borghini nel programma stilato intorno al 1570 per il grandioso affresco che giorgio Vasari si apprestava ad eseguire all’in-terno della calotta del Brunelleschi, affresco che sarebbe stato poi ter-minato da federico zuccari nel 1579 dopo la morte di Vasari (1574). nella elaborazione dei temi destinati al settore orientale della cupola, l’iconologo «per i cori angelici si ispirò ai mosaici del Battistero, riu-nendo i due più alti, cherubini e serafini, in un solo settore attorno a cristo. Quanto al resto dei gruppi e delle figure, le serie di sette [doni dello spirito santo, Virtù, Beatitudini, Peccati capitali] furono artico-late occupando sette spicchi, e riservando l’ottavo (est, corrisponden-te all’altar maggiore) a cristo giudice con la corte celeste; il settore est, liturgicamente preminente, assumeva così un ruolo di cerniera che lo sottraeva alla numerologia complessiva e al tempo stesso gli su-bordinava l’intera composizione»1. in particolare, in merito alla fascia più bassa di quel settore, quella sotto il gruppo del cristo giudice (tav. 30), Borghini scriveva:
«sotto questa parte da basso, non farei huomini che risuscitassero, o faces-sero altro, riserbandogli a’ luoghi loro, secondo la loro distinzione: ma vi farei la natura, messa nel mezzo del tempo et del Moto, et simil’altre cose: et che el tempo havesse in compagnia il giorno et la notte; l’un chiaro, l’altra oscura, o distinguendogli altrimenti che si conoscessero; et spezzasse
1 Acidini luchinat, 1998-1999, ii, p. 65. sull’iconografia degli affreschi della cupola di santa Maria del fiore, ed in particolare di quelli del settore est, cfr. anche Acidini luchinat 1995, pp. 64-8 (in part. p. 68).
stefano Pierguidi
82
il tempo i suoi horivoli; la Morte, la falce: così li si potrebbono mettere l’in-firmità, i dolori etc. (.…)»2
nel disegno di Vasari al louvre in cui è studiata la composizione del settore est, non compare nessuna delle figure previste al di sotto della corte celeste del cristo giudice,3 e non sappiamo quindi come l’are-tino pensasse di trattare quell’inedito gruppo di figure allegoriche. Borghini, infatti, lasciava spesso mano libera a Vasari in merito agli attributi con cui connotare le sue personificazioni4: per la natura, ad esempio, egli non ne aveva indicato alcuno. nella tradizione iconogra-fica cinquecentesca del Giudizio universale non è inoltre possibile trova-re confronti stringenti: natura, tempo e Morte non erano raffigurati affatto5.
nel dies irae, celebre lirica latina del Xiii secolo attribuita a tom-maso da celano, che generalmente si ritiene abbia influenzato anche Michelangelo per l’affresco con il Giudizio universale nella cappella si-stina, sono in realtà citati sia la Morte sia la natura6:
Mors stupebit et natura, cum resurget creatura, judicanti responsura.
in questa terzina, peraltro, il tema è quello della sorpresa della Morte e della natura nell’assistere alla resurrezione dei corpi, mentre nel Giudizio universale della cupola di santa Maria del fiore era quello del-la fine della funzione del tempo e della Morte, e quindi anche del-la natura. A confermarlo è la descrizione anonima manoscritta degli affreschi della cupola, verosimilmente riferibile allo stesso Borghini, in cui del tempo si dice «che non ci ha più che fare, e però spezza l’oriolo, e lo getta via» e della Morte «che rompe la falce, come quella,
2 il programma manoscritto di Borghini venne pubblicato la prima volta in giusti 1857, pp. 132-40, e poi in Verdon 1996, pp. 171-79 (il passo riportato è a p. 174).
3 Acidini luchinat 1997-1998, p. 119.4 scorza 1987, pp. 92, 196 e 255.5 de Maio 1978, pp. 79-93.6 redig de campos 1964, pp. 54-7: lo studioso suggerì di identificare con la Morte
uno scheletro che compare in basso a sinistra nell’affresco di Michelangelo, e con la natura la figura a lui davanti, riversa in terra su un fianco, ma con tutta probabilità si tratta solo di due anime beate che risorgono dalla terra.
il giudizio universale nella cupola di santa Maria del Fiore
83
che perde anch’essa l’ufizio suo in quel giorno»7. È possibile allora che Borghini si fosse rifatto anche ad un’altra fonte, ovvero la lettera del 15 settembre 1537 che Pietro Aretino scrisse a Michelangelo, in procinto di affrescare la parete di fondo della cappella sistina, per suggerirgli una visione grandiosa del giudizio universale.
Pubblicata nel primo, fortunatissimo libro delle lettere dell’Aretino, stampato a Venezia per i tipi di francesco Marcolini nel gennaio del 1538, quella lettera aveva al centro un brano che lo stesso autore avrebbe riproposto (o aveva già elaborato) ne il Genesi con la visione di noè che vide la luce, in quello stesso anno, e sempre a cura dello stesso geniale editore forlivese8. in quell’opera noè ha una visione del giorno del giudizio accostabile a quella che Aretino, con un artificio retorico, aveva avuto al pensiero del grandioso affresco che Michelangelo stava per eseguire:
io veggo in mezzo de le turbe Anticristo con una sembianza sol pensata da voi [Michelangelo]. Veggo lo spavento ne la fronte de i viventi. Veggo i cen-ni che di spegnersi fa il sole, la luna e le stelle. Veggo quasi esalar lo spirto al fuoco, a l’aria, a la terra, e a l’acqua. Veggo là in disparte la natura ester-refatta, sterilmente raccolta ne la sua età decrepita. Veggo il tempo asciutto e tremante, che, per esser giunto al suo termine, siede sopra un tronco sec-co. e mentre sento da le trombe de gli angeli scuotere i cori di tutti i petti, veggo la vita e la morte oppresse da spaventosa confusione, perché quella s’affatica di rilevare i morti, e questa si provvede di abattere i vivi. Veggo la speranza e la disperazione che guidano le schiere dei buoni e gli stuoli dei rei (…). Veggo la fama con le sue corone e con le sue palme sotto i piedi, gittat là fra le ruote de i suoi carri9.
e ne il Genesi Aretino scriveva:
7 la descrizione, conservata alla Biblioteca nazionale di firenze, è stata pubblicata in scorza 1987, pp. 255-9 e in Acidini luchinat 1988-1989, pp. 169-75 (il passo riportato è a p. 172). secondo l’Acidini, autore della descrizione sarebbe Baccio Valori. di opinione contraria è però scorza (cfr. anche la sua scheda in Belloni, drusi 2002, pp. 144-8) che ritiene di poterla riferire allo stesso Borghini. in ogni caso è certo che la descrizione sia stata stesa con l’obiettivo di difendere le pitture dalle critiche che si erano attirate: proprio come nel caso del discorso sopra la mascherata della geneologia degl’iddei de’ gentili pubblicato da Baccio Baldini nel 1565 per le stesse ragioni, infatti, sia il nome dell’auto-re dello scritto sia quello dell’estensore del programma iconografico erano taciuti, cfr. Pierguidi, 2007, pp. 347-64.
8 Barnes 1997, p. 65.9 Aretino 1997-2002, i, pp. 277-9.
stefano Pierguidi
84
tre angeli di tutta la milizia eterna, accennati dal ciglio di dio, prese le trom-be terribili, si posero a lo incontro de le tre parti de l’universo; e datogli il suono con il fiato de la volontà del creatore, tremò il sole, si scosse la luna, sbigottirono le stelle, spaventarono gli elementi, disperse la natura, impigrì il tempo, si smarrirono le genti, e uscì di se stesso il mondo; e Anticristo, con le turbe credenti ne la falsità dei suoi miracoli, perduta la baldanza de la iniquità e la potenza della predicazione, non sapendo che farsi, errava ne la confusione del peccato, il nefando del quale inciampava ne lo eterno de la penitenza (…), il tempo, caduto nel fine del suo corso, secco e orrido, si stava raccolto ne lo ultimo dei suo anni stremi; le palpebre de le ciglia cascanti giuso gli velavano lo spiraglio de la luce; la sua bocca con niun den-te non si apriva, la barba bianca e la testa calva testimonia il suo non avere più giuridizione ne lo invecchiare. ecco la natura, che perduto il nome di madre, ridotta sterile, benché le prema, non può trarre punto di latte de le poppe infinite con cui ella sosteneva il genere degli uomini, degli animanti e de le piante. era un tremore nei viventi, un pallore e un languore che spie-ga ne l’altrui fronte le insegne de la Morte; la quale, cacciata de le tombe, de le fosse, de le sepolture, dei monimenti, de le arche e dei depositi, stupiva de l’ossa, de le reliquie, dei corpi e dei cadaveri restaurati dal vitale degli spiriti; i quali, mossi da le virtù che ebbero mentre abitarono ne le vite rette da essi, ritornavano in questi e in quegli, come ape a le case loro10.
la reiterazione del verbo «veggo» nel primo brano richiama forse l’apocalisse di giovanni11, in cui quasi ogni capitolo è introdotto nello stesso modo; merita riportare soprattutto un brano del XXi, certo tenuto presente dall’Aretino:
Vidi poi un trono bianco, molto grande; davanti a colui che sedeva su di esso, fuggirono il cielo e la terra e il loro posto non si trovò più. i morti, grandi e piccoli, stavano davanti al trono (…). infatti, dopo che il mare ebbe dato i suoi morti e la Morte e l’Ade ebbero dato i loro morti, furono giudicati singolarmente secondo le loro opere. la Morte e l’Ade furono gettati nello stagno del fuoco.
se da una parte la conoscenza dell’apocalisse e del dies irae sarebbe for-se potuta essere sufficiente a Borghini per orchestrare il gruppo allego-rico che doveva chiudere in basso il settore est del Giudizio universale di
10 Aretino 1970, pp. 974-5.11 la reiterazione del verbo «veggo» si ritrova anche nella lettera scritta da Aretino a
Vasari il 7 giugno 1536 nel quale l’autore, da Venezia, rievocava l’apparato per l’entrata trionfale di carlo V a firenze che lo stesso Vasari gli aveva descritto in una lettera prece-dente, cfr. frey 1923-1940, i, pp. 70-1.
il giudizio universale nella cupola di santa Maria del Fiore
85
santa Maria del fiore, dall’altra non si può fare a meno di sottolineare la forte somiglianza tra i brani dell’Aretino, il passo di Borghini e il gruppo affrescato dallo zuccari. in particolare la figura della natura, per la quale l’erudito fiorentino non aveva indicato nessun attributo, e che il pittore avrebbe caratterizzato solo attraverso la magrezza dei seni e l’aspetto affranto, ricorda da vicino il precedente aretiniano:
la natura esterrefatta, sterilmente raccolta ne la sua età decrepita.ecco la natura, che perduto il nome di madre, ridotta sterile, benché le prema, non può trarre punto di latte de le poppe infinite.
lo zuccari aveva raffigurato nella cupola il tempo tra il Presente e il Passato, secondo una soluzione iconografica ignota a Borghini e sugge-rita invece dalle Pitture di Anton francesco doni (1564)12. egli, quindi, avrebbe anche potuto attingere autonomamente alla lettera di Aretino a Michelangelo. la natura, nel cinquecento, era comunque general-mente caratterizzata prima di tutto dalle mammelle ricche di latte13, e forse non è necessario ipotizzare una conoscenza diretta di quel testo da parte del pittore. Più probabile è che Borghini, uomo di lettere, avesse recuperato le figure allegoriche del tempo, della natura e della Morte dal precedente aretiniano, senza per questo copiare pedissequa-mente quel modello.
È ben noto che Borghini, incaricato da cosimo i di stendere il pro-gramma iconografico per l’entrata trionfale a firenze di giovanna d’Austria nel 1565, si fosse scrupolosamente documentato sulle descri-zioni a stampa delle più celebri entrate trionfali tenutesi in europa nel cinquecento14. niente di più facile, quindi, che anche per elaborare lo schema degli affreschi della cupola di santa Maria del fiore, egli avesse studiato a fondo le più importanti fonti testuali a sua disposizione, tra le quali era anche il Genesi dell’Aretino. e la lettera del 1537, con la quale si era aperto il carteggio, poi divenuto aperta polemica, tra Areti-no e Michelangelo in merito all’affresco della cappella sistina, doveva essere molto nota.
il 12 gennaio 1572, mentre era ancora impegnato agli affreschi della sala regia nei Palazzi Vaticani, Vasari scrisse a francesco i de’ Medici, rassicurandolo in merito al lavoro che lo attendeva a firenze: «né mi
12 Acidini luchinat 1998-1999, ii, pp. 89-90; doni 2004, p. 59.13 così, infatti, è raffigurata in una delle xilografie delle sorti di francesco Marcolini
(Venezia 1540 e 1550) ed è descritta in una voce in ripa 1593, p. 175.14 scorza 1981, pp. 57-60.
stefano Pierguidi
86
scorderò de’ disegni della cupola, perché lo studiar qui importa assai, e l’opera che s’ha da fare n’ha di bisogno, e la volta della cappella di Michelagnolo mi sarà scorta15» in merito alla decorazione della cupola di santa Maria del fiore, paradossalmente, Vasari menzionava quindi la volta della cappella sistina, per la magistrale soluzione del problema del ‘sotto in su’, a cui egli si sarebbe rifatto, senza far cenno alla parete d’altare, dove Michelangelo aveva affrescato il suo Giudizio universale. certo è che, anche a seguito del passaggio del testimone da Vasari allo zuccari, la volta della cupola di santa Maria del fiore sarebbe finita per essere un’opera quanto mai lontana dal difficile, scomodo e criticato precedente michelangiolesco. un’opera, però, dove sarebbe sorpren-dentemente ricomparso quel gruppo di figure allegoriche che Aretino aveva suggerito al Buonarroti di raffigurare nel suo affresco della cap-pella sistina.
15 Vasari, 1906, iX, p. 463.
il giudizio universale nella cupola di santa Maria del Fiore
87
Acidini luchinat 1988-1989c. Acidini luchinat, Per le pitture della cupo-la di santa Maria del Fiore, «labyrinthos», 7-8, 1988/1989, pp. 153-75.
Acidini luchinat 1995c. Acidini luchinat, Traccia per la storia del-le pitture murali e degli artisti, in c. Acidini luchinat e r. dalla negra (a cura di), Cu-pola di santa Maria del Fiore: il cantiere di re-stauro 1980 – 1995, roma, istituto poligra-fico zecca dello stato, 1995, pp. 63-112.
Acidini luchinat 1997-1998c. Acidini luchinat, da Michelangelo a raffaello, due modelli opposti per il «Giudizio» nella cupola, in M. Winner e d. heikamp (a cura di), der Maler Federico zuccari: ein römischer virtuoso von europäischem ruhm, Atti del congresso internazionale (roma-firenze 23-26 febbraio 1993), «römisches Jahrbuch der Bibliotheca hertziana», 32, 1997-1998, pp. 117-24.
Acidini luchinat 1998-1999c. Acidini luchinat, Taddeo e Federico zuc-cari: fratelli pittori del Cinquecento, 2 voll., Milano, Jandi sapi editori, 1998-1999.
Aretino 1970P. Aretino, scritti scelti di Pietro aretino, g.g. ferrero (a cura di), torino, utet, 1970.
Aretino 1997-2002P. Aretino, lettere, P. Procacciali (a cura di), 6 voll., roma, salerno, 1997-2002.
Barnes 1997.B. Barnes, aretino, the Public, and the Cen-sorship of Michelangelo’s last Judgment, in e.c. childs (a cura di), suspended license. Censorship and visual arts, seattle and
london, university of Washington Press, 1997, pp. 59-84.
Belloni, drusi 2002g. Belloni, r. drusi (a cura di), vincenzio Borghini: filologia e invenzione nella Firenze di Cosimo i, catalogo della mostra (firenze, 21 marzo-20 aprile 2002), firenze, ol-schki, 2002.
de Maio 1978r. de Maio, Michelangelo e la Controriforma, roma, laterza, 1978.
doni 2004A.f. doni, Pitture del doni academico pellegri-no, a cura di s. Maffei, napoli, la stanza delle scritture, 2004.
frey 1923-1940K. frey (a cura di), der literarische nachlass Giorgio vasaris, 3 voll., München, Müller, 1923-1940.
giusti 1857 c. giusti a cura di, la cupola di santa Maria del Fiore: illustrata con i documenti dell’archi-vio dell’opera secolare; saggio di una compiu-ta illustrazione dell’opera secolare e del Tempio di santa Maria del Fiore, firenze, Barbèra, Bianchi & co., 1857.
Pierguidi 2007s. Pierguidi, Baccio Baldini e la «mascherata della genealogia degli dei», «zeitschrift für Kunstgeschichte», 70, 2007, pp. 347-64.
redig de campos 1964d. redig de campos, il Giudizio universale di Michelangelo, Milano, Martello, 1964.
ripa 1593c. ripa, iconologia, roma, heredi di gio. gigliotti, 1593
BiBliogrAfiA
stefano Pierguidi
88
scorza 1981r.A. scorza, vincenzo Borghini and invenzi-one: the Florentine apparato of 1565, «Journal of the Warburg and courtauld institutes», 44, 1981, pp. 57-75.
scorza 1987r.A. scorza, vincenzo Borghini (1515-1589) as iconographic adviser, Ph.diss., university of london, Warburg institute, 1987.
Vasari 1906g. Vasari, le opere di Giorgio vasari: con nuo-ve annotazioni e commenti di Gaetano Milane-si, 9 voll., firenze, sansoni, 1906.
Verdon 1996t. Verdon (a cura di), l’uomo in cielo: il pro-gramma pittorico della cupola di santa Maria del Fiore; teologia ed iconografia a confronto, atti del simposio internazionale di firenze (18 ottobre 1995), Bologna, edizioni de-honiane Bologna, 1996.
Abstract
il programma iconografico stilato da Vincenzio Borghini per il giudizio universale che gior-gio Vasari doveva affrescare nella cupola di santa Maria del fiore a firenze prevedeva, per la fascia più bassa del settore est (liturgicamente il più importante), la raffigurazione di per-sonificazioni allegoriche quali la natura, il tempo e la Morte. si trattava di un particolare estraneo alla tradizione iconografica di quel tema, per il quale Borghini potrebbe essersi ispirato al dies irae e alla lettera che Pietro Aretino scrisse a Michelangelo Buonarroti nel settembre 1537 per suggerirgli temi da raffigurare nel giudizio universale che egli stava per affrescare nella cappella sistina. federico zuccari, che terminò gli affreschi di santa Maria del fiore dopo la morte di Vasari, raffigurò poi quel gruppo allegorico tenendo anche conto di un’altra fonte testuale, le Pitture di Anton francesco doni.
according to the iconographic program devised by vincenzio Borghini for the last Judgment that Giorgio vasari would paint inside the dome of Florence Cathedral, the lower part of the eastern section (the most important liturgically) was intended to show an allegorical group with personifications such as nature, Time and death. This was something new in the iconographic tradition of that theme, for which Borghini may have drawn on the dies irae or on the letter written by Pietro aretino to Michelangelo Buonarroti in september 1537 to suggest some themes to be represented in the last Judgment Michel-angelo was about to paint in the sistine Chapel. Federico zuccari, who finished the frescoes in santa Ma-ria del Fiore after vasari’s death, referred also to another literary source, anton Francesco doni’s Pitture, for his depiction of the allegorical group.