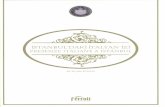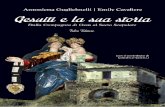-La superficie liscia delle cose. Collezioni e presenze maioliche rinascimentali a Pistoia ed in...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of -La superficie liscia delle cose. Collezioni e presenze maioliche rinascimentali a Pistoia ed in...
Gabriele Marangoni
LA SUPERFICIE LISCIA DELLE COSE.
COLLEZIONI E PRESENZE MAIOLICHE RINASCIMENTALI IN PISTOIA E NELLA VALDINIEVOLE
Lontani da centri di produzione ceramica privilegiati (Faenza, Deruta, Casteldurante, Savona,
Montelupo), i territori dell’alta Toscana occidentale sono rimasti fuori dalla ricerca ceramologica colta,
affidando la sistemazione e lo studio dei materiali lì conservati quasi esclusivamente all’attività
archeologica. Nei territori di Lucca e Pistoia sono invece presenti numerose realtà: musei di diversa
natura e dimensione, piccole raccolte (sia pubbliche, sia private), depositi di materiale di scavo. Si
tratta per lo più di realtà poco o affatto studiate, sia nelle singole specificità, sia come strutture
articolate. Come altre branche delle cosiddette “arti minori”, e forse anche più' delle altre, lo studio
delle sopravvivenze ceramiche permette di fotografare percorsi ed abitudini, o almeno contribuisce in
larga scala a ricostruire, con buona approssimazione, le vicende economiche e culturali di realtà
complesse (intese in senso lato come aree territoriali, oppure nello specifico di singoli personaggi
storici o gruppi familiari), anche, proprio, per l’ampia differenziazione (in termini di qualità e di costo
economico) che caratterizza la realizzazione e la diffusione di questi manufatti. Accanto a produzioni
artistiche correnti si trovano infatti con estrema facilità veri e propri capolavori, soprattutto là dove
condizioni favorevoli di committenza lo hanno permesso. Proprio per la natura e l’utilizzo dei prodotti
ceramici, la proliferazione e la commercializzazione degli oggetti non sottostanno ad ambiti territoriali
stretti e non seguono percorsi consimili: a produzione locale non corrisponde necessariamente
diffusione locale (primaria diretta, o secondaria, ovvero dovuta al commercio postumo ed al
collezionismo) e lo studio dei manufatti derivanti da un determinato ambito produttivo deve essere
condotto su larga scala. È quindi necessario, come si evince da quanto detto fino a qui, compiere
ricerche a tappeto su territori differenziati, sì da contribuire, ognuno con singoli apporti, al dibattito
generale sulla storia e sulle caratteristiche della produzione ceramica italiana.
Una piccola precisazione, solo per evitare a priori inutili fraintendimenti: da qualche decennio a questa
parte convivono all’interno dello stesso percorso disciplinare approcci metodologici diversi, che fanno
capo rispettivamente alla pratica archeologica da una parte ed alla ricerca storica e storico artistica
dall’altra: in un caso si cerca di ricondurre il reperto fisico ad un sistema di relazioni inedite venutesi a
creare nel momento di suo occultamento materiale, dall’altra si cerca di contestualizzare lo stesso nel
periodo storico che lo ha prodotto.
Se fino a non molto tempo fa la divisione, di per se netta sia dal punto di vista metodologico sia da
quello degli obiettivi e delle finalità, tra “archeologia” e “storia delle arti” faceva riferimento anche a
campi di indagine cronologicamente differenziati (dalla tarda antichità ai periodi precedenti territorio di
indagine archeologica; dal medioevo in poi campo di ricerca degli storici e degli storici dell’arte; alto
medioevo e periodo bizantino/paleocristiano/barbarico territorio borderline senza particolari invasioni
di campo), la nascita improvvisa di discipline quali l’”archeologia medievale” , l’”archeologia
industriale” e di altre vari percorsi di ricerca che si avvalgono di questo aggettivo, hanno posto
problemi di convivenza e di competenza non sempre portate ad una soluzione accettabile e che hanno
minato fortemente l’identità della pratica archeologia stessa.
Lo studio dei reperti ceramici medievali e post medievali, proprio perché oggetti provenienti in molti
casi da campagne di scavo è diventato elemento di scontro, più che di scambio, tra approcci
metodologici diversi e le conseguenze sul piano del dibattito scientifico e della fruizione dei reperti
stessi sono particolarmente evidenti.
L’oggetto artistico, mai solo prodotto estetico, bensì oggetto fisico e tangibile, è documento diretto
della cultura che lo ha prodotto, elemento intelligibile che documenta non solo l’abilità ma anche
l’insieme di conoscenze tecniche di chi lo ha realizzato e di chi lo ha utilizzato, attraverso la propria
fisicità materiale; è oltremodo utile riferimento ed elemento di confronto con gli altri prodotti artistici-
materiali-estetici-culturali dell’ambiente storico culturale in cui il manufatto è stato concepito,
realizzato, utilizzato e fruito.
Lo studio dell’oggetto ceramico, sia esso un singolo frammento piuttosto che un elemento
perfettamente conservato, un prodotto di alta qualità ed alta committenza oppure una semplice terraglia
d’uso, contribuisce ad apportare dati specifici e preziosi al dibattito scientifico sulla identità delle varie
epoche, anche e non di meno, attraverso utili confronti con altri prodotti estetici coevi, lo studio degli
elementi decorativi, la riproposizione di temi figurativi mutuati da un ambito produttivo ad un altro (si
pensi a quanto è utile lo studio delle maioliche istoriate nella ricerca sulla pittura rinascimentale italiana
per il continuo scambio di temi e soluzioni). Molti oggetti ci sono pervenuti integri, altri, hanno subito
un destino di sfortuna fisica che ne ha impedito la conservazione o la fruizione per un certo periodo
della propria esistenza. Questo è il caso dei cosiddetti reperti archeologici, oggetti cioè che per motivi
diversi sono stati “nascosti” (interrati per motivi naturali, o riutilizzati come materiale di riempimento
per l’edilizia, o buttati in guasti e in pozzi di gittata, come smaltimento) e recuperati con, riconosciamo,
estrema maestria e competenza dai moderni archeologi. Il problema è che una volta recuperato,
l’oggetto occultato, in mano all’archeologo ormai diventato anche studioso/catalogatore/sistematore
oltre la pratica di scavo, smette di essere un oggetto estetico-culturale- materiale per diventare un
“oggetto archeologico”, cioè un reperto non più materialmente celato ma virtualmente celato
(conservando anche dopo il rinvenimento le condizioni in cui l’oggetto si trovava quando era sotto
terra), singolo componente di uno scavo compiuto, privilegiando ed assolutizzando il periodo di
occultamento materiale dell’oggetto rispetto a quello di sua produzione fisica ed estetica. Tutto ciò
nella pratica esegetica del documento figurativo-materiale costituisce di per sé un fraintendimento ed
una aberrazione. La sfortuna fisica dell’oggetto non può in alcun modo alterare , mutare o cambiare
l’identità dell’oggetto stesso perché non ha conseguenze retroattive ed il sistema di relazioni reciproche
con altri reperti provenienti da uno stesso scavo non è necessariamente elemento di pertinenza
esegetica. Questa convivenza/scontro tra competenze metodologiche differenti ha come conseguenza
diretta, da una parte il fatto che i reperti archeologici difficilmente riescono ad essere studiati anche
dagli storici dell’arte per tutta una serie di problematiche pratiche e burocratiche su cui non ci andiamo
a dilungare, ma, soprattutto, vengono esposti nei musei come oggetti di scavo, ricostruendo e
sottolineando le relazioni con gli altri oggetti pertinenti allo scavo di provenienza e non con gli
elementi culturali dell’ambito produttivo di appartenenza: se un oggetto ceramico realizzato in Liguria
nel secolo XVI viene rinvenuto in fase di scavo insieme a prodotti montelupini del Quattrocento non
diventa esso stesso oggetto toscano rinascimentale (la “Trinità” di Masaccio nella chiesa di Santa Maria
Novella in Firenze diventa automaticamente prodotto figurativo Trecentesco perché fisicamente
accanto ad un Crocifisso di Giotto? Le relazioni di “vicinanza”, “contatto”, “presenza” sono davvero
così legittime? Veramente tra ciò che troviamo sotto terra e ciò che avviene in superficie possono
esistere regole così diverse e in molti casi opposte? Lo studio di un manufatto si esaurisce realmente
nella registrazione meramente classificatoria della sua forma e nella annotazione della sua fortuna
fisica?), ci sarà invece da porsi dei problemi sulla pertinenza degli oggetti che compongono lo scavo in
generale, o di quella specifica stratigrafia ed anche sulla opportunità di studiare (cioè ricollocare
l’oggetto nell’ambito produttivo-culturale suo proprio) seguendo percorsi di indagine, conservazione ed
esposizione differenziati.
La ricerca sul territorio ha portato ad individuare alcuni nuclei di raccolta di reperti ceramici, sia
pubblici, sia privati, differenziati per tipologia museale (musei comunali, musei civici, raccolte
ecclesiastiche, etc), per tipologia dei pezzi esposti (reperti di scavo, opere provenienti da collezionismo
o mercato antiquario), accessibilità (musei aperti tutto l’anno; aperti solo in determinati periodi; aperti
solo su richiesta;raccolte private) criteri di esposizione e conservazione (inserimento dei pezzi nel
percorso museale, conservazione in deposito; divisione delle vetrine in aree tematiche, semplice
esposizione non ragionata dei pezzi; presenza o assenza e natura di apparati informativi e didascalici).
In tutti i casi, ad eccezione di uno, si tratta di realtà estranee all’ambito ecclesiastico, sia come carattere
giuridico della raccolta, sia come provenienza dei pezzi: le sopravvivenze di maiolica conventuale sono
rare e sporadiche e probabilmente provenienti da collezionismo privato o mercato antiquario
(dovrebbero, in questo senso, fare eccezione le due ciotole cat. nn°35 e 36 del museo di Larciano,
provenienti da scavo). Il rinvenimento di raccolte private o di singoli oggetti in proprietà privata è
molto difficile, sia perché non esiste una schedatura relativa agli oggetti artistici privati, sia per la
diffidenza da parte dei proprietari nel far conoscere i pezzi in loro possesso; alcune raccolte si sono
dovute escludere dalla ricerca proprio per questo motivo. Per quanto riguarda la conservazione dei
pezzi il panorama a noi postoci davanti è stato vario e variegato. Il Museo Civico di Pistoia non espone
pezzi di scavo, bensì unicamente oggetti provenienti da collezioni preesistenti, perfettamente integri
(qualche sbreccatura, sbocconcellatura o caduta di smalto; diviso in due frammenti e ricomposto solo il
catino scheda cat n° 24), così come il Museo Civico di Pescia (anche qui, unica eccezione è una piccola
ciotola recentemente rinvenuta durante i lavori di restauro del Palazzo Galeotti, ove il museo è ospitato;
inedita, non esposta e fuori nostro catalogo, che riteniamo, a prima vista, ascrivibile ad officina
montelupina degli anni ’90 del Quattrocento). Rispetto alle poche risorse monetarie a disposizione ed
al limitato afflusso di visitatori, l’ostinazione a tenere aperte queste realtà e il rigore con cui sono state
ordinate è da ritenersi fatto estremamente positivo. Per la maggior parte dei casi si tratta infatti di
piccole raccolte tematiche ospitate in piccoli paesi, lontani dai percorsi turistici ed in cui non si paga
alcun biglietto di ingresso (un piatto ad imitazione del lustro può essere più interessante della Gioconda
per uno studioso specializzato, non per il turismo di massa). Più in generale l’utenza che fruisce queste
piccole collezioni, per lo più comunali, è da riconoscersi in scolaresche locali (soprattutto elementari e
medie) e pochi turisti estivi. Si è visto che in alcuni casi, proprio per questo motivo, gran parte della
progettazione museografica si è orientata verso la messa in opera di ampi apparati didascalici e
informativi (cartelloni esplicativi o di confronto, con foto e spiegazioni in linguaggio semplice ed
elementare) più che nella valorizzazione degli oggetti ceramici esposti (come singole unità o come
gruppi significanti).Se in letteratura, la ricerca relativa alle discipline museografiche e museologiche ha
codificato e promosso tipologie museali consimili (si pensi soprattutto agli anni ’80 ed ai tentativi di
importare in Europa le esperienze americane dei musei scientifici e dei Please Touch Museum), la forte
didascalicità di queste piccole esposizioni toscane (non si guardi solo il caso di Pistoia ma anche del
vicino territorio lucchese) è da imputarsi a fattori pratici, più che ad una impostazione teorica
consapevole e programmatica. A questa tipologia espositiva appartengono soprattutto il Museo
Archeologico di Larciano, quello di Scienze ed Archeologia della Valdinievole in Pescia (almeno nelle
intenzioni). Il museo Civico di Pescia invece utilizza criteri espositivi molto empirici: le due fiasche
faentine (cat. n°25 e n°26) e l’albarello montelupino a foglie luce/ombra d’azzurro (cat. n°27) sono
semplicemente appoggiati su mobili posizionati lungo il percorso espositivo, senza protezioni, vetri e
didascalie invadenti (la parte del piccolo museo in cui sono esposti i nostri reperti è concepita in forma
di abitazione ottocentesca, con carta da parati in broccato amaranto e tendaggi di velluto porpora,
quadri alle pareti e mobili); tutti gli altri pezzi sono raggruppati a mucchio sopra ad un tavolino in
un’altra stanza, coperti da una teca in vetro. Similmente, i pezzi conservati nel Museo Rospigliosi di
Pistoia sono appoggiati, divisi in due gruppi, sopra i mobili esposti nel museo, con la sola differenza
che in questo secondo caso i cordoli che segnano il percorso impediscano ai visitatori di avvicinarsi ai
manufatti. Il Museo Civico di Pistoia deve, anche in questo caso, essere considerato vicenda a parte:
qui la collezione di maioliche Cinque-settecentesche è esposta all’interno di belle vetrine progettate ad
hoc, rivestite in velluto scuro ed illuminate ad effetto: Si tratta di contenitori quadrangolari a forte
sviluppo orizzontale, con triplo vetro a scorrimento sul fronte e struttura a doppio scalino all’interno
(che permette una esposizione regolare dei pezzi in file ordinate); illuminazione interna (assenza di luci
all’esterno puntate sui vetri) e velluto alla base per evitare riverberi e riflessi fastidiosi. Una sezione
ben ordinata di maioliche ottocentesche (fuori nostro catalogo) si trova in un’altra stanza in due
semplici vetrine trasparenti a più scaffali, appese al muro. Dal punto di vista museologico, più che
museografico, la formazione dei gruppi tipologici e la distribuzione dei pezzi all’interno degli
espositori potrebbe necessitare di piccole rivisitazioni (essendo l’attuale esposizione basata su una
campagna di studio oramai datata e mai più arricchita in contributi). Attualmente non esiste alcuno
studio sistematico generale sulla produzione ceramica nelle aree indagate ne’ sulle raccolte di
ceramiche li presenti. Il museo di Larciano non ha un catalogo delle collezioni, ma pubblicazioni di dati
relativi agli scavi redatti secondo criteri di tipo archeologico, poco utili alla ricerca storico artistica.i Per
quanto riguarda il Museo Civico di Pescia, non solo non esiste un catalogo del museo, ma anche gli atti
del convegno relativo alla sua fondazione ottocentesca ed ai suoi primi decenni di storia non sono
affatto utili alla nostra ricerca, così specifica.ii Il Museo Civico di Pistoia ha un catalogo delle
collezioni ben curato e molto ben fatto, purtroppo datato e bisognoso di aggiornamento.iii
Gli oggetti
ceramici sono schedati uno ad uno e corredati di foto. I nuclei di raccolta individuati sul territorio e qui
indagati sono i seguenti:
Museo Civico di Pistoia: grande e significativo museo ospitato all’interno del Palazzo del Comune,
nella piazza principale di Pistoia; museo Comunale; raccoglie importanti pitture e sculture dal secolo
XIII al secolo XX; nuclei di maioliche, vetri e abiti. Corredato di catalogo.
Museo Clemente Rospigliosi di Pistoia: ospitato all’interno del Palazzo Rospigliosi, unitamente al
Museo Diocesano, nelle immediate vicinanze del Duomo; museo tematico di grande interesse culturale
di pertinenza diocesana; raccoglie importanti oggetti e arredi posteriori al secolo XVI. Privo di
catalogo.
Museo Civico di Pescia (Pistoia): ospitato all’interno di Palazzo Galeotti, nel centro abitato di Pescia;
museo comunale; raccoglie pale fondo oro, tele, sculture, mobili, suppellettili; fondato alla fine del
secolo XIX su di un nucleo originale di pezzi ed arricchito in seguito da numerose donazioni di privati
ed oggetti in deposito dalla Soprintendenza fiorentina; non ha un catalogo delle collezioni; attualmente
chiuso.
Museo di Scienze ed Archeologia della Valdinievole , Pescia (Pistoia): museo didattico che raccoglie
reperti geologici ed archeologici (soprattutto di epoca preistorica), animali impagliati, ricostruzioni
didattiche in gran numero e frammenti ceramici raccolti durante campagne di scavo locali;museo
comunale; non esiste un catalogo delle collezioni; i frammenti di scavo esposti nel museo non sono
stati catalogati perché non ci è stato concesso il permesso di fare ricerca all’interno della struttura.
Museo Archeologico e del Territorio, Larciano (Pistoia): All’interno del castello di Larciano; museo
comunale; ospita i reperti di scavo (dall’epoca romana al secolo scorso) rinvenuti durante le campagne
di indagine messe in opera nei territori della Valdinievole orientale negli ultimi decenni; non ha un
catalogo delle collezioni.
Per ogni nucleo di raccolta è stata fatta una scelta dei reperti da schedare, data l’altissima quantità di
materiale rinvenuto: in questo caso si sono escluse tutte le (numerose) sopravvivenze ceramiche
medievali, extraitaliane, e, tranne per rari casi, ceramiche ingobbiate e maioliche posteriori alla fine del
secolo XVIII.
Come modello di schedatura degli oggetti si è utilizzato quanto proposto in C. RAVANELLI
GUIDOTTI Ceramiche datate dal XV al XIV secolo, con una scheda critica rapportabile ad ogni
singola unità di catalogo, composta da una prima, sintetica, definizione dell’oggetto (misure, tecnica,
attribuzione, datazione); una descrizione generale del manufatto e dei pigmenti utilizzati; un apparato
critico (che permette di confrontare e dati relativi allo studio dell’oggetto con quanto presente in
letteratura); note relative alla conservazione; eventuali notizie relative alla provenienza o alla
acquisizione; bibliografia specifica. Per quanto riguarda la conservazione abbiamo inteso per
frammento la singola parte, libera su tutti i lati ed isolabile dal contesto, di un oggetto preesistente;
frammentato, un oggetto rotto o diviso in più elementi e le cui unità componenti sono state riaccostate
sì da ricomporre la forma originaria nella sua interezza e totalità; frammentario o frammentario
lacunoso, una unità compositiva divisa in più elementi dai quali, per distruzione o dispersione, non è
più possibile ottenere un intero completo. Il termine “non rilevato” (dimensioni, marchi e siglature) sta
ad indicare che, non avendo avuto la possibilità di accedere direttamente all’oggetto (è il caso dei
reperti chiusi all’interno di vetrine che non ci è stato possibile aprire, per vari motivi), non si è avuto
modo di riportare dati relativi: si tratta di un “non dato” non di un dato di negazione.
01 Catino
Museo civico, Pistoia;diametro cm 59;Manifattura toscana, 1604 (datato)
Descrizione: Catino rotondo con piccoli manici; tesa leggermente inclinata e decorata da una fascia a
chele di granchio (ingobbio bianco graffito a stecca) tra due campiture cordonate. Nel tondino un santo
stante, graffito, regge un cartiglio con la mano sinistra mentre la mano opposta è impegnata nell’atto di
benedire. La corta tunica del santo è brevemente campita da un tono blu zaffera. Una fascia lineare
contorna il cavetto con una iscrizione graffita in lettere capitali.
Apparato critico:Tipico prodotto della produzione toscana ad ingobbio graffito a stecca, con la
variante nell’impiego del cobalto, per ingentilire l’elemento figurativo riportato nel tondino. Prodotto, e
diffuso, soprattutto in area pisano-lucchese questo tipo di manufatti ceramici caratterizzati da decori
a“chele di granchio” (che ricordano in parte i bianchi girari
impiegati in altre produzioni figurative a partire dal secolo XIV) è presente fin dal Quattrocento sia in
prodotti di fattura corrente, sia in pezzi contraddistinti da grande qualità esecutiva, come nel caso qui
esaminato. La scheda di catalogo del museo Civico relativa a questo pezzo (scheda 24 pag 237) lo cita
come “uscito da una manifattura pistoiese”, senza specificare elementi comprovanti tale affermazione.
Si confronti anche scheda cat. n°51.
Conservazione: Incrinato. Perdita dello strato superficiale di ingobbio soprattutto nella
parte superiore della tesa e in alcuni punti dell’iscrizione
Iscrizioni: CELERIA DELLE MONACHE DI SAN GIOVANNI DI PISTOIA M604
Marchi o firme: //
Provenienza e acquisizione:Proviene dal Convento di San Giovanni Battista di Pistoia, così come
riporta l’iscrizione nel cavetto. Già presente nell’inventario del Museo del 1935.
Bibliografia:M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
02 Crespina Museo civico, Pistoia; diametro cm27 ; altezza cm 8; Manifattura faentina (Utili? Calamelli?), secolo
XVI, fine
Descrizione: Crespina circolare sagomata a rilievo, sbocconcellata e decorata con forme di conchiglia
impresse intorno al cavetto; bordo smerlato, piede circolare. Uno strato di smalto bianco ricopre il
manufatto nella sua intierezza. Decorata con un fregio compendiario di giallo e d’azzurro lungo il
bordo esterno, in forma di fiori, fogliame pendente e spirali, nella maniera più classica della produzione
faentina sul finire del Cinquecento. Una breve sottolineatura del bordo del cavetto è ottenuta
accennando virgolature di giallo a mo’ di fascia. Al centro, un amorino alato in blu cobalto, accasciato
sopra una nuvola, con la testa voltata nel lato opposto. In giallo la parte superiore delle ali, il laccio
posto a tracolla e la parte posteriore della nuvola.
Apparato critico:Prodotto tipico, in stile compendiario, delle botteghe faentine della fine del
Cinquecento, questo pezzo si contraddistingue per il valore della lavorazione che dimostra un alto
indice di qualità sia nella fase di confezionamento, sia nella invetriatura (che non presenta difetti nel
recto come nel verso) ed infine, sia nella decorazione pittorica, condotta con grande accuratezza
nonostante il carattere seriale di questo tipo di produzione. La provenienza dalla bottega Utili è molto
probabile ma non ci sentiamo di escludere a priori un avvicinamento alla produzione della bottega
Calamelli.
Conservazione:Ottima
Iscrizioni//
Marchi o firme:Sul verso, all’interno del piede, sono applicate etichette adesive relative a precedenti
campagne di catalogazione degli oggetti del museo che non permettono di rilevare la presenza di firme
o marchi in quella sede
Provenienza e acquisizione:Presente tra gli oggetti del museo già'88 nella catalogazione del 1935
Bibliografia:M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
03 Crespina Museo civico, Pistoia; diametro cm25 ; altezza cm 5,5; Manifattura faentina, secolo XVI, fine
Descrizione: Crespina circolare sagomata a rilievo, baccellata a raggiera; bordo smerlato, piede
circolare; uno strato di smalto bianco copre il manufatto nella sua intierezza. Decorata nei toni del
cobalto, del manganese e del giallo antimonio con un amorino stante e danzante, voltato all’indietro
mentre sorregge un volatile con la mano destra, nel centro del tondino. Una fascia corrente di spirali
color manganese ed oculi illuminati di giallo corre lungo tutto il bordo esterno intorno ad una brave e
sottile modanatura lineare, anch’essa nei toni del manganese.
Apparato critico: Tipico prodotto faentino, in stile compendiario, della fine del Cinquecento di fattura
seriale. Il motivo decorativo dell’amorino stante è qui proposto nella versione più' tarda in cui la mano
del raffigurato è impegnata nello stringere un elemento decorativo, in questo caso un volatile. La fascia
decorativa esterna a spirali correnti (foglie stilizzate) ed oculi alternati di giallo (bacche) è elemento
comune e variamente ripetuto in questo tipo di produzione tanto che se ne segnala la presenza in altri
pezzi conservati nello stesso museo(vedi schede n°4 e n°5).
Conservazione:Rottura del piede; lievi abrasioni sull’orlo.
Iscrizioni //
Marchi o firme: Sul verso, all’interno del piede, sono applicate etichette adesive, relative a precedenti
campagne di catalogazione degli oggetti del museo, che non permettono di rilevare la presenza di firme
o marchi in quella sede.
Provenienza e acquisizione: Presente tra gli oggetti del museo già'88 nella catalogazione del 1935
Bibliografia: M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
04 Crespina Museo civico, Pistoia; diametro cm24 ; altezza cm 6; Manifattura faentina, secolo XVI, fine
Descrizione: Crespina circolare sagomata a rilievo, baccellata a petalo; bordo smerlato, piede circolare;
uno strato di smalto bianco copre il manufatto nella sua intierezza. Decorata nei toni del cobalto,
dell’arancio e del giallo antimonio con un amorino stante e armato, voltato all’indietro, nel centro del
tondino;uno scudo nella mano sinistra mentre il braccio opposto è alzato ed espone un pugnale con la
lama verso l’alto. Una fascia corrente di spirali color arancio ed oculi illuminati di giallo corre lungo
tutto il bordo esterno intorno ad una breve e sottile modanatura lineare, anch’essa di toni ferrosi.
Apparato critico: Tipico prodotto faentino, in stile compendiario, della fine del Cinquecento di fattura
seriale ma di ottima qualità' esecutiva. Il motivo decorativo dell’amorino stante è qui proposto nella
variante “scherzosa” del portatore di armi. La fascia decorativa esterna a spirali correnti (foglie
stilizzate) e bacche segnate di giallo è elemento comune e variamente ripetuto in questo tipo di
produzione tanto che se ne segnala la presenza in altri pezzi conservati nello stesso museo (vedi
schede n°3 e n°5).
Conservazione:Lievi abrasioni sull’orlo.
Iscrizioni //
Marchi o firme Non rilevati
Provenienza e acquisizione: Presente tra gli oggetti del museo già'88 nella catalogazione del 1935
Bibliografia: M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
05 Crespina Museo civico, Pistoia;diametro cm26 ; altezza cm 7; Manifattura faentina, secolo XVI, fine
Descrizione: Crespina circolare sagomata a rilievo, baccellata a raggiera; bordo leggermente smerlato,
piede circolare; uno strato di smalto bianco copre il manufatto nella sua intierezza. Decorata nei toni
del cobalto, dell’arancio, del giallo antimonio e del verde ramina, con una raffigurazione di Santa
Caterina nel centro del tondino; una palma del martirio in verde nella mano sinistra, mentre il braccio
opposto, piegato al corpo, stringe una piccola ruota dentata. Una fascia corrente di spirali color arancio
ed oculi illuminati di giallo corre lungo tutto il bordo esterno intorno ad una breve e sottile modanatura
lineare, anch’essa nei toni ferrosi.
Apparato critico: Tipico prodotto faentino, in stile compendiario, della fine del
Cinquecento di fattura seriale; media qualità esecutiva ma ricchezza
nella policromia. La presenza di una figura di Santa farebbe pensare
ad una committenza di tipo conventuale. La fascia decorativa esterna
a spirali correnti (foglie stilizzate) e bacche segnate di giallo è
elemento comune e variamente ripetuto in questo tipo di produzione
tanto che se ne segnala la presenza in altri pezzi conservati nello
stesso museo (vedi schede n°3 e n°4). Un manufatto simile è stato
battuto all’asta da Rubinacci il 28 novembre 1996; si confronti anche
Victoria and Albert Museum pag. 166.
Conservazione:
Lievi abrasioni sull’orlo.
Iscrizioni//
Marchi o firme:Non rilevate
Provenienza e acquisizione:Presente tra gli oggetti del museo già'88 nella catalogazione del 1935
Bibliografia:M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
06 Crespina Museo civico, Pistoia; diametro cm27 ; altezza cm 8; Manifattura faentina (Bottega Utili), secolo XVI
Descrizione: Crespina circolare sagomata a rilievo, baccellata a raggiera ed umbonata al centro; bordo
elegantemente smerlato, piede circolare. Uno strato di smalto bianco ricopre il manufatto nella sua
intierezza. Decorata con un ampio ed elegante fregio compendiario, di giallo e d’azzurro lungo il bordo
esterno, in forma di fiori, fogliame pendente e spirali nella maniera più classica della produzione
faentina sul finire del Cinquecento (si veda anche l’esemplare cat. N° 2 conservato nello stesso museo).
Al centro un amorino alato, stante, in blu cobalto, che stringe un elemento vegetale nella mano destra.
In giallo la parte superiore delle ali, del capo e parte della breve notazione paesaggistica che funge da
appoggio alla figura.
Apparato critico: Prodotto tipico, in stile compendiario, delle botteghe faentine della fine del
Cinquecento, questo pezzo si contraddistingue per l’alta qualità della decorazione pittorica, condotta
con grande accuratezza nonostante il carattere seriale di questo tipo di produzione. Molto elegante la
cornice floreale, qui condotta con andamento più sinuoso del solito e con una ampiezza maggiore e,
soprattutto l’andamento liquido e sicuro delle pennellate che contornano la figurina al centro. La
provenienza dalla bottega Utili è molto probabile. Attualmente è attribuita (catalogo del Museo , n°29,
pag 239 ) ad ambito derutese.
Conservazione: Buona, piccole abrasioni in prossimità del bordo esterno
Iscrizioni //
Marchi o firme Non rilevate
Provenienza e acquisizione: Presente tra gli oggetti del museo già'88 nella catalogazione del 1935
Bibliografia: M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
07 Boccale Museo civico, Pistoia; altezza cm 18; Manifattura di Montelupo, secolo XVI
Descrizione: Boccale ansato di forma globulare e collo rialzato decorato con monogramma
bernardiniano nei toni del giallo, dell’arancio, del manganese e del cobalto; fasciato lungo il bordo in
giallo e bruno (disposti in campiture nastriformi lisce e parallele) e striato di verde ramina sul manico.
La raggiera bernardiniana è realizzata in blu cobalto mentre il monogramma è del tono del bruno in
campo giallo fasciato di arancione.
Apparato critico: Oggetto di uso comune, per quanto elegante nella forma, di probabile provenienza
conventuale. Non presenta elementi figurali oltre ai simboli stilizzati ed alle decorazioni a fascia.
Conservazione: Sbreccature lungo l’orlo superiore.
Iscrizioni YHS sormontato da una croce, al centro della raggiera.
Marchi o firme Lettera “B” maiuscola sotto il manico. Nella scheda relativa all’oggetto, all’interno del
catalogo del museo (n° 33, pag 240) si collega la lettera “B” con quella di un altro boccale conservato
in collezione privata fiorentina.
Provenienza e acquisizione: //
Bibliografia: M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
08-09 serie di due piattini Museo civico, Pistoia; diametro cm20,5 e cm 16; Manifattura di Montelupo, secolo XVII seconda metà.
Descrizione: Serie di due piattini circolar,i caratterizzati da una decorazione a foglie di vite (di grandi
dimensioni) disposte a raggiera intorno ad un elemento a spirale posto al centro della composizione.
Nell’esemplare cat. N° 8 quattro foglie nei toni della ramina, stesa con consistenza acquosa, e
contornate di bruno, sono disposte secondo uno schema cruciforme intorno ad una spirale di color
giallo aranciato; nell’altro esemplare le foglie di vite sono in numero di tre, di dimensioni maggiori,
mentre la spirale centrale di color giallo aranciato è inserita all’interno di un disco color cobalto. In
entrambi i casi l’intera superficie del piatto è caratterizzata da toccature di cobalto e di manganese
(quest’ultimo in particolare per tracciare i contorni) e presentano in prossimità del bordo esterno
accenno a foglie poste al di fuori del campo figurato.
Apparato critico: Piatti del genere a “foglia verde” nella variante con piccola spirale centrale. Si
confrontino Donazione Galeazzo Cora scheda 643 e scheda 644; C. RAVANELLI GUIDOTTI
Ceramiche datate dal XV al XIX secolo pagg. 146 – 147 ; F. BERTI 1997 pagg. 214, 215 e
pag. 397. Stretta relazione con l’esemplare conservato presso il Museo del vino di Forgiano.
Conservazione: Buono l’esemplare cat. n° 8; abbondanti abrasioni localizzate sul bordo dell’altro
esemplare.
Iscrizioni //
Marchi o firme Sigla “IF” incisa sul fondo dell’esemplare cat. n° 8. La stessa sigla è, similmente,
presente sul fondo esterno degli esemplari cat. n° 10, n°11 e n° 12. Non compare invece in BERTI
1997, regesto dei marchi di fabbrica delle manifatture di Montelupo.
Provenienza e acquisizione://
Bibliografia:M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
10- 11- 12- 13 Serie di quattro piatti Museo civico, Pistoia; diametro cm21,5 ; altezza cm 3- diametro cm21 ; altezza cm 3- diametro cm22,4
; altezza cm 4- diametro cm18 ; altezza cm 4,5; Manifattura di Montelupo, secolo XVI
Descrizione:Serie di quattro piatti caratterizzati dalla più tipica tra le decorazioni non figurali del
Seicento montelupino, la raggiera di spirali, qui interpretata in forma di sequenza dinamica di elementi
lineari curvilinei e rigature, disposti a raggiera intorno ad un elemento spiraliforme situato al centro
della composizione. L’andamento direzionale della spirale centrale è lo stesso secondo il quale si
rincorrono i moduli decorativi posti all’esterno. L’ampia superficie del piatto è interamente
dipinta da giochi lineari di segmenti (sia curvilinei sia diritti) disposti parallelamente tra di loro sì da
creare un modulo che è stato poi fatto ruotare attorno ad un punto centrale. Elemento caratterizzante
questo tipo di composizione è la grande dinamicità degli elementi strutturali che si inseguono sulla
superficie del piatto in questa disposizione a girandola ed il forte contrasto tra i colori vivaci (qui
utilizzati, in piena saturazione, nei toni del giallo, dell’arancio, del manganese e del verde ramina) ed il
bianco di fondo. Il bordo è, in tutti e quattro gli esemplari, dipinto con fasce lineari nel tono del giallo
con sottolineatura in arancio.
Apparato critico: Tipico prodotto montelupino degli inizi del secolo XVII caratterizzata da una
decorazione geometrica non figurale di grande impatto visivo e per questo molto utilizzata tra i
ceramisti locali in questo periodo. L’utilizzo di elementi geometrici e lineari in colori vivaci secondo
andamenti spiraliformi, ma soprattutto l’uso della linea in generale (in tutte le sue varianti:dritta,
curvilinea, spiraliforme, in fasce o gruppi paralleli etc) caratterizza la produzione montelupina non solo
sulla superficie relativamente ampia e regolare di piatti e taglieri ma anche di albarelli e boccali.
Conservazione: Buona. Piccole abrasioni e rotture solo sul bordo.
Iscrizioni //
Marchi o firme Lettere IF incise sul fondo esterno di tre dei quattro esemplari. Le stesse iniziali si
trovano incise, similmente, sul fondo del piatto cat. n° 8).
Provenienza e acquisizione: //
Bibliografia: M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
14 Albarello Museo civico, Pistoia; diametro cm9 ; altezza cm 21; Manifattura di Montelupo, secolo XVII
Descrizione: Albarello decorato a rameggi fogliati e cartiglio vuoto. La decorazione isodoma a
tappezzeria che copre tutta la superficie del manufatto è caratterizzata dalla stilizzazione di foglie
luce/ombra (vedi anche schede cat. nn°27 e 28 ) nei toni del blu su fondo bianco. Il cartiglio è
caratterizzato dai toni del giallo, dell’arancio e del cobalto mentre il risvolto presenta i toni della
ramina.; due linee parallele, in giallo, segnano la superficie del cartiglio. Decorazioni lineari a fasce
parallele nei toni del blu segnano la superficie del manufatto sia nella parte superiore, sia in quella
anteriore, in prossimità della base e dell’imboccatura. Una fascia lineare gialla si trova immediatamente
al di sopra dello spigolo superiore.
Apparato critico: Tipico albarello da farmacia di forma allungata a decorazione in monocromo blu di
racemi vegetali e foglie di vite luce/ombra di consistenza liquida. Due albarelli praticamente identici
sono stati battuti all’asta il 23 novembre 2001 da Christie’s South Kensington. Si confronti anche
orciuolo n° 591 pag. 233 Donazione Galeazzo Cora. Nella scheda relativa all’oggetto, all’interno del
catalogo del Museo (n° 39, pag. 243), si collega lo stesso ad un vaso biansato conservato presso il
Museo del Bargello. Si vedano anche nostre schede cat. n° 27 e n° 28.
Conservazione: Buona. Sbocconcellature sull’orlo superiore.
Iscrizioni //
Marchi o firme Non rilevate.
Provenienza e acquisizione: //
Bibliografia: M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
15 Albarello
Museo civico, Pistoia; diametro cm9,8 ; altezza cm 19,5; Manifattura senese, secolo XVIII primo
quarto
Descrizione: Albarello sagomato con fascia centrale bianca limitata da una doppia profilatura in
cobalto. La parte superiore e quella anteriore alla fascia riportano lo stesso schema decorativo
composto da un grande tulipano giallo ombreggiato di arancione e da foglie liquide e stilizzate di
grandi dimensioni nei toni del cobalto (inferiori) e della ramina; uso del manganese per filettare i
contorni. Pennellate ampie e veloci, pigmenti di consistenza liquida e trasparente. Un fondo bianco
omogeneo copre il manufatto nella sua intierezza.
Apparato critico: La scheda relativa all’oggetto, all’interno del catalogo del museo (n°42, pag. 244),
riporta una attribuzione ad ambito centro italiano del secolo XIX. Riteniamo plausibile un
restringimento dell’ambito produttivo a manifattura senese del primo decennio del secolo XVIII. Il
motivo a tulipano stilizzato, assai raro nella decorazione ceramica conosciuta in letteratura, si ritrova in
un piatto conventuale, datato 1709, del Museo delle Ceramiche di Faenza. Un altro esempio è stato
pubblicato da F. BERTI in Le ceramiche della farmacia di Santa Fina a San Gimignano, albarello fig.
19. Si vedano anche nostre schede di catalogo nn° 21 e 22.
Conservazione: Sbocconcellature alla base e sull’orlo superiore.
Iscrizioni //
Marchi o firme Non rilevati
Provenienza e acquisizione: //
Bibliografia: M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
16 Catino Museo civico, Pistoia; diametro cm25 ; altezza cm 4; Manifattura senese, secolo XVIII primo quarto
Descrizione: Catino circolare sagomato a baccellature e smerlato al bordo; decorato in cobalto con una
doppia fascia di motivi vegetali stilizzati ed archetti e con un paesaggio stilizzato in monocromo
(parimenti in blu, molto intenso) al centro. Profilature sottili in manganese nel paesaggio centrale.
Toccature di blu all’esterno e sul fondo.
Apparato critico: Ceramica conventuale di produzione senese assai tarda, testimoniata da un altro
esemplare pubblicato da Carmen Ravanelli Guidotti in Maioliche italiane. Siena Collezione Chigi
Saracini, 1992 , fig. 33 pag. 35. Si tratta della evoluzione, con inserimento di elemento figurale a paesi
e ispessimento della pennellata nei racemi decorativi, di una tipologia decorativa tipica della
produzione senese ad uso conventuale conosciuta già dalla fine del secolo XVI e testimoniata da
Ravanelli Guidotti 1992 fig. 23 pag. 27 e dai due esemplari esemplari pag. 8 in Antiche maioliche
senesi. Siena Palazzo pubblico: Magazzini del Sale 1988.TAV XI pag.371 in BOJANI 1990.
Conservazione: Incrinato.Sbocconcellato sul bordo e sulle emergenze di maggior rilievo.
Iscrizioni “BO” in lettere capitali color cobalto, al centro del cavetto,immediatamente al di sotto della
campitura figurata
Marchi o firmeSi rileva la presenza di una breve pennellata in tono di blu al centro
della base, all’esterno ma dubitiamo, al momento, possa trattarsi di un marchio di fabbrica.
Provenienza e acquisizione: //
Bibliografia: M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
17 Targa devozionale Museo civico, Pistoia; larghezza cm27 ; altezza cm 32;Manifattura romagnola, secolo XVII fine- XVIII
inizi
Descrizione:Targa devozionale modellata a bassorilievo, rappresentante una sacra famiglia (madonna
velata e coronata che sorregge il bambino e San Giuseppe posto dietro la sua spalla sinistra) entro una
cornice quadrangolare a doppia modanatura. La parte figurata è realizzata nei toni del giallo,
dell’arancio, del cobalto e del manganese (quest’ultimo solo nelle profilature e nei contorni a mo’ di
linea); la cornice è contraddistinta dai toni del cobalto (l’emergenza interna, a contorno
della raffigurazione) della ramina (l’emergenza esterna) e del giallo molto diluito nella depressione
centrale. Tra le mani della Vergine e del Bambino, scapolari carmelitani.
Apparato critico: Targa devozionale di ottima fattura, variata nella policromia e definita nei
particolari più minuti. Grande eleganza nelle fattezze della Vergine. Variazione, con l’inserimento della
figura di San Giuseppe, di un modello compositivo già noto in Emilia ed in Romagna, come si vede
nell’esemplare datato 1638 del Museo Civico di Imola e nell’esemplare Case Lanzi, datata 1729, di
Vidiciatico.
Conservazione: Sbocconcellato nelle emergenze plastiche di maggior rilievo, soprattutto sulla cornice
Iscrizioni //
Marchi o firme Non rilevate
Provenienza e acquisizione: //
Bibliografia: M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
18 Bacinella
Museo civico, Pistoia; diametro cm21,5 ; altezza cm 7: Manifattura Ligure, Savona, secolo XVIII
Descrizione: Bacinella sagomata a baccellature con bordo increspato, interamente figurata. Dipinta nei
toni del blu carico su fondo azzurrino tendente al grigio. Al centro un cherubino immerso in paesaggio
naturale, organizzato in fronde vegetali ed elementi atmosferici che si depositano lungo il bordo
esterno; piccole notazioni paesaggistiche (montagne, colli in degradare) ottenute con pennellate ampie
e veloci di un pigmento diluito che vanno solo a suggerirne la forma.
Apparato critico: Manufatto tra i più tipici della produzione savonese del secolo XVIII; per quanto
riguarda il tema decorativo si confrontino: piatto sagomato n° 1450 battuto all’asta da Rubinacci il 12
dicembre 2002; piatto sagomato n° 50 battuto all’asta da Finante il 15 giugno 1988; grande piatto a tesa
n° 153 battuto all’asta da Finante il 28 novembre 1989; tavola LXXVII in C: BARILE Antiche
ceramiche liguri 1965.
Conservazione: Buona. Leggermente sbocconcellata lungo il bordo
Iscrizioni //
Marchi o firme Marca scudo crociato sul fondo
Provenienza e acquisizione: Già citata nell’inventario del museo del 1946
Bibliografia: M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
19 Bacinella Museo civico, Pistoia; diametro cm24 ; altezza cm 4,5; Manifattura ligure, Savona (Giuseppe
Valenti?) secolo XVIII
Descrizione: Bacinella sagomata a baccellature e smerlata al bordo decorata con tre uccelli (uno,
centrale, raffigurato in volo, gli altri due poggianti a terra) in schema di triangolo, fronde di alberi e
festoni, su fondo bianco. Gli uccelli ed i festoni sono realizzati nei toni del giallo, dell’arancio, del
cobalto e del manganese; Il verde ramina è utilizzato esclusivamente nelle notazioni vegetali. Una
leggera filettatura blu profila il bordo della bacinella, appena sotto l’orlo.
Apparato critico: Tipico prodotto savonese del secolo XVII, con decorazioni ad uccelli e festoni in
ambiente naturale, largamente riproposta dalle botteghe Levantino e Siccardi fino alla fine del secolo.
Si è avuto modo di vedere ( ma non di fotografare ) due bellissimi albarelli, praticamente identici al
nostro, in collezione privata pisana, con siglatura L.L. di Luigi Levantino.Un piatto molto simile è stato
battuto all’asta il 24 marzo 2004 da Rubinacci
Conservazione: Incrinata, sbocconcellature sul bordo. Difetti di cottura (sbollature da untuosità) sul
verso, sia in prossimità dell’orlo, sia sul fondo.
Iscrizioni //
Marchi o firme “V” sul fondo esterno ed una sigla indecifrabile
Provenienza e acquisizione://
Bibliografia:M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
20 Catino Museo civico, Pistoia; diametro cm31 ; altdezza cm 12; Manifattura Ligure, Siccardi, secolo XVIII
Descrizione: Catino sagomato a baccellature e smerlato al bordo interamente figurato nei toni del
cobalto (un tono molto carico, più scuro, ed uno in diluizione, con distinzione molto netta) con tre
caprioli che saltano in un paesaggio naturale e paesi. La posizione delle fronde vegetali e gli elementi
atmosferici segue il profilo del bordo.
Apparato critico: Si confronti piatto collezione Vittorio Gabbarini, Genova Sampierdarena, sempre di
officina Siccardi (TAV CI in C: BARILE Antiche ceramiche liguri 1965)
Conservazione: Incrinato
Iscrizioni //
Marchi o firme “S” di Siccardi sul fondo esterno
Provenienza e acquisizione://
Bibliografia:M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
21 - 22 due crespine.
Museo civico, Pistoia; diametro cm28,5 ; altezza cm 5; diametro piede cm 10 - diametro cm28,5 ;
altezza cm 6; diametro piede cm 11; Manifattura senese, secolo XVI
Descrizione: Serie di due crespine sagomate, baccellate a raggiera e smerlate al bordo, simili nella
fattura, nelle dimensioni e nella tipologia decorativa. In entrambi i casi la decorazione pittorica si
organizza in un disco figurato centrale con motivo di uccello passante (dal becco puntuto, le gambe
sottili ed il piumaggio della coda fortemente allungato), inserito in un paesaggio di frasche e due grandi
fiori laterali; una raggiera di foglie globulari stilizzate, in verde ramina, intorno alla figurazione ed
un’ampia fascia esterna decorata con elementi vegetali e floreali in colori brillanti(nei toni del giallo,
dell’arancio, del verde ramina, e del cobalto),semplicemente delimitata da una doppia filettatura in
azzurro diluito. La cromia è molto accesa e giocata su contrasti di colori acquosi, stesi senza rispettare i
contorni del disegno (realizzati in bruno manganese) ed a contrasto con il bianco di fondo.
Apparato critico: Nonostante l’attribuzione a manifattura savonese che riporta il catalogo del museo,
ci sentiamo di spostare l’ambito produttivo in Siena, entro il primo ventennio del secolo XVIII. Si
confronti nostra scheda di catalogo n° 15. Un esemplare molto simile è stato pubblicato in Donazione
Galeazzo Cora n° 691, pag 270.
Conservazione: Lievi sbocconcellature in entrambi i manufatti
Iscrizioni //
Marchi o firme Non rilevati
Provenienza e acquisizione: //
Bibliografia: M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni Donazione Galeazzo
Cora n691
23 Alzatina Museo civico, Pistoia; diametro cm21,5 ; altezza cm 4,5; diametro piede cm 8,8; Manifattura ligure,
Savona, secolo XVII fine
Descrizione: Alzatina con piede a disco e forma circolare (bordo lineare), decorata a tappezzeria, nei
toni del cobalto e del manganese su fondo bianco, con figurazione centrale libera di (non inclusa in
cornici ne in campiture) di paese stilizzato; raffigurazioni di zolle erbose e fiorite (con fiori a
campanula) in monocromo azzurro si dispongono a croce in prossimità del bordo esterno.
Apparato critico: Si confronti alzata con marchio stemma di Savona fig. 30 pag. 92 in 1° mostra
maioliche savonesi “ La Navicella galleria d’arte” ; ibidem pag. 30 fig. 17 e pag. 31 fig. 18.
Conservazione: Lievemente sbocconcellata ai bordi, cadute di smalto di non ampie
dimensioni.
Iscrizioni //
Marchi o firme Non rilevati
Provenienza e acquisizione: //
Bibliografia:M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
24 Catino
Museo civico, Pistoia; diametro cm37 ; altezza cm 12; Manifattura veneta, Bassano, Bottega
Antonibon, secolo XVIII (1750-70).
Descrizione: Ampio Catino sagomato con baccellature a raggiera, smerlato sul bordo e smaltato in un
tono di bianco molto caldo, quasi avorio. La decorazione si sviluppa sia in prossimità dell’orlo
superiore, dove si organizza in un tralcio vegetale in fiori di tacchiolo e nastri spezzati, sia al centro
della vasca; qui , liberamente sparsi sul fondo, senza cornici di contenimento, tralci sinuosi di fiori di
tacchiolo si organizzano intorno ad una grande cornucopia. Il grande elemento centrale,la cui
decorazione è giocata (in maniera molto accattivante) su una analogia/ambivalenza tra la forma di una
cornucopia e quella di una crisalide di farfalla, si inserisce, e stravolge, lo schema “a ponticello” su cui
è impostata la decorazione di base. L’intera tavolozza è giocata nei toni del verde salvia, del giallo e del
blu, mentre il bruno è utilizzato solo per delineare i contorni. La stesura dei colori è accurata,
calligrafica, con le campiture cromatiche perfettamente inserite all’interno dei contorni in bruno;
virtuosismo tecnico nella sfumatura in giallo sul corpo della cornucopia.
Apparato critico: Per quanto il motivo del fiore di tacchiolo e della decorazione “a ponticello” ci
portino a confermare la cronologia tardo settecentesca con cui è schedato il manufatto nel catalogo del
museo, riteniamo possibile spostare l’ambito di realizzazione dalla proposta di produzione milanese
alla manifattura Nove di Bassano, nella bottega Antonibon (terzo quarto del secolo XVIII).Escludendo
a priori l’ambito pescarese (ove è parimenti dimostrato è un’abbondante uso di decorazioni “al
tacchiolo”), caratterizzato comunque da una produzione ceramica decorata in toni liquidi (e mai
calligrafici, come qui), nella produzione ceramica settecentesca di area milanese e lodigiana conosciuta
in letteratura non si riscontra quella libertà di composizione che caratterizza il pezzo pistoiese, in luogo
di partiti simmetrici, rigidi e fortemente schematicizzati. La realizzazione nell’ambito della manifattura
Antonibon, nel primo periodo di produzione, ci sembra al momento la proposta più probabile, sebbene
il manufatto debba lo stesso considerarsi atipico anche in quel contesto: la decorazione del catino
pistoiese risulta coerente con quanto prodotto nella manifattura di Bassano (non solo nel repertorio
decorativo e negli schemi generali di composizione, ma, soprattutto, nel particolare ductus calligrafico
e minuto, in punta di pennello), la forma e lo spessore del catino, il tono caldo dello smalto di base e
l’ampio spazio lasciato all’elemento decorativo del nastro spezzato possono ancora lasciar luogo a
qualche perplessità. Di contro, proprio il motivo del nastro spezzato (di fatto praticamente assente nella
produzione ceramica italiana della seconda metà del Settecento) si ritrova (per quanto sappiamo in
unico esempio) in una tulipaniera di collezione privata veneziana uscita dalla bottega Antonibon. Si
Confrontino anche il grande piatto del museo Nove di Bassano ed il piatto rotondo del Museo Civico di
Bassano (rispettivamente n°46 e n°45 pag. 36 in G. ERICANI P. MARINI La ceramica nel Veneto.La
terraferma, 1990) . Un vassoio in ceramica Antonibon di composizione figurata molto ariosa, fiori di
tacchiolo e motivo di farfalla è stato battuto all’asta da Finante il 26 settembre 1995.
Conservazione:Rotto in due pezzi. Piede sbreccato
Iscrizioni//
Marchi o firme//
Provenienza e acquisizione://
Bibliografia:M.C.Mazzi Museo Civico di Pistoia. Catalago delle Collezioni
25-26 serie di due Fiasche Museo civico, Pescia; Larghezza cm 23 ; altezza cm 32; Manifattura faentina,Leonardo Bettisi, secolo
XVI, metà
Descrizione: Serie di due fiasche smaltate in bianco, decorate al centro in stile compendiario con
stemma della famiglia pesciatina dei “Della Barba” (Giano bifronte sormontato da una croce di Malta)
nei toni del giallo, dell’azzurro e del bruno. La decorazione è ottenuta impiegando sia mezzi pittorici
(limitata al solo stemma), sia la tecnica del bassorilievo, nei due putti reggistemma centrali e nelle due
arpie laterali; queste fungono principalmente da passacorda ma connotano plasticamente sia il profilo
del manufatto (con l’epa evidente e la testa sporgente), sia il corpo centrale (con i grandi girari in cui si
organizza il piumaggio delle ali), sia il piede (ove sono inserite le due zampe leonine)
Apparato critico: Tipico prodotto faentino della metà del Cinquecento in stile compendiario: smalto
bianco corposo steso uniformemente su tutto il manufatto a mo’ di glassa, sì da alterare i particolari più'
minuti della decorazione plastica in una massa molto elegante di forme vaghe ed indistinte. La sigla
“DO PI” in azzurro farebbe pensare ad una prima produzione della bottega del Bettisi. Per la tipologia
compositiva del manufatto si confrontino fiasca con anse passacorda n° 132 in Donazione Galeazzo
Cora e fiasca pag. 159 siglata “Don Pino” in C. RAVANELLI GUIDOTTI I bianchi di Faenza; Un
piatto in maiolica bianca in stile compendiario, di produzione faentina, con stemma della famiglia
pesciatina dei Della Barba, si trova in collezione privata faentina (proveniente da Pescia), pubblicato da
C. RAVANELLI GUIDOTTI “Contributo ai bianchi di Faenza” in Italienische Fayencen der
Renaissance, 2004. Purtroppo una ricerca in Pescia di altri oggetti consimili (sulla base di una ricerca
documentaria relativa alla donazione delle due fiasche, per ripercorrere a ritroso il percorso della
dispersione del servizio) non ha ancora avuto buon esito ma non è da escludere che possano essere
rinvenute ulteriori sopravvivenze del gruppo originario. Sappiamo anche che l’ultima discendente dei
“Della Barba” ha sposato un “Cheli” (anche questa, famiglia da poco estinta), ma anche questo ramo
della ricerca non ha dato frutti e non è comunque da escludere che la dispersione dei pezzi che
componevano il servizio dei Della Barba sia avvenuta in tempi precedenti. Resta anche da valutare se il
pittore conosciuto come “maestro del servizio V numerato”, ricostruito da Carmen Ravanelli Guidotti
ed a cui è attribuito il piatto faentino e Don Pino (che ha siglato la fiasca pesciatina) siano da
riconoscere nella stessa persona o se i due pezzi rinvenuti facciano parte di due distinti servizi in
maiolica di stile compendiario fatti fare in Faenza dalla famiglia di Pescia.
Conservazione: Lievemente sbocconcellate, soprattutto sulle emergenze di maggior
rilievo; perdita del tappo.
Iscrizioni //
Marchi o firme Firmato “DO PI” in azzurro sotto il piede
Provenienza e acquisizione: Incerta. La scheda n°09/00114378 della Soprintendenza di Firenze
Prato e Pistoia, competente sul territorio,indica una donazione “Fantozzi” degli anni ’50 come
momento di acquisizione di questi due pezzi ma non abbiamo trovato riscontri documentari che
avvallino tale affermazione. Da un lungo e paziente regesto dei documenti che compongono l’archivio
post unitario del Comune di Pescia si è potuto prendere nota della lunga, lenta e complessa formazione
del corpus di catalogo del museo pesciatino, per lo più'9d formato da donazioni spontanee di cittadini
intorno ad un nucleo originale ottocentesco di pezzi. È' da notare che, se è vero che esiste una
donazione di oggetti d’arte e libri fatta da tale signora Giulia Fantozzi vedova Bonazzi nel 1950, nel
minuzioso elenco fatto dalla Signora degli oggetti da donare (Archivio di stato di Pescia 2466 cat IX
1950. Lettera datata 7 luglio 1950 prot 8121 cat 9 classe 8 fasc 2), non compaiono oggetti in
maiolica, tantomeno fiasche. Si legge infatti: “Nell’intento di onorare la memoria di mio padre prof.
Piero Fantozzi (nato a Pescia il 27 .2. 1862 e defunto il 4 . 12 . 1945) e di mio fratello Prof. Giulio
Fantozzi (nato a Pescia il 29 . 5 . 1886 e defunto l’11. 1 . 1950) e per soddisfare un desiderio da essi
espresso in vita, intenderei donare: alla biblioteca…… al museo civico alcuni oggetti e mobili di
famiglia, di un certo interesse storico, tra cui un ritratto a olio (dell’avv Giuseppe Fantozzi) eseguito dal
pittore NORFINI padre, un grande ritratto di del maestro Giovanni Pacini ed il busto in marmo della
sua prima moglie Contessa Porro Calcaterra.……Giulia Fantozzi in Bonazzi”
Alla corrispondenza della signora Bonazzi ha fatto seguito una lettera datata 10 luglio 1950 e firmata
dal Sindaco, con l’accettazione della donazione; un comunicato stampa datato12 luglio 1950 dove si
parla di “donazione veramente cospiqua” ; un articolo sul numero del 14 luglio 1950 de “Il nuovo
corriere”, un giornale locale non più esistente, dove non si danno ulteriori notizie. L’appellativo di
“donazione cospiqua” potrebbe far anche pensare alla presenza di oggetti altri rispetto all’elenco delle
cose più' notabili stilato dalla donatrice, con l’esclusione di oggetti sicuramente ritenuti meno
importanti, ma, di fatto,non fornisce elementi di conferma.Per contro, in nessuno dei numerosi elenchi
di oggetti appartenenti al museo che il bibliotecario del Comune di Pescia stilava, periodicamente, ad
uso del ministero o del Soprintendente (ne quelli precedenti ne’ quelli successivi al 1950) vengono
elencati pezzi in maiolica. Nessuna notizia neppure dall’elenco datato 1962 (dove però si parla anche di
“cimeli” e “ricordi” senza prendersi l’impegno di specificare di cosa si possa trattare), mentre solo
nell’elenco del 1964 vengono citate le due fiasche, unitamente ai quattro albarelli cat. n° 29, n° 30, n°
31, n° 32.
Bibliografia: Inediti
27 Albarello
Museo civico, Pescia; altezza cm 23; Manifattura di Montelupo, secolo XVII
Descrizione: Albarello da farmacia di forma allungata in maiolica bianca, contraddistinto da una
decorazione isodoma di racemi vegetali con foglie di vite luce/ombra e fiori stilizzati nei toni del
cobalto (in purezza e fortemente diluito).Filettature lineari e parallele alla base (intorno al piede) e
intorno al bordo superiore. Una fascia puntinata in prossimità dell’imboccatura.
Apparato critico:Tipica decorazione a foglie luce/ombra della produzione montelupina
del secolo XVII. Questo tipo di produzione è perfettamente riconoscibile per l’impiego di foglie di vite
dalle proporzioni estremamente allungate, condotte nei toni del cobalto molto acquoso con una metà a
campitura piena (ombra) e l’altra metà in bianco a risparmio (luce), spesso senza linee di distinzione. Si
confronti ad esempio orciuoli nn° 587 e 588 pag. 232 in Donazione Galeazzo Cora.Utili confronti con
nostreschede cat. nn° 14 e 28.
Conservazione: Rotture e sbreccature sull’imboccature; cadute di smalto.
Iscrizioni//
Marchi o firmeNon rilevati
Provenienza e acquisizione://
Bibliografia:Inedito
28 Albarello Museo civico, Pescia;altezza cm 16;Manifattura di Montelupo, secolo XVII
Descrizione: Albarello da farmacia con spigoli sporgenti ed imboccatura dall’orlo pronunciato
decorato al centro con una ampia fascia lineare nei toni del giallo e del manganese riportante una
iscrizione, parimenti in manganese. Due fasce parallele, opposte per andamento della decorazione,
riportano una sequenza ordinata di foglie stilizzate nei toni del cobalto. Filettature lineari in cobalto
attorno al piede ed all’orlo; fascia dentellata, similmente nello stesso tono, al di sottodell’imboccatura.
Apparato critico:Albarello da farmacia di tipo corrente, con decorazione a foglie stilizzate luce/ombra
di piccole dimensioni in sequenza regolare. Si confrontino albarello n° 603 pag. 238 Donazione
Galeazzo Cora e ivi vaso n° 606 pag. 239. Utili confronti con nostre schede cat. n° 14 e n° 27.
Conservazione:Incrinato; sbocconcellato; ricoperto di sporcizia.
IscrizioniNella fascia centrale, iscrizione S.DI AGNOCASTO in lettere capitali nei toni del manganese
Marchi o firme Non rilevati
Provenienza e acquisizione: Non presente in alcun elenco degli oggetti di proprietà del museo
precedenti al 1968
Bibliografia: Inedito
29-30-31-32 Serie di quattro albarelli Museo civico, Pescia; altezza cm 14; Manifattura di
Montelupo, secolo XVIfine – XVII inizi
Descrizione:Serie di quattro albarelli da farmacia in maiolica bianca; di forma tozza, ma molto
elegante, con la sporgenza superiore molto pronunciata ed una pancia globulare da basso. Tutti e
quattro gli esemplari riportano stemma araldico d’azzurro con crescente giallo sormontato da tre stelle
a sei punte ugualmente gialle, riconducibile alla famiglia Simi. Negli esemplari scheda n° 29 e n° 30,
un’ampia fascia inferiore, delimitata da ampie modanature in giallo, riporta una bella decorazione a
baccellatura su doppio ordine, con cromia a contrasto, nei toni del bianco e del cobalto; le profilature
sono in manganese con ombreggiatura in giallo; nei due albarelli rimanenti una decorazione a foglie
d’acanto sostituisce questo elemento. Una fascia nei toni della ramina fortemente diluita si accompagna
ad un’altra simile condotta in giallo nella definizione cromatica dell’imboccatura. Il resto del manufatto
è dipinto con motivi a grottesca, in figurine femminili fantastiche, mascheroni ed ippogrifi nei toni del
giallo e dell’azzurro, con toccature di ramina ed arancio e profilature in manganese.
Apparato critico: Rara serie di quattro albarelli, di forma piuttosto inusuale, riferibili agli inizi del
secolo XVII. La decorazione a grottesche sottili su fondo bianco (conosciuta soprattutto per la serie
splendida della farmacia di Santa Maria Novella in Firenze) è tipologia compositiva che prende campo
tra la seconda metà del secolo XVI e gli inizi del secolo successivo, limitatamente, almeno in queste
forme, alla produzione Montelupina ed a quella di Deruta. Per quanto di aspetto esteriore molto simile,
le grottesche derutesi non presentano il motivo della espansione a sbuffo nella articolazione clavicola-
spalla-omero, a mo’ di ala di farfalla, come si vede nei pezzi del museo pesciatino. Anche i motivi
decorativi degli apparati trovano puntuali riscontri in
produzione consimile montelupina: per quanto riguarda la forma e la
decorazione dello scudo araldico si confronti fiasca schiacciata a grottesche Donazione Galeazzo Cora
n° 558 pag.221 e pure BERTI 1997 n° 245 pag.336; per la soluzione formale scelta a conclusione
laterale della targa su cui è posta l’iscrizione si vedano orciuoli nn° 587 e 588 pag.232 in Donazione
Galeazzo Cora; per il motivo a doppia baccellatura posto alla base degli esemplare cat. nn° 29 e 30 si
vedano gli orciuoli n° 562 e n° 563 sempre in Donazione Galeazzo Cora pag. 223 e, soprattutto,
orciuolo battuto all’asta a Parigi il 21 ottobre 2001 da Drouot – Richelieu.
Conservazione: Lievi sbocconcellature
Iscrizioni “ESUCA”, “CEDOARIA”, “PIOMBO ARSO”, “pill/e DA MATRICE”
Marchi o firme //
Provenienza e acquisizione: Riportati per la prima volta nell’elenco degli oggetti di appartenenti al
museo datato 1964; non si è rinvenuta nell’archivio del Comune di Pescia traccia documentaria
dell’acquisizione.
Bibliografia: Inediti
33 Scodella Museo Archeologico, Larciano; Dimensioni non rilevate; Manifattura Toscana, (Montelupo?), secolo
XVI, inizi.
Descrizione:Scodella in maiolica bianca con ampia tesa decorata con motivo ad embricazioni correnti
(profilate in azzurro su fondo arancio) tra due modanature azzurre. Vasca di bianco a risparmio con
motivi di occhio di penna di pavone disposte a croce intorno a grande decorazione a ventaglio sul
fondo. Dipinta nei toni dell’azzurro, dell’arancio, del manganese con leggere toccature di ramina.
Apparato critico: Sebbene la presenza di occhi di penna di pavone porti ad indicare una cronologia ed
un ambito di produzione ben indagata in letteratura, l’apparato decorativo del manufatto nella sua
interezza (con quella fascia ad embricazioni e, soprattutto nel bel motivo a ventaglio raffigurato al
centro) porterebbero a far slittare avanti la datazione di qualche decennio, in favore di un primo quarto
del secolo XVI. Per quanto riguarda il motivo a ventaglio, anche se non è da considerarsi produzione
esclusiva e peculiare, non si può non ricordare la grande quantità di oggetti simili prodotti nelle fornaci
di Montelupo.
Conservazione: Frammento ricostruito; lacunosa
Iscrizioni //
Marchi o firme Non rilevati
Provenienza e acquisizione: Castello di Larciano, scavi.
Bibliografia: Larciano Museo e Territorio; a cura di M. Milanese, A. Patera, E.
Pieri; scheda n° 30 pag. 104
34 Piatto Museo Archeologico, Larciano; Dimensioni non rilevate; Manifattura Toscana, (Montelupo?), secolo
XVI, inizi.
Descrizione:Piatto in maiolica bianca, decorato con motivi a nastri spezzati nei toni diluiti dell’arancio,
dell’azzurro e della ramina; profilature in manganese. Grande motivo a doppia rosetta stilizzata nel
tondino, con profilature in manganese e alternanza di arancio e cobalto nella rosetta superiore; fasce
concentriche lineari nei toni del giallo e dell’azzurro sul cavetto ed in prossimità del bordo esterno;
grande motivo ad intreccio di nastri spezzati, nei toni del blu diluito in alternanza di bianco a risparmio,
sulla tesa. Motivi vegetali fortemente stilizzati (fogliame in ramina, fiore in arancio) tra gli intrecci del
nastro.
Apparato critico: Tipica decorazione a nastro spezzato in blu e bianco emergente su fitta
composizione policroma Si veda a confronto F. BERTI 1997 pag. 263. Abbondante produzione in area
montelupina nel secolo XVI. Piatti in tutto simili e con il medesimo decoro a stilizzazione vegetale in
arancio e ramina (a corona dell’intreccio dei nastri) si vedono nel museo archeologico di Pietrasanta,
nostre schede cat. n° 65 e cat. n° 66.
Conservazione:
Frammentario; parzialmente ricostruito; lacunoso
Iscrizioni//
Marchi o firmeNon rilevati
Provenienza e acquisizione:Castello di Larciano, scavi.
Bibliografia:Larciano Museo e Territorio; a cura di M. Milanese, A. Patera, E.Pieri; scheda n° 61 pag.
107
35 - 36 due ciotole Museo Archeologico, Larciano; Dimensioni non rilevate; Manifattura toscana,Montelupo, secolo XVI
terzo quarto.
Descrizione:Serie di due ciotole decorate con motivi figurali nelle sembianze di una Santa Barbara
nell’esempare cat. n° 35 e di una Santa Chiara nell’altro; in entrambi i casi si tratta di rappresentazioni
di sante stanti, a figura intera, con braccia aperte, su fondo giallo in saturazione. Nell’esemplare cat. n°
35 è possibile vedere un bordo arancio sull’orlo superiore della ciotola ma non è più leggibile la parte
inferiore della figurazione; nell’altro esemplare invece è ancora visibile un bel paesaggio naturale nei
toni dell’azzurro diluito, del giallo e dell’arancio. Manganese nel manto superiore; tonaca in bianco a
risparmio, ombreggiata in azzurro fortemente diluito; verde ramina sulla palma del martirio (solo
esemplare cat. n° 36); toccature di arancione nel paesaggio ai piedi della Santa Caterina e sulla torre,
sul viso e sull’orlo superiore dell’altro esemplare.
Apparato critico:Per quanto qui di fattura più corrente, si confronti produzione
montelupina con figure stanti di santi su fondo giallo per la farmacia di Santa Novella in Firenze; tra
tutti orciolo n° 3 (datato 1570-90) pag. 7 in F. BERTI La farmacia di Santa Maria novella. Si vedano
anche Berti 1997 vol V pagg 197 – 201.
Conservazione: Frammenti: parzialmente ricostruito solo l’esemplare cat. n° 54.
Iscrizioni //
Marchi o firme Non rilevati
Provenienza e acquisizione: Castello di Larciano, scavi.
Bibliografia:Larciano Museo e Territorio; a cura di M. Milanese, A. Patera, E.
Pieri; scheda n°'a1 60 pag. 107 per l’esemplare cat. n°'a1 35; inedito
l’altro.
37 Scodella Museo Archeologico, Larciano; Dimensioni non rilevate; Manifattura Toscana, secoloXVI fine - XVII
inizi
Descrizione:Scodella in maiolica ingobbiata e graffita a stecca, con motivi a chela di granchio nella
tesa e stemma araldico al centro, sottolineato da brevi pennellate policrome nei toni diluiti della ramina
(scudo) e del giallo (stella ad otto punte in campo bianco); motivo ondulato graffito nel cavetto.
Apparato critico: Versione tarda della produzione toscana di ceramica ingobbiata e graffita con
decorazione a chele di granchio (tipica, in particolar modo, dell’area lucchese e pisana), qui
impreziosita da tracce di policromia nel tondino. Un manufatto simile per tecnica si trova nel Museo
Civico di Pistoia (vedi scheda n°1). Due catini frammentari identici (uno con stemma diverso ma scudo
simile e simile per tecnica; l’altro con stesso stemma) si trovano nel Museo delle ceramiche di
Camporgiano, fuori nostro catalogo)
Conservazione: Frammenti: parzialmente ricostruito.
Iscrizioni //
Marchi o firme Non rilevati
Provenienza e acquisizione: Castello di Larciano, scavi.
Bibliografia: Larciano Museo e Territorio; a cura di M. Milanese, A. Patera, E.Pieri.
38 Orciolo Chiesa parrocchiale di Cecina di Larciano; cm 22 altezza, cm 7,5 diametro del piede, cm 8
diametro dell’orlo superiore; Montelupo, secoloXVI fine - XVII inizi
Descrizione:Versatoio globulare monoansato con cordolo di sostegno del beccuccio. Realizzato in
maiolica policroma nei toni dell’azzurro in diluizione e del giallo, con tocchi di ramina nel risvolto del
cartiglio e sull’ansa ed utilizzo del manganese per i contorni e l’iscrizione frontale.
Apparato critico: Tipico versatoio da farmacia, con cartiglio ed iscrizione, della produzione
montelupina del tardo secolo XVI. Decorazione a foglie luce/ombra in diluizione di azzurro, girali e
filettature su tutta la superficie bianca a risparmio. Definizione in giallo carico ed in diluizione del
cordolo di sostegno del beccuccio e del cartiglio frontale. Prodotto di buona fattura probabilmente già
parte del corredo strumentale di una officina farmaceutica.
Conservazione: Integro e perfettamente leggibile in tutte le sue parti componenti. Lievi
sbocconcellature sui bordi.
Iscrizioni: In lettere capitali nel cartiglio “SV. ROSATSE”
Marchi o firme “L” maiuscola in cobalto al di sotto dellansa all’interno di una campitura circolare
Provenienza e acquisizione: Non rilevata.
Bibliografia: Inedito.
39 - 40 Serie di due orcioli
Museo Clemente Rospigliosi, Pistoia; cm 16 altezza del solo corpo principale, cm 21 altezza massima
comprensiva dell’ansa, cm 10 diametro del piede alla base, cm 15 diametro della bocca; Savona,
secolo XVIII.
Descrizione: Il vaso ha forma globulare con maggiore emergenza superiore, piede piatto ed espanso,
collo cilindrico leggermente estroflesso con larga bocca dall’orlo espanso e tagliente su cui si innesta
un’ansa anguiforme che la attraversa, superiormente, da parte a parte; largo beccuccio a cannello,
leggermente svasato nella emergenza distale. Decorazione invadente a paesi nei toni del cobalto in
diluizione con toccature di giallo e ramina solo nel grande stemma centrale retto da putti entro
campitura polilobata in bianco a risparmio.
Apparato critico: Tipico prodotto ligure di gusto pittorico e di alta qualità esecutiva del periodo
compreso tra la seconda metà de secolo XVII e la prima metà del secolo XVIII. Lo stemma raffigurato
al centro dei due manufatti (inquartato d'oro e d'azzurro, a quattro losanghe dell'uno nell'altro) ne indica
la provenienza dalla dotazione della famiglia Rospigliosi. Oltremodo, nel 1641 il Senato genovese
concedeva alla fabbrica Grosso di Albisola il privilegio di marcare le ceramiche con il simbolo del faro
di Genova, la lanterna. Tra la fine del secolo XVII e l'inizio del successivo, sempre con il permesso del
Senato genovese, la lanterna diveniva il simbolo della società Chiodo-Peirano di Savona.
Conservazione: Integro e perfettamente leggibile in tutte le sue parti componenti. Leggere sbreccature
e sbocconcellature sulle emergenze massime dell’orlo superiore e del piede.
Iscrizioni: //
Marchi o firme: Marca “lanterna” sotto il piede
Provenienza e acquisizione: Non rilevata; probabilmente già parte della dotazione del palazzo.
Bibliografia: Inedito.
41 – 42 Serie di due crespine
Museo Clemente Rospigliosi, Pistoia; cm 13 altezza, cm 14 diametro del piede alla base, cm 35
diametro massimo dell’orlo superiore; Savona, secolo XVIII.
Descrizione: Grande crespina baccellata e dotata di piede; decorazione invadente con paesi, verzura,
putti e figure mitologiche nei toni del cobalto, puro e in diluizione. Toccature di giallo e ramina nel
grande stemma centrale. Motivi vegetali parimenti in cobalto, ma a campitura omogenea, sul verso.
Apparato critico: Tipico prodotto ligure di gusto pittorico e di alta qualità esecutiva del periodo
compreso tra la seconda metà de secolo XVII e la prima metà del secolo XVIII. Lo stemma raffigurato
al centro dei due manufatti (inquartato d'oro e d'azzurro, a quattro losanghe dell'uno nell'altro) ne indica
la provenienza dalla dotazione della famiglia Rospigliosi. Oltremodo, nel 1641 il Senato genovese
concedeva alla fabbrica Grosso di Albisola il privilegio di marcare le ceramiche con il simbolo del faro
di Genova, la lanterna. Tra la fine del secolo XVII e l'inizio del successivo, sempre con il permesso del
Senato genovese, la lanterna diveniva il simbolo della società Chiodo-Peirano di Savona.
Conservazione: Integro e perfettamente leggibile in tutte le sue parti componenti. Sbreccature e
sbocconcellature diffuse sulle emergenze massime dell’orlo superiore e del piede. Molto compromesso
il piede di uno dei due manufatti.
Iscrizioni: //
Marchi o firme: Marca “lanterna” sotto il piede.
Provenienza e acquisizione: Non rilevata; probabilmente già parte della dotazione del palazzo.
Bibliografia: Inedito.
43 – 44 serie di due piatti
Museo Clemente Rospigliosi, Pistoia; cm 6 altezza, cm 19 diametro del cavetto, cm 46 diametro della
tesa; Liguria, secolo XVIII, seconda metà.
Descrizione: Grande piatto sbocconcellato nella tesa ed istoriato nel cavetto, decorato nei soli toni del
cobalto. Al centro del tondino scena di genere (figure muliebri con ceste in paesaggio naturale con
animali nel primo esemplare; incontro tra un viandante e due fanciulle suonatrici di archi in ambiente
naturale, nell’altro) entro campitura circolare sormontata da grande stemma araldico. Nel bordo esterno
si dispone una trina decorativa omogenea.
Apparato critico: Lo stemma riprodotto in grandi dimensioni (qui realizzato nei soli toni del cobalto
ma in realtà d'oro, a tre bande d'azzurro; con il capo d'argento, caricato del leone leopardito di rosso)
farebbe supporre una primiera ed originale appartenenza alla famiglia Cellesi, nobile ed antica casata
pistoiese i cui membri intrapresero notevoli attività commerciali, nonché legati fin dal 1650 alla
famiglia Rospigliosi attraverso il matrimonio tra Lucrezia Cellesi e Giacomo Rospigliosi. Probabile
committente del servizio risulterebbe essere però Luigi Cellesi, cavaliere degli ordini di Malta e Santo
Stefano a partire dal 1779, come si evince dalla presenza di una croce di malta a supporto dello
stemma.
Conservazione: Integro e perfettamente leggibile in tutte le sue parti componenti
Iscrizioni: //
Marchi o firme: Solo su uno dei due esemplari “S” maiuscola in cobalto sul verso con una stella a
cinque punte. Il Marchio Stella, sovente seguita dalla lettera S, è stato impiegato nella prima metà del
Settecento da una fabbrica attiva a Savona o Albisola e attribuita alla famiglia Salamone. Risulta però
che a Savona i salamone cessano la propria attività alla fine del Seicento, continuando la propria
attività ad Albisola almeno fino alla fine del secolo XVIII.
Provenienza e acquisizione: Non rilevata; probabile passaggio per eredità dalla famiglia Cellesi.
Bibliografia: Inedito.
45 – 46 Serie di due catini da barba
Museo Clemente Rospigliosi, Pistoia; cm 10 altezza, cm 15 diametro del cavetto, cm 39 diametro
massimo della tesa; Liguria, secolo XVIII, seconda metà.
Descrizione: Grande recipiente ad ampia parete svasata, dotato di tre piccoli piedini e decorato nei soli
toni del cobalto. Destinato prevalentemente ad uso igienico. Si tratta di un catino da barba, con ampio e
profondo cavetto emisferico e tesa ad orlo leggermente rialzato, munita del necessario scavo poggia
gola. La forma complessiva è quella della valva di una conchiglia, con definizione plastica a
baccellature e scanalature. La forma di conchiglia è ripresa sul verso nella definizione dei tre piccoli
piedini su cui il manufatto poggia. Al centro é rappresentata una scena di genere (suonatrice di viola
con verzura e putti nel primo esemplare; cavaliere su cavallo impennato e spada alzata nell’altro) con
grande stemma araldico. Nel bordo del catino si dispone una trina decorativa omogenea.
Apparato critico: Lo stemma riprodotto in grandi dimensioni (qui realizzato nei soli toni del cobalto
ma in realtà d'oro, a tre bande d'azzurro; con il capo d'argento, caricato del leone leopardito di rosso)
farebbe supporre una primiera ed originale appartenenza alla famiglia Cellesi, nobile ed antica casata
pistoiese i cui membri intrapresero notevoli attività commerciali, nonché legati fin dal 1650 alla
famiglia Rospigliosi attraverso il matrimonio tra Lucrezia Cellesi e Giacomo Rospigliosi. Probabile
committente del servizio risulterebbe essere però Luigi Cellesi, cavaliere degli ordini di Malta e Santo
Stefano a partire dal 1779, come si evince dalla presenza di una croce di malta a supporto dello
stemma.
Conservazione: Integro e perfettamente leggibile in tutte le sue parti componenti
Iscrizioni: //
Marchi o firme “S” maiuscola in cobalto sul verso con una stella a cinque punte. Il Marchio Stella,
sovente seguita dalla lettera S, è stato impiegato nella prima metà del Settecento da una fabbrica attiva
a Savona o Albisola e attribuita alla famiglia Salamone. Risulta però che a Savona i salamone cessano
la propria attività alla fine del Seicento, continuando la propria attività ad Albisola almeno fino alla fine
del secolo XVIII.
Provenienza e acquisizione: Non rilevata; probabile passaggio per eredità dalla famiglia Cellesi.
Bibliografia: Inedito.
47 Crespina
Museo Clemente Rospigliosi, Pistoia; cm 13 altezza, cm 17,5 diametro massimo del piede, cm 33
diametro massimo dell’orlo superiore; Liguria, secolo XVIII, seconda metà.
Descrizione: Grande crespina baccellata e dotata di piede; decorata sul fondo nei soli toni del cobalto
con scena istoriata (incontro tra viandanti in ambiente naturale) all’interno di una campitura circolare.
Nel bordo esterno si dispone una trina decorativa omogenea, parimenti nei soli toni del cobalto in
purezza.
Apparato critico: Differentemente da quanto visto negli esemplari cat. 43-46, il manufatto non
presenta alcuno stemma araldico, ne’ corrisponde la marca di fabbricazione. Nonostante questo
l’esemplare nostro oggetto di indagine deve essere ritenuto parte integrante di uno stesso servizio,
unitamente agli esemplari citati, corrispondendo con quelli la tecnica di esecuzione, i materiali, la
destinazione d’uso e la tipologia decorativa.
Conservazione: Integro e perfettamente leggibile in tutte le sue parti componenti
Iscrizioni: //
Marchi o firme “C.B.I” maiuscola in cobalto sul verso, al centro del piede
Provenienza e acquisizione: Non rilevata; probabile passaggio per eredità dalla famiglia Cellesi.
Bibliografia: Inedito.
i Larciano : museo e territorio / Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica della Toscana ...
A cura di Marco Milanese, Anna Patera, Roma,L'Erma di Bretschneider, 1997 ii Atti della giornata di studio su "Il Museo Civico di Pescia nel Sistema Museale della Valdinievole dall'Unità d'Italia",
Pescia, 30 novembre 2002 / Istituto Storico Lucchese, Sezione Valdinievole, Pescia, 2004 iii
Museo Civico di Pistoia : catalogo delle collezioni / Comune di Pistoia. A cura di Maria Cecilia Mazzi. – 1. ed. ,
Firenze,La Nuova Italia Editrice, 1982