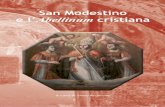L'incanto malefico. L'Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
ISCRIZIONI FRINIATI NELLA BUCA DEL DIAVOLO (ALTA VAL LIMENTRA, PISTOIA)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of ISCRIZIONI FRINIATI NELLA BUCA DEL DIAVOLO (ALTA VAL LIMENTRA, PISTOIA)
Adolfo Zavaroni
ISCRIZIONI FRINIATI NELLA BUCA DEL DIAVOLO (ALTA VAL LIMENTRA, PISTOIA)
PREMESSA. Questo articolo, che dovetti scrivere in modo da non dare ai valutatori elementi per l’individuazione dell’autore, fu proposto ad una nota rivista accademica italiana via e-mail alla fine di giugno 2015. Il 1° di luglio mi fu comunicato che era stata avviata “la procedura di revisione paritaria” e che si sperava di potermi rispondere “entro settembre”. Il 15 luglio 2015 mi fu detto che la valutazione era negativa e mi fu inviato il seguente giudizio:
L’articolo Iscrizioni friniati nella Buca del Diavolo (alta val Limentra, Pistoia) presenta alcune nuove iscrizioni rupestri affini a quelle recentemente scoperte nell’area del Frignano, nell’Appennino modenese.
Sul piano del metodo l’articolo suscita forti perplessità, non solo per la disinvoltura di certe analisi linguistiche comparative, ma soprattutto per la sistematica tendenza a ipotizzare scritture per così dire stratificate, cioè modificate per un’intenzionale ricerca dell’ambiguità.
Così, ad esempio, alle linee 2 e 3 un originario imos sarebbe stato poi corretto rispettivamente in embos e in embs o embos, mentre per un’iscrizione friniate dal cosiddetto Ponte d’Ercole l’autore si spinge a sostenere che la scritta RIMO, se le lettere sono lette come latine, darebbe rīmō, “fendo, rompo” (verbo non deponente in Pacuvio), ma se le lettere sono lette come grafia friniate, darebbe riimo, “lego, vincolo”. Per l’autore non si tratta di scegliere fra le due alternative: a suo giudizio «non sono rari esempi simili di doppia lettura con significati opposti, spesso ottenuti con l’aggiunta di uno o due tratti incisi meno profondamente che mutano la legatura e quindi il senso della scritta». La fragilità di queste affermazioni non dimostrate pare evidente.
Altrettanto azzardata sembra la proposta di riconoscere una precisa volontà da parte dell’incisore di scrivere la parola con cui inizia la linea 2 (tommos) «in modo da raffigurare anche un animale».
Anche il riferimento di questi testi ad attività antiromane al tempo della Guerra Sociale (che non risulta abbia mai interessato un’area così a Nord), con la possibilità di collocarla sia più indietro che più avanti nel tempo, non sembra sufficientemente fondato.
Siccome studio le iscrizioni del Frignano dal 2007, mi sembra evidente che il valutatore (in verità i referees dovrebbero essere due) non ha mai visto un’iscrizione friniate e probabilmente nemmemo delle incisioni rupestri. Non nego che le mie affermazioni relative a non rari casi di iscrizioni friniati congegnate con sovrapposizioni di grafi tali da permettere ambivalenti letture e giochi di parole possa sollevare legittime perplessità nel lettore. Ma la mia asserzione si basa sull’esame delle numerosissime iscrizioni con sovrapposizioni e su un’esperienza formatasi con uno studio assiduo di otto anni. Anche l’esempio delle ambiguità giocate sulla scritta RIMO citata dal
2
referee ha tali basi. Sono il primo a pensare che le mie interpretazioni sia delle figure e dei simboli sia delle iscrizioni possano suscitare perplessità e scetticismo nel lettore, ma preferisco presentarle ugualmente proprio per stimolare lo spirito critico di chi legge. Vorrei però sottolineare che che generalmente chi scrive su argomenti nuovi ha dovuto scegliere ciò che propone fra numerose ipotesi e la scelta si è basata su una quantità di dati che generalmente chi si avvicina a tali argomenti per la prima volta non possiede. Ad esempio, le mie asserzioni si basano non solo sull’analisi delle iscrizioni, ma anche delle figurazioni dei Friniati, ricca fonte di concetti religiosi e filosofici appunto basati sull’idea di un mondo e di entità divine continuamente mutevoli e quindi ambigue.
Mi pare poi evidente che in un breve articolo un autore non possa ripetere ciò che ha tentato di dimostrare in precedenti lavori, spesso più ampi e articolati. Purtroppo il valutatore del presente articolo non solo mostra di aver mai visto un’iscrizione friniate, ma di non avere neppure dato un’occhiata al materiale già pubblicato sull’argomento. Non a caso il giudizio è arrivato nel giro di due settimane.
Lo stesso discorso vale per l’ “azzardata proposta” di riconoscere una precisa volontà da parte dell’incisore di scrivere la parola con cui inizia la linea 2 (tommos) «in modo da raffigurare anche un animale». Il valutatore ignora che in varie iscrizioni rupestri, comprese quelle camune della Valcamonica, a volte le lettere sono antropomorfizzate in modo da alludere ad aspetti e attribuiti dei personaggi a cui la scritta si riferisce.
Sono il primo ad invitare il lettore a cercare di verificare le mie
interpretazioni, così come io faccio anche nei confronti di studiosi ben più noti e stimabili. Ma gli elementi di novità del mio articolo ‒ in particolare il fatto che il territorio degli antichi Friniates si estendesse anche all’Appennino pistoiese-bolognese ‒ mi sembravano già importanti e tali da indurre la redazione di una rivista di storia e filologia a renderli noti, lasciando poi al lettore la libertà di ricusare o criticare vari dettagli o interpretazioni.
Per evitare ulteriori contrattempi, ho deciso di pubblicare l’articolo sul sito www.academia.edu dove si lascia agli autori la libertà e la responsabilità delle loro asserzioni ed ai lettori la libertà di giudicare senza la pre-valutazione di referees che generalmente devono seguire stabiliti criteri di “politica” editoriale.
1. Visitai la Buca del Diavolo (1), localmente chiamata anche Tana della
Volpe, il 18 novembre 2006. Questa stretta grotta si trova nell’Alta Val Limentra, presso Treppio (2). Tale località, a 920 metri sul livello del mare, è in
(1) Mi ero associato agli amici Giancarlo Sani (Empoli), autore di varie pubblicazioni sulle
incisioni rupestri della Toscana, Romano Falaschi (Fucecchio) e Mauro Colella (Milano), appassionati ricercatori di rocce incise.
(2) La grotta ha la forma di uno stretto corridoio lungo circa 15 metri e terminante in una spaccatura ingombra di massi caduti dalla volta. L’ingresso è largo quasi due metri. Il corridoio
3
provincia di Pistoia, mentre il torrente Limentrella, presso cui Treppio sorge, è tributario del fiume Reno che attraversa il territorio di Bologna.
Fig. 1. Zona con due delle scritte in grafìa friniate esaminate.
Sulla parete sinistra della grotta poco dopo l’ingresso, nella zona alta dove ha inizio un anfratto superiore, notai un gruppo di scritte che mi sembravano antiche (Fig. 1). Siccome l’area non è raggiungibile da un uomo coi piedi sul suolo, l’incisore dovette salire su una scala. Essendo noi sprovvisti di scale, non fu possibile fare macrofoto che dessero una maggiore sicurezza nell’analisi delle scritte aventi piccoli caratteri. Le lettere del nome MOGONTIOS sono alte circa 2 centimetri (3).
Quando, alla fine del 2006, cercai di leggere il gruppo di scritte della Buca del Diavolo, non ebbi difficoltà nel leggere MOGONTIOS, ma non ero in grado di presentare letture plausibili degli altri termini visibili in Fig. 1. Ma ora, dopo lo studio delle iscrizioni rupestri dell’Appennino tosco-emiliano, ritengo che l’incisore o gli incisori della Buca del Diavolo si siano attenuti al
inizialmente scende verso il basso, si restringe dopo circa quattro metri e poi si riallarga, senza mai superare i 180 centimetri. Sulle due pareti sono incise scritte e simboli di varie epoche. Pure incise sono le pareti di uno stretto anfratto superiore, accessibile in modo disagevole poco dopo l’ingresso. Anche le pareti di tale anfratto sono incise, sebbene un uomo di taglia oggi normale possa entrare e soprattutto girarsi e muovere le braccia con molta difficoltà. Le incisioni più suggestive della grotta sono forse quelle di età preistorica, costituite da reticoli, segni a “phi”, serie di coppelle, graffi paralleli. Frequenti sono i segni di cristianizzazione (per lo più croci) di quello che sembra essere stato un luogo di culto pagano. Stando alle date (1737, 1761, 1779 ecc.), una certa frequentazione si ebbe nel secolo XVIII, forse in concomitanza con l’utilizzo produttivo del castagneto in cui la grotta si trova. A tale secolo sono infatti databili varie iniziali di nomi e cruciformi. Appaiono anche numerosi nomi e sigle di età più recente. Per una rassegna dei vari segni vedi L. De Marchi, I sassi scritti delle
Limentre (Appennino pistoiese e pratese), Porretta Terme 2000. (3) Le foto di G. Sani permettono di ricusare la lettura parziale ed erronea di L. De Marchi
che legge soltanto MDCCATIO e suppone che si tratti di una datazione. Vedi L. De Marchi, I sassi scritti delle Limentre cit., pp. 81-82.
4
sistema scrittorio degli antichi Friniates che Tito Livio considerava Liguri, ma che chiamavano se stessi Ombri, Umbri (4).
In Fig. 2 propongo un apografo della parte sinistra delle iscrizioni visibili in Fig. 1. In nero ho segnato i tratti relativi a tre varianti di scrittura e a figure (forse due cervidi e una falce) interferenti con i grafi.
Nella trascrizione sotto riportata sottolineo le lettere in legatura e pongo in corpo minore le lettere meno evidenti:
boios moGontios
tommos vacara embos
emб(o)s ir
iui ri ri ri ri ri ri ri ri
Fig. 2. Evidenziazione dell’iscrizione A.
Le lettere sono tracciate fra linee parallele preesistenti, molto più lunghe degli spazi occupati dalle lettere, la cui altezza e grandezza sono condizionate
(4) Vedi Liv. 39.2;41.19. Sulla questione vd. A. Zavaroni, Gli antichi abitanti del
Frignano si chiamavano Umbri, Ombri, «Il Frignano» 4 (2012), pp. 238-254 (reperibile anche nel sito internet Academia.edu).
5
anche dall’esistenza di altre linee leggermente oblique rispetto alle linee principali più calcate.
Mi sembra che nella prima riga il primo nome = boios sia stato aggiunto successivamente poiché è scritto come se l’incisore avesse avuto a disposizione uno spazio ristretto: il primo piccolo o è tangente a b e i è quasi addossato al primo o. Non escludo che siano presenti due tentativi di eseguire la legatura finale os del tipo , con gli o di differente dimensione. Tale legatura è molto frequente nelle iscrizioni in grafìa friniate.
Le lettere di moGontios hanno una dimensione decrescente, anche perché quelle finali, tios, sono delimitate superiormente da una riga leggermente obliqua. Non sono del tutto sicuro che la lettera dopo il primo o sia g e non c, ma mi sembra di vedere, anche se breve e poco profondo, il trattino verticale che sale dall’estremo inferiore del tratto curvo.
Occorre notare che la lettera g non esiste nelle numerosissime iscrizioni friniati: presumibilmente i suoni /g/ e /gh/ erano svaniti prima dell’uso della scrittura (5); ma qui, essendo il nome gallico, era necessario usare una lettera denotante /g/. Per la sua estraneità all’alfabeto friniate la trascrivo con G e non con g. Strana è la forma di n, denotato da un segno che nelle iscrizioni friniati della valle di Ospitale è uno dei grafi che marcano m. Per contro, m è marcato da , chiaro in embos della 2a riga, ma meno percepibile in moGontios a causa di varie interferenze. In tommos il doppio m ha la forma che richiama gli m friniati: ma l’adozione di tali m pare dettata dal desiderio di abbinare la scritta alla figura di un animale: anche questo abbinamento tra segni alfabetici e figure caratterizza parecchie iscrizioni friniati.
In vacara abbiamo un v di tipo friniate (nelle iscrizioni friniati esistono anche la variante e il tipo etruscoide rovesciato ) e tre a che non hanno la stessa forma: la prima è e il suo trattino inferiore a sinistra tocca il trattino di base del = v; la seconda a è legata con r nel gruppo = ar. La terza a non è certa a causa del fatto che il suo tratto destro dovrebbe coincidere con una linea obliqua sottile che scende verso il basso fino alla terza riga. La sua forma ( ) sarebbe abbastanza simile a quella della prima a.
Le e di embos della 2a riga e di emб(o)s della 3a riga sono differenti. L’una ha la forma II, l’altra è una e con asta quasi orizzontale ed i tre trattini verticali ( ). Si può però notare che una e di tipo con tratti poco profondi fu apposta al di sopra di II.
Il nome tommos nella 2a riga è totalmente scritto in grafìa friniate:
La piccolissima legatura os finale mi fa supporre che l’appendice denotante s dovesse alludere ad una corta coda. Mi sembra che l’incisore abbia voluto
(5) Vedi A. Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane della valle di Ospitale
(Appennino Modenese), Oxford 2011 (con DVD contenente 1230 files fotografici relativi alle iscrizioni), pp. 2-3, a cui rinvio anche per l’alfabeto e per una tabella con 544 esempi di legature che sono soltanto una parte del repertorio.
6
scrivere il nome in modo da raffigurare anche un animale: dal vertice alto del t sembrano partire dei tratti che interferiscono con m di moGontios e fanno pensare alle orecchie o alle corna di un daino. Forse una replica in scala maggiore della testa e del collo di un daino o cervide fu incisa superiormente. La testa conterrebbe il nome boios della prima riga. In verità l’estremità del muso è appuntita come un becco ed una piccola cavità lanceolata è incisa presso questa estremità, come se l’animale tenesse tra le labbra serrate una piccola cosa indefinibile (una fogliolina?): suppongo si tratti di una rappresentazione simbolica che allude al ciclo vita-morte-vita (6).
Dentro il secondo m di tommos sembra disegnata una testa elmata. Nella 2a riga la terza parola, che forse fu aggiunta più tardi, a prima vista
pare essere embos. Mentre b è sufficientemente percepibile, s finale in legatura non è evidente. Ipotizzo la sua presenza grazie alla linea leggermente sinuosa, più profondamente incisa, che scende più in basso rispetto alla base di b e che nell’estremità superiore si discosta appena dalla gobba superiore di b. Dentro la gobba inferiore del b c’è un tratto che lascia pensare alla presenza di una legatura = bo in cui la parte inferiore di b interseca l’o.
La prima delle due aste che formano un e del tipo II davanti a m è meno spessa e meno profonda della seconda e dello stesso m. Questo particolare m’induce a supporre che la prima asta di II sia stata aggiunta per mutare un precedente i in e. Una tale modifica non comporterebbe un cambiamento nel senso della parola dato che in friniate, come si vedrà, le basi *emb- e *imb- hanno la stessa radice e la stessa griglia semantica. Ma un cambiamento da *imb- a *emb- sembra poco motivabile, data l’equivalenza semantica di queste due basi, a meno che non si supponga che esso fosse dettato dalla volontà di adeguare la parola ad una variante dialettale. Una modifica forse più significativa sul piano lessicale, pur fra basi aventi la stessa radice e la stessa griglia semantica, potrebbe essere quella da imos a embos. Ipotizzando che la versione originaria fosse imos, ne deriva che per mutare imos in embos fu inciso un b sovrapposto all’o della legatura = os e fu aggiunta un’asta davanti ad i:
Sarebbe quindi giustificata sul piano epigrafico la presenza di una legatura
bos in cui s è poco percepibile. Ritengo che un’analoga modifica sia stata effettuata nella 3a riga. Qui la
lettera dopo è ambigua e presenta segni di ritocchi, seppur eseguiti con tratti più lievi. Forse la forma originaria di tale lettera era che corrisponderebbe alle legature friniati = = = = denotanti im. Poi,
(6) Si ricordino i cervi che saltano tra i rami dell’albero del mondo Yggdrasill e ne
mangiano le foglie. In un mosaico di Sens un cervo tiene in bocca una foglia strappata da una pianticella che sorge da un vaso posto su una colonnetta (vedi J.P.Darmon -H. Lavagne, Recueil Général des Mosaïques de La Gaule, II, Province de Lyonnaise 3, C.N.R.S., Paris, Pl. XXVII).
7
volendo mutare imos in emбos, furono aggiunti dei tratti, ottenendo : presumo che l’intento dell’incisore fosse duplice: dare al segno una somiglianza con m di tipo ed esprimere l’idea di unione raddoppiando alcuni tratti. Infatti anche l’e ( ) incisa davanti a deve probabilmente la sua strana forma all’intenzione di alludere ad un animale bicipite.
Il terzo segno ( ) è assimilabile alla lettera denotante /bh/ dell’alfabeto friniate, ma ha stranamente l’asta superiore piegata all’indietro e interferente con la base dell’a finale di vacara della 2a riga. Ciò mi pare dovuto al fatto che tale asta fu aggiunta in uno spazio ristretto per mutare in = un originario o di dimensioni simili alla legatura precedente = im e alla lettera seguente s. Dunque, suppongo che anche qui la parola scritta in origine fosse imos. Successivamente la si sarebbe trasformata in emбs e/o in emбos. Con б trascrivo = (7).
Dentro il cerchio di ci sono altri segni. Il più marcato è un o incompleto che non è chiuso nella parte inferiore: avrebbe una specie di collo e la sua base, rettilinea, insisterebbe su quella del б. Non è raro che nelle iscrizioni friniati le o e le coppelle abbiano la forma di teste mozzate che alludono tanto ad anime che risorgono quanto alle teste dei nemici da decapitare. Qui, però, mi sembra che il contorno della testa delineata dall’o appartenga ad una figura comprendente anche due braccia: un braccio, armato di ascia con piccola lama, sarebbe formato dalla parte sinistra del б inclinato; l’altro da s finale: sul tratto superiore di questo s è innestato un angolo in modo che esso alluda ad un’ascia con la lama appuntita.
Davanti all’o avente la forma di una testa, sempre internamente al cerchio di , ci sono altri segni più lievi che possono essere letti come b. Insomma, potremmo leggere bo: trascurando il grande e tenendo presente che si è mutato = im in simile a = m, avremmo embos. Se però considerassimo come legatura il gruppo = бo formato da e dall’o interno ad esso, potremmo leggere emбos. In verità non ricordo di avere visto una tale legatura in altre iscrizioni, ma è ettestata alcune volte la legatura, concettualmente affine, = ro, con o dentro r.
Insomma, questi sarebbero gli esiti delle possibili modifiche di un originario o nella terza riga:
>
>
o > б > бo o/e bo
Nella 3a riga, dopo emб(o)s, è leggibile ir. In grafia friniate le forme
modello di r sono e P: qui abbiamo la forma intermedia . Non è chiaro se r
sia stato rifatto nella forma in dimensioni maggiori contenenti il più piccolo
(7) Seguo la convenzione grafica adottata in Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre
antiromane cit., p. 2 (convenzione basata sulla somiglianza grafica e non sul valore fonetico di б/Б nell’alfabeto russo).
8
o se il tratto curvo di ciò che può sembrare un appartenga ad una grande linea sinuosa, avente la forma di un S retrogrado, estranea all’iscrizione.
Nella 4a riga il primo termine appare come iui: il secondo i parte dalla riga su cui sono posti gli estremi superiori del primo i e di u, ma è più breve ed è sulla stessa verticale della gamba destra di . Sulle prime pensai che iui corrispondesse a ivi «unisciti» delle iscrizioni friniati (8), sebbene la frequentissima base friniate *iv- sia sempre scritta con v, mai con u: mi sembrava che fosse stata adottata una grafia latina (in pochi casi, riguardanti altre parole, si ha u invece di v) e che V denotasse /v/. Ma poi notai che in friniate /iui/ potrebbe corrispondere agli imperativi latini iuga, iunge. Infatti le coniugazioni friniati sono variabili, gli imperativi 2a sing. in -i sono frequenti e soprattutto /g/ svanì prima dell’uso della scrittura: non c’è nessun segno per g, mentre sono numerosi i lessemi che occorre ricondurre ad una radice indoeuropea terminante in g o g
h. Insomma, iui significherebbe «unisciti», perché rifletterebbe /iui/ < /*i̯ugi/ e non per una equivalenza grafica (u per v) con friniate ivi (9).
Dopo iui c’è un gruppo di segni: l’analisi epigrafica mi porta a ritenerlo formato da legature ri dei tipi comuni , R parzialmente sovrapposte: se ne possono contare otto. Un tale gruppo fu eseguito intenzionalmente nello stesso momento: la serie dei ri doveva comunicare l’idea espressa dal termine: «légati, vìncolati». Infatti ri è un sinonimo di iui «unisciti». Ad Ospitale è attestato riom «legaccio, vincolo» (10); a Rovinamala (nel comune di Montecreto, Appennino modenese) abbiamo riiom o riimo (la legatura finale
vale sia om sia mo) e riom «legame, vincolo, lega», plur. ria (11).
(8) Sono attestati: gli imperativi 2
a sing. iv < ivi, ive, iva, ivli, 2a pl. ivite; i presenti
indicativi 1a sing. ivom > ivo, ivilo, ivalio, 1a pl. ivemus, ivumus, 3a pl. ivunt; il congiuntivo esortativo 1a pl. ivamis e i necessitativi ivila, 1a pl. ivimila > ivimla. Come nomi abbiamo: iva
(femm. abl.), ive (dat.) «unione», iveom (nom. neu.) e ivem, ivom (acc.) «unione», ivisus (acc. pl.) «unioni», ival = ivul «compagno» (voc.), ivali (nom. pl. alla latina), ivalis (dat. pl.).
(9) Secondo A. Zavaroni, Apporto di alcuni lessemi nordumbri di Ospitale alla ricerca
etimologica di termini indoeuropei ed etruschi, «IF» 116 (2011), pp. 229-231, la base friniate *iv- sarebbe l’esito, per affievolimento e scomparsa della nasalizzazione, del passaggio *iv- < *ig
hw- < *H
ng
h-w- di un ampliamento in -w- di *Hǝ
nG- (G- qualsiasi occlusiva velare)
«stringere», radice che avrebbe dato luogo anche a quelle che J. Pokorny, Indogermanisches
Etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Bern - München 1959, formula come 1. angh- «eng; einengen; schnüren»; 2. ank- «Zwang, Notwendigkeit»; 3. *onogh-: ongh-, nogh-, kelt. ṇgh- «Nagel, Kralle, unguis» < «che serra, stringe». Come esempi dello sviluppo *-
ngh-w- > -v- e *-
ngwh- > -w/v- Zavaroni cita acymr. eguin, ewin = air. ingen «nail» (< ie. *h3ṇgh-w-) e mcymr.
tauawt da protocelt. *tangwāt < ie. *dṇgh-weh2- «lingua» (cf. alat. dingua). In tauawt u vale /v/ (mod. cymr. tafod; vedi K. McCone, Towards a Relative Chronology of Ancient and
Medieval Celtic Sound Change, Maynooth 1996, p. 40). (10) Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit. p. 219. (11) C. Beneventi - A. Zavaroni, Le pietre della memoria. Antiche iscrizioni nell’Alto
Frignano, Pavullo 2015, pp. 104, 112, 166-167, 169. Nelle pareti di due edifici ora cadenti di un borgo chiamato Rovinamala furono incastonate numerose pietre di recupero su cui sono incise scritte in lingua e grafìa friniate. Il recupero di pietre con antiche iscrizioni e rappresentazioni religiose si verificò anche in altre località dell’Alto Frignano.
9
Sul Ponte d’Ercole (12) c’è, non connessa ad altre di quell’area, una scritta RIMO: leggendo le lettere come latine possiamo supporre che significhino rīmō «fendo, rompo» (verbo non deponente in Pacuvio), mentre in grafìa friniate abbiamo riimo «lego, vincolo». Non sono rari esempi simili di doppia lettura con significati opposti, spesso ottenuti con l’aggiunta di uno o due tratti incisi meno profondamente che mutano la legatura e quindi il senso della scritta. D’altra parte, poco lontano da RIMO, si leggono di nuovo rimom e riimom con l’ulteriore aggiunta di segni che inducono a leggere pure ritumnom (da *rei-to- «inciso, tagliato, scisso») (13). La base *ri- (*rī- < *rii̯- < *rigi- < *rei̯g-i̯-) è riconducibile a *rei̯g- «legare», radice produttiva in celtico e germanico e presente anche in lat. corrigia «laccio da scarpe, correggia».
2. Il nome Boios Mogontios è certamente gallico e la notorietà dei due termini rende superfluo ogni ulteriore commento (
14). Ovviamente non si può
stabilire se Boios indichi una persona appartenente ai Galli Boii che abitavano
anche nell’Appennino Bolognese, ma il senso complessivo dell’iscrizione rende plausibile una tale ipotesi.
Il nome Tommos richiama Tommo (dat.) di CIL, V, 381 (Eraclea Veneta,
Cittanova), il presumibile [T]ommus di CIL, V, 417 (Buje, in Histria) e
Tommonis (gen.) di AE 1996, 708 (Noale, Altinum). Per Vacara gli unici raffronti plausibili sono con Vacarus (AE 2010,
00109; Kupa/Sciscia, Pannonia Inferior), Vacarra[---] (CIL, XV, 3902;
Roma), Vacer (CAG-52-02, p. 148; Belgica). Forse c’è un nesso con lat. vacerra «palo, ceppo» > «insensato, stupido, pazzo, furioso».
Come si è visto, il terzo termine della 2a riga è leggibile come embos se si
considera un trattino arcuato dentro la gobba inferiore di b. Comunque la scritta originaria sembrerebbe essere imos. La possibilità di tali sovrapposizioni e di più letture apparirà probabilmente strana a chi non abbia mai visto le iscrizioni friniati, ma in realtà il numero delle iscrizioni friniati con modifiche ‒ dovute a vari motivi, ma per lo più causate da sovrapposizioni tendenti a fornire due o più letture, a volte perfino con significati opposti ma logicamente legati al contesto ‒ è nettamente superiore a quello delle iscrizioni che ammettono una sola lettura. A volte l’ambivalenza del messaggio era cercata con ingegnose modifiche. L’ambivalenza, la multiformità, la ciclicità sembrano
(12) Il Ponte d’Ercole o Ponte del Diavolo è una roccia lunga 44 metri, larga meno di 3 metri, modellata in forma di ponte, situata quasi al centro dell’attuale Frignano. Presso di esso furono trovati vari reperti fra cui numerosissime monete romane, alcune delle quali risalenti al II secolo a.C. In una cella ricavata nella testata settentrionale del ponte furono incise le figure di due divinità sovrapposte una delle quali doveva rappresentare un deus puer. Vedi A. Zavaroni, Il sacro Ponte d’Ercole (Ponte del Diavolo). Iscrizioni religiose e antiromane degli
antichi abitanti del Frignano, Pavullo 2012 (con DVD contenente 368 immagini relative alle scritte e alle incisioni figurative).
(13) Lettura non rilevata da Zavaroni, Il sacro Ponte d’Ercole cit., p. 64. (14) Per l’etimologia di Boios vedi ad esempio X. Delamarre, Dictionnaire de la langue
gauloise, Paris2 2003, p. 83. Notoriamente la base celtica *mog- di Mogontios, Mogetios,
Mogenios ecc. deriva da ie. *meĝ(h)- «potenza». Per i nomi divini con base *mogont- «che potenzia, ingrandisce» vedi C. Sterckx, Taranis, Sucellos et quelques autres. Le dieu souverain
des Celtes, de la Gaule à l’Irlande, Bruxelles 2005, p. 418.
10
infatti essere alla base delle idee filosofiche e religiose dei Friniati. L’elevato numero di legature non canoniche, spesso concernenti più lettere o un intero termine, era generalmente dovuto alla volontà di mutare un messaggio già scritto e alla necessità di usare gran parte dei tratti esistenti; più raro appare il desiderio di giocare sull’ingegnosità degli espedienti grafici. In qualche caso le soluzioni grafiche ambigue sono dovute a problemi fonologici o grammaticali: ad esempio si trovano sovrapposizioni di o ed u probabilmente per denotare un o chiuso o delle varianti dialettali, mentre le sovrapposizioni fra -am ed -em finali sono dovute anche al sincretismo delle terminazioni ed alla aleatorietà delle declinazioni.
Pure la possibile variazione embs / embos della 3a riga potrebbe essere di ordine dialettale: embs sarebbe l’esito della caduta di o in *emбos, come in friniate Drumbos > Drum(b)s, ilims < *ilimos (ilimos non è attestato, ma lo è il suo equivalente ilemos) e come regolarmente avvenne per i nomi della 2a declinazione in umbro e osco. D’altra parte in friniate il gruppo mб, che si alterna con mb, dovrebbe teoricamente denotare una pronuncia più antica: in vari lessemi b è l’esito del passaggio б (/b
h/) > b dovuto alla deaspirazione,
certamente influenzata dalle parlate dei vicini Galli. Nelle iscrizioni friniati vi sono numerosi termini riconducibili ad una
radice *HəmB-, grado zero *H
mB-, «unire; insieme; coppia; l’uno e l’altro» (H
= qualsiasi laringale; B = qualsiasi occlusiva labiale) che ha parecchi sviluppi, fra cui *amb(h)-, *emb(h)-, *imb(h)- e, per caduta della labiale a causa di una maggiore enfasi sulla nasalizzazione (15), *am-, *im-, *um-, attestati pure in friniate. Nelle lingue italiche, celtiche, germaniche non tutti i suddetti sviluppi sono presenti.
Nelle iscrizioni friniati vari sostantivi esprimono «insieme, unione, compagnia, comunità»: emba (abl.) emбam (acc.), imba\
em, umбa(m) = umbam,
umбem, umбiam (acc.), umбei (gen.?), umбe (dat.), umбi (loc. o/e dat.?) (16), il frequentissimo umua e anche imla (abl. o acc. con omissione di -m), imisia
(abl.) e probabilmente imuem (acc. sing.). A questi termini della 1a e 3a declinazione va forse aggiunto emбom
di una scritta di Ospitale in cui la legatura om fu eseguita (intenzionalmente?) in modo che non si può escludere la lettura am (17). Qui emбom è l’oggetto di ul «fai crescere» e può essere
(15) L’enfasi sulla nasalizzazione, rendendo instabile il modo di articolazione, avrebbe
causato ora la variabilità della labiale ora la sua caduta. Questa tesi è espressa in A. Zavaroni, I-E. “apple”, Hamito-Semitic “genitals” and roots beginning with *HmB-, «HSF» 120 (2007), pp. 20-41; Id., Unione compagnia strumento: ie. HmB-i, bi, pi, mi (> etr. pi), «HSF» 120 (2007), pp. 42-62; Id., Germanic words for ‘heaven’, ‘haven’, ‘together’, ‘good’, ‘god’: in
search of IE roots, «IJLSA» 10,2 (2005), pp. 187-201; Id., Prenasalized stops and possible
semantic developments from ‘bite’ to ‘take’, «IJLSA» 12,2 (2007), pp. 277-302; Id., Lat. pēnis, pars, membrum, maritus e la radice *HmB- “insieme, pari”: ricerche semantiche, «Latomus» 70-1 (2011), pp. 1-17.
(16) La terminazione del dat. sing. si presenta come -e ed -i, ambedue sviluppi di un precedente -ei.
(17) In una scritta poco leggibile del sito La Tana di Ospitale la lettura emбam mi sembra preferibile a emбom (lettura proposta in Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit. p. 131).
11
interpretato come «(bene) comune» oltre che come «unione». Sulla pietra R1A9 di Rovinamala nella riga superiore, leggo iti imbos i piuttosto che iti
imbom i (18); quindi interpreto iti imbos i come «procedi compagno!, su!», dato che il vocativo in friniate non è distinto dal nominativo. La forma iterativa iti (cf. lat. itō) è attestata parecchie volte.
In conclusione, le forme della 2a declinazione imbos, emбos, imos sembrano significare a volte «compagno» e altre volte «compagnia, comunità, bene comune». Quindi sarebbe giustificato supporre che emбos e il possibile emбs (nom. voc. sing.) della Buca del Diavolo non denoti «unione», ma «compagno, congiunto, appartenente alla comunità», sebbene la maggior parte dei nomi friniati con questo senso abbia un formante -l- (imul, imel, imal, umul, umol, simul, simil, samul, emбuli (nom. pl. latineggiante), semulos (nom. e acc. pl.) ecc. Altri dati confortano l’interpretazione di emбos come «compagno, appartenente alla stessa etnìa».
Come si è visto nel § 1, è probabile che embos della 2a riga e emбs o/e emбos della 3
a riga fossero stati incisi ognuno su un più antico imos. Questo
sostantivo non pare attestato ad Ospitale, sebbene i termini derivati da *im-
siano abbastanza numerosi, né al Ponte d’Ercole. Ma sulla pietra R1C6 di Rovinamala imom è l’oggetto di un verbo che mi sembra essere sturi «rafforza» piuttosto che stri «stringiti a» (+ accus.?) (19). Sulla pietra R1B5 è incerto se si debba leggere imo o simo, non essendo chiaro se sia intenzionale
una sorta di lieve baffo che attraversa l’asta di i: se il segno fosse , potrebbe
essere una legatura si e avremmo simo che comunque è un sinonimo di imo,
perché deriva da *sem- come lat. simil, friniate simil, acc. pl. similus, gen. pl. similom «compagno, -i», simiom > simio «mi unisco» ecc. (20). Il lieve tratto intersecante potrebbe essere stato aggiunto in un secondo tempo.
imo o simo (dativo o accus. con omissione di -m?) è retto dall’imperativo streбi riconducibile a *strei-b
h- «tender(si) verso, protendere, aspirare a» (cf. ted. streben). Se il senso di streбi fosse questo, negli esempi di Rovinamala imo- non denoterebbe «compagno», ma piuttosto «comunità, bene comune».
D’altra parte il termine gallico imon, della 2a declinazione, a mio avviso vale «membro virile» e più in generale «ciò con cui ci si congiunge». Questo termine appare nella scritta su fusaiola da Saint-Réverien (Nièvre) moni gnata gabi / buđđutton imon che interpreto in questo modo: «vieni, ragazza, prendi il tumescente membro»: buđđutton significherebbe «tumescente» (21).
(18) La lettura e l’interpretazione iti imbom i «vai, all’unione procedi» sono date in
Beneventi - Zavaroni, Le pietre della memoria cit. p. 98, dove però non si è notato che la legatura om appartiene ad una differente redazione della scritta, che è iti bomi «vai (> su!) vieni». Un’appendice a destra sulla sommità di o, più profonda del tratto denotante m, dà luogo alla lettura os.
(19) In Beneventi - Zavaroni, Le pietre della memoria cit. p. 107 è data la lettura stri
imo(m). (20) Per i derivati da friniate *sim- vedi Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit.
p. 221. (21) A buđđutton attribuisco la radice di ir. bod «penis»: in molte lingue i termini con
questo senso derivano da radici che esprimono «gonfiore, tumescenza». P.-Y. Lambert, La
langue gauloise, Paris 1995, p. 123, traduce l’iscrizione così: «Ma fille, prends mon petit
12
Ritengo che in gallico dalla base *im- derivi anche imi, scritto su un’altra fusaiola. Considero errata la tesi secondo cui imi equivarrebbe a ιµµι «io sono» di un’iscrizione gallica vascolare scritta in caratteri greci (vedi sotto). Alcune fusaiole trovate nell’Est della Francia recano delle iscrizioni sia latine sia
galliche (22). Come nota Lambert, «ces objets portent des souhaits ou de
compliments amoureux» e «devaient être donnés en cadeau par des galants dont les intentions sont claires» (
23). Su una fusaiola trovata a Sens si legge
geneta imi / daga uimpi. Lambert traduce così: «Je suis une jeune fille bonne et
belle» (24). Anche Lejeune (
25) assimila imi ad ιµµι che in un’iscrizione
vascolare gallo-greca (G-13) vale incontestabilmente «io sono» (< *es-mi). Nelle altre iscrizioni su fusaruole, però, il verbo non è mai una prima persona
avente per soggetto la giovane a cui l’iscrizione è indirizzata. Si ha una 1a
persona nell’iscrizione marcosior maternia «puisse-je chevaucher les organes maternels» (
26), dove il soggetto è il donatore della fusaiola e non la
destinataria. Quindi ritengo più probabile che imi sia una voce verbale esortativa come gabi «prendi», da «dona, dà», vis «vuoi» > «consenti», ACCEDE, AVE etc. In tal caso, visto il contenuto di tali iscrizioni, il senso più probabile per imi sarebbe «copula, congiungiti», dalla radice sopra menzionata
*H)mB- «unire» con perdita della labiale a causa dell’enfasi sulla nasale. Sull’esempio di gallico imon (acc. sing.) ritengo possibile che i sostantivi
friniati imos, emбos, embos (> emбs, embs?) possano indicare «che si unisce > compagno, socio, amico» oltreché «compagnia, comunità, bene comune».
Anche gr. ������ ha questi significati: «partecipe, compagno, congiunto (di sangue, della stessa etnìa); comune» e, al neutro, «comunità, cosa pubblica, società» ecc. Mentre nella citata scritta di Rovinamala imom pare essere un neutro, qui nella Buca del Diavolo è sulle prime dubbio se imos ed emбos siano un nominativo sing. (come lo sarebbe emбs) o un accusativo plur. della 2a declinazione (27).
Nella 3a riga ir può essere soltanto un imperativo 2a sing. con apocope (che sembra facoltativa in molti imperativi friniati) della vocale finale -i o -e. Nelle iscrizioni di Ospitale sono attestati gli imperativi 2a sing. con diversa coniugazione iri e ira. Dalla base *ir- si formò *irm-, da cui derivano gli imperativi 2a sing. irma e irmi (28). Sul Ponte d’Ercole sono leggibili il presente
[baiser? pénis?]». W. Meid, Gaulish inscriptions, Budapest, 1994, p. 53, propone «Come here,
girl, take my little kiss». (22) Vedi M. Lejeune, Notes d’étymologie gauloise II. Gaulois VIMPI et I(M)MI. «EC»
XV, 1, 1976-77, p. 96-103; W. MEID, Gallisch oder Lateinisch? Soziolinguistische und
andere Bemerkungen zu populären gallo-lateinischen Inschriften, Innsbruck 1980; Lambert, La langue gauloise cit. pp. 122-125.
(23) Lambert, La langue gauloise cit., p. 123. (24) Lambert, La langue gauloise cit., p. 124. (25) Lejeune, Notes d’étymologie gauloise cit., pp. 103-104. (26) Mi sembra valida questa interpretazione proposta da Lambert, La langue gauloise cit.,
p. 124. (27) Un prospetto delle terminazioni di varie declinazioni ed altri elementi di grammatica
sono dati in Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit. pp. 183-196. (28) Per le attestazioni di queste forme da *ir- e *irm- si veda Zavaroni, Le iscrizioni
nordumbre antiromane cit., p. 211, da cui sono presi gli esempi qui riportati.
13
indicativo 1a pl. irmomus, l’imperativo ire e il termine irum la cui morfologia è incerta perché esso non è collegato con le scritte circostanti che hanno altri orientamenti e lettere di dimensioni nettamente minori. I contesti inducono ad attribuire a *ir- e *irm- il senso «potenziar(si), rafforzar(si), ingrandir(si)» (29). Occorre notare che nelle iscrizioni friniati i casi di verbi accompagnati da un pronome riflessivo sono soltanto tre, ma in tanti altri casi l’interpretazione richiede un verbo riflessivo italiano. Ciò vale, ad esempio, con verbi indicanti «ingrandirsi, potenziarsi, rafforzarsi», «gettarsi», «applicarsi», «sollevarsi» ecc. che non sono associati ad un oggetto.
Nella scritta TaBMrO6 della Tana di Ospitale si legge iri tlebumis semua:
tlebumis semua significa «sosteniamo (esortativo) l’unione» se semua sta per semuam (a volte -m finale dell’accusativo è omesso) o «sosteniamoci con l’unione» se semua è un ablativo (30). Quindi appare idoneo attribuire a iri il senso «poténziati». In TaAR8A irmi precede la sequenza seli ele ilsie sisi
«favorisci spingi nella rivolta géttati» (31): anche qui il senso «potenzia(ti)» sembra idoneo. In TaAR5B1 ira, che pare modificato in irma, segue ise (da *h1eish2- «muover(si) con forza, essere potente, forte, smaniare»). Mi sembra convincente comparare le basi friniati *ir-,*ir-m- con germ. *ermana-, *irmin-
«possente, grande», aat. ernust «vigor, animadversio, Energie, Ernst». Tornando all’iscrizione in esame, l’imperativo ri della 4
a riga è, come si è
visto sopra, la forma contratta di rii che, come riimo e riiom > riom «vincolo, lega», è riconducibile alla radice *rei̯g- «legare». Quindi ri è interpretabile come «légati, aderisci, assòciati». Come si è detto sopra, il gruppo di almeno
otto legature ri (Fig. 2) è disposto in modo da suggerire l’idea di un fascio, di
una lega. 3. Dall’esame epigrafico ricavo l’impressione che il nucleo primitivo della
scritta fosse Mogontios / Vacara / imos / iui «Mogontios (e) Vacara (sono) compagni (> soci): unisciti». Qui imos sarebbe un nominativo plurale con desinenza -os al posto del più frequente -us. Non è possibile stabilire se in friniate fosse usato un verbo «essere» in proposizioni le cui corrispondenti in lingue indoeuropee moderne come l’italiano, il francese ecc. lo richiedono. La sola voce, neppure sicura, del verbo «essere» presente nelle iscrizioni friniati è sont, associata al participio passato neutro pl. rotuta «ruotati». Coi numerosi necessitativi in -la, -li e -le non c’è mai un verbo «essere». Ho contato cinque casi in cui è omesso quel che per noi è il verbo «essere» come copula.
(29) In Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit., p. 210, è proposto il senso
«sostenere, essere di sostegno»; ma a p. 154 il necessitativo irmila è interpretato come «bisogna rinforzarsi»; a p. 165 irma, che segue stilpa бiri «sostieni consolida», è tradotto con «assicura».
(30) La base *tleb- <*tleб- è riconducibile a *telh2- «sollevar(si), sostener(si)». Il tema friniate nominale e verbale *semu- deriva da ie. *sem- > *sṃ- «unità, insieme».
(31) L’imperativo seli deriva da *selh2- «essere propizio, favorire»; ele da *h1elh2- «muover(si), spinger(si)»; sisi da *seh1- «gettare, seminare, spargere». Per la base *il-s-, ampliamento di *il- «volgere», vedi Zavaroni, Apporto di alcuni lessemi nordumbri cit. p. 245 ss.
14
In un secondo momento sarebbero stati aggiunti gli appellativi Boios
davanti a Mogontios, Tommos davanti a Vacara, imos dietro Vacara e nella terza riga si sarebbe mutato imos in emбs. In tal caso avremmo: «Boios Mogontios / (e) Tommos Vacara (sono) soci: / compagno! / unisciti». Poi imos
della 2a riga sarebbe stato trasformato in embos e emбs della 3a riga in emбos che sarebbe la forma normale non ridotta di nominativo e vocativo singolare. Infine sarebbero stati aggiunti ir «raffòrzati» nella 3a riga e il fascio dei ri
«collégati, vìncolati» nella 4a riga. 4. Al livello della 3a riga dell’iscrizione commentata nei paragrafi
precedenti, dopo ir, ci sono altre lettere e sotto di esse si nota un gruppo di segni sovrapposti in modo abbastanza simile al fascio di ri visto sopra (Fig. 3). Nella riga superiore le lettere sono molto ravvicinate e sviluppate più in altezza che in larghezza.
Fig. 3. Il gruppo di segni con la scritta ur uibri бustri i.
Fig. 4. Riproduzione della scritta ir (piuttosto che ur) uibri бustri i. La riga superiore è riprodotta in modo più visibile in Fig. 4, dove si può
meglio notare che parecchi tratti devono alludere ad armi da taglio. La riga contiene le legature (valore incerto: ir o ur), = ri e = ustri che raggruppa
per sovrapposizione le legature, consuete tra le iscrizioni friniati, = us, =
str e = ri. Complessivamente si legge ir (meno probabilmente ur) uibri бustri i. Non ho trovato la legatura in altre iscrizioni. Le legature ur più
usuali sono , , , . Quindi mi sembra più probabile che denoti ir, con r di tipo addossato all’asta dell’i leggermente inclinata. La presenza di ir nell’altro gruppo di scritte rafforza questa interpretazione. L’eventuale ur sarebbe un imperativo, più volte attestato, significante «sorgi, sollévati», da *h3er- / *h3�- «metter(si) in moto, spinger(si) su, sollevar(si)».
15
L’imperativo uibri è presente soltanto qui, ma la base *u̯iб- > *vib- (< da *u̯eib-) si trova in alcune iscrizioni di Ospitale, dove abbiamo gli imperativi 2a sing. uiбi, viбa, viбe, gli indicativi presenti 1a sing. uiбiom e uiбom, il congiuntivo esortativo 1a pl. uibumis e l’indicativo futuro sigmatico 1a sing. uibiso (32). Come le basi friniati *vemб- e *vip- anche *uiб- denota «scuotersi, agitarsi». Suppongo che uibri della Buca del Diavolo abbia la griglia semantica di lat. vibrāre.
Gli imperativi бustri «picchia, fustiga» (da bhaud-sti-, da cui si ha pure lat.
fūstis: la radice è *bhau- «picchiare») e i «vai, su!» sono interpretabili con
certezza. Sotto la scritta ir uibri бustri i c’è un gruppo di segni molto più alti, fra
loro sovrapposti: nella maggior parte sono interpretabili come lagature ri «légati, assòciati», ma nello spigolo in basso a destra la composizione contiene dei tratti che potrebbero appartenere ad una figura o/e ad una legatura multipla che non so interpretare. Vi si nota un lungo T che forse fa parte di una parola non discernibile in modo sicuro.
4. A destra del gruppo di ri di maggiore altezza ci sono altre iscrizioni in
grafia friniate grosso modo disposte su tre righe (Fig. 5).
Fig. 5. Terzo gruppo di scritte in grafìa friniate.
Nella riga superiore sono presenti le legature (vedi sotto), = om, simile a di Rovinamala e ai tipi = = = = = di Ospitale (sono attestati parecchi altri tipi, parte dei quali può denotare anche mo), e = ut (rara rispetto a , , ecc.). Nella riga inferiore sono presenti le legature = umu e forse = am (vedi sotto).
(32) Cf. Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit., p. 229.
16
Nella riga superiore il primo segno assomiglia ad un D latino (ma r in friniate) molto largo. A ben vedere, però, a sinistra non c’è un tratto verticale unico, bensì due: il secondo è molto più profondo (e con spessore variabile) rispetto a quello anteriore che è meno inciso. Ritengo quindi che sia una legatura ambigua, come lo sono tante legature e in particolare quelle in cui i è sovrapposto a c o s:
= = = = ci e ic ; = = = = = = = is e si.
Analogamente potrebbe valere sia ri sia ir. Essa richiama il tipo = ri che appare nel termine riom scritto su una pietra di recupero di Rovinamala (33). Mentre sulla pietra di Rovinamala riom significa «legaccio, vincolo», ma allude al «legaccio» imposto dal dominio romano (34), qui ha il senso di «lega, alleanza», presumibilmente contro Roma, anche se l’odiata nemica non è citata.
Tuttavia, potremmo interpretare anche come ir e leggere il primo termine come irom, attribuendogli il senso «rafforzamento» (vedi ir «raffòrzati» nel § 2). Ovviamente si tratterebbe del rafforzamento dovuto all’unione, alla lega.
Dopo riom o irom si nota un punto; poi si legge iussut abbastanza agevolmente. Questo termine non è attestato in altre iscrizioni friniati e sembra un adattamento di latino iussit al perfetto friniate in -u-t nella 3a sing.: cf. iluut, vemбut, stoudrut, ureuvut (35). Non si può accertare se il tema *iuss- sia un imprestito dal latino: in ogni modo non ho riscontrato altri esempi di -ss- nelle iscrizioni friniati.
La sequenza riom iussut è dunque interpretabile come «legame (> unione, alleanza’) ha comandato», mentre irom iussut è interpretabile come «il rafforzamento ha comandato» Il soggetto non è espresso, ma dopo iussut è ricostruibile, seppure in modo incompleto, una figura antropomorfica che molto probabilmente rappresenta un dio che solleva una grande ascia e pare affiancato da un cane o da un lupo. In altre iscrizioni un dio è il soggetto di ammonimenti, ordini e presagi che esortano all’unione contro i nemici (36).
La riga inferiore potrebbe essere stata modificata. Si possono individuare le legature = umu e = am su cui però grava l’incertezza dovuta alla
(33) Beneventi - Zavaroni, Le pietre della memoria cit. p. 169. (34) La scritta è riom sluim luom «il legaccio debilitante sciolgo». Per l’accusativo sluim
l’ipotesi più plausibile è che rifletta un tema aggettivale *slugi- derivante da una radice *sleu-
g- «schlaff, allentato» (Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch cit. p. 962); ma *slugi- dovrebbe avere un senso attivo: «che infiacchisce».
(35) Esistono, però, anche le forme in -v-it, -u-i-t: cf. dulbavit, druvit, uruuit e forse oruit, ostiuit. Vedi Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit., p. 189.
(36) Vedi A. Zavaroni, Profezie e incitamenti attribuiti a divinità tra le scritte antiromane
dei Friniates, all’indirizzo https://www.academia.edu/10100486/.... Secondo l’A. una delle scritte esaminate sarebbe così leggibile e interpretabile: imбutus semбuli osit/osut «(che) i congiunti si devono unire (il vate [menzionato nella riga soprastante]) divina/ ha divinato». Imбutus sarebbe formalmente un participio passato passivo sostantivato plurale e semбuli un necessitativo plurale in -li con consueta mancanza della copula.
17
mancanza del trattino intermedio di a ed ai diversi spessori dei tratti coinvolti. Su am sarebbe stato sovrapposto un tratto verticale più spesso e profondo (vedi oltre). Anche i tratti della legatura = umu non hanno uno spessore e una profondità uniformi: quelli denotanti u sembrano apposti ad un precedente = mu. In ogni modo è leggibile come umuam che sarebbe l’oggetto del successivo imperativo iv (con v del tipo соmе іn vacara) «stringiti, congiungiti» (37). Il senso di umua, accus. umuam ‒ parola molto frequente e spesso realizzata in un’unica legatura ‒ è «lega, unione». Siccome il verbo ivom, come gli altri verbi denotanti «unir(si)», regge ora l’accusativo ora il dativo, umuam iv è interpretabile come «alla lega unisciti» (38).
A sinistra rispetto alla legatura c’è un tratto verticale profondo incorporato in un segno complesso: considerando anche il tratto profondo, il segno è interpretabile come una legatura = idr, attestata anche ad Ospitale, connessa con il segno interpretabile come una legatura denotante uis, la cui forma sarebbe dovuta anche all’intenzione di alludere ad una falce o ad un arpione. Il termine idruis sarebbe il presente indicativo 2a sing. di un verbo di cui ad Ospitale è presente la 1a pl. idrumus. Ad Ospitale sono attestati anche un imperativo 2a sing. idre ed un congiuntivo esortativo idremis (39), mentre al Ponte d’Ercole si ha il presente indicativo 3a sing. idruit ed il presumibile futuro sigmatico 3a pl. idrusant (40). La base *idr-, così come *id- e il derivato *idur-, denota «crescere, ingrossar(si), irrobustir(si), riempir(si)», la radice essendo *h2ei̯d- «gonfiar(si), crescere, ingrossar(si)».
Dopo idruis si legge ui che, come in altri casi, sta per vi, ablativo di vis «forza, violenza». Quindi idruis ui significa «ingrandisciti con la forza».
Ma come si è detto sopra, il tratto verticale superiore della legatura = idr è molto più profondo. Inoltre dalla sua estremità inferiore si leva un trattino obliquo, facente parte della sommità di r, anch’esso più profondo degli altri tratti della legatura. I due tratti profondi danno luogo ad un l di forma che sarebbe stato inciso per formare un termine comprendente anche la legatura umu e il tratto profondo sovrapposto alla legatura am. Insomma, si può leggere lumui interferente con umuam. Dalla base friniate *lum- (da ie. *lemH-, causativo *lomH- «rompere, spaccare») derivano numerosi termini, fra cui i presenti indicativi 1a pl. lumuomus e lumumus e l’epiteto divino lumuar «Spaccatore» di un dio assimilabile al gallico Sucellos. Forse lumui è il dativo (o locativo?) di un sostantivo *lumuis «strage, caedes», nel qual caso lumui iv
significherebbe «unisciti alla (o: nella?) strage». La scritta sarebbe correlata con idruis ui «ingrandisciti con la forza». Occorre notare che solchi
(37) Per la base *iv- vedi le note 8 e 9. La formula umuam iv richiama ive umuam di Ospitale (vedi Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit., p. 83).
(38) La base *umu- è un ampliamento di *um- «unione, lega; unirsi», forma equivalente ad *am- e *im-, dal grado zero *H
mB- di *Hə
mB- «unione, insieme, pari» (B = qualsiasi
consonante labiale), di cui si hanno vari sviluppi (vedi nota 15). L’enfasi nella nasalizzazione produsse un passaggio *H
mB- > *Hmm- > *Hm- > *im-, *um-. Ad Ospitale è presente
parecchie volte anche la base *umб- e su una roccia della Tana di Ospitale si ha la forma ummua dopo samo «mi associo».
(39) Vedi Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit., pp. 209-210. (40) Vedi Zavaroni, Il sacro Ponte d’Ercole cit., pp. 55 e 58.
18
profondamente incisi, a volte in forma di virgole, alludono a colpi inferti da armi da taglio. Qui il tratto verticale di l di lumui potrebbe avere una tale funzione.
5. I nomi Boios Mogontios e Tommos Vacara sono inseriti in un contesto
di iscrizioni in cui i lettori sono esortati all’unione, all’alleanza. I termini imos, embos, emб(o)s, iui, ri, riom, umuam, iv(i) non lasciano dubbi su questa esortazione. D’altra parte le scritte ur uibri бustri i «insorgi, vibra (i colpi), colpisci, su!» e idruis ui «ingrandisciti con la forza» specificano che l’unione o alleanza ha scopi bellici.
Dunque, è possibile che Boios Mogontios e Tommos Vacara siano i capi di un tentativo d’insurrezione locale, verosimilmente contro Roma, come il Victor
Moccos menzionato in una scritta della Tana di Ospitale. Sulla Parete Nord-Est del grande Masso della Tana B si legge la scritta sieme / uic mocci / umбo che è così interpretabile: «alla lega / di Vic(tor) Moccus / mi associo» (41). In verità potrebbe essere dubbio se il verbo sia sieme o umбo. Infatti *siem- e *umб-
denotano concetti affini. Come si desume da altre scritte, la base *siem- deriva da *sh2ei̯- «legare» (42). In un’altra scritta della Tana di Ospitale, una primitiva scritta = siemumila fu mutata in = sieme umila (43), il cui senso può essere soltanto «alla lega bisogna unirsi». Ne deduco che sieme è il dativo (< *siemai) di un femminile *siema e non un imperativo 2a sing. «légati».
Quanto a umбo, dalla base *umб- parallela ad *emб- e *imб- (< *HəmB-) denotante «unirsi, unire, unione, lega» (44), derivano verbi e sostantivi. Tra le voci verbali il presente indicativo 1a sing. umбo è attestato più volte ed esiste pure la forma umbom. Sono poi presenti le forme nominali umбa < umбam = umbam, umбem, umбiam (acc.), umбei (gen.?), umбe (dat.), umбi (loc. o/e dat.?) «unione, lega», mentre un sostantivo della 2a declinazione *umбos >
*umbos non è attestato. Insomma, è meglio supporre che umбo sia un presente indicativo 1a sing.
Una buona parte delle iscrizioni della valle dʼOspitale fu incisa durante il bellum sociale del 91-89 a.C. In un’iscrizione sulla Parete 2 della Sega sono menzionati gli Osci, la lega degli Italici e il console romano Pompeo Strabone
(41) Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit., p. 174. (42) Per la radice vedi Lexikon der Indogermanischen Verben. Die wurzeln und ihre
primärstammbildungen, unter Leitung von H. Rix. Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage bearbeitet von M. Kümmel und H. Rix, Wiesbaden, p. 544. A questa radice sono riconducibili: 1. siemo «legaccio, vincolo» che sembra un nominativo neutro in una scritta e un accusativo con omissione di -m (neutro? maschile?) in un’altra; 2. siemos (accusativo plur., come se il nome fosse masc.); 3. siema che funge da oggetto, ma non si può accertare, per l’aleatorietà delle declinazioni, se sia un acc. sing. femm. con omissione di -m o un neutro plurale; 4 siemala «bisogna legarsi» (necessitativo impersonale) e siemimla «ci dobbiamo associare» (necessitativo 1a plur.).
(43) In Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit., p. 168, si suppone che siemimla possa essere sovrapposto ad un più sicuro siemumla: non si è notato che emu fu mutato in eme, che un piccolo u fu aggiunto davanti al secondo m e che invece di un semplice l c’è una legatura il legata con l’ultimo m, per mutare siemumila in sieme umila.
(44) Vedi la nota 38.
19
sconfitto dagli insorti (45). Il recente ritrovamento di iscrizioni friniati in diverse località dell’Appennino tosco-emiliano, tutte scritte con lo stesso sistema basato su un ampio uso di legature e con alcune lettere non di rado antropomorfizzate, inducono a dilatare lo spazio temporale entro cui le scritte potrebbero essere state incise. Lʼostilità verso i Romani durò certamente qualche secolo né cessò immediatamente con la fine del bellum sociale.
Molto importante, se venisse confermata da altri studiosi, sarebbe la menzione della Lega degli Italici, nelle forme vitelium, che sarebbe un genitivo-dativo plurale in -um (i due casi hanno sincreticamente la stessa desinenza in alcune scritte), e vitalios\
m (con -s e -m sovrapposti perche le parole che precedono il termine furono modificate e cambiò la sintassi della scritta: vitalios è un accusativo plur). Si tratterebbe di due varianti connesse con la legenda osca viteliú delle monete coniate dalla Lega italica durante la guerra sociale. I contesti friniati mostrerebbero che viteliú non ha alcuna relazione con lat. vitulus «vitello», come comunemente si legge (46), ma deriva dalla radice *u̯i̯eh1- di lat. vieō «lego», vītilis «intrecciato», vitta «fascia, benda», got. kuna-wida «Fessel», aisl. við, viðjar «gedrehtes Band» etc.
È impossibile stabilire se le iscrizioni della Buca del Diavolo presso Treppio furono incise durante il bellum sociale o in un altro periodo. Non credo che una datazione, anche approssimativa, possa dedursi dalla comparazione delle epigrafi e dalla presenza di lettere particolari come l’e di tipo II. In base ad una delle iscrizioni si può supporre che un Gallo, quale doveva essere Boios
Mogontios, era fautore di una lega, presumibilmente antiromana, insieme ad un’altra persona la cui etnìa non è deducibile dal nome. Ma il fatto che le iscrizioni siano incise secondo il sistema scrittorio friniate rende plausibile che dei Friniati fossero fautori della lega (47).
(45) Controllai l’iscrizione il 20 maggio 2015 e confermo la lettura e l’interpretazione date
in Zavaroni, Le iscrizioni nordumbre antiromane cit., p. 44. Come sappiamo da Appiano (Bell.
Civ. 3.40), Pompeo Strabone comandava l’esercito romano che operava contro i ribelli del territorio piceno durante il bellum sociale. In un primo tempo il suo esercito fu sconfitto dagli insorti guidati da Judacilio, T. Lafrenio e P. Ventidio, non altrimenti noti, che avevano unito le loro forze presso il monte Falerino. Gneo Pompeo dovette rifugiarsi a Fermo in attesa di rinforzi.
(46) Per la bibliografia relativa all’etimo di viteliú vd. J. Untermann, Wörterbuch des
Oskisch-Umbrischen, Heidelberg, 2000, p. 860. 47 Da iscrizioni della Valle d’Ospitale e del Ponte d’Ercole si deduce che i Friniates
chiamavano se stessi Ombri, Umbri. Sulla sommità del Ponte d’Ercole è scritta un’invocazione rivolta ad un dio affinché fosse propizio o/umbrali re «alla repubblica o/umbra». Sulle questioni che un tal etnico solleva vedi Zavaroni, Gli antichi abitanti del Frignano si
chiamavano Umbri, Ombri cit.

























![Terrorism, A Female Malady [on Segreti segreti and Diavolo in corpo]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63156614c32ab5e46f0d49c2/terrorism-a-female-malady-on-segreti-segreti-and-diavolo-in-corpo.jpg)