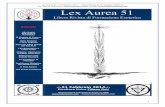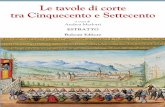Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
Transcript of Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
San Modestino e l’Abellinum cristiana
a cura di Sabino accomando
San
Mod
esti
no e
l’Ab
ellin
um c
rist
iana
9 7 8 8 8 9 7 1 7 4 0 0 4
Indice
PremeSSa ................................................................................................ 7
Vittorino GroSSi, Il significato della letteratura martiriale, ...................... 9
FranceSco marino, Anno giubilare di San Modestino................................. 13
raFFaele Farina, La Chiesa antica modello di riforma .............................. 19
SerGio Zincone, Le vie dei santi tra Antiochia e l’Italia: la Campania ..... 35
amalia Galdi, Chiesa, società e santità in Avellino medievale ................. 43
SerGio melillo, San Modestino tra Storia e Leggenda ............................ 59
andrea maSSaro, La devozione popolare per San Modestino San Flaviano e San Fiorentino ................................... 75
FranceSco barra, Scipione Bella Bona trastoriografiaepassionecivile ............................... 91
GiuSePPina ZaPPella, L'Avellino sacro di Scipione Bella Bona ............... 121
Paolo Peduto, La chiesa di S. Giovanni di Pratola tra le catacombe e la basilica dell’Annunziata di Prata ............................... 163
Gennaro PaSSaro, San Sabino, Vescovo di Abellinum, alla luce della storia ... 171
maria Fariello, Abellinum cristiana, gli scavi della Basilica ................ 205
Heikki Solin, Le iscrizioni paleocristiane di Avellino................................ 215
cHiara lambert, Archeometriaepigrafica: la sperimentazione di Abellinum .................................. 239
armando monteFuSco, Lo Specus Martyrum della Chiesa di S. Ippolisto di Atripalda ................................. 251
GiuSePPe muollo, L’arte nei luoghi simbolo della cristianità in Irpinia .. 261
VirGilio iandiorio, Il Monte Capitolino .................................................. 281
errico cuoZZo, La struttura diocesana dell’Italia meridionale altomedioevale e la nascita della diocesi di Avellino........ 297
marGHerita ceccHelli, Santi campani e culto romano ............................. 319
SilVana ePiScoPo, Aspetto del culto dei santi in alcuni centri della Campania .. 339
inSerto FotoGraFico .................................................................................. 369
indice analitico ......................................................................................... 401
215Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
Heikki Solin*
Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
Sua Eccellenza, Vescovo della diocesi di AvellinoPrima di entrare in argomento, desidero ringraziare sentitamente gli
organizzatori del presente convegno per avermi invitato a parlare del pa-trimonio epigrafico della cristiana Abellinum. Così sono stato spinto a ri-prendere il lavoro sulle iscrizioni cristiane abellinati che per troppo tempo è stato a maggese. Abbiamo cominciato, Mika Kajava e io, a schedare e fotografare questo consistente gruppo di documenti alla fine degli anni Ottanta dello scorso millennio, ma a causa di altre numerose incomben-ze non ho potuto ancora completare l’edizione cui attendo (anche Mika Kajava, per i suoi numerosi impegni quale docente di filologia greca, ha dovuto arrestare il lavoro dell’edizione). Ma ora, avvolto da sì gran nube di testimoni, confermo che essa è a buon punto e sarà terminata a breve. E ora che si avvicina questo momento, sento il dovere di ringraziare tutti coloro che mi hanno dato una mano nella preparazione del volume: in primo luo-go la Soprintendenza ai beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta; non è un fatto comune che la pubblicazione di una coerente serie unica di documenti epigrafici, come quelli venuti alla luce nel corso degli scavi della necropoli di Capo La Torre venga affidata a studiosi stranieri. Sono molto grato di questo atto di fiducia, e spero di essere al livello della considerazione dimostrata. In particolare, mi hanno dato il loro appoggio la dott.ssa Gabriella Colucci Pescatori e la dott.ssa Maria Raffaella Fariello Sarno, che le è succeduta nella sede avellinese della Soprintendenza, per non dimenticare altri amici avellinesi quali Consalvo Grella, e il prezio-so appoggio che mi hanno dato nello studio delle lapidi stesse la collega e amica prof. Chiara Lambert dell’Università di Salerno e il caro amico
* Università di Helsinki
216 Heikki Solin
Alfonso De Concilio, assistente tecnico-scientifico della Soprintendenza. Grazie al loro interessamento, ho potuto studiare ancora a tre riprese – nel febbraio e maggio del 2008 e nell’aprile del 2012 – materiali nuovi o venu-ti in luce in tempi successivi, conservati nel deposito della Soprintendenza ad Avellino.1
È mia intenzione dare molto brevemente uno sguardo generale alle iscrizioni cristiane di Avellino la maggior parte delle quali è costituita da un gruppo di epigrafi per lo più munite di datazioni consolari emerse dalla necropoli paleocristiana ad Atripalda. A causa dei limiti di tempo non pos-so analizzare il materiale che molto sinteticamente.
Sarà utile all’inizio dire due parole sul contesto geografico. L’Abellinum romana sorgeva anticamente sulla riva sinistra del fiume Sabato, vicino all’odierna Atripalda, che sorse come centro abitato nel secolo XI proprio nei pressi delle rovine della colonia romana e intorno allo specus martyrum, il cimitero cristiano di questa città romana. Gravemente colpita dalle lotte tra Goti e Bizantini, la città decadde sino a scomparire con la conquista longobarda nel 571 d.C. La nuova Avellino, la città che porta oggi il suo nome, sorse a circa 3 km ad O dell’antica posizione, quando i nuovi con-quistatori vi stabilirono la propria sede.
La necropoli cristiana, di dove proviene il nuovo gruppo di epigra-fi, è sorta su quella pagana, situata lungo la via Appia che portava verso Aeclanum.2 Questa necropoli cristiana, comunemente chiamata cemetero di S. Ippolisto, nell’antico quartiere di Capo La Torre di Atripalda è stata di recente esplorata. Di questo complesso ha poc’anzi riferito la Fariello Sarno. Da qui proviene dunque il cospicuo gruppo di nuove iscrizioni, come pure quello pubblicato dal Galante, mentre dell’ultima provenienza delle iscrizioni note in precedenza si sa poco: per tutte le iscrizioni incluse nel CIL X, la collocazione più antica che si conosca, si riferisce a chiese o monasteri (CIL X 1191 proviene dal cimitero di S. Ippolisto, e per 1194 e 1195 si potrebbe ipotizzare la provenienza dallo stesso cimitero, in quanto si trovano nella chiesa di S. Ippolisto).
Ma prima di tutto, occorre un rapido sguardo statistico sulle iscrizioni paleocristiane abellinati. Prima dei nuovi scavi il loro numero era assai li-
1 Durante queste tre riprese ho goduto anche dell’aiuto di Paola Caruso nella schedatura e nel fotografare dei pezzi; si è inoltre presa la briga di rivedere il mio stile italiano.
2 Sulla topografia e sugli scavi recenti vedi in generale G. ColuCCi PeSCatori, EAA Sup-pl. 1970, pp. 127-130; Suppl. 1971-1994, I, pp. 570 sg. M. R. Fariello Sarno, Il complesso paleocristiano di S. Ippolisto Capo La Torre, Rassegna Storica Irpina 2, 1991, nn. 3-4, pp. 11-34; ead., in questo stesso volume.
217Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
mitata. I primi studiosi locali di cui si sa che hanno copiato delle iscrizioni cristiane, sono Francesco Verderosa e Scipione Bella Bona, ambedue attivi intorno alla metà del Seicento; quest’ultimo è stato oggetto di una comuni-cazione di stamane. Il Mommsen conobbe soltanto cinque di queste iscri-zioni (CIL X 1191-1195); delle tre ritrovate da lui (1193-1195), noi ne ab-biamo visto due (1194-1195), mentre la 1193, vista ancora dal Mommsen nel monastero di S. Pietro a Cesarano, è ormai smarrita, come confermato da un sopralluogo nel monastero nel 1984. Invece siamo riusciti a ritrova-re la 1192,3 trascritta da Bella Bona, non vista dal Mommsen, ma che si trova tuttora ad Aiello del Sabato (un piccolo paese di origine longobarda circa 4 km a S di Atripalda), nella chiesa di S. Maria della Natività murata nella parete interna, a sinistra dell’ingresso principale. Siccome il testo dell’epigrafe è interessante, come interessanti sono le vicende della storia del testo, mi si permetta un breve excursus su esso. Il Mommsen lo pub-blicò nella forma tramandata da Franceso de’ Franchi, Avellino illustrata, Napoli 1709, p. 463 (che l’ebbe dalle schede di Scipione Bella Bona del XVII secolo), come segue: HIC REQVIESCIT IN PACE DEI SERVVS / IOANNIC ·VV·PRAESBYT· QVI· VIXIT· ANN·LXXX / EVOCATVS A DOMINO DIE XIII KAL·AVGVSTI / BASILIO·V·C·SEDIT·ANN·XXI, datandolo, pur con esitazione, all’anno 541 d.C. e chiedendo se per la riga 4 si potesse come alternativa intendere P·C·BASILI·V·C·ANN·XXI. Ora, la lettura dell’epigrafe non pone alcun problema; il suo testo suona come segue:
† Hic requiescit in pace Dei ser- vus Iohannis v(ir) v(enerabilis) presb(yter), qui vi- xit ann(os) LXXX; evocitus a D(omi)no die XIII Kalend(as) Augus(tas) Fl(avio) Basilio
5 v(iro) c(larissimo) cons(ule). Sed(it) ann(os) XXI.
Mommsen (seguito dal Diehl) attribuì, pur con esitazione, l’iscrizione al 541, ma la nuova lettura ci permette di datarla, con tutta probabilità, all’an-no 463 d.C.4 Nelle date consolari del 541 (e 480) al nome di Basilius segue di regola iun.; e sarebbe quanto mai improbabile che iun. fosse omesso per errore in questa iscrizione altrimenti eseguita con correttezza. Inoltre l’elemento Fl. compare di rado, e solo in Oriente nelle datazioni del 541,
3 Dal MoMMSen la riprende dieHl, ILCV 3342 A. 4 Lo hanno visto anche gli autori di CLRE 616 ad loc. Inutilmente ancora C. laMbert,
in Campania fra tarda antichità e alto medioevo, p. 65 esita tra 463 il tradizionale 541.
218 Heikki Solin
mentre nelle iscrizioni dell’Italia del 463 viene spesso prefisso a Basilius. Il nuovo testo ci regala anche altre novità interessanti. Ne adduco evoci-tus, una forma secondaria per evocatus;5 ma il punto più importante è che l’espressione evocatus a Deo o Domino, che è attestata più volte nelle nuo-ve iscrizioni della necropoli cristiana, non compare epigraficamente fuori Avellino; si tratta dunque di una peculiarità del gergo epigrafico funerario della comunità cristiana locale.6 Alla fine va notata la contrazione D(omi)no per il tramandato DOMINO.7 E poi ancora due quisquilie: Iohannis (scritto dunque con h) non finisce con una C (interpretata dal Diehl come un sigma greco), ma con una S; e sedit sta bene, solo che non è scritto per intero (il Mommsen vorrebbe eliminare la parola, ma sedit poteva essere usato anche di un presbitero). – Il defunto è stato considerato nella tradi-zione locale un vescovo di Abellinum, ma senza argomenti solidi.8
Dopo l’edizione del Mommsen nel quadro del CIL X è stato reso pub-blico solo un folto gruppo di epigrafi cristiane, venute in luce nello stesso cimitero, come nuovi ritrovamenti, pubblicate da G. A. Galante nel 1893.9 Purtroppo questo gruppo di epigrafi molto interessanti è rimasto pressoché sconosciuto; non se ne trova traccia né nella nota silloge Inscriptiones chri-stianae Latinae veteres del Diehl né nell’Année épigraphique, la rassegna annuale di epigrafia latina, inaugurata nel 1881.10 Il loro numero è 13. Del destino di esse non si sa niente; sono tutte smarrite, tranne un frammento marmoreo che abbiamo ritrovato conservato nella biblioteca della Facoltà teologica, sezione S. Tommaso a Capodimonte, Napoli.11
Prima di passare al gruppo delle iscrizioni venute in luce nei nuovi scavi a Capo La Torre, vanno ricordate ancora tre iscrizioni cristiane fi-nora inedite tramandate come provenienti dalla località Civitas (cioè dal sito dell’antica Abellinum), confluite nel Museo Irpino per donazione Di Marzo Capozzi, tutte munite di data consolare (sono databili tra 347 e la metà circa del VI secolo d.C.). La più antica è, come sembra, del 347 d.C.
5 Su questa forma vedi ThlL V 2, col. 1053, 20-24; esistono anche vocitus, provocitus, revocitus.
6 Invece evocare del Dio che chiama a sé l’uomo compare in autori cristiani: vedi ThlL. V 2, coll. 1056, 80-1057, 6.
7 Sulla contrazione DNO cfr. U. Hälvä-nyberg, Die Kontraktionen auf den lateinischen Inschriften Roms und Afrikas bis zum 8. Jh. n. Chr., Helsinki 1988, p. 243.
8 Cfr. lanzoni p. 242. 9 gennaro aSPreno galante, Il cemetero di S. Ipolisto martire in Atripalda, Atti Acc.
Arch. Napoli 16, 1891/1893, parte I, pp. 189-222; ristampa anastatica a cura dell’Assesso-rato ai Beni culturali di Atripalda 1984.
10 E così neanche nel Thesaurus monacense.11 galante, pp. 193 sg.
219Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
Si tratta dell’epitaffio di una donna, ma la struttura del testo non è imme-diata. Esso non inizia con il nome della defunta, bensì con un’espressione che si riferisce alla chiamata della defunta al cielo. La lettera prima di VOCATA dovrebbe essere A, M o X, e si potrebbe pensare a qualcosa come [in pacem aeterna]m vocata. Il participio vocatus compare qualche volta nelle iscrizioni sepolcrali cristiane con l’accezione ‘chiamato da Dio alla vita eterna’, ma non con grande frequenza (sembra mancare a Roma, altrove vi sono sparse attestazioni: ILCV 1053, 1644). Vocatus, che ad Abellinum ricorre forse in n. 2, e soprattutto evocatus (vedi n. 4) sembrano una peculiarità del gergo sepolcrale cristiano locale; quest’ultimo manca infatti al di fuori di Abellinum.
Si conoscono tre consoli del Basso Impero di nome Eusebius, del 347, del 359 d. C. e del 489 e 493. Va preferita la prima data, in quanto nelle datazioni di quell’anno (le attestazioni in CLRE pp. 252 sg.; ivi aggiungi ICUR 26312 Rufino e[t Eusebio]) il nome di Eusebius segue regolarmente a quello del primo console, Rufinus, mentre nelle datazioni del 359 Eusebius di regola sta al primo posto e Hypatius al secondo; da parte sua, il nome di Eusebius, console nel 489 e 493 non fu divulgato a Roma o nell’Italia, nel 493 mai nell’Occidente e nel 489 solo occasionalmente nella Gallia (le at-testazioni in CLRE pp. 512 sg., 520 sg.; per il 489 aggiungi ICUR 27361). Per quanto riguarda la forma delle menzioni dei nomi, non è del tutto da escludersi che anche i gentilizi Vulcacius e Flavius sarebbero premessi ai cognomi, come alle volte succede, ma se così fu, sarebbero stati scritti in forma abbreviativa (se fossero stati scritti per intero, lo spazio a sinistra di-venterebbe inutilmente lungo). La nostra iscrizione è dunque del 347 d. C.
Ricordo ancora un frammentino ritrovato nel 1880 a Prata di Principato Ultra con due righe probabilmente integre a destra: MEMORI e SVB DIAE,12 nonché un epitaffio del 469 d. C. dalla stessa località;13 a ciò si ag-giungono due frammenti tardi, se non addirittura medievali da S. Giovanni di Pratola Serra.14 Inoltre va ricordato un piccolo frammento venuto recen-temente in luce, oriundo di Sorbo Serpico, ritrovato nell’area della chiesa
12 galante, pp. 195 sg. Non è del tutto certa l’appartenenza di Prata al territorio di Abel-linum (il Mommsen pubblica l’unica iscrizione a lui nota di Prata nel CIL IX: 1089), ma assai probabile; Prata è sempre appartenuta alla diocesi di Avellino, e circostanze geografi-che almeno non parlano contro l’appartenenza all’agro abellinate di essa. Anche la dizione con sub diae è molto “abellinate”.
13 A. Sogliano, NSc 1893, p. 422 = CLE 689 = ILCV 3114. 14 Vedi D. Mauro, in P. Peduto (ed.), S. Giovanni di Pratola Serra. Archeologia e storia
nel ducato longobardo di Benevento, Salerno 1992, pp. 342 e 346; C. laMbert, in Campa-nia fra tarda antichità e alto medioevo 68, con foto.
220 Heikki Solin
(Castello) nel 2007, ora nel deposito della Soprintendenza ad Avellino.15 Il numero delle iscrizioni venute in luce nei nuovi scavi a Capo La Torre
ammonta per il momento (aprile 2012) a ± 140. Il numero complessivo delle iscrizioni paleocristiane abellinati è quindi ± 166; di esse sono smar-rite 18 (2 pubblicate nel CIL, 12 atripaldesi pubblicate dal Galante, e 2 da Prata e 2 da S. Giovanni di Pratola Serra); tuttora ne esistono dunque 144, ma di epigrafi note dal periodo anteriore ai nuovi scavi soltanto 4.
Questo patrimonio epigrafico costituisce una serie straordinaria di do-cumenti epigrafici cristiani. È notevole come in una modesta città campana le iscrizioni cristiane pullulino di aristocrazia locale e come sia ricco il lessico del gergo sepolcrale nell’Abellinum cristiana - nel complesso si tratta di un esempio unico relativo a una serie di documenti omogenei per provenienza e genere degli ultimi secoli dell’antichità precisamente datati. Ho già dimostrato quante novità possa offrire la nuova e corretta lettura di un’epigrafe. Ciò non significa tuttavia che le altre iscrizioni già pubblicate nel CIL (sono CIL X 1191, 1193-1195) sarebbero prive di interesse; anzi, a cominciare dalla smarrita 1991, pongono problemi di ordine testuale e ci offrono interessanti visioni sulla dizione del gergo epigrafico locale e sulla mentalità della gente del luogo nel comporre epitaffi per i loro sacerdoti.16 Purtroppo non posso occuparmene più dettagliatamente qui; un’adeguata trattazione richiederebbe una lezione a parte. Particolarmente vorrei at-tirare la vostra attenzione su due lunghi testi sepolcrali: sull’epitaffio di Sabino, stamane trattato da Gennaro Passaro, e quello del levita Romulo, tutti e due probabilmente del VI secolo, ed ambedue importanti quali testi-monianze della presenza di echi letterari ad Abellinum e della mentalità del clero locale, in grado di servirsi di passi letterari.
Anche il gruppo delle iscrizioni pubblicate già alla fine del secolo scor-so dal Galante, ma rimaste praticamente sconosciute, offre una quantità di novità soprattutto lessicali, ma anche onomastiche, ed è veramente deplo-
15 C. laMbert, in Campania fra tarda antichità e alto medioevo 69, con foto. 16 CIL X 1191 (= dieHl 3352), quindi smarrita, del 357 d. C., offre difficoltà di inte-
grazione nella parte destra che era caduta già quando fu trascritta da un anonimo all’inizio del Seicento; nella riga 1 si potrebbe intendere ad Dom(inum) v[ocatus] (la S sovrapposta dopo DOM nel testo offerto nel CIL altro non è che un punto divisorio, tanto caratteristico dell’epigrafia cristiana, anche ad Abellinum); e nelle righe 3-4 è notevole la dizione [neo]fitus qui Dei voluntate cum sanctis sociatus es[t]. Per 1193 (= dieHl 3869) del 558 d. C. la forma del testo non può essere del tutto accertata; interessante la formula di minaccia per la violazione della tomba. Importanti quali testimonianze della presenza di echi letterari ad Abellinum e della mentalità del clero locale di servirsi di passi letterari sono gli epitaffi di Sabinus (1194 = dieHl 1011 = CLE 1424) e del levita Romulus (1195 = dieHl 1235 = CLE 788), tutti e due probabilmente del VI secolo.
221Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
revole che queste iscrizioni siano finora rimaste inutilizzate dalla ricerca storica e filologica. Interessantissima è per es. un’iscrizione probabilmente dell’anno 505 (n. 8), senza del tutto escludere il 399 d. C., anche se la da-tazione in quest’anno è meno probabile, non essendo nessun’altra epigra-fe altripaldese di questo complesso anteriore al V secolo;17 essa comincia con le parole depositio Pacci Caesi Providenti viri optumatis et primari; si cerca invano nel Thesaurus monacense sotto optimas un riferimento a questa epigrafe, tanto più notevole, in quanto offre la grafia arcaizzante con -um-. Che cosa del resto vogliano dire nel concreto queste designazioni di rango, resta beninteso nascosto, ma in ogni caso si riferiscono alla nobiltà locale come pure anche la designazione vir principalis di Paccius Caesius Anatholius in un’epigrafe del 526.18 In più queste due iscrizioni fanno ve-dere la persistenza di vecchie formule onomastiche nella nomenclatura della nobiltà locale ancora nel VI secolo: tutti e due i notabili appartengono alla famiglia dei Paccii Caesii,19 portano quindi ben due vecchi gentilizi romani, anche se il gentilizio aveva cessato di essere usato come elemen-to obbligatorio nella nomenclatura romana già secoli prima. Dei singoli nomi colpisce quello di una Mecrosa l(audabilis) f(emina) (523 d. C.),20 una nuova formazione per l’onomastica antica. Non lo posso capire se non come derivato, mediante il suffisso latino -osa, dalla famiglia onomasti-ca greca basata su μικρός, popolare nell›antroponimia greca, e ben nota anche nell›onomastica romana, anche se è vero che a Roma si usavano esclusivamente forme in Mic(c)-. Ora i nomi Mica Micinus ecc. sono stati spiegati anche come latini,21 ma andrebbero, nell’onomastica locale, bene anche come nomi celtici e, in parte anche come africani;22 va inoltre no-tato per inciso che il suffisso -osus è particolarmente popolare nell’Africa dell’età imperiale.23 Ma la presenza di -r- nel nome lascia optare in primo luogo per un antroponimo grecanico munito di un suffisso latino, cosa non straordinaria: conosciamo addirittura un Micosus da un’iscrizione cristia-
17 galante, pp. 205-209. galante legge PACCIC, seguito da un’edera. Si tratterà di una specie di dittografia, se il segno letta come C dal Galante non era un segno divisorio (un susseguirsi di un divisorio ornamentale e di un’edera non sarebbe straordinario, anche se non attestato nelle iscrizioni abellinati).
18 galante, pp. 210-212. Sui principales cfr. ad es. A.F. norMan, Gradations in Later Municipal Society, JRS 48, 1958, pp. 83 sg.
19 Nelle nuove iscrizioni compare una Paccia Marcia del 466 d. C. (n. 6), il cui nome è dunque costituito da soli due gentilizi, ed un Pac(cius) o Pac(cia) Ga[---].
20 Galante, pp. 213-215. 21 Così kajanto, LC, p. 348.22 k. jongeling, North-African Names from Latin Sources, Leiden 1994, pp. 93 sg.23 Cfr. H.-g. PFlauM, Ant. Afr. 14, 1979, pp. 213-216.
222 Heikki Solin
na di Roma;24 si può addurre anche il popolare Charitosa, ben attestato a Roma.25 In ogni caso un nome grecanico Microsa si spiega senza difficoltà nel quadro dell’antroponomia dell’età imperiale inoltrata; d’altra parte, tro-vandoci nel VI secolo, non possiamo del tutto escludere la possibilità che si tratti di una formazione non meglio precisabile; ma sappiamo troppo poco della diffusione, in Campania, per es. dei nomi germanici venuti con i Goti. Un altro nome degno di nota è Gemma in un’epigrafe del 542 d. C.,26 di cui si conosce nell’onomastica romana finora solo un’attestazione dubbia da Sens nella Lugdunense, dove compare il ritratto di una ragazza e, sopra, GIIMMA.27 Delle singole espressioni del linguaggio epigrafico sepolcrale vale la pena di notare recondi[t---] senza contesto chiaro in un’iscrizione probabilmente del 464 d. C.28
E ora passiamo ad una breve rassegna di alcuni aspetti che le nuove iscrizioni ci offrono. La pubblicazione degli scavi di Capo La Torre sarà curata dalla sua direttrice, Dottoressa Maria Raffaella Fariello Sarno; a me è stato affidato il compito di compilare l’edizione del materiale epigrafico, schedato e fotografato da Mika Kajava e da me a partire dal 1991, che usci-rà nella serie Inscriptiones christianae Italiae.29 Sono tutte latine, tranne una che è greca. Vanno dal 453 al 548 d. C. Comincio con una grande stele opistografa (n. 7) che nel verso reca l’epitaffio di una [V]aria C. f. Tertulla; nel retro sono ricordate due deposizioni, di Marcellinus v(ir) l(audabilis), arciater e di Claudius Successus defensor; si riferiscono al 505 e al 513 d. C. rispettivamente. Dunque all’inizio del VI secolo un archiatro stava a capo dell’assistenza sanitaria della città irpina - un punto veramente note-vole, e un bell’arricchimento sulla lista degli archiatri del tardo Impero.30 Vir laudabilis sarà un epiteto senza significato preciso. Resta anche dubbio che cosa si voglia dire esattamente con defensor, ma in ogni caso si trat-
24 IChrUr 6825 d; latino per kajanto, Lc (p. 348).25 Vedi Solin, Gpn2 pp. 493 sg.26 galante, p. 216.27 ciL Xiii 4394. Siccome l’altro ritratto, probabilmente di sua madre, reca il nome giiM-
nian///, non è escluso che il nome della figlia debba essere inteso Gem(i)na. kajanto, Lc, p. 346 considera il termine di sesso ignoto dubitando del suo carattere onomastico. Ma certamente si tratta del nome della ragazza.
28 galante, pp. 203-205. Di solito il verbo fu usato con reliquiae, caput ecc., ma non direttamente come attributo del defunto.
29 La futura edizione conterrà, beninteso, tutte le iscrizioni paleocristiane di Abellinum e sarà preceduta, oltre che da un’introduzione storica, da una trattazione del contesto arche-ologico della Dottoressa Fariello Sarno.
30 Sugli archiatri nel mondo antico in generale vedi v. nutton, Archiatri and the medi-cal profession, PbSr 45, 1977, pp. 191-226.
223Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
terà di un titolo di rango come defensor civitatis, meno probabilmente di defensor ecclesiae, certo non di defensor fidei. Ma compaiono anche gradi più alti della gerarchia statale. Una iscrizione ci regala un patrizio: "chri-stogramma" Abundantius [vir] inl(ustris) et patricius / ex p(rae)p(osito); dep(ositus) XVIIII Kal(endas) Ian(uarias) tert(ium) p(ost) c(onsulatum) Lampadi, Or(estis) del 533 d. C. (n. 14). Il defunto, che si vanta di essere un patrizio, era stato un praepositus senza una esatta determinazione.
Per continuare con deposizioni doppie, leggiamo in una lastra (n. 12) come primo testo "christogramma" hic requiescit in pace Cel(ius) Leo diac(onus), evocitus a D(omi)no, del 519 d. C., mentre la seconda par-te suona "christogramma" hic requiescit in pace religiosa Palumba dia-cona, evoceta a D(omi)no ... indic(tione) XV Fl(avio) Bilisar(io) v(iro) c(larissimo) cons(ule). Belisario era console nell’Oriente nel 535. Il 15. anno dell’indictio cominciò nel settembre 536, cosicché il febbraio ad esso pertinente cadde nel 537. Belisario occupò la Sicilia nel 535 e l’Italia me-ridionale nel 536, per cui il suo consolato entrò qui in vigore soltanto nel 536, come si vede dalle iscrizioni di Roma e dell’Italia: nessuna menzione di Belisario compare in iscrizioni databili al 535; in quell’anno le iscrizio-ni di Roma e dell’Italia riportano esclusivamente il consolato di Paolino iunior nella forma post consulatum (Fl.) Paulini iun(ioris) v. c. - nel 536 poi appare poche volte la forma di datazione post consulatum Belisari v. c., benché più comune sia scrivere iterum post consulatum Paulini iun(ioris) v. c.31 Ora la lettura del passo che contiene la data consolare, benché al-quanto complicata, è certa, per cui il responsabile del testo dell’epigrafe ha commesso un errore: ammesso che il numero XV dell’indictio sia esat-to (ed è più facile immaginarsi l’errore nell’omissione di p. c. che non ammettere un duplice errore sia nell’indicazione del postconsolato sia del numero dell’indictio) doveva scrivere iterum p. c. Fl. Belisari, come si scrive a Roma nelle iscrizioni del 536 p. c. Belisari. Errori di questo genere sono di per sé comprensibili; anche in un’epigrafe urbana (IChrUR 4283) del 537 si legge p. c. Belisari,32 invece di iterum p. c. Belisari. Questo non è l’unico caso in cui la data consolare ponga problemi. L’epitaffio di una Maurica porta la data pos(t) consulatu APII v(iri) c(larissimi) cons(ulis); il nome del console è singolare e non so trovare per esso una spiegazione plausibile (n. 11, con un tentativo di spiegazione). Ho pensato ad A(ga)pi(t)i, con la quale lettura otterremmo come data l’anno 518 d. C. Ma ciò
31 Cfr. CLRE, pp. 604 sgg. 32 Sulla data, che rimane, è vero, un po’ controversa, vedi CLRE, p. 606, 608.
224 Heikki Solin
non soddisfa molto.33 Per finire con un terzo esempio, nell’epitaffio di Leo aurefex del 506 d. C. (n. 10) seguono, dopo la data Fl(avio) Messala v(iro) c(larissimo) cons(ule), le lettere FL·A che restano enigmatiche (il resto della riga sembra essere stato privo di scrittura). Contro l’abbreviazione contrattiva f(i)l(i)a depone il segno di punteggiatura tra FL e A, che non viene usato in queste iscrizioni dentro una parola. Non si pensi neanche al nome di chi ha eretto l’iscrizione, in quanto un Fl(avius) non si usa nella nomenclatura della gente comune; e ancor meno a Fl(avius) A(reobindus), il console d’Oriente nel 506, giacché il suo nome non fu divulgato in Occidente (cfr. CLRE, p. 547).
E ancora un caso. La bella iscrizione con la depositio sanctae memori[ae F]ortunae offre, dopo le due date della morte e della deposizione (adcep-ta in somno paces IIII Idus Februa(ria)s, deposita III Idus Februarias) accompagnate dalla data consolare post cons(ulatum) Anici Olibri v(iri) c(larissimi), una vera sorpresa: una riga scritta in greco: ἰν(δικτίωνος) γ’ μεχὶρ ιη’, il nome del mese egiziano (n. 5). Perché il committente abbia voluto ancora aggiungerlo, rimane oscuro, come oscuro rimane il senso delle tre prime lettere; l’interpretazione del testo greco viene ulteriormente complicata da due fatti: prima che la data offerta dal testo greco, cioè il 18 del mese μεχείρ corrispondente al 12 febbraio non concorda né con la data della morte né della deposizione date nella parte latina che cadono al 10 e all›11 febbraio rispettivamente; in secondo luogo, l›anno del consolato non può essere stabilito con certezza. Per farla breve, sono a disposizione cinque consoli di nome Olybrius nel Basso Impero: quelli del 379,34 395, 464, 491 e 526 d. C. Fortuna potrebbe teoricamente essere morta dunque in uno degli seguenti anni: 380, 396, 465, 492 o 527 d. C. Ora, gli unici con-soli di questi anni,35 nel nome dei quali Olybrius è preceduto da Anicius, sono quelli del 395 d. C., Anicius Hermogenianus Olybrius,36 e quello del 464 d. C., Anicius Olybrius.37 Ma ci sono delle difficoltà. Prima, nel 396 i consoli erano gli imperatori Arcadio e Onorio, per cui sarebbe stato strano scegliere, invece dei loro nomi, quello di Olibrio con postconsolato, per
33 aPione, console del 523, non viene in questione, perché in Italia non si usava la data del suo consolato.
34 Quest’anno manca nell’indice dei nomi sotto Olybrius in cLre, p. 716.35 Invece per il console del 526, che figura in pLre II p. 798 sotto il nome Fl. Anicius
Olybrius, non è documentato con certezza il nome Anicius; la lettura dell’iscrizione de roSSi I 1009, cui fa riferimento la prosopografia cantabrigense, è del tutto incerta come risulta dalla nuova edizione in icUr 5045.
36 Sul personaggio cfr. PLRE I pp. 639 sg.37 Cfr. pLre II pp. 796-798. In cLre, p. 462 figura come un Fl(avius).
225Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
di più da solo. Tra le innumerevoli epigrafi romane, in cui appaiono, per il 396, i nomi dei due Augusti, non c’è traccia di un postconsolato dei consoli dell’anno precedente. Si potrebbe osservare che forse nella città campana non era ancora giunta nella metà del febbraio la notizia della nuova coppia consolare, ma a Roma la coppia degli Augusti appare già in un’iscrizione sepolcrale del 3 gennaio (ICUR 20809). Secondo, l’indicazione della data consolare mediante il postconsolato era nella seconda metà del IV secolo ancora rara nelle iscrizioni d’Italia e se compare, si tratta dei nomi di im-peratori (l’attestazione più antica a me nota è ICUR 12543 con il postcon-solato di Onorio ed Euticiano). Avremmo tuttavia un caso analogo in un’i-scrizione catanese (AE 1933, 26) del 25 gennaio 402, in cui la data è resa con p(ost) c(onsulatum) Vincentii, anche se i consoli di quell’anno erano Arcadio e Onorio (ambedue la quinta volta). Per quanto riguarda il console del 464, le prospettive sono uguali. Non sono attestate datazioni del 465 con il postconsolato di Olibrio e poi non compare nelle indicazioni del suo consolato il nome Anicius (cosa che invece accade in un buon numero delle attestazioni epigrafiche del console del 395), che, a giudicare dalla documentazione numismatica, dovrebbe tuttavia essere contenuto nella forma onomastica completa del console. Ora tra il nuovo materiale della necropoli di Capo La Torre compare un’iscrizione databile al 466 (n. 6) con la data die XIIII Ka<l>endas Maiias post cons(ulatum) Hermeniric[i] et Basilisci, una forma attestata anche altrove (CIL V 5685); perché dunque la stessa cosa non poteva accadere nell’anno precedente, tanto più la metà febbraio viene cronologicamente prima? La scelta proprio di quest’anno darebbe ancora il vantaggio di poter fare interpretare le prime tre lettere del testo come indicanti la terza indictio; infatti il febbraio del 465 cade nella terza indictio. A fin dei conti, opterei dunque per l’anno 465 come giusta datazione di questa iscrizione. Si noti ancora che l’epigrafe sembra tutta della stessa mano; lo stesso lapicida avrà dunque inciso anche l’aggiunta in greco. Del resto niente accenna all’estrazione orientale della defunta o dei committenti, per cui l’origine dell’aggiunta greca rimane aperta.
Andiamo avanti. Anche queste nuove iscrizioni offrono formule ono-mastiche con due nomi. Oltre a quelle già ricordate compare in un epitaffio del 506 d. C. (n. 9) un Fuficius Petrus v(ir) h(onestus).38 I nomi stessi sono anche interessanti. Hirculentius si chiama uno morto nel 511 d. C. in età molto avanzata. Si tratta del nome latino Herculentius, attestato esclusi-
38 Nessun Fuficius nella silloge del dieHl.
226 Heikki Solin
vamente in iscrizioni cristiane, nonostante la sua ‘ideologia’ pagana.39 Il nome Fortuna non è rarissimo in epigrafi cristiane, ma si trova soprattutto in Africa. Le iscrizioni pullulano di nomi tipicamente cristiani. Nomi bibli-ci sono Petrus, Andreas, Thomas, e Petronius divenne popolare nell’ono-mastica cristiana per la somiglianza fonetica con Petrus. Cristiano è anche Cyriace, e lo stesso può dirsi anche di Abundantius, anche se non porta un distintivo cristiano - per esprimermi più esattamente, è un nome tardo. Dal punto di vista morfologico speciale interesse desta Thomas che compare nel suo epitaffio del 501 d. C. nel genitivo Tomatis, dunque con flessione eteroclitica; di solito si fletteva questo nome secondo la prima declinazio-ne (in IChrUR 18062 compare un genitivo grecizzante Thoma). Del resto Tommaso in italiano ha la stessa origine di Tomatis, con una s causata da dissimilazione consonantica.
Degli appellativi indicanti mestieri, oltre a quelli già ricordati, sono de-gni di nota aurefex in un’epigrafe del 506 d. C. (n. 10), laneus in un’altra epigrafe del 513 d. C. e gregarius in un’ulteriore epigrafe, anche del 513 d. C., di cui ci sfugge l’esatto significato; probabilmente si riferisce ad una persona adibita alla custodia di greggi, se non si tratta di un miles gregari-us, di un soldato semplice.
Queste osservazioni danno solo una pallida immagine della ricchez-za dell’epigrafia cristiana abellinate. Ho tralasciato nella mia rassegna di trattare per es. delle formule riferentisi direttamente alla morte ed alla de-posizione, seguite regolarmente dall’esatta data della morte o della depo-sizione, ma sembra che tutti e due i costumi, cioè indicare o la data della morte o quella della deposizione, erano in uso; date doppie sono più rare. Anche i modi di designare i giorni e gli anni hanno una varietà notevole. Ho saltato pure di notare particolarità linguistiche e abbreviazioni con-trattive tra cui si trovano alcune non molto diffuse.40 In genere si può os-servare che si tratta di una documentazione se non del tutto omogenea, di una uniformità notevole sia per rispetto ai caratteri esterni del documento, sia rispetto all’andamento del testo epigrafico. Per es. l’arrivo di Belisario nell’Italia meridionale non significa alcun cambiamento incisivo nella pro-duzione di epigrafi sepolcrali. In genere colpisce la presenza e ricchezza dei testi incisi entro un arco di tempo molto lungo. La prima data consolare
39 Vedi kajanto, LC, p. 214. 40 Per es. CNS = consulatu: Hälvä-nyberg, o. c., p. 239, cui si aggiungano dall’area
campana CIL X 1346, 1354; DM (Hälvä p. 242, più CIL X 1361); DN (Hälvä p. 242, più CIL X 1537, 4514); NOBR (Hälvä p. 257, più CIL X 4630).
227Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
si riferisce probabilmente al 347 d.C.,41 e l’ultima esattamente databile al 558 d.C. (CIL X 1193); la datazione di alcune iscrizioni che portano la data p(ost) c(onsulatum) Basili in forma frammentaria, potrebbe teoricamente protrarsi fino al 575 d.C., ma praticamente non si possono sorpassare gli anni ‘40 o ‘50 del sesto secolo: già gravemente colpita dalle lotte tra Goti e Bizantini, la città decadde sino a scomparire con la conquista longobarda nel 571 d.C., per cui sarà a priori improbabile trovare documenti epigrafici durante l’ultimo periodo in cui si poteva usare il nome di Basilio nelle date consolari. Si noti anche per esempio la totale mancanza di nomi germanici, che poi si diffondono un poco più tardi nell’Italia meridionale, soprattut-to nella Puglia, dove si trovano in gran numero nei graffiti del Gargano recentemente scoperti. Ma è già notevole che ancora nel 558 d.C. venne innalzato l’epitaffio di un lector, per di più con una formula sepolcrale non del tutto quotidiana.42 Nel complesso, si tratta di una documentazione con un colore di peculiarità locale, assai diversa dal materiale epigrafico di altre comunità cristiane vicine. Purtroppo la documentazione epigrafica paleocristiana delle zone limitrofe dell’Irpinia è molto esigua, per cui un confronto non s’impone,43 ma un confronto con la ricca documentazione di città non lontane come Nola o Capua fa intravedere certe differenze, di cui sarà trattato più dettagliatamente nella futura edizione critica integrale del-la straordinaria documentazione epigrafica paleocristiana abellinate all’uso dei cultori dell’epigrafia antica.
Antologia di epigrafi cristiane di Abellinum
1. Frammento di una lastra in marmo, mutila a sinistra (sembra integra di sopra e di sotto, probabilmente anche a destra). Retro liscio. 23 x (22,5) x 2,5; alt. lett. 2 - 3,2. Proviene dalla località Civitas (dal sito dell’anti-ca Abellinum). Attualmente nei depositi del Museo Irpino, donazione Di Marzo Capozzi; n. inv. 62. Autopsia e foto 1983.
41 L’iscrizione in questione porta come data consolare [--- Eu]sebio cons(ule), che po-trebbe anche riferirsi all’anno 359. La successiva data consolare si riferisce con certezza all’anno 357 (CIL X 1191).
42 È vero che i nuovi conquistatori stabilirono una nuova sede a circa 3 km dall’antica città, per cui in sé e per sé la vita cittadina poteva continuare e anche iscrizioni sepolcrali essere innalzate, ma almeno le iscrizioni provenienti dal cimitero cristiano della vecchia Abellinum non possono essere datate a un periodo dopo la conquista.
43 Ne disponiamo ora un’edizione moderna: Inscriptiones christianae Italiae septimo saeculo antiquiores, VIII, Regio II, Hirpini, introduzione, edizione e commento a cura di A. e. Felle, Bari 1993.
228 Heikki Solin
[---]+vocata [---]nia; vixit an(nos) [--- ben]e meritae Ia- [---]+s deposita die5 [-- Apr]ilib(u)s [--- Rufino et Eu]sebio cons(ulibus).
PaSSaro, Propagazione pp. 374 sg. da copia mia, ma con integrazioni erronee (AE 2003, 322). – Sull’interpretazione dell’epigrafe vedi supra.
2. Lastra, come sembra, mutila a destra. Il segno dopo DOM, simile alla lettera S, nella riga 1 riprodurrà senza dubbio il punto abbreviativo, tanto in voga nelle iscrizioni paleocristiane. Ritrovato presso i muri della chiesa maggiore di Atripalda. Irreperibile.
1christogramma2 Ad Dom(inum) v[ocatus ?] Nonius Mam( ) L[--- neo-] fitus, qui Dei voluntate cum sanctis sociatus es[t ---,]5 vixit LVIIII, mens(es) [---], depositus XV Kal(endas) Aug(ustas) Constantio Aug(usto) VIIII et Iuliano Caes(are) II co[ns(ulibus)]. Benemerito filii sui [fecerunt ?].
ugHelli, Cod. Vat. Lat. 9094, p. 288 dalla scheda mandata da un ano-nimo a Roma nel 1629; da ugHelli dipende Marini, Cod. Vat. Lat. 9074, p. 933 n. 10 (sched. crist. 5607); G. B. de Rossi, Lettera soggiunta alla re-lazione fatta alla Sacra Congregazione delle Indulgenze e Reliquie, 1874; MoMMSen, CIL X 1191, da ugHelli e Marini (dieHl, ILCV 3352); da que-sti, galante pp. 6-8; CaSSeSe pp. 84; gaMbino, Ricorda che… pp. 7-9; PaSSaro, Propagazione p. 375 (segue gaMbino).
2 Mamilianus ? – 357 d. C.
3. Cinque frammenti di una lastra. 36 x 33. Ritrovata nel 1890 pres-so la basilica di S. Ippolisto, nell’area del cimitero cristiano di Atripalda. Irreperibile.
----------------- Caesid[---] Mart(ias), q[u- vixit annos ---] XVII post c[onsul(atum) d(omini) n(ostri) Theo-] dosi XVIII et D[eci Albini v(iri) c(larissimi)].
229Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
galante pp. 18 sg.L’andamento del testo non è immediato, ma XVII all’inizio di 3 sembra
riferirsi al numero dei giorni vissuti in un mese. – Probabilmente del 445 d. C. (così anche galante), infatti non vedo altra possibilità di datazione. È vero che per il 445 d. C., la forma post consulatum Theodosi et Albini è attestata solo una volta in Oriente (SPP XX 123, 2 del 28 marzo).44 In tutte le altre date consolari di quest’anno, anche in Oriente, compaiono Valentinianus VI e Nomus. Ma la cosa viene complicata da due fattori: nel nome di Albinus non compare altrove Decius; e la prima lettera del suo nome era per Galante incerta ed egli optava piuttosto per B anziché per D, leggendo B[asili Albini]. Ciò non è possibile, perché Albinus non può essere stato un Basilius; egli era un aristocratico romano, attestato come prefetto urbano nel 426 e probabilmente nel 414 se è lo stesso come sem-bra (PLRE II p. 50 n. 7. p. 53 n. 10). La combinazione dei nomi Basilius e Albinus è del tutto ignota nella nomenclatura del Basso Impero. Dobbiamo dunque per forza intendere D[ecius] (a giudicare dalla forma della tra-scrizione offerta dal Galante, l’ultima lettera non sembra possa essere A; e vista la solita attendibilità delle sue letture, darei credito alla sua tra-scrizione). Anche altrove nelle iscrizioni cristiane abellinati compare nelle date consolari un primo elemento onomastico, di regola omesso nel resto dell’Occidente. – Forse il redattore del testo epigrafico non conobbe ancora i nomi dei consoli del 445 (così anche Galante); nota che tutte le attestazio-ni dalle iscrizioni dell’Occidente di quest’anno si riferiscono alla seconda parte dell’anno partire dal 25 agosto: ICUR 13404).
4. Lastra in marmo grigio. Punti di separazione dalla forma di s nelle righe 2 (due volte), 3 (due volte) e 4; se l’ultimo segno del testo sia un punto oppure si debba intendere XXII, non è certo. 38 x 70; alt. lett. 3 - 6. Aiello del Sabato, chiesa S. Maria della Natività, murata nella parete inter-na [tramandata dal de Franchi fuori della chiesa], a sinistra dell’ingresso principale.
P Hic requiescit in pace Dei ser- vus Iohannis v(ir) v(enerabilis) presb(yter), qui vi-
44 Ὑπατείαν τοῦ δεσπότου ἡμῶν Θεοδο[σίο]υ τοῦ αἰωνί(ου) Αὐγούστου τὸ ιὴ καὶ Φλ. Ἀλβίνου τῶν λαμπροτάτων φαρ[μ(ουθι)] β (dunque 28 marzo). L’editore data il papiro erroneamente al 444 d. C. (cf. BL VII 263), cambiando il testo a ὑπατείᾳ; ma era comune, nelle indicazioni del postconsolato, omettere μετὰ τήν (vedi R. S. bagnall - K. A. WorP, Chronological Systems of Byzantine Egypt, Leiden 20042, p. 197).
230 Heikki Solin
xit ann(os) LXXX; evocitus a D(omi)no die XIII Kalend(as) Augus(tas) Fl(avio) Basilio 5 v(iro) c(larissimo) cons(ule). Sed(it) ann(os) XXI.
Autopsia 1988. FranCeSCo de FranCHi, Avellino illustrata, Napoli 1709, p. 463 dalle schede di SCiPione bella bona (XVII secolo); da cui luPoli, Iter Venusinum, sine loco 1793, p. 73; MoMMSen, CIL X 1192 (da cui dieHl 3342 A); n. gaMbino, Civiltà altirpina 8, 1983, pp. 35-44; PaSSaro, Propagazione p. 386; Solin 1, 472 sg. con foto; C. laMbert, in Campania fra tarda antichità e alto medioevo, pp. 65 sg., con foto p. 67. – Sulla let-tura e l’interpretazione dell’epigrafe vedi supra.
5. Lastra in marmo venato frammentata nella parte superiore e sinistra, retro liscio. Foglioline d’edera di forma variabile in tutte le righe. 32 x 48 x 2,5; alt. lett. 2,5 - 3,5. Ritrovata nella tomba 321 negli scavi a Capo La Torre ad Atripalda. Attualmente nei depositi del Museo Irpino.
[Dep]ositio sanctae memori- [ae F]ortunae, quae vixit plus minus annos L, adcep- ta in somno paces IIII Idus5 Februa(ria)s, deposita III Idus Febru- arias post cons(ulatum) Anici Olibri v(iri) c(larissimi).
ἰν(δικτίωνος) γ’ μεχὶρ ιη’.
Autopsia 1991. Solin 1, pp. 480 sg. Probabilmente del 465 d. C.; vedi supra.
6. 19 frammenti combacianti di una lastra in marmo bianco, retro liscio. Linee guida. M e S sono in parte scritte a capovolta. 42 x 46 x 2,5; alt. lett. 3,5 - 5. Ritrovati nella tomba 321 n. 2 - 3 negli scavi a Capo La Torre ad Atripalda. Attualmente nei depositi del Museo Irpino.
[D]epositio Pacc- iae Marciae, die XIIII Ka<l>endas Maiias post c-5 ons(ulatum) Hermeniric[i] et Basili{ii}sci [v(irorum) c(larissimorum) ?]
231Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
Autopsia 1992. Solin 1, p. 481. 466 d. C. L’espressione della data consolare mediante la menzione del
postconsolato di Hermenericus e Basiliscus non è normale; di regola si ser-vì del nome di uno dei consoli, d. n. Leo III, accompagnato qualche volta da Tatianus (su cui vedi CLRE pp. 466 sg.). Il postconsolato di Hermenericus e Basiliscus compare altrove solo in ILTG 145 (Bituriges).
7. Stele in calcare. Punti a forma di S nelle righe 1 e 2; foglioline d’e-dera nella riga 6. (143) x 93 x 32 - 37; alt. lett. 3 - 4. Ritrovata nella tomba 284 negli scavi a Capo La Torre ad Atripalda.
Dep(ositio) Marcellini v(iri) l(audabilis) arciatri d(ie) GII Kal(endas) Maias Thodoro v(iro) c(larissimo) cons(ule).5 Depositio Claudi Successi defenso- ris s(ub) d(ie) GI Id(us) April(es) Fl(avio) Probo v(iro) c(larissimo) cons(ule). †
Autopsia in situ 1992. Solin 1, pp. 477 sg. 505 d. C. e 513 d. C. – Sull’interpretazione dell’epigrafe vedi supra. La stele ospitava originariamente l’epitaffio del I secolo d.C., del cui
testo, che si trova capovolto rispetto all’epigrafe cristiana, resta [V]aria C. f. / Tertulla. / Quod miserrimum / est, mater fìlìs. All’inizio del testo sono andati perduti i nomi dei figli defunti. – Degna di nota è l’espressione quod miserrimum est mater filis, che compare nel lessico del gergo sepolcrale soltanto ad Abellinum (CIL X 1167; AE 2000, 331).
8. Lastra in otto pezzi. Foglioline d’edera; una palmetta con nastro nella parte inferiore e destra. 45 x 59 x 3-4. Ritrovata nel 1890 presso la basilica di S. Ipolisto, nell’area del cimitero cristiano di Atripalda. Irreperibile.
"christogramma" Depositio Pacci{x} Cae- si Providenti viri optumatis et prim- mari [d(ie)] XV Kal(endas) Oct(obres)5 Fl(avio) The[odoro v(iro)] c(larissimo) cons(ule); qui vix[it ann]os CV.
232 Heikki Solin
galante, pp. 21-26. – PRIM/MARI trádito dal galante. 505 d. C., senza escludere 399 d. C., anche se meno probabile, essendo
nessun’altra epigrafe atripaldese di questo complesso anteriore al V secolo.
9. Due frammenti combacianti di una lastra in marmo bianco, retro li-scio. Punto a forma di S nella riga 3; sbarre oblique che tagliano D e L nella riga 2. 43 x 44 x 3; alt. lett. 3 - 4. Ritrovati nella tomba 314 negli scavi a Capo La Torre ad Atripalda. Attualmente nei depositi del Museo Irpino.
Dep(ositio) Fufici Petri v(iri) h(onesti), qui vixit ann(os) XXV, s(ub) d(ie) XG Kal(endas) No(vem)br(es) ˹Fl˺(avio) Messala v(iro) c(larissimo) cons(ule).
Autopsia 1992. – 506 d. C.
10. Tre frammenti combacianti di una lastra in marmo bianco, retro li-scio. Linee guida. Punti a forma di S. 23 x 48 x 3; alt. lett. 3,5 - 4. Ritrovati nella tomba 313 negli scavi a Capo La Torre ad Atripalda. Attualmente nei depositi del Museo Irpino.
Depositio Leonis aure- ficis s(ub) d(ie) IIII Kal(endas) Oct- obr(es) Fl(avio) Messala v(iro) c(larissimo) con- s(ule) FL · A
Autopsia 1991. – 506 d. C. – 4 su FL×A vedi supra.
11. Due frammenti combacianti di una lastra in marmo bianco, retro li-scio. Linee guida. Foglioline d’edera nelle righe 2 e 6. S scritta a capovolta nella riga 1. 44 x 42 x 3; alt. lett. 3 - 3,5. Ritrovati nella tomba 330 negli scavi a Capo La Torre ad Atripalda. Attualmente nei depositi del Museo Irpino.
† Hic requiescit in pace Maurica, que vixit an- nos plus minus XL Dep(o)s(ita) sub d(ie) III Kal(endas) Iun(ias)5 pos(t) consulatu A(ga)pi(t)i v(iri) c(larissimi) cons(ulis).
233Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
Autopsia 1992. – Solin 1, pp. 478 sg. con foto.
518 d. C. (?). L’identificazione del console ci mette davanti a un proble-ma spinoso. La lapide ha chiaramente APII VC. Ora, l’unico console, che compare nell’Occidente nelle indicazioni del postconsolato da solo, senza un collega, e nel cui nome (nel genitivo) sono comprese le lettere A (inizia-le, s’intende), P e I, è Agapitus, console nel 517, il cui nome appare spesso nelle datazioni del 518 nella forma p(ost) c(onsulatum) Agapiti v. c. [Sono da escludersi Apio, console nel 539, il cui consolato (e neanche postconso-lato) non fu diffuso in Italia; Apollonius, console nel 460 che non compare da solo e di cui non è attestato il postconsolato; Asclepiodotus e Aspar, consoli nel 292, 423 e nel 434 rispettivamente che non compaiono da soli e di cui non sono attestati postconsolati nell’Occidente; senza parlare di Appalius 482 e Apronianus 494 che non rappresentano i nomi principali del console in questione e così non compaiono mai nelle datazioni.] Ma la forma della contrazione APII è molto insolita (almeno ci si aspetterebbe di trovare G dopo l’A iniziale). In documenti ben scritti contrazioni sono usa-te per risparmiare spazio, ma devono restare comprensibili. Perciò contra-zioni notevolmente abbreviate sono piuttosto evitate nei nomi di persona, compresi quelli di consoli e infatti nelle datazioni consolari non si trovano, nei nomi dei consoli, contrazioni del tipo APII = Agapiti. Supporre un puro errore di scrittura sarebbe una scappatoia, a cui non ricorrerei, visto che l’i-scrizione è ben composta, le lettere sono regolari e il testo è privo qualsiasi errore. Forse il redattore del testo epigrafico ha applicato per il nome del console una forma meno consueta, senza accorgersi che questa non era di immediata comprensione per i lettori.
12. Lastra in calcare, retro grezzo. Linee guida. Palme al di sotto di ambedue le parti. Punti a forma di S nelle righe 1-4 di a e nelle righe 2-4 di b. Sbarre oblique che tagliano D nella riga 2 di a e la prima D della riga 3 di b. 63 x 44 x 4,5; alt. lett. 2-4. Ritrovata nella tomba 307 negli scavi a Capo La Torre ad Atripalda. Attualmente nei depositi del Museo Irpino. Autopsia 1991.
a) "christogramma" Hic requiescit in pace Cel(ius) Leo diac(onus) evocitus a D(omi)no s(ub) d(ie) X Kal(endarum) Maiar(um), qui vixit annos p(lus) m(inus) LX, Fl(avio) Eutharico v(iro) c(larissimo) cons(ule).
234 Heikki Solin
b) "christogramma" Hic requiescit in pace religiosa Palumba diacona evoceta a D(omi)no s(ub) d(ie) IIII Idus Febr(uarias), que vixit annos p(lus) m(inus) LX, indic(tione) XV Fl(avio) Bilisar(io) v(iro) c(larissimo) cons(ule).519 e 537 d. C. – Sulla datazione della seconda deposizione cfr. supra.
13. Lastra in marmo bianco. Retro grezzo. Lati diritti, ma non rifiniti. Linee guida. Punti separativi in forma di piccola S. 31,5 x 54 x 4-5; alt. lett. 3 – 4, 5. Trovata nel 2004 negli scavi di Capo La Torre (tomba 70). Autopsia 2008.
† hic requiescit Re- gina in pace, qui vix- it an(nis) pl(us) m(inus) XLV et bocita d(ie) K(a)l(endas) Martias5 Fl(avio) Balerio v(iro) c(larissimo) <co>(n)s(ule).
2 qui per quae, fenomeno comune nella lingua volgare, in particolare in documenti della tarda antichità. – 4 D sembra da intendere d(ie); die seguita dall’indicazione del giorno in accusativo non è, beninteso, co-mune, tanto meno nell’indicazione delle calende, none e idi ma il tipo esiste: ICUR 478; 2531; 2849; 3582; 4403; 4904; 13120; 16089; 17478; 23578; CIL III 8849 = 9530; VIII 10638; 10904; 20412; 20453; 21479; 21681; 22842; 23041; 23061; X 8079. 8080; XI 4996; XII 5339; XIII 1548; 2360; IHC 60; 62; 77; 305; 308; 310; 525; 506; HEp 15, 458; RIT 945; ILJug 2033; AE 1905, 3 (Afr. proc.); 1992, 1787 (Lepcis Minor); 2004, 920 (Aquitania); IAM 2, 506; ILAlg I 2759; IRT 193; I. Altava 193. – 5 il lapicida ha commesso un errore scrivendo V C S invece di V C COS.
521 d. C., come sembra. Di solito il nome corre nelle datazioni senza Fl., ma non abbiamo altri anni con le stesse caratteristiche.
14. Due frammenti combacianti di una lastra in marmo (brecciato rosa da Bitinia). Retro liscio. Linee guida. (13) x (24,7) x 1,4; alt. lett. 3,8-4. Punti a forma di S nella riga 2. A fine testo, O e R sono attraversate dalla sbarra obliqua, che evidentemente sta a indicare che il nome del secondo console era abbreviato. Ritrovato nel 1995 negli scavi a Capo La Torre ad Atripalda. Attualmente nei depositi del museo Irpino. Autopsia 1996 e 2008.
235Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
"christogramma" Abundantius vir inl(ustris) et patricius ex p(rae)p(osito); dep(ositus) XVIIII Kal(endas) Ian(uarias) tert(ium) p(ost) c(onsulatum) Lampadi, Or(estis).533 d.C. – Sull’interpretazione dell’epigrafe vedi supra.
15. Due frammenti combacianti di una stele in marmo bianco. Retro liscio. Lati superiore, sinistro e inferiore dritti; quello destro grezzo. Da punti divisori, non incisi regolarmente, fungono linee sottili o verticali o lievemente oblique. 6,45 x 48 x 4; alt. lett. 4,3 – 5 (righe 1-2), 5 – 6 (riga 3), 4,5 – 5 (riga 4), 3 – 4,5 (riga 5), 4 – 5 (riga 6). Ritrovato negli scavi a Capo La Torre ad Atripalda (T 707); n. inv. 210569. Attualmente nei depositi del museo Irpino. Autopsia 2012.
† hic requiescit innoce(ns) Gratus, qui vixit ann(is) GII, dep(ositus) Idu(s) Martia(s) et iter(um) pos(t) cons(ulatum)5 Basili v(iri) c(larissimi) IIII.
4 non è da leggere IDVS MARTIAS; il segno dopo IDV e MARTIA non è una S, bensì il punto; invece in 4 dopo PO segue chiaramente una S, dunque pos(t), e non po(st).
2 Gratus era un cognome diffusamente in uso nell’onomastica romana, ma meno comune nell’antroponimia cristiana. kajanto, LC p. 282 ne elen-ca quattro attestazioni cristiane (più sei attestazioni di Grata), ma l’esame dei nuovi volumi (IV-X) delle ICUR ne ha aumentato alquanto il numero.45 Invece ben documentati nell’antroponimia cristiana i nomi suffissali quali Gratianus o Gratiosus. – 3 sull’uso dell’accusativo nell’indicazione delle calende, none e idi vedi supra n. 13. – 4 il termine et iterum sta per indicare lo stesso di tertium post consulatum (usato per es. in n. 14). Non era abitu-dine molto comune di servirsi di questo termine; ne conosco i seguenti casi: ILCV 135, 690, 1278, 1304, 3186, 3189; ICUR 20389; ICI VII 25.46 Poiché
45 Le seguenti attestazioni non sembrano essere comprese nelle cifre di KAJANTO: di Gratus: ICUR 14016 (un senatore del IV o del V secolo; manca in PLRE), 15970, 11 (tardo, forse medievale), 25225; di Grata: ICUR 17141, 18865 Grate (forse dativo), 20082, 23966 (Crata). Non mi è del tutto chiaro se le due iscrizioni, in cui compare Grata, cioè ICUR 24413 = ILCV 4611 adn. e 27424 = ILCV 4005 E adn. siano comprese nella statistica di KAJANTO; probabilmente no, in quanto le sue statistiche sembrano basarsi unicamente sui volumi del CIL e delle ICUR.
46 Cfr. anche A. SZANTYR, ThLL VII 2, 556, 43-48.
236 Heikki Solin
Basilius era console nel 541, l’iscrizione si data al 544 (in CIL XI 1408 da Luna si usa dello stesso anno la formula III p(ost) c(onsulatum) Basili v(iri) c(larissimi)). Che cosa voglia dire alla fine del testo IIII perforato da una linea leggermente obliqua che va dal basso a sinistra verso l’alto a destra, non è dato da vedere; per congettura si potrebbe proporre di vedervi il quar-to anno dopo il consolato dell’imperatore Giustino: IIII post consulatum Iustini, se è lecito pensare che il lapicida (se non l’ordinator) avesse dimen-ticato di aggiungere, dopo IIII, il resto della formula. – 544 d.C.
16. Frammento visto dal Mommsen nel monastero di S. Pietro a Cesarano presso Mugnano. Irreperibile (nel monastero non c’è; sopralluo-go nel 1984).
[Hic r]equiescit in pace [---]nus lictor, qui vixit [an]nos pl(us) m(inus) XIII, d(e)p(ositus) III K(a)l(endas) Sep- [te]mbris XVII p(ost) c(onsulatum) Basili5 [-- per ? i]udi7ci8um vos coniur(o) ut ni qui sepoltura mea violet.
luPoli, Iter Venusinum, 1793, p. 23. MoMMSen, CIL X 1193 (dieHl 3869).
2 = lector. 5 [---]‹DIOVM la lapide (secondo il Mommsen), ante iuDI-CIVM Lupoli; forse il lapicida ha scritto male O per CI.
558 d. C.
237Le iscrizioni paleocristiane di Avellino
Bibliografia
Abellinum 1976-1996 = Abellinum 1976-1996. Vent’anni di ricerca archeo-logica. Dogana dei Grani - Atripalda (AV), 30 ottobre - 31 dicembre 1996 (un dépliant).
Atti Acc. Arch. Napoli = Atti della Reale Accademia di archeologia, lettere e belle arti, 1 - n. s. 15, Napoli 1865-1936.
Campania fra tarda antichità e alto medioevo = La Campania fra tarda anti-chità e alto medioevo. Ricerche di archeologia del territorio. Atti della giornata di studio Cimitile, 10 giugno 2008. A cura di C. ebaniSta e M. rotili, Cimitile 2009.
CaSSeSe = l. CaSSeSe, Spunti di storia di Atripalda, Avellino 1930; ristampa Salerno 1974.
CIL = Corpus inscriptionum Latinarum, Berolini 1863-. CLRE = r. S. bagnall - a. CaMeron - S. r. SCHWartz - k. a. WorP, Consuls
of the Later Roman Empire, Atlanta 1987. Cristiani nell’Impero romano = Cristiani nell’Impero romano. Giornate di stu-
dio. S. Leucio del Sannio - Benevento, 22, 29 marzo e 5 aprile 2001, Napoli 2002. Fariello Sarno = M. Fariello Sarno, La necropoli paleocristiana di
Abellinum, Avellino s. d. galante = g. a. galante, Il cemetero di S. Ipolisto martire in Atripalda e
altri scritti. Ristampa anastatica. Introduzione di R. La Sala. Appendice bibliografica a
cura di A. Berrino, Atripalda 1984. Il saggio principale “Il cemetero di S. Ipolisto martire in Atripalda, diocesi di Avellino” uscì originariamente in Atti Acc. Arch. Napoli, 16, 1891-1893, 189 sgg. Qui di sotto le pagine si riferiscono alla ristampa.
gaMbino, Ricorda che… = N. gaMbino, Ricorda che… Un gruppo di martiri ha dato la vita per la libertà della Santa chiesa avellinese, Avellino 1990.
Hälvä-nyberg = u. Hälvä-nyberg, Die Kontraktionen auf den lateinischen Inschriften Roms und Afrikas bis zum 8. Jh. n. Chr., Helsinki 1988.
ICUR = Inscriptiones christianae urbis Romae, n. s. I-X, in Civitate Vaticana 1922-1992.
ILCV = Inscriptiones Latinae christianae veteres, edidit e. dieHl, I-III, Berolini 1925-1931;
IV Supplementum, ediderunt J. Moreau - H. I. Marrou, Dublini et Turici 1967. ILTG = P. WuilleuMier, Inscriptions latines des trois Gaules (France), Paris
1963. kajanto, Lc = i. kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki 1965. lanzoni = Fr. lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo
VII (an. 604) (Studi e testi 35), Faenza 1027. lePore = g. a. lePore, La Basilica della Annunziata in Prata di P. U., Viterbo
1935. NBullAC = Nuovo Bullettino di Archeologia cristiana. PaSSaro, Propagazione = g. PaSSaro, La propagazione del cristianesimo in
238 Heikki Solin
Irpinia e la Istituzione delle diocesi, in Cristiani nell’Impero romano. Giornate di studio, S. Leucio del Sannio - Benevento 22, 29 marzo e 5 aprile 2001, Napoli 2002.
PLRE = Prosopography of the Later Roman Empire. RAC = Rivista di archeologia cristiana. Rass. Stor. Irpina = Rassegna Storica Irpina. Solin 1 = H. Solin, Le iscrizioni paleocristiane di Avellino, in Epigrafia roma-
na in area adriatica. Actes de la IXe rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain, Macerata, 10-11 novembre 1995, a cura di G. Paci, Macerata 1998, 471-484.
Solin 2 = H. Solin, Eine neue Quelle für das Spätlatein: Christliche Inschriften von Abellinum, in Latin vulgaire - latin tardif V: Actes du Ve colloque inernatio-nal sur le Latin vulgaire et tardif, Heidelberg, 5-8 septembre 1997, édités par H. PeterSMann - R. ketteMann, Heidelberg 1999, 477-485.
Solin, GPN2 = H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, Berlin - New York 20032.
Spp = Studien zur Paläographie und Papyrologie.