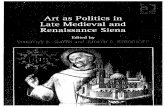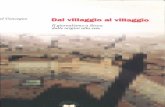I resti faunistici dall'insediamento romano di Pantani-Le Gore (Torrita di Siena-SI)
Le rime di Antonio di Cecco da Siena
Transcript of Le rime di Antonio di Cecco da Siena
INDICE
ANGELO EUGENIO MECCA, Dante e il Serventese romagnolo del1277
MARIA CLOTILDE CAMBONI, Le rime di Antonio di Cecco da Siena
ELISABETTA CREMA, Osservazioni sulla tecnica della rima tra ilFurioso e l’Amadigi
ALESSANDRA DI RICCO, Note sull’eredità pariniana: GiovanniTorti e Alessandro Manzoni
VINICIO PACCA, «Tuo fratello morì giovane»: la famiglia dellaMosca e la genesi degli Xenia
TESTI E DOCUMENTI
LUCA D’ONGHIA, Frotola de tre vilani bergamasca (1527)
MAIKO FAVARO, Su alcuni componimenti sconosciuti di Erasmo daValvasone
DISCUSSIONI
CLAUDIO GIUNTA, Poesia antica e poesia moderna (a proposito diun libro recente di Guido Mazzoni)
CARLO CARENA, Il mito classico dalla Commedia alla Conquistata
9
19
75
139
157
187
207
231
253
*Ringrazio Pietro Beltrami, Anna Bettarini Bruni, Furio Brugnolo, Roberta Cella, Domenico de Robertis,Claudio Giunta, Pär Larson e Roberta Manetti per i preziosi suggerimenti.1. Le due rubriche sono «Sonetto fecie Antonio di Cieccho da Siena» (c. 85r) e «Misticcio del sonettodi sop(r)a fecie Antonio di Ciecho» (c. 85v). (Nella trascrizione delle rubriche, degli incipit e degli expli-cit sciolgo le abbreviazioni – tra parentesi tonde –, separo le parole, introduco la punteggiatura, le maiu-scole e i segni diacritici secondo l’uso moderno, distinguo u da v e sostituisco il grafema j con i). I due te-sti sono inoltre affini dal punto di vista del contenuto: in entrambi il poeta si rivolge alla stessa persona,si citano, pressappoco negli stessi termini, altri due personaggi e si richiede al destinatario o ai destinataridel vino di Candia.2. Cfr. Bilancioni, p. 98.3. TINUCCI, Rime, p. XV; il sonetto è pubblicato (come di Niccolò Cieco) in LTQ, vol. II, p. 211.
MARIA CLOTILDE CAMBONI
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA
1. Il manoscritto miscellaneo Conventi soppressi 122 della Biblioteca MediceaLaurenziana di Firenze (Lc) trasmette vari componimenti attribuiti a «Antonio diCecco da Siena» (o, più semplicemente, a «Antonio di Cecco»): due canzoni, unaballata, sette sonetti e un testo dalla forma non immediatamente riconoscibile,definito «misticcio» dalla rubrica, la quale informa anche della sua relazione colsonetto trascritto subito prima1. Altri tre sonetti fanno parte di altrettanti scambicon un altro rimatore, il «conte Naddo»: nel codice sono trascritte anche le suedue proposte e la sua risposta al missivo del senese. Fra quelli di Antonio e quellidel suo corrispondente vi sono quindi in totale quattordici testi: nessuno di essi èstato mai pubblicato o citato altrove, e nessuno risulta attestato in altri mano-scritti. Lc sembra quindi essere l’unica testimonianza oggi disponibile della pro-duzione poetica di Antonio di Cecco.Un poeta chiamato Antonio da Siena compare però nell’Indice delle carte di
Pietro Bilancioni, dove sono citati come suoi due sonetti2. Il primo, O novello Ar-go, e’ ti convien guardare, è trascritto nel Chigiano L.IV.131 della Biblioteca Apo-stolica Vaticana e nel Rediano 184 della Biblioteca Medicea Laurenziana (in en-trambi i casi attribuito ad «Antonio da Siena»); il secondo, Quantunque e’ vi siainnanzi agli occhi tolta, sembra essere un caso di errata attribuzione. Infatti, purtrovandosi nei manoscritti anche sotto il nome di Antonio Cieco da Siena e sottoquello di Niccolò Tinucci, il sonetto è da restituire a Niccolò Cieco, che lo inviò«nel 1440 a Cosimo dei Medici in occasione del lutto che lo aveva colpito nellapersona del fratello Lorenzo»3.In realtà, in alcuni testimoni sotto il nome di Antonio Cieco da Siena non si
trova il sonetto originale di Niccolò, ma un suo «raffazzonamento [...], confezio-
4. TINUCCI, Rime, p. XVI.5. In LTQ, vol. II, p. 211, il Barberiniano latino 3679 (attribuizione a Antonio Cieco da Siena) è citatofra i testimoni del sonetto di Niccolò Cieco; in TINUCCI, Rime, p. XVI lo stesso manoscritto pare invecetramandare il rifacimento (assieme al Vaticano latino 4830 e alla raccolta dei poeti senesi di mons. LeoneAllacci - Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigiano M. VI. 127 - e quindi alle copie daquesta tratte).6. La data del sonetto va forse avvicinata a quella della raccolta di laudi stampata a Firenze nel 1485,in cui si trova una «Lauda di don Antonio da Siena iniesuato» (cioè dell’ordine dei Gesuati), Con giubi-lante core: cfr. CRESCIMBENI 1730, vol. II, part. II, lib. IV, p. 178, n. 23: «In una Raccolta di Laudi stam-pata in Firenze per Fran.o Buonaccorsi a petitione di Jacopo di Maestro Luigi de’ Morsi nell’anno 1485,adì primo di Marzo, [...] leggesi una sua [= di Antonio Cieco da Siena] laude». (In realtà, vista la diffu-sione del nome è possibile che si tratti ancora di un altro personaggio).7. Allo studio del codice è dedicata la mia tesi di dottorato (CAMBONI 2004).8. Il sonetto fu scritto quando ancora l’autore era araldo della Signoria fiorentina, carica che lasciò ap-punto nel 1446 (anche se già dal 1442 venne affiancato dal già citato Anselmo Calderoni). Fa infatti rife-rimento a un’alleanza fra fiorentini e senesi, ed è «da ricongiungere a due canzoni dell’araldo della Signo-ria di Siena fino a noi pervenute. Unito a queste, ci offre un esempio prezioso, forse l’unico che possie-diamo, di vera e propria corrispondenza ufficiale in rima tra due repubbliche italiane del quattrocento»(FLAMINI 1891, p. 228; le due canzoni sono poi state pubblicate in LTQ, vol II, pp. 489-93).9. Entrambi sono tramandati solo da Lc; trattandosi di testi riferiti a fatti di cronaca dell’epoca, po-
nato dal senese in occasione della ‘morte del padre di messer Giuliano Davanza-ti’»4: un altro componimento, rifatto sul primo, che ha lo stesso incipit del suomodello. Non è in questa sede possibile stabilire in quali testimoni sia trascritto ilsonetto di Niccolò Cieco e in quali la versione posteriore5: sembra comunque daescludere che Antonio Cieco da Siena, l’autore del rifacimento di Quantunque e’vi sia, sia da identificare con Antonio di Cecco da Siena, l’autore delle poesie tra-mandate in Lc. Infatti, se il sonetto-modello di Niccolò Cieco è del 1440, il rifaci-mento del senese deve essere ovviamente più tardo6. Tale datazione alla secondametà del secolo XV (o al limite alla metà dello stesso secolo) però non pare vero-simile per l’autore dei testi conservati in Lc.
2. Lc è stato compilato a più riprese durante la prima metà del secolo XV: il suocopista principale (nonché primo possessore) ha più volte aggiunto al primo nu-cleo del manoscritto altri fascicoli, per poter ampliare la raccolta copiandovi testiattinti da fonti acquisite successivamente. La dinamica degli accrescimenti materia-li è piuttosto chiara, ed è di conseguenza possibile suddividere il manoscritto in piùsezioni, ognuna composta da fascicoli aggiunti al codice nello stesso momento7. Itesti di Antonio di Cecco e del conte Naddo sono tutti trascritti nella prima di que-ste sezioni, e quindi nella parte del codice che è stata compilata per prima.Anche considerando le sezioni successive, nel manoscritto non è presente nes-
sun rimatore attivo nel pieno del secolo XV: i testi più recenti in esso trascritti sonocon ogni probabilità il capitolo in terza rima di Anselmo Calderoni dedicato aBraccio di Montone, morto nel 1420 (data limite entro cui va situata la sua compo-sizione) e un sonetto di Antonio di Meglio sicuramente anteriore al 14468, che so-no stati copiati rispettivamente nella penultima e nell’ultima sezione del codice9.
20 MARIA CLOTILDE CAMBONI
trebbe non essere del tutto azzardato ipotizzare che fra la data della composizione e quella della trascri-zione non sia passato molto tempo.10. È rimarchevole il fatto che il copista di Lc, che altrove lascia anche più di una riga in bianco permarcare l’assenza di uno o più versi (versi che trascrive quasi sempre in colonna), qui non segnali le lacu-ne in nessun modo, segno che nel suo antigrafo non erano palesi. Per l’ipotesi che la perdita dei tre versiiniziali e di altri tre versi a così breve distanza sia giustificabile con la caduta di una carta in un ascenden-te e poi di un’altra in una copia da esso tratta è ovviamente necessario supporre che la la lacuna internanon sia di soli tre versi (troppo pochi per riempire una carta): d’altra parte, ammettendo che anche lacanzone I fosse composta da cinque stanze più congedo come la II, e che l’attuale prima stanza di dettacanzone tale fosse anche in origine, la lacuna fra ciò che resta di essa e l’attuale seconda stanza sarebbe di37 versi, non molti ma abbastanza per riempire entrambe le facciate di una carta di formato medio-pic-colo. Per l’incongruenza della lacuna iniziale col fatto che non è andata perduta l’attribuzione in rubrica,si potrebbe ipotizzare che la perdita della parte iniziale del testo possa essere avvenuta in una fase dellatradizione in cui una serie di testi del poeta erano preceduti da una rubrica collettiva (a questo propositovorrei segnalare il caso del fascicolo cartaceo contenente alcune poesie di Aldobrando da Siena conserva-to all’Archivio di Stato di Firenze, segnalato da BARTOLI 1863, pp. LXII-LXIII). È possibile che la lacunainiziale sia dovuta a un saut du même au même dalla rima in -ode posta alla fine del primo piede a quellaposta alla fine del secondo (e, in questo caso, sarebbe più probabile che fosse interna piuttosto che vera-mente iniziale); d’altra parte, un salto di tre versi nella trascrizione della prima stanza di una canzone èun errore di cui non conosco altri esempi, né è possibile rintracciarne in Lc, dove pure non è raro chemanchino singoli versi. Inoltre, i primi versi della canzone I trascritti in Lc non solo non hanno l’aspettodi un esordio di canzone, ma l’invettiva in essi contenuta parrebbe doversi inserire in un discorso già av-viato.11. Non è infatti certo che l’autore del sonetto-rifacimento da Niccolò Cieco sia anche l’autore della lau-da di cui alla n. 6; ma la questione esorbita dall’ambito di questo studio. L’esistenza di un rimatore più tar-do quasi omonimo non è tuttavia priva di conseguenze: difatti in vari strumenti si trovano menzioni di unAntonio da Siena, poeta, che sembrano però riferirsi tutte al più recente dei due autori (d’altra parte, An-tonio di Cecco da Siena nelle rubriche di Lc può essere chiamato Antonio di Cecco, mai Antonio da Sie-
La data della composizione delle poesie di Antonio va inoltre probabilmenteallontanata da quella della loro trascrizione in Lc: l’ipotesi di uno scarto tempo-rale fra i testi e il manoscritto che ne è latore è supportata dalle condizioni in cuici è giunta la canzone I. L’attuale prima stanza di tale canzone infatti è mutila siadell’inizio che della fine, e in base allo schema delle altre possiamo dire che nemancano i primi e gli ultimi tre versi. Dal momento che in origine doveva avernediciassette, la distanza fra le due lacune è di soli undici versi: un intervallo decisa-mente breve, soprattutto se si pensa che i versi mancanti ben difficilmente sonostati saltati nel processo di copia, e che la loro perdita è stata più probabilmenteprovocata da lacune materiali intervenute successivamente in due diversi antece-denti di Lc, uno copia dell’altro10. Per quanto rapido possa essere stato il dete-rioramento del testo, sembra difficile che la sua composizione abbia avuto luogosolo poco prima della sua trascrizione in Lc: e una datazione del poeta alla metào alla seconda metà del secolo XIV si accorderebbe bene anche con la fisionomiametrica e stilistica dei suoi testi (per cui cfr. infra, §§ 4-7).Se quindi per ragioni di cronologia Antonio di Cecco da Siena non è Antonio
Cieco da Siena, e le poesie dell’uno vanno distinte da quelle dell’altro, è legittimochiedersi a questo punto quale dei due sia l’Antonio da Siena autore di O novelloArgo, e’ ti convien guardare: ammesso che non si tratti di una terza persona11. La
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 21
na), spesso anticipato al secolo precedente a quello in cui sembrerebbe essere stato effettivamente attivo(cfr. ad esempio la datazione ‘stilistica’ del Crescimbeni a ridosso del luogo già citato alla n. 6, o quella con-tenuta in ZAMBRINI 1824, p. 199, dove si parla anche di un «poema» dello stesso autore, scritto forse attor-no al 1350, che giacerebbe tuttora manoscritto) e talvolta confuso con altri personaggi (per esempio DEANGELIS 1824, pp. 46-7, identifica l’Antonio da Siena di cui parla il Crescimbeni con un religioso domeni-cano morto nel 1363: ma tale religioso per ovvi motivi cronologici non può essere l’autore di testi scrittinella seconda metà del Quattrocento, né può essere identificato col nostro Antonio di Cecco perché la fi-sionomia del personaggio, per come si delinea dalle sue poesie, in particolare X e XI, non pare assoluta-mente compatibile con la sua appartenenza al clero regolare). In realtà, tutti i testi consultati alla ricerca dinotizie sul poeta paiono rifarsi al lavoro del Crescimbeni, che a sua volta attinge alla raccolta dei poeti se-nesi di monsignor Leone Allacci (l’attuale codice Chigiano M. VI. 127 della Biblioteca Apostolica Vatica-na), dove si parla appunto di Antonio Cieco: e non soccorrendo gli strumenti, non resta che la ricerca di-retta sulle fonti, le cui prospettive però sono solo apparentemente promettenti. Infatti i nomi citati all’inter-no dei testi (alcuni dei quali, in base a una delle interpretazioni possibili di X e XI – vale a dire, che le ri-chieste in essi contenute siano fatte a nome di un gruppo d’armati capitanati da Zan Medaglia – verosimil-mente apparterrebbero a persone che ricoprivano una qualche carica) non sembrano essere altro che ap-pellativi burleschi, o nella migliore delle ipotesi, soprannomi; in nessuna delle principali famiglie comitalidell’epoca (almeno fra quelle che avevano a che fare con Siena) è stato possibile rintracciare un «Naddo» o«Leonardo» (e anche in questo caso, è possibile si trattasse di un soprannome); il nome del poeta era moltodiffuso, il patronimico altrettanto; infine, è possibile che il poeta risiedesse abitualmente in una città diver-sa da quella di provenienza (Zan Medaglia, in base al nome, pare infatti provenire dal Nord Italia), e quin-di prima di un’eventuale ricerca in archivio andrebbe deciso in quale archivio svolgerla. È stato comunquecompiuto qualche tentativo presso l’Archivio di Stato di Siena, che non ha però avuto nessun esito.12. I due finora noti (Chigiano L.IV.131 della Biblioteca Apostolica Vaticana e Rediano 184 della Bi-blioteca Medicea Laurenziana) sono anche notoriamente imparentati: sull’identità della loro fonte perquello che riguarda la sezione in cui si trova il sonetto di Antonio da Siena, cfr. BARBI 1915, pp. 472-3.
questione, in assenza di altri testimoni del sonetto12 e nell’impossibilità di deci-frare le allusioni a ignoti personaggi dell’epoca in esso contenute, appare al mo-mento irrisolvibile, e O novello Argo resterebbe quindi un componimento di au-tore incerto. In realtà sembra molto probabile che sia da attribuire al secondo deidue rimatori, dato che nei suoi testimoni è associato a poesie di autori del pienoQuattrocento, e soprattutto visto che presenta allusioni mitologiche più facil-mente attribuibili a un rimatore più tardo e dalla cultura differente rispetto aquella, ancora trecentesca, dell’autore dei testi qui editi: di conseguenza, si è op-tato per non includerlo nella presente edizione.
3. Malgrado l’indiscutibile importanza di Lc nella tradizione di Antonio diCecco, si è scelto di non rispettare l’ordine dei testi nel manoscritto, dove essi so-no d’altra parte separati in sette blocchi distinti, sparsi in più di novanta carte einseriti in una successione in apparenza accidentale, assolutamente eterogenea epriva di coerenza interna. I componimenti sono stati riordinati (e di conseguenzanumerati) secondo il genere metrico di appartenenza, mettendo in prima posizio-ne le canzoni, poi la ballata, i tre sonetti di corrispondenza (accompagnati daicorrispettivi del conte Naddo), i tre sonetti di argomento amoroso e infine il so-netto associato al «misticcio», seguito dallo stesso. L’ordine in cui si trovano nelmanoscritto è comunque interessante: si può infatti ipotizzare che il copista di Lcli abbia trascritti da più fonti distinte.
22 MARIA CLOTILDE CAMBONI
13. La tavola del codice si trova in CAMBONI 2004, pp. 77-119.
Si dà ora di seguito l’elenco dei testi secondo la successione in cui si trovano inLc, accompagnati dal loro numero d’ordine nella tavola del codice13, dall’indica-zione delle carte nelle quali si trovano e dalla loro rubrica; a fianco al numerod’ordine nella tavola è indicato il numero del testo nell’edizione.
[14] (I) 5r-5v Chanzone morale fecie Antonio di Cieccho. Inc. «O satiata fame, oghusto ingnudo»; expl. «che più parlar no(n) può se ’l mal no(n) passa».
[15] (VII) 5v-6r Sonetto fecie Antonio di Cieccho. Inc. «Già mai il chore o l’almano(n) distilla»; expl. «sicch’io mi so’ i(n)darno affatichato».
[31] (II) 12v-14r Chanzone morale fecie Antonio di Ciecho da Siena. Inc. «O almaschonsolata e chore aflicto»; expl. «e chome a laccio uccel, così ade-scha».
[44] (IVa) 29v-30r Sonetto fecie il chonte Naddo e mandollo a Antonio di Cieccho.Inc. «O tu che tien della invidia all’archo»; expl. «che del tacier ne piglal’uom gran fructo».
[45] (IVb) 30r Sonetto fecie Antonio di Ciecho da Siena risposta di quel di sop(r)a emando al chonte Naddo. Inc. «S’io avessi in odio o nimichasse»; expl.«che l’alma e ’l chore i(n) tutto gli dismagra».
[91] (III) 69r Chanzone da ballo fecie Antonio di Cieccho. Inc. «Fonna benigna ed’amoroso aspetto»; expl. «voler star più dentro al tristo petto».
[94] (Va) 69v-70r Sonetto fecie il chonte Naddo e mandollo a Antonio di Cieccho.Inc. «Ben sublevar si può il mio i(n)telletto»; expl. «dove si spera lamente nostra ama(n)te».
[95] (Vb) 70r Risposta d’Antonio di Cieccho al chonte Naddo. Inc. «A veraso(m)mità e buono efetto»; expl. «chonservi l’alma n(ost)ra e triunfante».
[96] (VIa) 70r Sonetto di Antonio di Cieccho, mandò al conte Naddo. Inc. «Sospi-gnendomi amore a passo a passo»; expl. «a sviluparmi del feroce artiglo».
[97] (VIb) 70v Risposta fecie il conte Naddo a Antonio di Cieccho. Inc. «Bench’io siafragile e di senso basso»; expl. «chi volge i remi e salva il suo naviglio».
[98] (VIII) 70v Sonetto fecie Antonio di Cieccho da Siena. Inc. «Quando potrò, si-gnor dal cielo p(ro)dutto»; expl. «e veggia che pietà aquanto fiocchi».
[123] (X) 85r Sonetto fecie Antonio di Cieccho da Siena. Inc. «Se ’l conte padovanoo d’Albania»; expl. «non sono ingrati né brudeni o erri».
[124] (XI) 85v Misticcio del sonetto di sop(r)a fecie Antonio di Ciecho. Inc. «O prezio-so Adobbo, non essare zoppo»; expl. «arete prestamente delle chuccole».
[135] (IX) 96r-96v Sonetto fecie Antonio di Cieccho da Siena. Inc. «O ineffabile do-no, o chiaro lume»; expl. «non desideran mai altro vedere».
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 23
14. Cfr. VII, vv. 9 e 11.15. Cfr. PELOSI 1990, schemi CXXX, CXXXI e CXXXIII, corrispondenti ai componimenti 253, 254e 255.16. Cfr. PELOSI 1990, schema LXXII (componimento 161).
Le poesie di Antonio ci sono pervenute in condizioni testuali molto diverse:mentre alcune presentano errori o lacune evidenti, altre sembrano non avere inalcun modo bisogno di correzioni. La maggiore o minore – perlomeno apparente– correttezza della lezione è pressapoco sullo stesso livello per tutti i testi che nelmanoscritto appartengono allo stesso blocco: i primi che sono stati copiati sononelle condizioni peggiori, mentre gli ultimi sono quelli nelle migliori. Si è già di-scusso delle lacune della canzone I; il testo ad essa immediatamente successivo, ilsonetto VII, nella lezione del manoscritto si presenta con un endecasillabo noncanonico e una parola in rima scambiata con quella che immediatamente la pre-cede14; e anche al di là degli errori evidenti, nelle prime poesie trascritte si trova-no quasi tutte le scansioni difficoltose e la maggior parte delle rime imperfette(per cui cfr. infra, § 6). Il fatto che gli indizi di probabili corruttele siano cosìconcentrati difficilmente può essere del tutto casuale, e sembrerebbe quindiplausibile pensare che, pur trovandosi tutte nella stessa sezione del codice, lepoesie di Antonio siano arrivate al copista di Lc da tradizioni differenti, e che ilgrado di correttezza dei testi sia legato alla fonte che questi aveva davanti.Malgrado si sia di fronte a un testimone unico, la possibile provenienza dei
componimenti da più fonti, ognuna esito di una trafila testuale differente, non èquindi un dato privo di importanza: ne consegue che la cattiva qualità della lezio-ne della canzone I non può riverberarsi sui testi copiati ben più avanti nel codice,in particolare sul «misticcio», e giustificare ipotesi di errori o lacune non eviden-ti. Il «misticcio» andrà semmai accostato al sonetto ad esso adiacente (X) o aquello che lo segue qualche carta dopo nel manoscritto (IX), entrambi giudicatinon bisognosi di correzioni; e visto che la reale natura di questo testo appare unproblema di non facile soluzione, non pare inutile limitare in qualche misura lapossibilità che la sua forma dipenda da un forte stato di corruttela.
4. Lasciando per il momento da parte il «misticcio», la fisionomia metrica del-le restanti rime di Antonio di Cecco è nettamente trecentesca. Entrambe le suecanzoni si presentano con schemi che trovano dei paralleli più o meno stringentinel repertorio di Pelosi. La canzone I ha uno schema rimico (rilevato sulla secon-da stanza, la meno sfigurata) che nel suddetto repertorio ritorna ben tre volte15.La canzone II, O alma sconsolata, o core aflitto, ha non solo lo stesso schema ri-mico, ma anche lo stesso schema prosodico di Io guardo i crespi e i biondi capellidi Fazio degli Uberti16; identico è perfino il congedo (peraltro costituito sempli-cemente da coppie di rime baciate: ABbCcDD), con l’unica lieve differenza chela rima iniziale dello stesso congedo, che nella canzone di Antonio resta irrelata,in quella di Fazio ritorna invece come rima interna al quartultimo verso. Una ri-
24 MARIA CLOTILDE CAMBONI
17. «La struttura più rappresentativa (in termini quantitativi) del corpus trecentesco è quella dotata dimutazioni di due versi a rime alternate, volta con concatenatio, e ripresa generalmente distica, più spessogiocata su una sola rima, secondo lo schema / ZZ AB,AB;BZ /» (PAGNOTTA 1995, p. LX).18. Su entrambi i tipi, cfr. BELTRAMI 1991, pp. 250-1.19. CASTELLANI 2000, p. 357.20. Cfr. CASTELLANI 2000, p. 360.21. Per il passaggio di er atono (e in particolare postonico) ad ar tipico del senese e dei dialetti toscanoorientali cfr. CASTELLANI 2000, pp. 354 e 365.22. Questa forma del futuro di potere è propria sia dei dialetti toscano orientali (cfr. CASTELLANI 2000,pp. 444-5) che del senese (cfr. BIFFI 1998, p. 101), ma anche della lingua poetica: cfr. CASTELLANI 2000,p. 447.23. II 65 e 66; per la chiusura di o in u in protonia nel senese cfr. BIFFI 1998, pp. 65-6, dove è esplicita-mente citata la forma cuperchio.24. XI23; nel corpus TLIO è presente solo nella Cronaca senese dall’anno 1202 al 1362 (in Cronache se-nesi, pp. 41-158; databile a circa il 1362), a p. 115, mentre nel GDLI è citata come forma dialettale di pa-ragone dando un unico esempio da s. Bernardino da Siena (cfr. GDLI s.v. baragone).25. Per questa forma cfr. BIFFI 1998, pp. 67-8.26. Questa forma presenta sia l’esito ss (da ks) tipico tanto di Siena (cfr. CASTELLANI 2000, p. 357)quanto dei dialetti toscani occidentali (cfr. CASTELLANI 2000, p. 304) e, in concorrenza con sc, dei dialettitoscano orientali (cfr. CASTELLANI 2000, pp. 398-9), che la conservazione di ar atono nel futuro dei verbidella prima classe (cfr. CASTELLANI 2000, pp. 293, 354 e 365-7; anche tale conservazione è tipica di quasitutta la Toscana non fiorentina).27. Questa particolare forma di congiuntivo è propria sia del fiorentino che del senese, nonché di alcu-ni dialetti toscani di transizione, a partire dalla fine del secolo XIII: in seguito diventa sempre più fre-quente (cfr. MANNI 1979, pp. 156-9; BIFFI 1998, p. 106, in particolare la n. 236).
ma interna nella stessa posizione può essere ripristinata anche nel congedo di Oalma sconsolata, modificando l’ordine delle parole del primo verso (cfr. la n. al v.86 della canzone): ma visto il fatto che i legami fra la canzone dell’Uberti e quelladi Antonio non paiono sufficienti a costringere la ripresa dello schema metrico,voluta o meno, ad essere assolutamente fedele, la correzione è apparsa ingiustifi-cata ed è quindi stata lasciata a testo la lezione del manoscritto.Passando alla ballata Donna benigna, questa si struttura secondo uno degli
schemi in assoluto più comuni, ZZ AB,AB;BZ, definito dalla Pagnotta come il«più rappresentativo (in termini quantitativi) del corpus trecentesco»17. Infine, isonetti IVb, VIa e X si presentano con una coda o un ritornello, secondo i tipi at-testati a partire dal Trecento o dalla fine del Duecento (dal Trecento IVb, che hala coda costituita da un settenario in rima col verso precedente più due endeca-sillabi a rima baciata; dalla fine del Duecento tutti gli altri, che si presentano conun ritornello costituito da una coppia di endecasillabi a rima baciata18).
5. Coerentemente con la dichiarata provenienza del loro autore, i testi presen-tano vari tratti senesi: vi si ritrova ad esempio un caso di «apocope sillabica nelpron. lo ‘loro’ in funzione di dativo» (XI14)19; la prima persona sing. so ‘io sono’(VII 14)20 e l’infinito essare ‘essere’ (XI2)21; il futuro porò ‘potrò’ (III 5)22; le formecon chiusura in protonia superchio e cuperchio23 e il sostantivo baragone ‘parago-ne’24. Vi sono inoltre forme verbali diffuse in più aree della Toscana, tutte però at-testate a Siena, quali sien (XI9)25, lassarete (XI30)26, abbi (III 6) e debbi (II 34)27;
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 25
28. Ecco un elenco di casi: I 23 «tuo malvagia rete»; I 25 «tuo false promisse»; I 28 «tuo corte«; I 50«tuo veloci remi»; I 55 «la suo saetta»; I 61 «suo martiri e suo penosi afanni»; II 6 «mie debili ingegni»;II 9 «suo falsi inganni»; II 10 «suo tristi lacci»; II 29 «il mie ingegno»; II 58 «suo grazia»; II 72 «suo chia-reza»; II 77 «suo vagheza»; III 10 «suo forza»; VII 6 «tuo rimedi»; VII 8 «tuo artiglia»; VII 12 «tuo fa-ce»; VIII 3 «tuo gran virtù»; VIII 6 «mie stento»; X 8 «avendo missa tutta suo balia». Le forme sono pre-senti anche nelle poesie del corrispondente, il conte Naddo: cfr. IVa «la tuo coruzione»; IVa 14 «la<tuo> lingua»; VIb 2 «l’alte tuo parole»; VIb 6 «suo stanza»; VIb 7 «tuo spene».29. Cfr. ROHLFS 1966-9, vol. II, § 427; MANNI 1979, pp. 131-5; BIFFI 1998, p. 94.30. L’analisi della lingua del copista di Lc si trova in CAMBONI 2004, pp. 51-64; l’errata attribuzione aser Dota nasce da un falso ricordo del Flamini (cfr. FLAMINI 1891, p. 183, in n.), già segnalato da ClaudioGiunta (cfr. GIUNTA 1999, p. 122, n. 85).31. SAVIOZZO, Rime, pp. CDXLIII-CDXLIV.32. La forma dell’imperativo di II sing. delle classi diverse dalla prima in -e anziché in -i come a Firenzeera diffusa sia in Toscana occidentale che in Toscana orientale, e anche a Siena (cfr. CASTELLANI 2000, p.359).33. Cfr. CASTELLANI 2000, p. 350 e BIFFI 1998, pp. 56-7, che segnala la forma po(n)nta, mentre entram-bi segnalano la forma vence ‘vince’; è possibile rintracciare più volte vento per ‘vinto’ anche nei testi se-nesi del corpus TLIO.
molto diffuse sono poi le forme invariabili del possessivo mie, tuo e suo28, propriesia del fiorentino che del senese tre-quattrocenteschi29. Tali possessivi invariabilisono in realtà diffusi in tutto il manoscritto, il quale, anche se non è opera del no-taio ser Dota come viene talvolta affermato negli studi, è comunque stato quasicertamente copiato da un senese30. Di conseguenza, per quanto, come ha scrittoEmilio Pasquini, il copista di Lc «sembra proprio che non alteri il colorito genui-no dei testi»31, è possibile – e anzi probabile – che vi siano divergenze, anche si-gnificative, fra le forme adoperate dall’autore e la veste linguistica in cui le suepoesie ci sono pervenute, e che almeno alcuni dei tratti senesi sopra citati siano daascrivere al copista piuttosto che al rimatore.Una parte di essi sembra però da attribuire a Antonio stesso: fanno fede di ciò
alcune forme in rima, come ti stende (imperativo – I 52 – in rima con gli indicati-vi m’offende 55 e mi rende 57)32, e soprattutto tre rime apparentemente irregola-ri, punte : pronte (II, vv. 61 : 64), contento : spento : vinto (III, vv. 4 : 6 : 7) e spen-ta : vinta (VII, vv. 10 : 13). Più che di rime imperfette dal punto di vista vocalico,infatti, parrebbe trattarsi di forme in origine non anafonetiche (pónte, vénto/a)33,e quindi genuinamente senesi, successivamente modificate dando luogo all’appa-rente irregolarità, non è chiaro se dal copista di Lc o da quello del suo antigrafo.Un caso analogo si presenta anche in Va, del conte Naddo, dove rimano fra lo-
ro degno, benigno, maligno e segno (vv. 2 : 3 : 6 : 7). Si potrebbe pensare a dueoriginari latinismi, digno e signo, banalizzati da un copista: ma dal momento cheVa ha tutte le rime e svariate parole in rima, fra cui degno e segno, in comune conla risposta di Antonio (Vb), che sulla stessa rima presenta il rimante ingegno, l’i-potesi più economica è che anche Naddo adoperasse forme non anafonetiche.Ciò non implica però che fosse senese: è anzi possibile che non fosse nemmenotoscano. Il secondo verso del sonetto IVa si apre infatti con una forma non atte-
26 MARIA CLOTILDE CAMBONI
stata in Toscana, è’ ‘tu sei’. Sulla base di essa, però, non si possono certo fare illa-zioni sulla provenienza del conte: è infatti possibile che sia stata introdotta du-rante il processo di copia, per sovrapposizione di patina linguistica o, più facil-mente ancora, per la banale caduta di una s iniziale di verso (l’originale avrebbequindi avuto sè).Sempre in posizione di rima, nelle poesie di Antonio è infine possibile rintrac-
ciare alcuni settentrionalismi (cfr. IVb, v. 5 e 8, e XI42, e relative nn.) e latinismi.È quindi assai probabile che la veste linguistica originaria dei testi – così comequella delle liriche di vari poeti coevi – presentasse varie forme di provenienzaeterogenea, inserite in una base forse più toscana che senese.
6. Prendiamo ora in considerazione le rime imperfette che non sono spiegabilicon l’introduzione di forme anafonetiche al posto delle originarie non anafoneti-che: di seguito, sono elencate nell’ordine in cui si trovano nei testi (a loro voltaordinati in base alla loro posizione nel manoscritto).
1 condotti : lutti I, vv. 25 : 262 freddo : nido I, vv. 36 : 393 Apollo : rigoglio I, vv. 46 : 474 distilla : dispartilla : favilla : artiglia VII, vv. 1 : 4 : 5 : 85 fiamma : lamia II, vv. 45 : 466 alma : dramma II, vv. 79 : 807 favilla : dipartirla II, vv. 87 : 888 pene : neve : leve IVb, vv. 11 : 14 : 159 bragia : dismagra IVb, vv. 16 : 1710 spiega : tregua : niega III, vv. 10 : 12 : 1311 fievole : onorevole : debole : colpevole VIII, vv. 2 : 3 : 6 : 7
L’elenco è piuttosto nutrito, soprattutto considerando che il numero di versipreso in considerazione non è molto elevato. Alcune di queste rime in originenon dovevano essere affatto imperfette: è il caso di 1 e 7, facilmente sanabili, eprobabilmente anche di 10, dato che esiste la forma triega per ‘tregua’ (cfr. le nn.ad loca). È inoltre possibile constatare che sette rime imperfette su undici si tro-vano nei primi tre testi trascritti nel manoscritto (copiati dalla c. 5r alla c. 14r:dieci carte sulle più di novanta in cui sono sparsi i testi di Antonio), nove su un-dici nei primi cinque (dalla c. 5r fino alla c. 30r: ventisei carte), e in più di caso siaccompagnano ad altri indizi che fanno pensare che la lezione non sia più quellaoriginale; e gli unici due casi in cui l’irregolarità rimica coinvolge una vocale (eche non sono quindi riducibili a semplici assonanze), i primi due dell’elenco so-pra citato, si trovano entrambi nella canzone I e sono entrambi eliminabili ripri-stinando un latinismo (cfr. le nn. ad loca). Alcune irregolarità rimiche sarannoquindi al tempo stesso la spia e la conseguenza dello scadimento della lezione deiprimi testi del poeta copiati in Lc. Ma per quanto l’elenco qui fornito debba pro-babilmente essere ridotto, non può essere azzerato: è impossibile dire in che mi-
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 27
34. La candidata più probabile ad essere rima imperfetta anche nell’originale è certamente 11: cfr. la n.a VIII, v. 6.35. Di cui Antonio potrebbe conoscere le Heroides nella versione volgarizzata da Filippo Ceffi: cfr. la n.a II 46.36. Per l’elenco delle rime, ecc., cfr. il cappello introduttivo al testo.
sura, dal momento che non si può stabilire quali fra le rime sopra citate siano vo-lute dall’autore e quali no, ma è assai probabile che l’assonanza per la rima rien-trasse fra le possibilità ammesse dal poeta34.
7. Antonio di Cecco pare nutrire una spiccata predilezione per figure retori-che quali l’esclamazione (a volte comprendente l’apostrofe, ma non sempre) el’interrogazione più o meno retorica, entrambe spesso associate all’anafora. Talepredilezione è evidente soprattutto nelle due canzoni e nei sonetti di argomentoamoroso. Per il IX, in particolare, vengono in mente alcuni sonetti dei Rerumvulgarium fragmenta, come il 161, il 146 e il 253 (gli ultimi due sono rivolti alladonna amata come quello del senese). Da un lato, però, simili anafore-apostrofi aun destinatario ripetute più volte sono già presenti in alcuni sonetti di Guittone,dall’altro la figura sembra più che altro propria dello stile del poeta, che anzi ten-de a variarne le modalità di utilizzo sia rispetto alle parole (o ai sintagmi) fatteoggetto di ripetizione, sia rispetto alle sedi in cui vengono collocate: basta guar-dare la seconda stanza della canzone I (sei occorrenze di tu anaforico nei primicinque versi) o la canzone II, dove ogni stanza – resta escluso solo il congedo – siapre con parole o sintagmi poi ripetuti al suo interno (un simile uso dell’anaforanelle stanze di una canzone è riscontrabile in Cino da Pistoia: cfr. il cappello in-troduttivo alla canzone II).Situazioni analoghe a quella appena delineata per l’anafora tendono a presen-
tarsi ogniqualvolta si cerca di porre il problema dei modelli poetici di Antonio ocomunque dei suoi contatti con altri rimatori. Trovare casi sicuri di intertestualitàappare difficoltoso. Non che il poeta brilli per originalità rispetto al resto dellaproduzione trecentesca: al contrario, la maggior parte delle tematiche da lui af-frontate e la cultura a cui fa riferimento (per esempio, le allusioni mitologiche sibasano su Ovidio35 come usuale nel Trecento), oltre che lo stile e il linguaggio dalui adoperati, appaiono talmente comuni al resto della produzione coeva da nonpermettere di accostare Antonio di Cecco da Siena a nessun altro rimatore tre-centesco in particolare.È emblematico a questo proposito il caso della canzone II e dei suoi possibili
rapporti da un lato con il Filostrato del Boccaccio, dall’altro con Io guardo i crespie i biondi capelli di Fazio degli Uberti. La canzone di Fazio e quella di Antoniocondividono una caratteristica significativa come lo schema metrico e presentanovarie rime e rimanti comuni: nella maggior parte dei casi però questi sono piutto-sto banali, e il rapporto diretto fra i due testi resta indimostrabile36. In quanto aicontatti col Filostrato, all’interno della canzone II di Antonio è possibile trovare
28 MARIA CLOTILDE CAMBONI
37. Cfr. le nn. ad loca della canzone II.38. Cfr. il cappello introduttivo al sonetto.
prima una metafora (quella dell’acqua che, gettata nella fucina, anziché smorzareil calore-sentimento amoroso, lo ravviva: vv. 52-53) e poi un sintagma («valore ul-timo», tecnicismo per indicare la suprema ricompensa che si può ottenere incampo amoroso: vv. 90-91) già utilizzati nel Filostrato di Boccaccio, oltretutto peresprimere gli stessi concetti37. La metafora nasce però da un’immagine ben pre-sente nella cultura del tempo, innestata su quella (assai comune) del fuoco-senti-mento d’amore, mentre il sintagma esprime un concetto anch’esso vulgato, pro-veniente dalla trattatistica di argomento amoroso (a partire dal De Amore di An-drea Cappellano). Non è impossibile che Antonio di Cecco conoscesse il Filostra-to e intendesse citarlo: ma i punti di contatto rintracciabili fra i due testi nonpaiono sufficienti a dimostrarlo.Anche da questa difficoltà ad accostare Antonio ad uno piuttosto che ad un
altro dei rimatori medievali dipende la gravosità del tentativo di darne una collo-cazione più precisa nel tempo e nello spazio. Non aiutano le poesie di corrispon-denza, visto che i suoi scambi poetici sono tutti col conte Naddo, di cui non co-nosciamo testi differenti dai sonetti che invia ad Antonio, così che risulta ancorpiù misterioso di lui. Neppure soccorrono le poesie ‘d’occasione’, dato che è at-tualmente impossibile comprendere a quali personaggi ed eventi si faccia riferi-mento nei testi di argomento non amoroso. Il contesto in cui viveva l’autore restaquindi nebuloso. Rispetto ai principali rimatori trecenteschi – soprattutto quelliche possiamo ipotizzare abbiano vissuto esperienze simili, come ad esempio il Sa-viozzo – si può però rilevare come sia assente, nella produzione di Antonio, la te-matica religiosa, e sia abbastanza ridotto anche lo spazio delle rime d’occasionerispetto a quelle d’amore. Ciò potrebbe d’altra parte dipendere semplicementedai gusti del copista di Lc, o dalla casuale perdita, nella tradizione, di rime dedi-cate ad alcune tematiche piuttosto che ad altre. Tuttavia, è possibile notare comele poesie di argomento amoroso del nostro poeta rispetto a quelle dei rimatorisopra citati abbiano un aspetto arcaizzante. L’argomentazione tende infatti a sci-volare verso l’analisi degli effetti di Amore e la conseguente affermazione di ve-rità generali, valide per tutti coloro che ne sono vittima (questa tendenza allagnome è riscontrabile anche nelle due risposte del poeta a Naddo). Nelle rimed’amore di Antonio lo psicologismo gioca un ruolo notevole, e lo spazio per ladiegesi e più in generale per la realtà evenemenziale (per quanto fittizia) ne risul-ta di conseguenza molto ridotto; si parla di e con Amore molto più che di e conMadonna, che resta una figura assolutamente indeterminata; e come già detto, sitende a non uscire dai topoi del genere. In questo quadro di apparente arretra-tezza rispetto al clima letterario del pieno secolo XIV assume una certa rilevanzail fatto che il modello più evidente (quasi clamoroso, in questo caso) di un testodi Antonio, il sonetto VIII, sia la canzone Quando potrò io dir: «Dolce mio dio,modello qui forse non solo linguistico e stilistico ma ideologico38. L’influenza di
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 29
39. Cfr. a questo proposito BALDUINO 1984, pp. 199-200 e sgg.40. BALDUINO 1984, p. 202.41. PANCHERI 1993, p. 55, n. 96.42. GIUNTA 2004, p. 43 e n. 15.43. GIUNTA 2004, pp. 43-4.44. PETRARCA, Disperse, pp. 263-9; da notare che per Pancheri il testo «si pone al di là del discrimine
Cino sui rimatori della seconda metà del secolo è infatti ridotta39 e quando purevi sia la «ripresa di materiali linguistici», questa «è ormai solo un dato esterno edepisodico»40. Di conseguenza, è possibile che le caratteristiche sopra citate dellapoesia di Antonio dipendano dal suo essere stato attivo nella prima metà del Tre-cento: ma dato che nessun elemento più concreto di quelli qui addotti può giu-stificare questa datazione, è forse più probabile che si tratti semplicemente di unrimatore dal gusto attardato rispetto all’epoca in cui viveva.
8. Il testo di Antonio che solleva più questioni è senza dubbio il «misticcio». Iltermine è stato già citato da Alessandro Pancheri per «illuminare i rischi di unaeccessiva fiducia nelle rubriche», dal momento che i suoi «referenti spaziano dal-la canzone Mai non vo’ più cantar [...] ai componimenti così rubricati» appuntoin Lc41, alcuni dei quali sembrano essere frottole o «testi morfologicamente mol-to prossimi alla frottola», mentre altri sono stati definiti da Claudio Giunta «testiche non sembrano avere alcuna struttura metrica definita, né alcuna ratio nellasuccessione delle rime, e che perciò andranno piuttosto considerati come prosarimata»42. Giunta cita inoltre altri manoscritti nelle cui rubriche è presente lostesso termine, quali il «Riccardiano 1091, il Palatino Parmense 286» e il «canzo-niere 10077 della Biblioteca Nazionale di Madrid»43, dove «misticcio» è riferitoal serventese sulla vecchiaia di Antonio Pucci.Il testo, quindi, è preceduto da una ‘definizione di genere’ quantomeno ambi-
gua, dal momento che viene associata a oggetti non omogenei: e questo problemanon si pone solo fra manoscritti diversi, ma, come osservato da Giunta, già all’in-terno del solo Lc, dove i testi chiamati in rubrica «misticcio» sono anzi persinopiù difformi di quanto già visto. Pare quindi ora necessario approfondire la loroanalisi, per vedere da quali caratteristiche possano essere accomunati, e quale siaquindi per il copista il significato di questa definizione.Nelle rubriche del manoscritto, «misticcio» ricorre sei volte; i testi così definiti
si trovano tutti nella prima sezione, raggruppati in due serie distinte. I primi tresono alle cc. 22r-25r, uno di seguito all’altro senza interruzioni; gli altri tre sonoinvece collocati alle cc. 84r-85v, dove dopo i primi due «misticci», adespoti econsecutivi, si trova il sonetto X di Antonio di Cecco, seguito dal suo «mistic-cio», a cui – come già detto – è in qualche modo associato.Di questi sei testi, cinque sono trascritti a mo’ di prosa, con una punteggiatura
composta da barrette oblique, e uno con i versi disposti su due colonne. È l’ulti-mo della prima serie (cc. 24r-25r), Accor’uomo! ch’io muoio, già stampato dal So-lerti tra le «frottole attribuite a Francesco Petrarca»44. Anche un altro «mistic-
30 MARIA CLOTILDE CAMBONI
oltre il quale la distinzione fra frottola e serventese è fondata al più su basi contenutistiche» (PANCHERI1993, p. 53) dal momento che è una serie di senari/settenari rimati a coppie e non un testo in cui «la mi-sura del verso oscilla» (BELTRAMI 1991, p. 296).45. SACCHETTI, Rime 2005, pp. 5-12. Il testo in Lc è dotato di un’attribuzione concorrente (a Nastagioda Montalcino; quella a Giannozzo Sacchetti è stata aggiunta in un secondo momento).46. L’affermazione sembra essere valida anche per Mentr’io d’amor pensava, malgrado le varie irregola-rità che il testo presenta sia nell’edizione citata nella n. precedente sia in SACCHETTI, Rime 1948 (pp. 85-93). Nessuna delle due editrici, infatti, sembra interessarsi in maniera particolarmente approfondita del-l’assetto metrico del testo, e le irregolarità di cui ho parlato non vengono quindi da loro segnalate (oltre anon venire – almeno apparentemente – prese in considerazione in sede di restituzione testuale): maognuna di esse sembra sanabile facendo ricorso a una differente suddivisione dei versi o, al limite, alla le-zione di un testimone diverso dal latore di quella adottata a testo.47. BELTRAMI 1991, p. 49.
cio» (il primo della stessa serie: cc. 22r-23v) è già stato pubblicato: si tratta diMentr’io d’amor pensava di Giannozzo Sacchetti45. Gli altri tre «misticci» (oltre aquello di Antonio di Cecco), adespoti, sono invece inediti, nonché unica di Lc.Mentre il testo intermedio della prima serie (cc. 23v-24r, incipit Chi piangie,
chi canta) ha una forma simile sia a Accor’uomo! ch’io muoio, sia a Mentr’io d’a-mor pensava (i due testi adiacenti), i due trascritti subito prima del sonetto di An-tonio (e qui pubblicati in Appendice) pongono grossi problemi. Tutti i testi dellaprima serie possono infatti essere definiti ‘testi rimati in maniera continuativa’, esono anzi accomunati dalla presenza quasi esclusiva, in tutti e tre, della rima ba-ciata (piuttosto che alternata o incrociata)46. I due delle cc. 84r-85r invece nonrientrano neppure in una definizione così generale; e il secondo, Ben vengaLapo!, un dialogo scherzoso fra il compratore e il venditore di un cavallo, nonpare possa essere considerato nemmeno un testo contenente delle rime.Di fatto, è impossibile rintracciarvi due parole che siano in un rapporto di rima
chiaramente riconoscibile come tale: non vi è infatti nessun omoteleuto tra formeabbastanza vicine da consentire d’individuare immediatamente l’identità fonica.Si può notare una serie di ‘rime’ tronche identiche, data dalle (sei) occorrenze ca-taforiche della forma à (da avere) nelle domande poste dal compratore (costruitesecondo il modulo «Che [parte del corpo del cavallo] à?»), ma la ripetizione diuna forma dalla frequenza così elevata non pare da considerare rima. È inoltrepossibile rintracciare un paio di assonanze, delle quali, però, in assenza di vere ri-me, non pare il caso di tenere conto. In base al principio «né verso senza rima, nérima senza verso», Ben venga Lapo! non sarebbe dunque un testo in versi.Neppure il tentativo di rintracciare all’interno del testo serie sillabiche della
stessa lunghezza (prendendo come riferimento il sistema di punteggiatura delmanoscritto) ha avuto esito: le barrette infatti individuano serie di sillabe di lun-ghezza assai variabile, e talvolta eccedente qualunque misura versale (escludendoi versi doppi). Dato che «i versi sono tra loro in rapporto di equivalenza in quan-to ognuno è ‘commisurabile’ con gli altri, in termini di numero di sillabe, accentio, nella metrica quantitativa, di durate» e «senza questi rapporti di equivalenza,rigorosi o elastici, la versificazione semplicemente non esiste»47, si arriva all’inevi-
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 31
48. Quest’uso è riscontrabile sia nei testi in prosa che in quelli in versi.49. Per un fenomeno analogo riscontrato per le frottole nell’autografo del Libro delle Rime di FrancoSacchetti, cfr. AGENO 1990, p. 316: «la mancanza del segno divisorio è comprensibile, per essere l’ultimaparola del verso in fine di riga».50. In questo caso, l’incongruenza potrebbe trovare un spiegazione logica nel salto, da parte del copi-sta, di una risposta del venditore (vi sarebbe quindi una lacuna non evidente). Per quello che riguarda in-vece i due casi in cui la barretta fra il discorso del venditore e quello del compratore è assente pur nonessendoci cambio di rigo, si può notare come questi costituiscano anche le uniche due eccezioni alla re-gola, altrimenti in questo testo sempre osservata, per cui l’inizio di ogni ‘battuta’ è segnalato da unamaiuscola. Anche le maiuscole, infatti, sembrano rientrare fra i segnali delle partizioni testuali: e cfr. la n.93 e l’edizione del testo in Appendice.51. GIUNTA 2004, p. 43 n. 15.52. Nei conteggi fatti, dall’esito logicamente variabile a seconda che si conti l’incontro tra due vocali co-
tabile conclusione che Ben venga Lapo! non è un testo in versi: è prosa, e nem-meno prosa rimata.Quanto alle barrette oblique (in pratica l’unico segno di punteggiatura utilizza-
to nel manoscritto, perlopiù come diacritico avente funzione distintiva per alcunimonosillabi, quali /o/ ‘ho’, /a/ ‘ha’, /e/ ‘è’48, ecc.; con tale funzione è d’altra partepresente anche in Ben venga Lapo!), l’ipotesi più plausibile è che servano a distin-guere le parole del compratore da quelle del venditore. A questa funzione paionoassolvere coscienziosamente, ma con alcune incongruenze: anche considerandoche il cambio di riga sembra far spesso saltare i demarcatori49 ed eliminando l’in-terferenza provocata dal fatto che lo stesso segno ha talvolta funzione di diacriticoe non di divisore (e quindi stabilendo caso per caso quale, o quali funzioni abbiala barretta, dal momento che più di una volta una battura del compratore si chiu-de con un monosillabo accompagnato dai segni diacritici, e che in assenza di dop-pie barrette si deve intendere che qui un unico segno cumuli su di sé due funzio-ni), restano infatti due casi in cui la barretta fra il discorso del compratore e quellodel venditore è assente, pur non essendoci cambio di rigo, e uno in cui invece labarretta separa due domande poste una di seguito all’altra dal compratore50.
9. Il fatto che misticcio sia riferito a un testo privo di rime fa sì che in questoparticolare caso non possa essere considerata valida l’ipotesi che il termine «fini-sca per essere non tanto il nome di un genere quanto il nome di una tecnica, diuna caratteristica formale: l’incalzare delle rime, indipendentemente da qualsiasinorma metrica o prosodica»51. L’osservazione sembra valida anche per un testodove sono presenti rime chiaramente riconoscibili come tali, ma in cui tale pre-senza non è che sporadica. Tale è Io voglio che voi sacciate, che in Lc precede im-mediatamente il già visto Ben venga Lapo!.Nelle 45 righe di scrittura occupate nel manoscritto da questo «misticcio» so-
no reperibili al massimo una ventina di parole interessate da identità fonica dellesillabe finali. Sono concentrate in tre diverse sezioni del testo.Le prime due omofonie si trovano proprio nella parte iniziale. Hanno entram-
be tre occorrenze. La prima si trova a circa 14 sillabe dall’inizio52, la seconda do-
32 MARIA CLOTILDE CAMBONI
me due sillabe o come una (come ho solitamente fatto, per cui è più probabile che il numero delle sillabesia superiore piuttosto che inferiore), sono sempre comprese anche le sillabe interessate dall’identità fo-nica.53. Quest’ultima ‘parola in rima’, posta in fine di rigo, chiude un endecasillabo a minore, aperto dal se-gno di punteggiatura immediatamente precedente.54. Quasi tutte queste sequenze presentano una barra dopo la rima o l’assonanza; fra le tre parole chefanno eccezione, due sono poste a fine rigo, dove, come si è già detto, parrebbe essere indifferente la pre-senza o meno del separatore (in questa posizione comunque presente una sola volta, e alla fine dell’ulti-mo rigo della pagina: cfr. il testo di Io voglio che voi sacciate pubblicato in appendice, 75). Un separatoreè inoltre posto prima della prima sequenza di otto sillabe.
po altre 14, la terza a 7 sillabe di distanza dalla seconda. Queste prime occorren-ze appartengono alla rima desinenziale -ato (arivato : rabuffato : gastigato). Le al-tre tre non sono molto distanti (ma neppure vicine: circa 25 sillabe), e due di essesono in rima identica: si ripete infatti due volte la parola abadia, in rima per l’oc-chio con cornacchia53. Non si tratta evidentemente di omofonie molto rilevanti, esono anche abbastanza distanziate (fra la prima occorrenza di abadia e la secondacorrono 18 sillabe; fra quest’ultima e cornacchia, 15 sillabe).Le successive ricorrenze dell’identità fonica sono più significative e più vicine
fra loro, ma ben distanziate dalle prime. Immediatamente prima della metà deltesto si trovano infatti tre coppie di omoteleuti, poste una di seguito all’altra inmodo tale che ogni ‘parola in rima’ chiude una sequenza di sette-otto sillabe. Letre coppie sono: paura : mura; Era (il corso d’acqua) : era (voce del verbo essere:rima equivoca); niuno (frutto di una congettura editoriale: il manoscritto leggenimo) : pruno. Questa serie di omoteleuti è inoltre preceduta da una coppia diparole fra loro assonanti, Arno e gallo, che a loro volta paiono individuare, con lapunteggiatura del manoscritto, altre due sequenze di sette-otto sillabe, che essen-do immediatamente adiacenti a quelle chiuse dalle ‘rime’ fanno sì che vi siano inquesto punto del testo otto sequenze consecutive pressappoco della stessa misurasillabica, delimitate da figure di ripetizione fonica e dalla punteggiatura54.Tralascio altre occorrenze dell’assonanza che paiono meno rilevanti, e arrivo
alle ultime sei parole in rapporto di omofonia (verso la fine del testo). Come nelgruppo precedente, si tratta di tre coppie di rime baciate: ma in questo caso sonopiù distanziate e meno significative. Sono: uccidesti : desti (la distanza fra le dueomofonie è di circa 18-19 sillabe), pigliatelo : legatelo (lontane fra loro 9 sole sil-labe) e su : giù (ancor più vicine: 6-7 sillabe). La distanza fra la prima rima del-l’ultima coppia e l’ultima della precedente è nove sillabe; fra la prima di questa el’ultima della prima, quattro sillabe.L’analisi delle omofonie presenti in Io voglio che voi sacciate è a questo punto
completa; l’analisi delle sequenze sillabiche delimitate dai segni di punteggiaturadà risultati simili a quella già compiuta su Ben venga Lapo!. Anche in questo ca-so, quindi, si deve concludere che si tratta di un testo in prosa, in cui la rima, purpresente, non arriva ad essere un tratto caratterizzante.
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 33
55. In base alle caratteristiche di Lc, che i «misticci» – e quindi le loro rubriche – provengano da piùfonti distinte è assolutamente verosimile.56. Il primo di questi è la canzone di Antonio da Ferrara I’ me te accuso, dolce mio Segnore (cfr. BECCA-RI, Rime, pp. 89-90, in seguito ripubblicato in MANETTI 2000, pp. 290-2). Il testo è mutilo per la cadutadi una carta; trattandosi di un unicum di Lc, non è possibile ricostruire in base al numero di versi man-canti se nella carta perduta, fra la fine di I’ me te accuso e l’inizio del testo successivo, ve ne fossero tra-scritti altri (ma non sembra probabile).57. Per la possibilità che «testi in prosa rimata» si concludano «con clausole metriche prosodicamenteregolari» cfr. GIUNTA 2004, p. 50.
10. Anche se è chiaro che in Lc «misticcio» viene riferito a testi differenti sottol’aspetto formale (almeno per quello che riguarda la presenza di rime e la possi-bilità di una scansione in versi), l’analisi fin qui compiuta sui due «misticci» chenel manoscritto precedono immediatamente il dittico di Antonio non pare deltutto infruttuosa. È infatti possibile che il termine faccia riferimento ad aspettirelativi al contenuto, o a caratteristiche formali differenti da quelle su cui si è finqui concentrata l’attenzione. Oltre a ciò, dato che il copista di Lc sembra essereabbastanza passivo rispetto alle sue fonti, pare abbastanza probabile che ne rico-pi passivamente anche le rubriche. La causa del fatto che definizioni identichema distanti si riferiscono a testi fra loro difformi potrebbe quindi essere rintrac-ciata nella provenienza delle rubriche da antigrafi distinti, per ognuno dei qualila definizione avrebbe avuto un significato differente55. Viceversa: se i «misticci»di una stessa serie fossero stati tratti dalla stessa fonte, l’indicazione in rubricapotrebbe invece per essi avere lo stesso significato.O prezioso Adobbo, il «misticcio» di Antonio di Cecco, nel testimone si pre-
senta con un’impaginazione particolare: pur essendo trascritto a mo’ di prosa(tanto che ben tre parole sono spezzate in due dal cambiamento di rigo) si chiu-de infatti con una coppia di endecasillabi sdruccioli a rima baciata scritti in co-lonna.Per l’impaginazione dei testi, ancor più che per la forma linguistica e la grafia,
il copista di Lc pare riprodurre ciò che copia senza interventi di rilievo: basta ve-dere come la scriptio continua per testi apparentemente in versi (in quanto dotatidi un sistema di separatori) sia presente, oltre che nelle due sezioni dei «mistic-ci», solo nelle attuali cc. 6r-7v, per tre testi copiati uno di seguito all’altro, quasicertamente impaginati dal copista in questo modo solo perché così li vedeva nellasua fonte56. Di conseguenza, secondo il copista e il suo antigrafo, l’ultima partedi O prezioso Adobbo è in versi: e quindi si è scelto di tralasciarla e analizzare dalpunto di vista ‘metrico’ solo ciò che la precede57.Escludendo dunque dal computo il distico finale, in questo testo la presenza
delle rime appare tutt’altro che sporadica. Vi sono infatti 39 (o 37: una coppia,’ndugia - bugìa, è in ‘rima per l’occhio’) parole coinvolte da omoteleuto in 22 ri-ghe di scrittura.Le 39 (o 37) parole interessate da omofonia si possono suddividere in 15 (o
34 MARIA CLOTILDE CAMBONI
58. I riferimenti sono alla numerazione delle sequenze di testo nell’edizione leggibile più avanti, fattatenendo conto in primo luogo dei segni di divisione presenti nel manoscritto e in secondo luogo delle ri-me. Ogni sequenza testuale è quindi delimitata o da un segno di divisione del manoscritto, o da una ri-ma, o da entrambi.59. PANCHERI 1993, p. 27.60. Caratteristiche che peraltro in O prezioso Adobbo paiono assenti: cfr. il loro elenco in PANCHERI1993, p. 58.61. PANCHERI 1993, p. 41.62. Pubblicato in BECCARI, Rime, pp. 164-8, ripubblicato in MANETTI 2000, pp. 346-50.63. Cfr. PANCHERI 1993, p. 46. Vorrei far notare che il testo è conservanto in un solo manoscritto; èquindi possibile che alcune delle irrelate siano dovute alla mancata trascrizione di parti di testo.64. Cfr. PANCHERI 1993, pp. 47-8.
14) coppie e tre terne: quindi, ogni ‘rima’ torna due volte, tranne tre che ricorro-no una volta in più.La lunghezza in sillabe delle sequenze di testo comprese fra una omofonia e
l’altra è molto variabile. Le sequenze più brevi sono di 4 sillabe (cfr. XI8 eXI38)58; la sequenza più lunga ha invece una lunghezza differente a seconda chesi consideri rima ’ndugia - bugìa, o meno. Nel primo caso, tale sequenza (da XI16a XI19) ha una lunghezza di circa una trentina di sillabe (il dato varia a secondadi quante sinalefi si ammettono); nel secondo caso, comprende circa 45-50 silla-be (da XI13 a XI19).All’interno del testo vi è quindi una sequenza piuttosto lunga priva di rime.
Non è l’unica, dato che almeno altre due eccedono la misura massima di un sin-golo verso (quella costituita da XI21 - endecasillabo - e XI22 - settenario -; e quel-la costituita da XI39 - ottonario - e XI40 - settenario ); e in nessuno di questi trecasi vi sono segnali di lacune o corruttele testuali.Tale dato ha una sua rilevanza: infatti, l’unico genere metrico a cui O prezioso
Adobbo sembra poter appartenere è la ‘frottola’, forma dalla definizione metricapiuttosto debole, e attualmente oggetto di analisi contrastanti. Nello studio giàcitato, Pancheri ha tentato «di ottenere [...] un’immagine più realistica (e funzio-nale) di questa forma»59, studiando da un lato la trattatistica coeva e dall’altro itesti sicuramente trecenteschi che ‘frottole’ si autodefiniscono. Ora, lasciando daparte le caratteristiche retoriche o contenutistiche individuate come proprie delgenere60, uno dei pochissimi vincoli metrici elencati è che nella frottola «nonpossono darsi rime irrelate»61. La regola ha immediatamente le sue eccezioni:uno dei cinque testi studiati da Pancheri per determinare le caratteristiche delgenere, Si forte me dole di Antonio da Ferrara62, presenta al suo interno alcunerime irrelate63, mentre altri due (entrambi di Franco Sacchetti) accettano la rimaimperfetta64. Ovviamente le due casistiche non sono affatto equiparabili: la rimaimperfetta è pur sempre rima, mentre altrettanto non si può dire per l’irrelata. Ilpunto importante è però che ammettendo un’eccezione alla regola si apre unabreccia più o meno larga nella quale possono passare altri testi.Se nella frottola possono darsi versi irrelati, il problema a questo punto è
quanto possa arrivare ad essere lunga, al suo interno, una sequenza testuale priva
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 35
65. Su questo problema cfr. già (ma da una prospettiva leggermente diversa) GIUNTA 2004, in part. lepp. 35-41, 48-50, 71-2.66. PANCHERI 1993, p. 47.67. Una percentuale di rime irrelate pari, se non superiore, si riscontra in A l’omo savio et insenato,‘frottola’ trecentesca pubblicata di recente da Stussi (STUSSI 2002), dove però «si hanno versi di quattro(3, 5, 8, 16, 22, 30), cinque (23, 28), sei (2, 7, 19), sette (4, 6, 11, 12, 12, 15, 18, 20, 24, 27), otto (14, 17,21), nove (1, 10, 29), undici sillabe (25, 26, 31, 32, 33, 34, 35)» (STUSSI 2002, p. 50). Molte delle «quasi-rime» di questo testo sono inoltre in realtà «bisticci in rima», ovverosia rime imperfette dal punto di vistavocalico (cfr. STUSSI 2002, p. 47).68. Si tratta delle parole finali delle sequenze 2, 4, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 39. (Questo considerando frale rime anche ’ndugia : bugìa).
di rime, e quanto spesso possa ripetersi, prima che la forma del testo si perda; equindi dove si ponga, da un punto di vista strettamente metrico, o rimico che dirsi voglia (tralasciando le altre caratteristiche del genere individuate da Pancheri),il confine fra la frottola e la prosa più o meno rimata: ammesso e non concessoche le due cose siano nettamente distinte65.A differenza di Io voglio che voi sacciate (decisamente più sbilanciato verso la
prosa), O prezioso Adobbo pare un buon esempio di testo ‘al limite’ fra prosa eversi: infatti, la concentrazione di sequenze ‘irrelate’ è molto più alta che in Si for-te me dole, posto che il testo di Antonio da Ferrara contiene tre irrelate in «162versi (molti dei quali [...] con rima al mezzo)»66, mentre il «misticcio» del suoomonimo senese ne ha perlomeno il doppio ed è molto più breve. Nell’edizioneche segue, infatti, ogni rima segna il limite di una sequenza testuale (non è statoquindi ricomposto nessun verso con rima interna), e sono state inoltre conservatetutte le suddivisioni suggerite dalla punteggiatura. Malgrado ciò, il numero dellesequenze compresa la coppia di endecasillabi finali ammonta appena a 50, dellequali solo una (XI19) ha una lunghezza superiore a quella di un singolo verso, epuò essere scissa in due settenari: insomma il testo potrebbe essere composto almassimo da 51 versi. A fronte di questa presenza di irrelate in percentuale certa-mente superiore al 10% (contro il nemmeno 2% di quella del testo del Beccari),le sequenze testuali di cui O prezioso Adobbo si compone possono però nellamaggioranza dei casi essere ricondotte a versi regolari, settenari o endecasillabi(spesso ricomponibili a partire da sequenze di misura inferiore): fanno eccezionesolo 25 e 19 (che però come si è visto può essere suddivisa in due settenari)67.
11. Dagli elementi fin qui addotti appare evidente che c’è una sfasatura fra lesuddivisioni interne al testo suggerite dalle rime e quelle indicate dai segni dipunteggiatura. Infatti, se escludendo dal computo i due versi finali O preziosoAdobbo conta 48 sequenze, individuate ponendo un limite ogni volta che c’èun’omoteleuto o un segno di divisione, e nella stessa porzione di testo sono pre-senti solo 39 parole interessate da omofonia, è evidente che in nove casi la barret-ta/divisorio del manoscritto si colloca dopo una parola non legata ad altre daomoteleuto68. Si dà anche il caso contrario: all’interno del testo infatti il copistainserisce 31 segni di punteggiatura (contando anche quello, doppio, posto subito
36 MARIA CLOTILDE CAMBONI
69. Cfr. il § 8.70. Cfr. il caso della canzone di Antonio da Ferrara citata alla n. 56.71. Cfr. BERISSO 1999, p. 230 (e cfr. tutte le pp. 228-33).
prima dell’a capo che separa la coppia di endecasillabi finale dalla porzione di te-sto che la precede). Nove di questi non sono posti dopo una parola interessata daomofonia, gli altri 22, quindi, sì. Ma dato che le parole interessate da omofoniasono 39, dopo 17 di esse non è presente alcun segno di punteggiatura.Anche la lunghezza delle sequenze delimitate dalle barre è variabile come
quella delle sequenze delimitate dalle rime, ma in misura minore: le più corte so-no infatti di 5 sillabe (17, 34), le più lunghe sono scindibili in un settenario piùun endecasillabo (20-21, 35-36, 37-38-39 e 46-47: tutte cadono a cavallo di duelinee di scrittura, e nel caso dell’ultima il cambiamento di rigo avviene subito do-po una parola interessata da omoteleuto, per cui potrebbe trattarsi di un caso co-me quelli citati alla fine del § 8).L’interesse per la punteggiatura del manoscritto e la sua relazione con le rime
può sembrare ozioso, ma pur non trattandosi, in questo caso, di testi autografi(per i quali il sistema degli indicatori metrici – ammesso che di questo si tratti –ha ovviamente un’importanza maggiore), non pare opportuno disinteressarsene.Infatti, se si trattasse di testi in versi (o anche di prosa contenente dei versi) lapunteggiatura diventerebbe il segnale principale delle suddivisioni interne al te-sto, visto che la misura dei versi non è omogenea né ricavabile dal ritorno di mo-duli identici (come per esempio le stanze di una canzone), e che, dato che alcunerime devono essere irrelate, neppure è possibile avvalersi della loro usuale fun-zione demarcativa. Il fatto che tale punteggiatura assolva a più funzioni nellostesso tempo complica ovviamente le cose; quando poi – e non così raramente –sembra non averne nessuna, si arriva inevitabilmente alla conclusione che la suapresenza non implica affatto un giudizio da parte del trascrittore sulla natura deltesto (prosa o versi, o prosa contenente dei versi), anche al di là della presenza omeno di rime.In Lc i segni interpuntivi sono sicuramente usati come diacritici69 e – almeno
in un testo70 – come separatori dei versi; talvolta, invece, sono assai probabilmen-te adoperati per separare i discorsi di due interlocutori (è il caso di Ben venga La-po! e della parte finale di Io voglio che voi sacciate, dove si alternano i discorsi dipiù personaggi); altre volte sembra che, come in alcuni casi analizzati da MarcoBerisso, «tendano [...] soltanto ad indicare la rima, senza operare in modo coe-rente e globale», dato che «non cadono sempre in corrispondenza della rima ma,anzi, con una certa casualità»71. Quest’ultima funzione, però, può essere validasolo nel caso che ci siano delle rime alle quali non segua alcun indicatore, più allimite qualche caso in cui un separatore non è collocato subito dopo omoteleuto.Ma in O prezioso Adobbo questa eventualità si verifica nel 30% circa dei casi, enon è quindi palese a cosa servano in questi casi le barrette. Non si può dare perscontato che segnalino la suddivisione in versi (e quindi, che il testo sia in versi):
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 37
72. La lettera è tramandata unicamente da Lc, ed è stata pubblicata da Pasquini in edizione diplomatica(riproducendo quindi il sistema di punteggiatura del manoscritto) in SAVIOZZO, Rime, pp. 268-70.73. Perderebbe quindi di valore l’affermazione di BARBIERI 2002, p. 299 «il dettato di Gianni, quel Gui-do salute è contraddistinto da quei segni di interpunzione metrica che lo scriba del Chigiano utilizza pertutti i componimenti in versi: canzoni, ballate, sonetti. Ciò significa che il nostro mottetto era sentito dal-l’esecutore di Ch o dal suo antecedente come un pezzo in versi». (Sulla presenza nel Chigiano L.VII.305di tali segni di interpunzione, cfr. anche la citazione da GIUNTA 2002 della n. 88).74. Cfr. BERISSO 1999, p. 224.75. Soprattutto considerando la presenza della ‘rima per l’occhio’ ’ndugia : bugìa, che farebbe invecepensare a una fruizione, più che uditiva, ‘visiva’ del testo (e una ‘rima per l’occhio’ sembra essere presen-te anche in Io voglio che voi sacciate: cfr. il § 9).
anche in Io voglio che voi sacciate vi sono molti casi (in proporzione, molti piùche nel testo di Antonio di Cecco) in cui i segni interpuntivi presenti non hannonessuna delle funzioni sopra viste, e un buon numero se ne trova anche nella let-tera del Serdini al cancelliere del re Ladislao72, epistola in prosa dove proprionon par possibile rintracciare delle rime73. Appare quindi chiaro che per decide-re della natura di O prezioso Adobbo (prosa o versi, o un misto delle due cose)non ci si può avvalere del fatto che nel manoscritto il testo presenta dei segni diinterpunzione, anche se altrove gli stessi segni sono adoperati come indicatorimetrici.
12. Non è certo possibile, in questa sede, arrivare a delle conclusioni rispettoal problema del discrimine fra i versi e la prosa nel Medioevo, o a quello dei limi-ti entro cui debbono restare i versi irrelati, nella frottola, perché questa continuiad essere tale: l’analisi andrebbe infatti estesa (e non di poco) ad altri testi, alcunidei quali ancora inediti o da rieditare, e quindi ad altri manoscritti. Ma lo scopoprincipale di questo lavoro è fornire l’edizione di un poeta, Antonio di Cecco daSiena, sotto il cui nome è pervenuto un testo problematico, che nel suo unico te-stimone (nonché unico testimone di tutta la produzione del poeta) si presentacon una definizione, offerta dalla rubrica, che, per quanto rintracciabile sia in al-tri manoscritti, sia nello stesso attribuita ad altri testi, aumenta l’oscurità più chediradarla.Non è infatti chiaro cosa significhi «misticcio», e nemmeno a quale aspetto del
testo faccia riferimento: pare però difficile che si tratti di una definizione di gene-re metrico. L’unica cosa che potrebbe accomunare i tre «misticci» di cui si è quitentata l’analisi è la possibilità che fossero destinati a una pubblica «esecuzioneorale»: possibilità già prospettata anche per la frottola, qualunque sia l’oggetto acui si riferisce tale definizione74. D’altra parte, per spiegare cosa si intendesse al-l’epoca con «misticcio» una (ipotetica) recitazione pubblica non sembra poter es-sere essere un dato risolutivo75, così come non può esserlo l’accostamento allafrottola, che per i due «misticci» anonimi sembra anzi probabile sia da respinge-re. Più complesso invece il caso di O prezioso Adobbo, che allo stato attuale pareveramente un testo sospeso in una zona grigia tutta da esplorare, dato che non neconosciamo di omologhi. Per esso possono essere però proposti altri accosta-
38 MARIA CLOTILDE CAMBONI
76. Si tratta delle lettere XXXI e XXXII dell’edizione Margueron (GUITTONE, Lettere 1990, pp. 304-7 e312-3).77. Si tratta delle lettere XXXIII e XXXV dell’edizione Meriano (GUITTONE, Lettere 1923, pp. 383-4 e399-400).78. Si tratta della lettera XXXIV dell’edizione Meriano (GUITTONE, Lettere 1923, pp. 391-2).79. Il testo è stato pubblicato in GUITTONE, Lettere 1923, pp. 459-61. Secondo l’ultimo editore delleLettere di Guittone, Margueron, è «difficilmente attribuibile all’aretino, bensì a un guittoniano» (GUIT-TONE, Lettere 1990, p. XX). Una simile struttura sarebbe però ricostruibile, per Pasquini, anche nella let-tera XXVI di Guittone (seguita, nel Riccardiano 2533 - ma non nel principale testimone delle Lettere diGuittone, il Laurenziano Redi 9 -, da un sonetto rinterzato che la rubrica mette in relazione con l’epistolain prosa: cfr. PASQUINI 1995, pp. 177-204, a p. 179, e la tavola del codice in CASINI 1884, p 165).80. Il sonetto e la sua rubrica vengono citati in GIUNTA 2002a, pp. 228-9.81. E nel numero potrebbe essere incluso anche A l’omo savio et insenato: cfr. l’edizione in STUSSI 2002,p. 54.
menti, oltre a quello con la frottola, principalmente con alcuni testi di carattereepistolare.Al di là della presenza di segni di punteggiatura analoghi a quelli dei «mistic-
ci» nella lettera del Serdini conservata in Lc, si può infatti notare che O preziosoAdobbo si accompagna a un sonetto. (Il collegamento fra i due testi è indubbio,dal momento che il «misticcio» si apre con un riferimento all’esortazione finaledel componimento che lo precede: «O prezioso Adobbo, / non essare zoppo / osgobbo || a far quel ch’io t’ò detto» – cioè «mostrare che gl’Adobbi e Stracciafer-ri / non sono ingrati né brudeni o erri» –; tale esortazione è ripetuta anche versola fine del «misticcio»: «mostrate cortesia e gentileza»). Una simile unione fra unsonetto e un testo di altro genere (entrambi però rivolti al medesimo destinatario,cui pongono la stessa questione) si può ritrovare in vari testi di carattere epistola-re, costituiti da una prosa seguita da un sonetto: due lettere di Meo Abbraccia-vacca a Guittone d’Arezzo76; altre due epistole del medesimo Meo rispettivamen-te a Bindo e a Dotto Reali da Lucca77, che già gli aveva inviato una missiva cosìcomposta78; e infine, una lettera adespota trascritta nello stesso Lc79. È evidentela somiglianza della struttura di questi testi con quella del gruppo Se ’l conte pa-dovano o d’Albania - O prezioso Adobbo, per quanto la successione sonetto-testosia rovesciata.Una struttura identica a quella dei testi di Antonio (vale a dire, sonetto + lette-
ra) potrebbe invece aver adoperato il rimatore fiorentino di metà Trecento Ma-netto da Filicaia. Il suo sonetto Carissimo fratel, s’io ben discerno nel ms. Redi184 della Biblioteca Medicea Laurenziana è infatti preceduto da questa rubrica:«Sonetto di Manetto detto mandò a Domenico Mannelli insieme con una letteraa Barzalona»80. Tale «lettera» purtroppo non ci è pervenuta, e non possiamoquindi sapere né che forma avesse né quanto la relazione fra i due testi si avvici-nasse a quella fra X e XI. Va però sicuramente notato che tutti questi testi (sia lelettere, sia O prezioso Adobbo) si rivolgono a dei destinatari specifici81, ed è notocome nel Medioevo l’oratoria e l’epistolografia siano un campo privilegiato perl’utilizzo di artifici formali come l’omoteleuto: se ne possono vedere vari esempi
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 39
82. Cfr. GUITTONE, Lettere 1990, alle pp. rispettivamente 99 e 181-3.83. Per le varie proposte successive, cfr. GUITTONE, Lettere 1990, pp. 97-8 e 180-1.84. GUITTONE, Lettere 1990, p. 181.85. Cfr. CASINI 1884, p. 168.86. GIUNTA 2002, p. 25.87. GIUNTA 2002, pp. 23 e 26.88. A proposito del quale Giunta afferma che «quanto alla presenza, nel testo così come ce lo tramandail Chigiano, di quegli stessi segni interpuntivi [...] e paragrafematici [...] che vengono adoperati nel ms.per la scansione delle poesie, essa non sorprende: sia che il copista interpretasse erroneamente il testo co-me poesia sia che, pur riconoscendo la prosa, egli intendesse comunque segnalare le rime o la partizionein cola [...]; ciò poteva accadere, del resto, anche nella prosa rimata latina» (GIUNTA 2002, p. 27 n. 44).
proprio in Guittone.Sempre fra le lettere di Guittone è inoltre possibile rintracciare altre strutture
simili a O prezioso Adobbo, come la lettera VII a Corso Donati e soprattutto lalettera XV a Simone82. Al di là della difficoltà di ricostruire quale sia il loro sche-ma metrico83, la differenza più grossa fra queste lettere e il «misticcio» di Anto-nio è la presenza, in esse, anche della rima alternata e incrociata, pur nella preva-lenza di quella baciata; sotto altri aspetti, la somiglianza è veramente notevole. Inparticolare, nella lettera a Simone sono presenti delle «irregolarità», fra le qualialcune «rime irrelate», che l’editore non sa se «imputare all’autore o ad alterazio-ni nella tradizione manoscritta»: ma fa «notare che il testo non manifesta alcunaalterazione quanto al significato là dove si rivelano delle irregolarità metriche»84.Le due lettere si presentano inoltre nei manoscritti con alcuni versi differenti dal-l’endecasillabo e dal settenario, normalizzati dall’editore, un quinario nella lette-ra VII e un novenario nella XV, tramandata questa da due differenti testimoni,anche se molto probabilmente discendenti da uno stesso antigrafo85.Un ultimo accostamento può infine essere proposto con un’altra, celeberrima
«lettera», anch’essa dal «tema [...] leggero e scherzoso»86: il ‘mottetto’ di GuidoCavalcanti. Oltre al registro giocoso e alla destinazione a persone specifiche econcrete, i due testi hanno infatti in comune la presenza esclusiva di rime baciateaccanto a quella di sequenze sillabiche più o meno lunghe prive di omoteleuti.Recentemente è stata proposta da Claudio Giunta l’ipotesi che, dal momento che«questo testo rimane un unicum inspiegabile finché continuiamo a considerarloun testo poetico», «non di versi si tratti ma di prosa rimata»87: di conseguenzanell’edizione del testo «la scrittura continua è preferibile ad una (irregolarissima,ametrica) scansione in versi», e lo stesso è stato quindi stampato come prosa sen-za riprodurre il sistema di punteggiatura del manoscritto88. Una simile soluzioneeditoriale era stata proposta da Marco Berisso anche per la ‘frottola’, «sequenzaininterrotta avvicinabile alla prosa», per la quale però «nel caso di frottole auto-grafe il sistema di indicatori metrici dell’originale dovrebbe essere riprodotto»;ma «lo stesso dovere risulta molto meno cogente per frottole dalla tradizionepluritestimoniale: a quale sistema ci si dovrebbe riferire, infatti, in casi come que-sti? Più prudentemente ancora, dunque, si potrebbe pensare ad una rinuncia di
40 MARIA CLOTILDE CAMBONI
89. BERISSO 1999, pp. 227-8.90. STUSSI 2002, p. 46.
ogni tipo di indicatore metrico»89.Nessuno dei testi appena citati, per quanto simile a O prezioso Adobbo possa
essere, può però chiarire a quale genere formale appartenga il testo di Antonio, ein nessuno può essere rintracciata la risposta al quesito (fin qui implicito), appa-rentemente più semplice ma in realtà ancor più irrisolvibile del precedente, sel’ultimo «misticcio» trascritto in Lc sia un testo in prosa o in versi. Non pare pro-prio possibile, in questa sede, argomentare ragionevolmente in favore di un’ipo-tesi o dell’altra: come già detto, la ricerca andrebbe allargata fino a risultare nonpiù gestibile nell’ambito dell’edizione delle rime di un autore. Nel quadro dellastessa edizione è però necessario giungere a una decisione operativa su comepubblicare il testo.Osserva giustamente Alfredo Stussi, nei preliminari alla sua edizione di A l’o-
mo savio et insenato, che «editare un testo antico, specie se poetico, comportasempre una ‘traduzione’ con perdita di dati culturalmente interessanti [...]. L’edi-tore, adottando convenzioni moderne come quella relativa alla divisione in versi,da un lato viene incontro alla attese degli utenti, dall’altro è costretto a esplicitareil suo punto di vista in merito all’articolazione metrica [...]. Preso dunque qualeipotesi di lavoro funzionale a una strategia comunicativa, il modo tradizionale dieditare le frottole mi pare ancora utile, tanto più se corredato, come qui, di unatrascrizione interpretativa ripettosa del testo disposto ‘come prosa’»90. Il testocosì pubblicato da Stussi è per vari aspetti simile a O prezioso Adobbo, per cui sipotrebbe quindi adottare la stessa soluzione editoriale: a patto però di essere ra-gionevolmente certi che si stia pubblicando una ‘frottola’ o comunque un testoin versi. Ma come si è detto, non si può purtroppo arrivare ad una conclusione aquesto proposito.Adottando un’impaginazione ‘in colonna’, quindi, si corre il rischio non sem-
plicemente di perdere dei dati culturalmente interessanti, ma di operare una verae propria violenza sul testo, tanto più evidente se si pensa all’impaginazione delmanoscritto, in cui O prezioso Adobbo non è semplicemente scritto «come prosa»ma come un testo la cui ultima parte è in versi, o, più ancora, se si prova ad im-maginare il risultato di una simile operazione editoriale sugli altri «misticci». Do-vendo fornire un’edizione del testo senza poter giungere a una conclusione preci-sa sulla sua natura, la soluzione migliore è parsa dunque quella di stamparlo im-paginato come nel manoscritto (riproducendone integralmente il sistema di indi-catori e indicandone gli a capo), suddiviso in micro-sequenze testuali determinatedopo ogni rima o ‘indicatore metrico’ (la stessa soluzione editoriale – con i cor-rettivi del caso vista la presenza scarsa o nulla di rime – è stata adottata anche perBen venga Lapo! e Io voglio che voi sacciate, pubblicati in appendice), e dando diognuna di esse (o anche di più fra loro associate) un’analisi metrica (a che versocorrisponderebbe, se si trattasse di versi).
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 41
Testi
Per i criteri generali di trascrizione, cfr. la n. 1 (non mantengo, però, le parentesitonde per lo scioglimento delle abbreviazioni).Nell’edizione (ma non in apparato) elimino le (oscillanti) grafie arcaiche per
l’occlusiva velare sorda e sonora (I 4 ghusto, I 6 lusingha, I 18 chon, I 22 chaldo,ecc.; ma I 12 conseghuire e I 19 pericolo), per l’affricata palatale sorda e sonora (I18 pacie, II 3 ingiengni, Va 8 leggadro, ecc.; ma I 7 maggior, I 37 piacere e II 6 in-gegni), per la n palatale (I 4 ingnudo, II 3 ingiengni, II 28 legnio ecc.; ma I 10ogni, I 31 benigno), per la l palatale (nel manoscritto sempre - almeno in questitesti - resa col digramma gl: quindi I 47 righoglo, II 20 vaglon, ecc.) e per i nessidi nasale con labiale (I 23 senpre, II 25 menbri, II 39 rasenbra, ecc.). Normalizzoinoltre le grafie latineggianti: molto comuni pt e ct per la doppia t (I 21 voluptà, I25 condocti, ma Vb 1 e 5 efetto e oggetto, in rima con concepto e intellecto; similialternanze grafiche in rima anche in Va e in VIII; da notare inoltre VIII 8 luctho,con la t sovrascritta su una precedente c, per cui l’h probabilmente è dovuta a uniniziale errore di lettura;); poi I 4 satiata, I 7 inlustre, I 45 nactione, III 2 subgetto,VII 5 inmensa, VIII 3 honorevole, IX 5 excelsa, ecc. Non sono però stati norma-lizzati, perché la grafia non è (o può non essere) del tutto priva di sostanza fone-tica e/o perché nomi propri: I 5 esentia (in rima con una parola perduta); I 42Esiphile e Phille, I 44 Holofernes; II 5 exaldite (in quanto forma di reazione: cfr.n. ad locum); Va 1 sublevar (collegato al non normalizzabile sublimato della rispo-sta: cfr. Vb 5); IX 4 exemplo; XI18 Alexandro.Le atone soprannumerarie sono segnalate da punto sottoscritto; le integrazioni
sono poste fra parentesi quadre, le espunzioni fra parentesi uncinate; le congettu-re editoriali sono in corsivo. Le lacune (concentrate nella canzone I – cfr. il § 2dell’introduzione – e in Ben venga Lapo! , dove sono dovute solo a cancellatura,ma tale da rendere impossibile recuperare il testo cassato) sono segnalate da trepuntini fra parentesi quadre, gli spazi lasciati in bianco da asterischi; le parti can-cellate ma leggibili sono sottolineate.
I.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, cc. 5r-5v
Invettiva contro Amore (la cui testa bendata è disegnata a c. 5r, assieme al poetanell’atto di parlargli) come molte altre canzoni nel Medievo: O tu, de nome Amor,guerra de fatto di Guittone d’Arezzo, Amor, nova e antica vanitate di Lapo Gian-ni, O dea Venus, madre del disio di Niccolò Soldanieri, ecc. Più che l’estrema for-tuna del tema può essere interessante notare come l’elenco dei personaggi vittimedi Amore presi dalla Bibbia e dalla mitologia classica presenti ai vv. 41-48 sia ingran parte sovrapponibile a quello della quinta stanza di un’altra canzone controAmore, Io vorrei prima stare in mezzo un fango (RdT, pp. 913-6; di attribuzione
42 MARIA CLOTILDE CAMBONI
controversa, forse di Monaldo da Orvieto: cfr. RdT, p. 911): «Ercole il seppe, Pa-ris, Nesso e Dido, / Isifile, Narcisso, Bibli e Fille, / Mirra, Adriana, Achille, /Cleopatràs, Proserpina e Medea; / sentì Canace fuoco di tal sido / e finì la sua vi-ta in tai faville, / senza qua’ più di mille / danzando spinti sono in tal corea; / enon pure i mortal, ma Citerea, / Mercurio, Febo, e ’l magno Giove e Marte /sentîr quanto tal arte / a chi la segue giusta ingiuria crea: / smarrì per lui David eSalamone / el vertuoso vero e la ragione» (RdT, pp. 915-6; vv. 57-70; corsivi miei.Anche il Febo del v. 66 di Io vorrei prima star può essere considerato equivalenteall’Apollo del v. 46 della canzone di Antonio). È notevole in particolare: a) il fattoche in entrambi i casi l’elenco di exempla sia separato in due parti da una formu-la di rincaro («Lasciamo star dell’umana nazione...», Antonio di Cecco I, v. 45;«e non pure i mortal...», Io vorrei prima stare, v. 65), che peraltro nel caso di Iovorrei prima stare non è del tutto coerente, dal momento che è stata già citata lanon-mortale Proserpina (l’esemplificazione della canzone di Antonio pare meglioscandita - i personaggi biblici sono in coda all’elenco dei mortali, e non in coda atutti - e vi mancano personaggi storici come la «Cleopatras» di Io vorrei primastare); b) la presenza dei tre rimanti identici Fille, Achille e Salamone (e forsesido: v. la n. al v. 36). Salamone però è in rima già in O tu, de nome Amor, guerrade fatto (v. 65; cfr. PD, vol. I, p. 220), e in generale tutti gli exempla comuni sem-brano piuttosto ovvi e la loro presenza in entrambe le canzoni non particolar-mente significativa. Quest’ultima osservazione pare valida anche per la coppiaidentica «David e Salamone», sebbene in entrambe le canzoni abbia la stessa gia-citura nel verso e svolga la stessa funzione di chiusura (nel caso della canzone diAntonio, dell’elenco dei mortali, in quello di Io vorrei prima star, dell’esemplifi-cazione in genere).Contatti puntuali ben più rilevanti possono essere rintracciati con la descrizio-
ne di Amore del De planctu Naturae di Alano di Lilla: «Pax odio fraudique fides,spes iuncta timori / Est amor et mixtus cum ratione furor; / Naufragium dulce,pondus leue, grata Caribdis, / Incolumis langor, insaciata fames / Esuriens sacies,sitis ebria, falsa uoluptas, / Tristicies leta, gaudia plena malis; / Dulce malum, ma-la dulcedo, sibi dulcor amarus / Cuius odor sapidus insipidusque sapor; / Tem-pestas grata, nox lucida, lux tenebrosa, / Mors uiuens, moriens uita, suaue ma-lum; / Peccatum uenie, uenialis culpa, iocosa / Pena, pium facinus immo suauescelus; / Instabilis ludus, stabilis delusio, robur / Infirmum, firmum mobile, fir-ma mouens; / Insipiens ratio, demens prudentia, tristis / Prosperitas, risus flebi-lis, egra quies; / Mulcebris infernus, tristis paradisus, amenus / Carcer, hiempsuerna, uer hiemale, malum» (ALANO, Planctu, p. 842, vv. 1-18; corsivi miei). Ilmaggior numero di concordanze si rintraccia nell’attuale seconda stanza: fino afalsa voluttà compreso, tutti gli appellativi rivolti ad Amore ai vv. 18-21 trovanodei paralleli più o meno stringenti nel testo di Alano (compreso pericolo grato edilettevol pianto: v. supra grata Caribdis e tristicies leta); nel prosieguo della stessastanza può inoltre essere accostato al De planctu il v. 29 (dilettoso inferno, tristoriso: v. supra mulcebris infernus e tristis paradisus). Malgrado la forza dei contatti
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 43
appena citati, non è però affatto certo che Antonio attinga direttamente al Deplanctu Naturae e non a un altro testo in qualche modo ad esso collegato.La canzone è pervenuta in condizioni testuali non ottimali. Lo schema metrico
(ABC,ABC;CDdEEFfGGHH) è rilevato sulla seconda stanza, che sembra la me-no sfigurata (la rima imperfetta dei vv. 25-26 è infatti facilmente sanabile). Perchécoincida con quello della terza (e ultima) occorre postulare che freddo : nido (vv.36 e 39) e Apollo : rigoglio (vv. 46 e 47) siano rime imperfette, e non versi irrelati.La prima stanza è frammentaria: mancano sia i primi sia gli ultimi tre versi, e visono di conseguenza tre rime irrelate (dovevano rimare con i versi ora perduti). Ilcongedo, di schema ABbA,BAaB;BCDeeFF, presenta due irrelate irriducibili (quiindicate in corsivo).
Canzone morale fece Antonio di Cecco
1 […] [-udo][…] [-entia][…] [-ode]O sazïata fame, o gusto ignudo,
5 o ardente fiammella, o fredda esentia,che quanto più lusinga, alor più rode!E quante più illustre e maggior lodeti son rendute, più ti fai superbo;quanto è più duro il nerbo
10 per te si speza, e nutrichi ogni inganno;e ciascun giorno più, di danno in danno,fai conseguire il tuo eterno male,e a tuo fiero stralenon vale arme battuta in questo mondo.
15 […] [-ondo][…][…]
Tu pace e odio, e ragion con furore,tu lieve peso, tu pericolo. grato,
20 tu dilettevol pianto e ebra sete,tu falsa voluttà e grande errore,tu caldo assai più ch’acciaio infocato!E sempre tessi tuo malvagia rete…Dè, quanti n’ài in tua amorosa mete
25 con tuo false promisse già condotti,che poi con tristi luttiusciti non ne son se non per morte!Ïo affermo e dico esser tuo corteun dilettoso inferno, un tristo riso;
30 ài dilettevol viso,o crudel alma con benigno aspetto!
44 MARIA CLOTILDE CAMBONI
Così possa mancar tuo falso efetto,come tu inganni chi più in te si fida:è tristo quei che ’n suo petto t’annida.
35 Tu fai ardere il cuore in mezo l’acque,in mezo il fuoco fai morir di freddo,a tuo piacere amare e disamare;e molte volte, quel ch’a l’uom più spiacque,quel fai suo letto, suo albergo e nido;
40 e non gli val versar lagrime amare.Ben lo provò Narcisso a l’onde avare,Ercole, Nesso, Esiphile e Phille,Biblis, Silla e Acchille,Holofernes, Davit e Salamone.
45 Lasciamo star dell’umana nazione:non festi tu a Giove e al grande Apollosentir tuo gran rigoglio,a Mercurio e a Pluto il tuo podere?Che val nostro volere o non volere,
50 che quando vuoi, con tuo veloci remi,quanto più rigido à nomo, più il premi?
Canzone, omai per tuo camin ti stende:dì ch’io non posso più parlarne a pieno,né scoprir suo veleno,
55 perché la suo saetta ancor m’offende,ma dì: se mai mi trae suo aspro freno,o se giamai mia libertà mi rende,o sue ofuscate tendeleva dinanzi al mio veder sereno,
60 quel ch’io potrò, i’ pur dirò, almenodi suo martiri e suo penosi afanni,perché la lingua sfoghi il tristo petto.E così ti distilla;dì che picciola ancilla
65 tu ssè d’un’alma faticata e lassa,che più parlar non può, se ’l mal non passa.
46 e al] il 55 perché] p(er)ò cheNote. 1. L’invettiva (come diventa evidente più avanti) è rivolta ad Amore; sazïata: ‘nauseata’. 4. gustoignudo: ‘desiderio, appetito sessuale manifesto’. 5. esentia può valere sia ‘ente’ che ‘aspetto’: per il secon-do significato e l’utilizzo del termine in riferimento ad Amore, cfr. LARSON 2000, pp. 107-8. Nel primocaso si avrebbe un’antitesi, come quelle del v. 18 e dei vv. 35-7; nel secondo invece si insisterebbe sulladiversa apparenza di Amore rispetto alla sua realtà (espressa anche ai vv. 30-1). L’interpretazione più pro-babile, visto il verso precedente, sembrerebbe la seconda. 24. mete (forma arcaica di meta: cfr. GDLIs.v.) può significare ‘limite, confine’, oppure potrebbe indicare la metaforica reggia di Amore. Il sensodel passo è comunque chiaro: Amore ha imprigionato già molti. 25. condotti: vista l’esistenza (e anzi lafrequenza, almeno nel corpus TLIO) della forma latineggiante condutti, piuttosto che di rima imperfettasi tratterà di grafia banalizzata da un copista. 28. Per la regolarità del verso è necessaria una dialefe inizia-le piuttosto dura fra ïo (bisillabico) e affermo. 32. falso efetto: ‘azione fatta a fine d’inganno’. 33. La co-
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 45
struzione transitiva di annidare è rara e non attestata nel corpus TLIO (cfr. TLIO s.v. annidare), ma ilGDLI ne dà esempi successivi (dalla fine del XV secolo in poi). 36. La rima freddo : nido potrebbe essereregolarizzata sostituendo a freddo il latinismo sido, perfettamente sinonimo; e freddo potrebbe quindi es-sere una glossa interlineare, scambiata per lezione alternativa e passata a testo. 41-4. Elenco di personag-gi, prima mitologici (Narciso, Ercole, Nesso, Isifile, Fillide, Biblis, Scilla e Achille) e poi biblici (Olofer-ne, Davide e Salomone) vittime del sentimento amoroso. Per la regolarità del v. 42 è necessario ammette-re una dialefe fra Nesso e Esiphile. 45-8. Dopo il primo elenco, di mortali, si citano ora gli dei. La corre-zione al v. 46 è la minima per avere una lezione che dia senso; anche l’assonanza fra 46 e 47 potrebbe es-sere dovuta a corruzione testuale, ma in questo caso è forse più probabile che tale fosse già in origine.D’altra parte, è possibile rintracciare nel corpus TLIO (in testi di area mediana e meridionale) la formaargollo per ‘orgoglio’. 51. ‘quanto più qualcuno ha fama di essere immune da debolezze, tanto più tu lotormenti?’ (ma si potrebbe anche pensare a un errore di lettura: «à nomo» per «è uomo»). 55. La lezioneiniziale è stata modificata perché saetta bisillabo appariva incongruo rispetto a saettati quadrisillabo (II61), saette e saetta trisillabi (rispettivamente II 65 e IVa 4). La sineresi sarebbe comunque eccezionale:cfr. BELTRAMI 1991, p. 147.
II.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, cc. 12v-14r
Canzone di cinque stanze di schema ABBC,ABBC;CDEeDFfGG, più conge-do ABbCcDD. Un’altra con lo stesso schema è rintracciabile in PELOSI 1990LXXII, componimento 161: si tratta di Io guardo i crespi e i biondi capelli, di Fa-zio degli Uberti. L’unica lieve differenza - peraltro facilmente sanabile - a livellometrico è nel congedo (cfr. la n. al v. 86). Le canzoni hanno inoltre in comune va-ri rimanti e almeno dodici rime (tredici, se il congedo conserva -iglio come rimainiziale; ma in tal caso resta diverso da quello di Fazio). Tali rime però (e anchequasi tutti i rimanti: fa eccezione adesca, e in misura minore chiarezza e divide)sono abbastanza banali: -are (rimante comune pare, in Io guardo i crespi ripetutodue volte), -ata, -egna (rimante comune degna), -egno (rimante comune ingegno),-elli, -ere (rimante comune piacere), -esca (rimante comune adesca), -ia, -ide (ri-mante comune forse divide: cfr. la n. al dilide del v. 51), -iso, -ore (rimante comu-ne core), -ezza (rimante comune chiarezza), e - come già detto - -iglio. È possibileche Antonio conoscesse e intendesse imitare la canzone di Fazio: però la relazio-ne fra i due testi rispetto al contenuto non è chiara (Io guardo i crespi è, com’ènoto, una lode dei vari aspetti della donna amata, elencati seguendo l’ordine ca-nonico della descriptio puellae) e rispetto alla forma non è scevra da ambiguità,tanto da non poter giustificare l’inversione dei sintagmi rispetto alla lezione delmanoscritto per ripristinare l’identità degli schemi dei due congedi. Più interes-santi i contatti col Filostrato di Boccaccio (per cui cfr. le nn. ai vv. 52-53 e 90-91),soprattutto per l’identità della tematica trattata, non fra le più comuni della poe-sia lirica: l’intensificazione del sentimento amoroso, e di conseguenza delle soffe-renze del poeta (rappresentato in atteggiamento sofferente a c. 13r a margine del-la prima stanza, con le braccia incrociate sul petto trafitto da una freccia - per cuicfr. i vv. 60-62, 65 e 78), in seguito all’avvenuto appagamento dei suoi desideri. Aquesto proposito, uno dei pochi testi in qualche misura comparabili è I’ me te
46 MARIA CLOTILDE CAMBONI
accuso, dolce mio Segnore di Antonio da Ferrara (BECCARI, Rime, pp. 89-90, in se-guito ripubblicato in MANETTI 2000, pp. 290-2; nel testo il poeta e la sua amataaccusano Amore, che li tormenta; purtroppo la canzone ci è pervenuta mutila infine – a questo proposito cfr. la n. 56 – e non ci è quindi dato sapere come si con-cluda). Va infine notato che tutte le stanze del componimento si aprono con pa-role o sintagmi ripetuti in posizione anaforica al loro interno; la figura è moltoevidente nel caso delle stanze I e II, e anche della V, meno nella III (già non midoglio... né già mi doglio, primo e ultimo verso del primo piede) e IV (anafora diomè, in posizioni metricamente significative, a inizio stanza e poi a inizio sirma).Un simile uso dell’anafora (non la stessa in tutte le stanze, come è ben più comu-ne – un esempio sono le canzoni di Lapo Gianni –, ma una differente in ognunadi esse) è presente anche in Quando potrò io dir: «Dolce mio dio di Cino da Pi-stoia (cfr. PD, vol. II, pp. 661-2), canzone con evidenza nota ad Antonio, che lariprende nel sonetto VIII (di cui cfr. il cappello introduttivo).
Canzone morale fece Antonio di Ceco da Siena.
1 O alma sconsolata, o core aflitto,o dolenti occhi o di lagrime pregni,o maladetti e asprissimi ingegnich’avete radoppiati i primi danni!
5 O exaldite grazie, che in despittosiete rivolte a’ mie debili ingegni:ché conquistati gl’amorosi regnimultiplicati sono i grandi afanni!Pensavate passare. suo falsi inganni,
10 e sviluparvi di suo tristi lacci,del gra’ disio avendo il suo valore:più si consuma il corevie per un mille, e par ch’el si disfacci,e ’l sangue che ’l nutriva è già mancato.
15 Omè, in sì aspro statosi trova ciascun senso in questo foco!e altrove abitar, non trovan loco.
Che val chiamar merzé al dispietato,che vale a suplicare a l’uom crudele,
20 che vaglion senza vento le gran vele,che vale il seminar su duri sassi?Quel valse a me il disio acettato,aver tessute già l’ordite tele:ch’ogni dolzore e fiamma e fele
25 encende i membri mïei stanchi e lassi.Ogni speranza sì quïesce e stassi,pensando avere il suo ultimo frutto:è maturato il pomo d’esto legno.
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 47
Omè! è questo il mie ingegno?30 El mi par che ritorni in tristo lutto,
sì ch’io non so omai che mi sperare:veramente el mi pareessere in <un> laberinto e grande errore,e non sa che cercar si debbi il core.
35 Già non mi doglio delle fiere membra,quai già pregai, né dell’ardita testa,la qual umilïai con mia inchiesta;né già mi doglio di crudele stile,ma del piacer che ’l pensier mi rasembra
40 e sempre prelïando mi tempesta;e quando credo della gra’ forestaesser già fuori, son <i> ’n mezo il covile.Quanto più penso in l’atto signorile,più novella vagheza in me si cria,
45 pur radopiando suo incendio e fiamma,che mai la bella lammiala sentì per Parìs sì cruda e ria;e temo della morte il crudo colpo,e di ciò non ne incolpo
50 altro, che gl’occhi in cui Amor s’asside,che [’l] debil cor in tutto mi dilide.
Omé, che fabrile acqua questa è stata:è acresciute in sul foco le legna!Che mai l’alma a pensar altro no ’nsegna
55 se non nelli atti suoi piacenti e snelli!Piatosa, micidial, benigna e grata,Venere. m’è stata, e sua amorosa insegnafé già la mente di suo grazia degna,e pullular co’ fiori i prataselli.
60 Omè, celesti dardi in me novellison saëttati con più aspre punte,che le primaie par fussen di piombo!Questo è il crudo rimbomboquando sento venir in me sì pronte
65 l’aurëate saëtte e ’l gran superchio,e questo è il cuperchioche tiene ogni piacer da me diviso,se non guardando il suo lustrante viso.
Questo è il benigno aspetto in cui si cria70 ogni sommo piacer ch’al cor s’aduce;
questo è riposo della lassa luce,faccendo specchio a lei di suo chiareza.Questo mi leva ogn’altra fantasiae nella mente mia sempre riluce,
48 MARIA CLOTILDE CAMBONI
75 questo è mio car signore e vero duce,lui seguirò fin nella somma alteza.Quando mi passò il petto suo vagheza,che ’l trovò disarmato al primo strale,libera e püerile. la mente e l’alma,
80 omè, che d’una drammanon si sentie carcata, e trïunfalereggeva i sentimenti a suo volere!Lusinghevol piacerem’à qui condotto, e Amor sa che gloria
85 promisse a me, che l’à bene a memoria.
Canzon, tu parlerai con buon consiglio:poca acqua amorta picciola favilla,e tardi dispartirlapuossi, o non mai, cresciuto il gran calore;
90 ché avendo il valoreultimo, ogni disio più si rinfresca,e come a laccio uccel, così adesca.
8 i grandi] i(n) grandi (titulus superfluo) 35 delle] d’amar le 38 crudele] crudeste
Note. 2. La seconda o può parere superflua, e forse è da espungere: ma, visto il fatto che una simile o ‘su-perflua’ è rintracciabile nel sonetto IX (v. 6: cfr. n. ad locum), si è scelto di mantenerla in entrambi i casi. 3.Gli ingegni sono i mezzi adoperati al fine di conquistare la donna, in rima equivoca con quelli del v. 6 (cheinvece sono le facoltà mentali del poeta). 5. exaldite per ‘esaudite’ è forma di reazione al passaggio di l a udavanti a consonante dentale (sul quale cfr. CASTELLANI 2000, pp. 297-302), fenomeno in fase antica tipicodel toscano occidentale; simili forme di reazione sono rintracciabili però sin dall’inizio del Quattrocentoanche a Firenze (cfr. MANNI 1979, pp. 122-3) e a Siena (cfr. BIFFI 1998, pp. 73-4). In despitto vale ‘al finedi recare offesa’. 11. Se disio equivale al sentimento amoroso, valore è il prezzo dello stesso, ovvero la cor-rispondente ricompensa (cfr. l’occorrenza di valore al v. 90, e relativa n.); d’altra parte il disio potrebbe es-sere la donna amata, e quindi valore equivarrebbe a ‘ciò che in essa è di pregio’ (ma sembra più probabilela prima ipotesi). 24. Il verso appare anomalo dal punto di vista metrico, come altri della canzone (e inparticolare di questa stanza): l’unica maniera per evitare l’ipometria è una doppia dialefe fra atone (fra ledue congiunzioni e le atone finali ad esse precedenti). 26-8. ‘Ogni speranza viene a cessare, al pensiero diavere il suo termine ultimo: è ormai venuto a compimento l’intento del sentimento amoroso’ (arrivati allameta prefissa, la speranza muore). 33. L’espunzione è stata fatta per sanare l’ipermetria; l’espressione (esse-re) in laberinto (qui in dittologia sinonimica con errore) trova un riscontro in Cino da Pistoia (sonetto Pic-ciol dagli atti, vv. 12-3: «da follia se’ spinto / in laberinto»; cfr. PD, vol. II, p. 638) e uno ancor più forte inNicolò de’ Rossi (son. 71, v. 14: «sì ch’el mi par essere in laberinto»: cfr. DE’ ROSSI, Canzoniere, p. 62). 35.La modifica, fatta al fine di normalizzare un verso altrimenti ipermetro, appare come la più economica,posto che, visto il parallelismo col v. 38, non sembra possibile eliminare né il già iniziale né il mi, e che unospoglio approssimativo compiuto sul corpus TLIO non ha permesso di rintracciare alcuna occorrenza delverbo dolere costruito con l’infinito senza preposizione. La correzione presenta inoltre il vantaggio di rista-bilire il parallelismo fra il v. 35 e il v. 36 (non mi doglio delle fiere membra… né dell’ardita testa). La nonbanalità del concetto espresso può giustificare la genesi della trivializzazione non mi doglio d’amar le fieremembra. 39-40. rasembra qui dovrebbe significare ‘raffigura nella mente’, ‘fa ricordare o immaginare’. Ilpoeta quindi si duole del ‘piacere’ (inteso o come il godimento che il poeta trae dalla donna, o forse comel’insieme delle qualità che rendono gradevole la vista della stessa, la sua avvenenza: per quest’ultimo signi-ficato, cfr. ED s.v. piacere), che il pensiero gli fa rammentare, e che combattendo continuamente si accani-sce contro di lui. 41-2. ‘quando credo d’essere uscito dalla foresta’ (per le cui connotazioni simboliche ne-gative si può vedere ED s.v. selva e bibliografia ivi citata) ‘sono nella tana (della belva)’. 46. lammia: cioè
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 49
‘ninfa’. Così si autodefinisce (per ben due volte) Enone nella sua lettera a Paride, nel volgarizzamento del-le Eroidi di Ovidio fatto da Filippo Ceffi (cfr. CEFFI, Epistole, pp. 42 e 44; il testo latino legge in entrambi ipassi – vv. 12 e 83 – nympha). La rima è sostituita da assonanza. 51. Il verbo dilidere non pare attestato nénel corpus TLIO né nel GDLI: potrebbe derivare da DE + LAEDERE, (ma non sarebbe chiaro l’esito del-la sillaba tonica) e significare ‘strazia’. Forse è più probabile che sia un errore per divide ‘spezza’: ma è an-che possibile che sia un conguaglio sul precedente s’asside (sostituito a un originario s’ass(i)ede/sis(i)ede?). 52. Che l’acqua gettata dal fabbro nella fucina ravvivi la fiamma anziché smorzarla è concettodiffuso nella cultura del tempo (cfr. ad esempio GEYMONAT 2000, vol. II, p. 112): per un passo in cui lostesso termine di paragone è adoperato ad esprimere identico concetto, cfr. il Filostrato del Boccaccio,parte III, ottava 68 (Criseida a Troiolo): «Io non mi credo ch’el possa giammai / questo fuoco allenar,com’io credea / che el facesse, poi che ’nsieme assai / fossimo stati, ma ben non vedea: / l’acqua del fabrosu gittata ci hai / sì che egli arde più che non facea, / perché mai non t’amai quant’ora t’amo…» (BOCCAC-CIO, Filostrato, pp. 102-3). 53. Per questa costruzione (impersonale, col participio concordato con l’ogget-to) cfr. AGENO 1964, pp. 159-63 (in part. la p. 162). 57-9. Il v. 59 si lega con difficoltà con ciò che precede,qualunque sia il significato da attribuire a amorosa insegna, ‘la donna amata’ o ‘il sentimento amoroso’; oforse il riferimento è a un attributo iconologico (ma quale?) della dea, sul tipo della fiaccola con cui è tal-volta rappresentata. Resta comunque il salto fra l’azione rivolta verso la mente del poeta e quella di far ri-fiorire i prati; e va anche detto che il sintagma amorosa insegna è rintracciabile (sempre in rima, comequi, e mai con un significato perfettamente limpido) anche in Al cor doglioso el bel succurso è gionto diAntonio da Ferrara, v. 2 («Al cor doglioso el bel succurso è gionto / con la gran forza d’amorosa insegna /com’è mistier che vegna / a chi pur segue lui senza retrare...»: MANETTI 2000, p. 287) e in Sì come al finde la sua vita canta di Giovanni Quirini, v. 33 («...e pur seguendo [soggetto: l’anima mia] l’amorosa inse-gna / che in voi si vede e la sembianza piana / ognor s’accese più e più di voi...»: QUIRINI, Rime, p. 184).61. punte: probabilmente è il travestimento anafonetico di una forma in origine non anafonetica (ponte);cfr. il § 5 dell’introduzione. 62. Il riferimento è all’immagine tradizionale delle frecce di Amore, quelle d’o-ro (per cui cfr. il v. 65) e quelle di piombo, presente nella poesia italiana sin dall’Abate di Tivoli (Oi deod’Amore, vv. 10-3: cfr. PD, vol. I, p. 83), e derivata dalla cultura classica (cfr. Ovidio, Met. I 468-71). 63.crudo rimbombo: il grido del poeta che esprime il suo tormento (riportato ai vv. 60-2). 69-71. Il dimostrati-vo iniziale dovrebbe riferirsi al lustrante viso del v. 68 (così come quello del v. 71, e probabilmente anche isuccessivi); al v. 71, luce (singolare) per ‘gli occhi’, ‘lo sguardo’ o meglio ‘il senso della vista’, ‘la facoltà visi-va’ è anche in Dante, Amor, tu vedi ben che questa donna, vv. 35 («e quel pensiero che m’accorcia iltempo / mi si converte tutto in corpo freddo, / che m’esce poi per mezzo della luce / là onde entrò la di-spietata luce»; cfr. DANTE, Rime, vol. III, p. 123) e 42 («io la veggio in pietra, / o in ogn’altro ov’io volga laluce»; cfr. DANTE, Rime, vol. III, p. 124) e Paradiso XXI, v. 30 («vid’io uno scaleo eretto in suso / tanto,che nol seguiva la mia luce»). 79. Oltre all’assonanza, il verso presenta una scansione non del tutto lineare,e anche dal punto di vista sintattico si lega ai successivi non senza fatica: non è inverosimile che la lezionedel manoscritto (qui conservata) sia un conciero. 86. Il verso è irrelato, ma modificando l’ordine delle pa-role in modo da mettere parlerai in ultima posizione (canzon, con buon consiglio parlerai), rimerebbe conmai del v. 89 (in rima interna), e verrebbe meno l’unica, lievissima differenza fra lo schema metrico dellacanzone e quello di Io guardo i crespi e i biondi capelli di Fazio degli Uberti (ma sulla questione cfr. quantoscritto nel cappello introduttivo al testo). 88. Più che a un’assonanza, pare di essere di fronte a una grafiache occulta l’assimilazione (esplicita invece al v. 4 del sonetto VII). 90-1. valore ultimo: equivale alla massi-ma ricompensa possibile in campo amoroso (per lo stesso sintagma col medesimo significato, cfr. il Filo-strato di Boccaccio, parte III, ottava 32, v. 8, in BOCCACCIO, Filostrato a p. 92).
III.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, c. 69r
Ballata di schema ZZ AB,AB;BZ (PAGNOTTA 1995 111) (due strofe). Accompa-gnata nel manoscritto da un disegno rappresentante l’amata e, più in basso, il poe-ta nell’atto di rivolgersi a lei, la ballata appare intessuta di motivi stilnovistici (manotare che il topos di Amore negli occhi di madonna è anche nella canzone II, v.
50 MARIA CLOTILDE CAMBONI
91. A proposito della dittologia, va però notato che i due termini sono associati già in Panuccio del Ba-gno, oltretutto in un contesto dal significato affine all’inizio della nostra ballata: «chiar conosco che l’umanlignaggio / d’aver fugge signor natoralmente / ma diviz’e’ da ciò diversamente, / regnando in me, avendogran diletto / d’essere servo di cui son soggetto, / in seguitare affanno sostenendo». Cfr. PANUCCIO, Rime,p. 80 (corsivi miei); per un altro contesto simile cfr. PANUCCIO, Rime, p. 57. Nella tradizione, in realtà, ‘ser-vo’ e ‘suggetto’ ricorrono vicini (anche se non nella stessa dittologia sinonimica come qui) non eccessiva-mente di rado: e il dato non stupisce, visto che quello del servizio d’amore è un tema molto diffuso.
50 «gl’occhi in cui Amor s’asside»). D’altra parte, le rime per musica (a cui la bal-lata appartiene a pieno titolo) sono «un genere di poesia [...] i cui legami con uncerto linguaggio stilnovistico (magari banalizzato in un’aggraziata convenzionalità)costituiscono una delle costanti di maggior rilievo» (BALDUINO 1984, p. 195); enon stupisce quindi riscontrare convergenze lessicali fra questa e varie delle balla-te pubblicate in PMT. Così il sintagma donna benigna è presente ai vv. 3-4 dellaballata I’ non ardisco mostrar il tormento di Francesco Landini (cfr. PMT, p. 183) eal secondo verso della ripresa di un frammento di Maestro Zaccaria (per cui cfr.PMT, p. 320); la dittologia sinonimica servo e suggetto si può trovare anche nel-l’incipit di un’altra ballata del Landini (dallo stesso schema della nostra), Perchétuo servo e suggetto mi tegno (cfr. PMT, p. 206; la ballata è in realtà la composizio-ne centrale di un trittico – aperto dall’altra ballata del Landini Perché di novo sde-gno – per cui nell’ed. citata il verso ha il numero 13)91 nonché al v. 26 di un’ulte-riore ballata dello stesso autore, De sospirar sovente, «levar al primo tuo servo esuggetto» (in rima con difetto come qui: cfr. PMT, p. 155); il primo verso dellaprima stanza di un’altra ballata ancora del Landini, Donna, la mie partenza, è in-credibilmente simile al primo verso della seconda stanza della ballata di Antonio,«Non mai d’amor mi dolfe né fortuna» (PMT, p. 161, corsivi miei); e così via.
Canzone da ballo fece Antonio di Cecco.
1 Donna benigna e d’amoroso aspetto,sempre sarò di te servo e suggetto.Amor[e], cui negl’occhi sempre porti,m’à posto in questo stato; i’ son contento;
5 e s’io porò sofrir pe’ troppi torti,prima che morte per te m’abbi spento,certo i’ non so, ch’i’ sento il cor sì vinto,ch’io non spero soccorso a suo difetto.+ Donna benigna
10 Non già d’amor mi duole. , ma di fortuna,che veggio in me ogni suo forza spiega,e rivoltasi a me con faccia brunas[e] a llei adomando o pace o tregua,per modo tal, che l’anima mi niega
15 voler[e] star più dentro al tristo petto.
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 51
1 Donna] Fonna 3 negl’occhi] nego gl’occh 5 troppi] trobbi 8 spero] ispero
Note. 1. La F iniziale dipende da un errore di chi ha eseguito le iniziali, che ha probabilmente scambiatole due n, scritte unite, per una r più una m (Forma benigna, quindi). La lezione donna si ricava dalla ripe-tizione, fra le due stanze, del primo emistichio del verso iniziale della ripresa, ivi inserito (come di normain tutto il manoscritto) allo scopo di segnalare la presenza della stessa. 3. Per l’espressione portare negliocchi (soggetto: la donna; oggetto: Amore), particolarmente utilizzata in posizione incipitaria, cfr. Dante,Ne li occhi porta la mia donna Amore (cfr. DANTE, Vita Nuova, p. 138), Madonna, quel signor che voi por-tate / ne li occhi… (cfr. DANTE, Rime, vol. III, p. 292) e prima ancora Cavalcanti, O tu, che porti nelli oc-chi sovente /Amor… (cfr. CAVALCANTI, Rime, p. 66). 7. vinto, anziché rima ‘guittoniana’ di e aperta con i,è probabilmente il travestimento anafonetico di una forma in origine non anafonetica (cfr. il § 5 dell’in-troduzione). 11. Per faccia bruna : fortuna, cfr. PUCCI, Centiloquio, vol. 4, p. 50: «che’ Fiorentini in pro-spera fortuna / fidandosi, in un punto vidon porsi / dov’ella dimostrò sua faccia bruna, / ed i Lucchesi astremità sì scorsi, / che poco tempo si potien tenere, / in un sol punto si vidon soccorsi» (c. 79, terz. 57) eTORINI, Rime, p. 390: «le varie percosse di fortuna, / la qual ver me tutte sue forze aduna / e con sua fac-cia bruna / ne minaccia tuttor crudele e ria». 12. Anche in questo caso (v. 7) la grafia potrebbe maschera-re una forma come trega, più volte attestata nel corpus TLIO, particolarmente in testi di area settentrio-nale; la forma dittongata triega è anche in Monte Andrea (A me nom piace di, tal triega, fare, v. 1; cfr.MONTE, Rime, p. 177; il sonetto, dato in attestazione unica dal Vaticano 3793 dove è il numero 657, è ri-pubblicato in CLPIO, p. 503).
IVa.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, cc. 29v-30r
Sonetto di schema ABBAABBA;CDC,DCD dEE. Scritto dal conte Naddo,appare come una violenta reprimenda ad Antonio, accusato di essere invidioso emaldicente e infine esortato a pentirsi e tacere. È apparentemente in contraddi-zione con le lodi che lo stesso Naddo gli indirizza nel successivo sonetto Va: masimili casi di invettive, anche violente, contro propri corrispondenti a cui in altreoccasioni ci si rivolge con ben altro tono sono rintracciabili anche altrove, peresempio nella produzione di Francesco di Vannozzo (cfr. ad esempio il sonettoTu sei sì fatto de la voce roco, risposta del Vannozzo a Bartolomeo da Castel dellaPieve, con cui corrisponde almeno altre due volte), nella coda (v. 15) del cui Oteste scioche, o viste rude e losche si trova anche un riscontro dell’espressione ‘ar-recarsi qsa al petto’. Vista anche la risposta di Antonio, in questo caso forse le ac-cuse e le esortazioni non sono che il principio pretestuoso preso dai due poetiper parlare dell’invidia; e le regole dello scambio poetico plausibilmente preve-devano la possibilità di scambiarsi ingiurie senza conseguenze. A margine (c.29v) è rappresentata una mano che porge una missiva a una figura, che a sua vol-ta tende la propria per prenderla.
Sonetto fece il conte Naddo e mandollo a Antonio di Cecco.
1 O tu che tien’ della invidïa all’arco,è’ sempre pronto e fermo nel maldire,che ciaschedun[o] faresti inaspriregittando la saëtta col tuo marco;
52 MARIA CLOTILDE CAMBONI
5 d’ogni ben far mi par che faccia il varco,volontaroso el peggio di seguire;né tra la gente dovresti aparire,però che sè d’ogni malizia carco.Ma poi che sè dagl’uomini. conosciuto,
10 statti in casa e rimanti di cianciare,ché la tuo coruzione i’ sì rifiuto.E non mi dar cagion di palesarecome nelle triste opre sè involuto:<che> me’ ti sarie la tuo lingua mozare!
15 Dè, vogliti arecarela mente al petto, e lagrimar con lutto,ché del tacer ne piglia l’uom gran frutto.
Note. 4. marco: ‘marchio’. La forma è attestata nel corpus TLIO in più testi documentari toscani: cfr. adesempio il Breve dell’Arte della lana di Pisa del 1304 e il Breve dei consoli della Corte dell’Ordine de’ Mer-catanti dell’anno MCCCXXI, in Statuti Pisa, vol. III (cfr. in part. le pp. 729 e 302), e anche (per un testosenese) Statuto Mercanzia senese (cfr. in part. la p. 254 del numero XVI). 5. L’espressione fare il varco èattestata in Nicolò de’ Rossi, son 212 (in rima con arco e carco come qui), con il significato di ‘fare strada’(cfr. DE’ ROSSI, Canzoniere, Glossario, s.v. varco). Probabilmente qui è adoperata in senso ironico. 15-6.L’espressione fraseologica arrecarsi la mente al petto dovrebbe equivalere pressapoco a ‘farsi un esame dicoscienza’; una simile è presente in Francesco di Vannozzo, O teste scioche, o viste rude e losche, v. 15(«senza arecarvi le virtute al petto»; Roberta Manetti, chiosando questo passo, interpreta arrecarsi qualco-sa al petto come ‘pensarci su, rifletterci’: cfr. MANETTI 1994).
IVb.Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, c. 30r
Sonetto di schema ABBAABBA;CDE,DCE eFF; risposta al precedente, ha undiverso schema metrico e non ne riprende alcuna rima, differenziandosi in que-sto dagli altri scambi pervenuti fra i due poeti, V e VI (per i quali cfr. infra). An-che a margine di questo sonetto si può vedere la stessa schematica rappresenta-zione del precedente: in questo caso, però, la figura che tende la mano per rice-vere la missiva è, apparentemente, coronata di alloro. Malgrado il tono accusato-rio della proposta di Naddo, la risposta di Antonio è generica e impersonale: silimita infatti a descrivere e analizzare con tono sentenzioso gli effetti negativi del-l’invidia (mentre lascia cadere completamente l’accusa di maldicenza), condan-nandola senza appello. La rima E è imperfetta (pene : neve : leve): di fatto, è unasemplice assonanza; lo stesso si può dire per la rima F (bragia : dismagra); cfr. lerelative nn.
Sonetto fece Antonio di Ceco da Siena, risposta di quel di sopra, e mandò al conte Naddo.
1 S’ïo avessi in odio o nimicassealcun in questo mondo con efetto,pregare’ Giove con tutto il concettoche d’esto vizio il cor gli fabricasse;
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 53
5 perché d’ogn’altro in tutto o in parte nassequalche piacere o qualche gran diletto;di questo non s’à mai se non dispetto:e’ del dolore altrui sempre si passe.Come son legna da foco consunte,
10 così dal suo efetto il cor che segue,quel che del gaudio altrui sente aspre pene,sì cche giamai non à nul patto o tregue.Però non ti bisogna avere agiuntepiù fiamme a consumar sì poca neve;
15 non li de’ parer levenel centro aferir sì calda bragia,che l’alma e ’l core in tutto gli dismagra.
Note. 2. con efetto: ‘di fatto, in realtà, con i fatti’. 3. concetto: la sede del pensiero, la mente (cfr. TLIOs.v. concetto). 4. ‘Che costruisse il suo cuore con alla base questo vizio’ (= l’invidia). 5. Le forme nasse epasse per ‘nasce’ e ‘pasce’ sono entrambe attestate nel corpus TLIO in testi di area settentrionale, e ancheROHLFS, vol. I, § 265 dichiara che l’esito normale di sc più vocale palatale al centro e al meridione è la si-bilante palatale sorda, mentre al nord oscilla fra questo e quello con s sorda: potrebbero quindi esseredei settentrionalismi, adoperati per esigenze di rima. (Peraltro nel Nord Italia la pronuncia sarebbescempia; per la confusione fra le due sibilanti, particolarmente negli esiti di -x- intervocalica, cfr. ancoraROHLFS, vol. I, § 225). 11. L’ennesimo caso di rima imperfetta, o meglio di rima sostituita dall’assonanza.16. Il verso è regolare solo a patto di ammettere una dialefe fra due atone (il ripristino della vocale finaledell’infinito darebbe luogo a un endecasillabo non canonico), e anche bragia è solo assonante con la pa-rola in rima del verso successivo. Si potrebbe pensare a una lezione banalizzante, magari sostitituita a unoriginario ‘podagra’ (nel senso più esteso di ‘malattia’: il verso significherebbe quindi ‘essere affetto dauna simile malattia spirituale’), che potrebbe essere stata facilitata dall’aggettivo che precede immediata-mente la parola in rima, oltre che dalle fiamme del v. 14. Pare invece più difficile intervenire sul verbo delsuccessivo v. 17: l’assonanza resterebbe infatti tale anche sostituendo dismagare a dismagrare, e sembrapoco probabile una forma dismagia ‘dismaglia’, simile a quelle che si possono rintracciare nel TristanoVeneto. (Va però detto che l’assonanza bragia:dismagra è presente anche altrove). La lezione del mano-scritto può inoltre essere interpunta (e di conseguenza interpretata) diversamente, inserendo una pausadopo aferir e intendendo centro non ‘anima’ ma ‘inferno’, per cui il riferimento non sarebbe più alle sof-ferenze provocate dall’invidia in vita (‘non deve sembrargli lieve il fatto che alla sua anima spetti un tor-mento così cocente, che…’) ma alla punizione eterna che lo stesso peccato provoca (‘non deve sembrar-gli lieve andare a finire all’inferno: una pena così dolorosa, che…’).
Va.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, cc. 69v-70r
Sonetto di schema ABBAABBA;CDC,DCD. Al di là delle difficoltà di inter-pretazione puntuale, non gravissime e legate più che altro alla sintassi di Naddo,che qui come negli altri suoi testi tende ad essere sconnessa e faticosa, non siamoin grado di ricavare dal testo informazioni sull’occasione per il quale è stato scrit-to: Naddo infatti si rallegra per qualcosa, apparentemente l’inclusione in ungruppo (una confraternita religiosa?) a cui Antonio – qui gratificato dall’appella-tivo gentilesco, cioè nobile, e fatto oggetto di rallegramenti – sembra già apparte-nere. La rubrica non offre alcun aiuto, e neppure l’illustrazione (c. 69v), che rap-
54 MARIA CLOTILDE CAMBONI
presenta semplicemente «due mani protese l’una verso l’altra, e tra le due mani,che passa dall’una all’altra, l’icona del sonetto-lettera: la lettera» (GIUNTA 2002b,p. 231).
Sonetto fece il conte Naddo e mandollo a Antonio di Cecco.
1 Ben sublevar si può il mio intellettopoi che l’alto Signor l’à fatto degnodel ceto prezïoso, e sì benigno,che florido ritiene il mio concetto.
5 Tu, gentilesco col grazioso efetto,che ben discerni il giusto col maligno!E benedetto sia il corrente segnoquando m’aparve il tuo leggiadro aspetto!Ma come grato, prospero e giocondo,
10 i’ ne ringrazio il coro trïunfante,che m’à prestato il fato sì secondo;e ciaschedun di noi sie sì costante,che cci conceda d’atignere il fondodove <si> spera la mente nostra amante.
13 conceda d’atignere] choncieda tignere
Note. 3. ceto: il TLIO s.v. ceto (1) dà come unico significato ‘assemblea di persone con potere decisiona-le’; qui dovrebbe valere semplicemente ‘assemblea di persone’ (una confraternita religiosa, probabilmen-te). Benigno (riferito all’alto Signor) è probabilmente grafia sotto la quale si nasconde la forma non anafo-netica benegno; lo stesso vale per maligno (v. 6; cfr. il § 5 dell’introduzione). 4. Il soggetto di ritiene (= ac-coglie presso di sé) è sempre l’alto Signor; l’aggettivo florido dovrebbe essere invece riferito al concetto (=la sede del pensiero, la mente: cfr. IVb, v. 3). 5. grazioso efetto: dovrebbe essere la capacità, messa in atto,di distinguere il bene dal male (cfr. il verso successivo). 7. corrente segno: forse una qualche manifestazio-ne della volontà divina. 10-1. Visto il successivo conceda (v. 13), il coro trïunfante sarà l’insieme delle in-telligenze angeliche che hanno concesso al poeta una sorte così propizia (fato sì secondo), più che il già ci-tato ceto (che, in questo caso, sarebbe dato in sorte dal destino benevolo). 13. L’integrazione, che sanauna probabile aplografia, oltre a evitare una dialefe fra due atone rende più facilmente comprensibile ilsignificato del verso (‘facciamo in modo di essere tanto costanti, che il coro trïunfante – o in alternativa ilfato – ci conceda di raggiungere il Paradiso’). 14. Il verso è ipermetro, e la correzione più economicasembra l’espuzione del si. Anche se il senso generale della perifrasi appare chiaro (il fondo è comunque ilParadiso), il significato del verbo spera è differente a seconda di come si interpreti la successiva mentenostra amante: la mente di Naddo e di coloro a cui si rivolge, che ‘spera’ di raggiungere la beatitudineeterna, o la divinità che ama e ‘aspetta’ i suoi figli nel luogo ultraterreno a loro destinato? In quest’ultimocaso l’inserzione del si potrebbe essere dovuta al fatto che sperare, se usato con l’accezione ‘aspettare’ (at-testata nel corpus TLIO), pare presentarsi prevalentemente con la costruzione pronominale, che potreb-be quindi essere stata ripristinata (dando luogo all’ipermetria) in quanto più normale per la coscienza lin-guistica del copista.
Vb.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, c. 70r
Sonetto di schema ABBAABBA;CDC,DCD. Stesse rime del precedente, a cui
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 55
risponde; uguali anche tre parole in rima su rima A e due parole in rima su ognu-na delle altre rime (in totale, 9 parole in rima su 14). Anche in questa sua secon-da risposta a Naddo Antonio si esprime con tono sentenzioso e con l’apparenteatteggiamento di un superiore verso un inferiore (non così invece in VIa, dove glisi rivolge per chiedergli consiglio); ma in questo caso dopo il discorso gnomicodei vv. 1-4 torna almeno a parlare del e con il suo interlocutore, pur non offrendoalcuna informazione utile a capire perché il concetto di Naddo si sia sublimato equindi quale sia l’evento all’origine dello scambio poetico. L’illustrazione è similea quella del sonetto precente, ma stavolta una delle due mani regge un calamo.
Risposta d’Antonio di Cecco al conte Naddo.
1 A vera sommità e buono efettod’ogni virtù e sottilissimo ingegno,per superbia già mai o per suo segnosi può venir, ch’è contrarïo oggetto.
5 Dunque, se sublimato è il tuo concetto,suo aversario ti fa di grazia degnoperché non ài nel gentil core a sdegnouno idïota e semplici intelletto.Ora i’ ringrazio quel che ’l cielo e ’l mondo
10 fé, poi ringrazio te (e tuo sembiante),che non ti schifi di mirar sin fondo,e poi ti prego che ci sii costante.Or prego amor che in istato giocondoconservi l’alma nostra, e trïunfante.
Note. 5. concetto: con lo stesso significato, al v. 4 della proposta. 6. aversario: il maligno, o forse la già ci-tata superbia. 8. La forma semplici per semplice presenta un fenomeno, quello del «passaggio di e finale ai dopo consonante palatale, caratteristico dei dialetti moderni di Sansepolcro e Anghiari, […] già attesta-to nei testi trecenteschi-quattrocenteschi delle due località» (cfr. CASTELLANI 2000, p. 393). Non pare daattribuire né all’autore, né al copista di Lc. 10. sembiante : ‘sguardo’. 11. Sin fondo: fino al limite estremo.
VIa.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, c. 70r
Sonetto di schema ABBAABBA;CDC,DCD EE. È una richiesta di consiglio,fra le più comuni nelle corrispondenze poetiche medievali: il poeta è tormentatocrudelmente da Amore, e non è in grado di difendersene, quindi chiede un pare-re a Naddo. L’illustrazione a margine (eseguita da due mani diverse o almeno indue momenti distinti: è infatti diverso il colore dell’inchiostro adoperato per ledue figure, e quella di Amore sembra posteriore) concretizza l’immagine inizialedel testo: si vede infatti una figura corrucciata e con la destra levata, incalzata allespalle da una freccia tenuta in mano da Amore, raffigurato in maniera tradiziona-le nudo, alato e bendato.
56 MARIA CLOTILDE CAMBONI
Sonetto di Antonio di Cecco; mandò al conte Naddo.
1 Sospignendomi Amore a passo a passo,condotto m’à nelle crudei catenedi tal che non mi vole, e pur mi tene;chiamar merzé, i’ son già stanco e lasso.
5 Ma ogni giorno più duro ch’un sassotrovo suo cor, me’ a crudele. s’avene;ond’io mi trovo in dispietate penee d’ogni speme dinudato e casso.Piango, omè!, sempre il mio crudo martire,
10 che poco giova il dimandare aiuto:privo è d’ogni diletto il mio disire.Non mi vale arme, non mi vale scuto,poter risistere a fiero colpire,o acettar lo stormo, o far rifiuto.
15 Però domando a voi alcun consiglioa sviluparmi del feroce artiglio.
2 crudei] crudeli
Note. 3. Il riferimento è ovviamente alla donna amata. 6. ‘meglio ci si ritrova nelle mani di un malvagio’.
VIb.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, c. 70v
Sonetto di schema ABBAABBA;CDC,DCD EE. Stesse rime del precedente,di cui è la risposta: in comune una sola parola in rima, sulla rima B, in identicaposizione nei due testi (v. 6). Naddo consiglia a Antonio prima di non pensarepiù all’amata, e poi, nel caso non ne fosse capace, di iniziare ad interessarsi adun’altra donna. Il disegno a margine raffigura Naddo nell’atto di scrivere la ri-sposta su un foglio.
Risposta fece il conte Naddo a Antonio di Cecco.
1 Bench’io sia fragile e di senso basso,a l’alte tuo parole a me convieneper ubidir allo ’ntelletto sene,di far risposta, e d’altro non mi spasso.
5 Tu d’amor preso più che in tana il tasso!Non fa suo stanza a te molto: s’avienepiù non pensar, né in lei fermar tuo spene,se del legame far vuoi il trapasso.Ma se di questo no· ne fussi il sire,
10 raguarda un’altra, e l’animo pasciutosarà alquanto, senza alcun mentire.E tu così con citera e lïuto
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 57
cantar potrai e già più non sentirele crudei pene, ogni martir caduto.
15 Che ben provede, stando in gran periglio,chi volge i remi e salva il suo naviglio.
Note. 1. senso basso (in opposizione alle alte parole): ‘intelletto inadeguato’. 4. Mi spasso: ‘mi diletto’. 6.‘Non rimarrà a lungo presso di te: è opportuno…’ (ma, vista la sintassi comunque zoppicante, si potreb-bero anche sostituire i due punti con una virgola, e intendere s’aviene ‘se accade’).
VII.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, cc.5v-6r
Sonetto di schema ABBAABBA;CDE,CDE. Il rimante al v. 8 è solo in asso-nanza con gli altri della stessa serie; la rima spenta : vinta invece molto probabil-mente è imperfetta solo in apparenza (cfr. nn. ad loca). Da notare i contatti con lacanzone I, a cui segue immediatamente nel manoscritto: anche in questo caso ilpoeta si rivolge ad Amore, visto in entrambi i testi come qualcosa di negativo dacui malgrado gli sforzi non si è in grado di difendersi o sottrarsi. Interessante so-prattutto l’ultimo verso: «sì cch’io mi so indarno affaticato». È possibile che sifaccia riferimento proprio alla fatica di comporre la canzone I contro Amore, eche quindi la consecuzione dei due testi non sia casuale ma prevista originaria-mente dall’autore. I due testi potrebbero essere associati anche dalla presenza,nella fronte del sonetto e nel congedo della canzone, della rima -illa, con ripeti-zione della parola in rima distilla; ma va notato che la stessa rima è anche nelcongedo della canzone II, che con la fronte di questo sonetto ha in comune en-trambi i suoi rimanti sulla stessa rima, favilla e dispartilla, e l’immagine (peraltroassai comune) del fuoco-sentimento amoroso difficilmente estinguibile. Per dir laverità, viste le tematiche trattate nelle due canzoni il sonetto può essere associatoalla II altrettanto bene che alla I, come – forse casualmente – nel manoscritto; ele cattive condizioni in cui questa canzone ci è pervenuta, e le lacune che la sfigu-rano, fanno sì che sull’interpretazione globale del testo e la possibilità di una suaconnessione con altri dello stesso autore sia d’obbligo la cautela. Sul margine de-stro, a c. 5v, si vede una figura umana (il poeta?) che tiene in mano un cuore (quicitato ai vv. 1 e 4) colorato di rosso.
Sonetto fece Antonio di Cecco.
1 Giamai il core o l’alma non distillaaltro pensiero. , se non isviluparsi,poi più nel nido tuo non intanarsie dal cor la tua fiamma dispartilla.
5 O crudel foco, o immensa favilla,e tuo rimedi son sì pochi e scarsi!Tardi con alcuna arme ripararsi
58 MARIA CLOTILDE CAMBONI
può, o non mai, cui tieni in tuo artiglia.Nel concetto cede questa fornace
10 per grande resistenza a verla spentae ritornar[e] nel primaio stato.Or veggio che resi[s]tere a tuo faceper nul modo si può, né fia mai vinta:sì cch’io mi so indarno affaticato.
11 nel primaio stato] nello stato primaio
Note. 3-6. I possessivi sono riferiti ad Amore, destinatario del sonetto e dell’apostrofe al v. 5. 8. Rima so-stituta dall’assonanza (cfr. il § 6 dell’introduzione); visto anche che il verso successivo ha uno schema ac-centuativo non canonico, mentre al v. 11 si è reso necessario invertire le ultime due parole per ripristina-re la rima, la lezione artiglia potrebbe essere dovuta a corruttela testuale, facilitata dal fatto che fra le gra-fie anticamente utilizzate per la l palatale vi è anche ll. Un possibile punto di partenza potrebbe esserestata una parola in rima come ancilla (cui tieni a tuo ancilla, ‘chi tieni come tuo servo’): il nesso nc a unalettura affrettata può essere scambiato abbastanza facilmente col nesso rt. 9. Endecasillabo non canonico;concetto: la sede dei pensieri e dei sentimenti, la mente (cfr. IVb, v. 3, e Va, v. 4). 13. Per vinta in rima conspenta, cfr. quanto detto in n. al verso 7 della ballata (III).
VIII.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, c.70v
Sonetto di schema ABBAABBA;CDC,DCD. La rima B è sdrucciola e nellaterza occorrenza imperfetta (v/b: ma cfr. n. ad locum). Le quartine ricalcano conmolta evidenza la prima stanza della nota canzone di Cino da Pistoia: «Quandopotrò io dir: «Dolce mio dio, / per tua grande vertute / or m’hai tu posto d’ogniguerra in pace, / però che gli occhi miei, com’io disio, / veggion quella salute /che dopo affanno riposar mi face»? / Quando potrò io dir: «Signor verace, / orm’hai tu tratto d’ogni oscuritate, / or liberato son d’ogni martiro, però ch’io veg-gio e miro / quella ch’è dea d’ogni gran biltate, / che m’empie tutto di soavita-te»?» (PD, vol. II, p. 661; corsivi miei). Oltre alle evidentissime riprese lessicali eall’uguaglianza tematica, è notevole l’identità dell’anafora e della doppia sermoci-natio, e la somiglianza fra i due testi potrebbe essere ancora incrementata situan-do le apostrofi ad Amore dentro lo pseudo-discorso diretto del testo di Antonio(o anche, fuori da quello della canzone di Cino: le due opzioni sono egualmentepossibili). Il contatto fra i testi è tanto più notevole in quanto appare palesemen-te non mediato (da Petrarca o da altri rimatori trecenteschi): infatti non solo ilsonetto è di gran lunga troppo conforme a Quando potrò io dir, ma non è possi-bile rintracciare nessun altro testo che riprenda il sintagma iniziale di questa can-zone ciniana. L’illustrazione a margine raffigura il poeta che con entrambe lebraccia alzate si rivolge ad Amore bendato, di cui è raffigurata solo la testa (e cfr.anche quanto detto a proposito del disegno a margine della canzone I nel cappel-lo introduttivo alla stessa).
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 59
Sonetto fece Antonio di Cecco da Siena.
1 Quando potrò, signor dal cielo. produtto,«Per grazia inestimabil, l’alma fievole»dir «per tuo gran virtù e onorevole,di mortal guerra in pace l’ài adutto!»?
5 Quando potrò io dir, signore, il frutto,o «Di mie stento il cor non è più debole!»?Né posso dir di te che sia colpevolea dar tanti tormenti e tristo lutto!Tu ài, signor, gl’amorosi sospiri,
10 l’antiche pene e poi gl’aguti stocchi,l’oculta fiamma e gl’ardenti disiri.Giamai, signor, di lagrimar questi occhinon finiran, se verso me non spiri,e veggia che pietà a[l]quanto fiocchi.
9 ài] sovrascritto, difficile dire su cosa
Note. 1. Signor dal ciel produtto: Amore, sentimento di origine divina, a cui si rivolge, come il preceden-te, anche questo sonetto. 6. Sotto la grafia debole potrebbe forse nascondersi una forma con spirantizza-zione; ma la rima imperfetta non è affatto da scartare, soprattutto perché sdrucciola (cfr. BELTRAMI 1991,p. 189, n. 92 «la tendenza alla rima imperfetta nel caso della rima sdrucciola è molto più marcata che nelcaso della rima piana»). 9. ài: forse andrebbe ripristinata una d iniziale (tu dai, quindi). 13-4. Difficile di-re se il soggetto dei due verbi in rima sia lo stesso: spirare secondo il GDLI può voler dire ‘essere emana-to o irradiato’, potrebbe quindi darsi che anche il soggetto di spiri, come del successivo fiocchi, sia lapietà, che dovrebbe quindi ‘effondersi’ o ‘manifestarsi’ avendo come oggetto evidente il poeta (quindispirare verso con soggetto un sentimento: ‘avere come oggetto qualcuno’). Ma è anche possibile che ilsoggetto di spiri sia Amore, che dovrebbe quindi finalmente ‘spirare’ verso il poeta, il quale desiderereb-be essere oggetto a sua volta del sentimento amoroso, essere cioè finalmente contraccambiato.
IX.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, c. 96r-v
Sonetto di schema ABBAABBA;CDC,DCD. Rivolto a madonna, raffiguratasul margine inferiore della c. 96r assieme al poeta nell’atteggiamento caratteristi-co degli oratori (mano alzata e indice proteso). L’iterazione dell’anafora di o intutti i versi della fronte fino a coinvolgere il primo della sirma ricorda alcuni deisonetti dei Rerum vulgarium fragmenta di Petrarca, come il 161 (per il numerodelle esclamative anaforiche, pur diversamente disposte), il 146 e il 253 (con lestesse presenti solo nei versi dispari della fronte, ma in entrambi, come in que-sto, indirizzate alla donna amata). Verso i Fragmenta pare condurre anche il sin-tagma chiaro lume, con cui si chiude il primo verso, riferito dal Petrarca a Lauraal v. 21 della sestina 142 (in rima come qui) e al 9 del sonetto 181. D’altra parte,anafore ripetute di o appellativo (rivolto a persone, in questo caso) sono presen-ti già in vari testi di Guittone d’Arezzo, e un altro esempio di sonetto costruitosu questa figura (proprio come il 161 di Petrarca) si può vedere fra le rime di
60 MARIA CLOTILDE CAMBONI
Matteo di Dino Frescobaldi (è O infelice giorno, punto ed ora: cfr. FRESCOBALDI,Rime, p. 124), fra le quali si trova anche chiaro lume riferito alla donna amata (ilsintagma in sé e per sé è ovviamente piuttosto frequente; è al v. 3 della ballataDeh, confortate gli occhi miei dolenti, in FRESCOBALDI, Rime a p. 92). In realtà, ilsonetto più che a quelli di Petrarca sembra avvicinarsi ad alcuni testi stilnovisti-ci (o degli epigoni trecenteschi dello Stilnuovo), soprattutto per gli appellativivolti a esaltare madonna nella sfera morale-spirituale, spesso formati mutuandoi termini del linguaggio religioso; e in questa direzione paiono condurre anchegli spiriti del v. 13.
Sonetto fece Antonio di Cecco da Siena.
1 O ineffabile dono, o chiaro lume,o fior d’ogni beltà, cosa celeste,o intelletto divino in mortal veste,o mirabile exemplo di costume!
5 O carità che tutto il mondo alume,o luce eccelsa, o sopra ogni terreste,o gentileza che ’l mondo riveste,o d’ogni gran virtù copioso fiume!O spera de’ mortali, a cui Amore
10 m’à suggetto, non contra a mio volere,mi ti racomandò alto signore;i’ son pur tuo, e bene il puoi sapere,che l’alma, spiriti miei, i sensi e ’l corenon desideran mai altro vedere.
11 all’inizio del verso è stata scritta una i, poi cancellata
Note. 2. cosa: il termine è utilizzato, come nel linguaggio stilnovista, per indicare la donna amata (cfr. EDs.v. cosa), destinataria del testo. 6. La seconda o può parere superflua, e forse è da espungere: ma, vistal’almeno apparente eccezionale correttezza della lezione del componimento e il fatto che una simile o ‘su-perflua’ è rintracciabile nella canzone II (v. 2), si è scelto di tenerla in entrambi i casi. Terreste per terre-stre non è forma estemporanea dovuta ad esigenze di rima, ma è attestata anche in prosa in testi prove-nienti da varie zone della Toscana. 13. spiriti: probabile grafia latineggiante, da leggere spirti per la rego-larità del verso.
X.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, c. 85r
Sonetto di schema ABBAABBA;CDC,DCD EE. Come nel testo successivo, sichiede del vino come contropartita dei servigi offerti. Non è purtroppo possibiledecidere al di là di ogni ragionevole dubbio se la brigata a nome della quale siavanzano le richieste sia effettivamente un gruppo d’armati capitanato da ZanMedaglia o semplicemente una compagnia di allegri gaudenti: in base al sonettosembrerebbe più probabile la seconda ipotesi, ma le immagini guerresche della
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 61
parte centrale di XI non sembrano tutte facilmente giustificabili come semplicimetafore di qualcosa di altro da sé (e le lodi di Zan Medaglia che seguono l’invitoa lasciar fare a lui non sembrano ironiche come dovrebbero in tal caso essere). Amargine è rappresentato un braccio, che reca sospeso al polso un oggetto di cuinon so dire natura né funzione, e in mano un altro oggetto, che potrebbe esserealtrettanto bene un pezzo dei formaggi di cui si parla al v. 6 quanto una missiva,forse contenente lo stesso sonetto (e il testo che segue).
Sonetto fece Antonio di Cecco da Siena.
1 Se ’l conte padovano o d’Albania,il saggio duca, o l’Adobbo pregiatofossero stati ogni dì al mercatocon tutto il lor sapere o vigoria,
5 così gentile e nobil mercantiadi buon formaggi non v’aré mandato,e ser Istraccia ne saria gabbatoavendo missa tutta suo balia.Ma Zan Mëaglia, prode e valoroso
10 in sempre far l’onor di suo signore,vi mostra come sempre è poderoso.E voi con singulare e grato amore,or che ne viene di Candia il pelosoche va a pelo in giù con gran dolzore,
15 mostrate che gl’Adobbi e Stracciaferrinon sono ingrati né brudeni o erri.
10] prima di senpre, vi è un fi (o fe) cancellato
Note. 1-2. Allo stato attuale delle ricerche, è purtroppo impossibile sapere chi siano i personaggi citati equando si svolgano gli eventi a cui si fa riferimento in questo testo o nel successivo, con esso collegato. Èinoltre possibile che al v. 1 non si alluda a individui storicamente esistiti, ma si adducano ironicamente,come exempla ficta di persone incapaci di compiere l’impresa tutt’altro che eroica di procurare del for-maggio, personaggi inesistenti ma che in base ai loro titoli dovrebbero apparire prodi e cortesi. Il nomeAdobbo torna anche al v. 15 (al plurale) e in XI1. 7. Anche questo nome torna tre volte, con varianti più omeno lievi: posto che si parli sempre dello stesso personaggio, Straccia (in questa particolare occorrenzacon la i prostetica) dovrebbe essere l’ipocoristico di Stracciaferri (cfr. il v. 15 e XI5). 8. balia: ‘autorità,potere, capacità’ (cfr. TLIO s.v.). 9. Altro nome che torna, leggermente variato, in XI29 (Zan Medaglia).13. peloso: non è chiaro come l’aggettivo possa riferirsi a un vino; dovrebbe comunque indicarne unaqualità positiva. 14. L’espressione a pelo in giù dovrebbe valere il contrario di «contropelo» (nel suo sen-so figurato) e quindi significare ‘senza nessuna difficoltà, facilmente’. 16. La forma brudeni non è rintrac-ciabile altrove; forse è un germanismo come erri, ‘tedeschi’ (cfr. GDLI s.v. erro2); è comunque certa lasua valenza negativa (forse potrebbero riferirsi entrambi a soldati mercenari provenienti d’Oltralpe).
XI.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, c. 85v
Rispetto la punteggiatura del ms. (barre oblique /, in un caso doppie //), tran-
62 MARIA CLOTILDE CAMBONI
ne che nel caso delle due barre poste una prima e una dopo io (40), in quantopaiono avere funzione di diacritico e non di separatore (cfr. il § 8 dell’introduzio-ne); la fine rigo è segnalata da ||. La suddivisione in sequenze testuali (e la conse-guente progressiva numerazione) è fatta tenendo conto innanzitutto dei segni didivisione presenti nel manoscritto, in secondo luogo delle rime: quindi ogni se-quenza testuale è delimitata o da un segno di divisione del manoscritto o da unarima. A margine del testo è raffigurato un personaggio che indica due fiaschi sti-lizzati, o meglio, le zuccole di cui si parla alla fine del testo.
Misticcio del sonetto di sopra fece Antonio di Ceco.1 O prezioso Adobbo, / 2 non essare zoppo / 3 o sgobbo || 4 a far quel ch’io t’ò detto; / 5 evoi, ser Straccia, 6 con || molta bonaccia / 7 fateli un poco caccia, / 8 che s’afretti! || 9 Che ’fiaschi sien ben netti, / 10 e pieni di Candia / 11 o Tiro: || 12 ch’a gran sospiro 13 c’è di que’ch’atendono, / 14 e lo grieva || la ’ndugia. / 15 Fate non sia bugìa / 16 tal domandar: ch’a ||sesto / 17 à tolto l’anda / 18 il tuo ser Alexandro; / 19 e essi a con||ventare in fa’ culto discacchi. / 20 Sì che non come || stracchi 21 si conviene onorare la brigata, / 22 quando ||farà il sermone; / 23 e fermo al baragone 24 ne sarà in || pochi giorni. / 25 Sì cche non ciscorni 26 vostra gran vi||goria: / 27 mettereteli in via 28 quando v’attaglia. / 29 E poi || a ZanMedaglia 30 lassarete il pensiero, / 31 con suo animo || altiero: / 32 ch’a far sempre l’onore33 di ciascun suo signo||re / 34 non fu mai lento. / 35 E fatto tal convento, 36 ne sarà ||vo-stra fama assai gioiosa, / 37 essendo la pilosa 38 a||morosa 39 e piacente a tal dottori. /40 Or io più dir non || posso, / 41 se non che ’l fante grosso / 42 e il governal || nosso 43 avoi si recomanda. / 44 È detto a randa a randa || 45 quel che ora bisogna: / 46 voi or sanzarampogna || 47 mostrate cortesia e gentileza, / 48 che chi più sa, || cotanto più la preza. //||49 E se farete abian piene le zuccole ||50 arete prestamente delle cuccole. ||
48 cotanto] chontanto
Note. 2-3. zoppo: ‘inefficace, inadeguato’ (cfr. GDLI s.v.); lo stesso significato ha probabilmente anchesgobbo (forma di ‘gobbo’?). 7. ‘Incalzatelo, stimolatelo un poco’. 10-1. Candia / o Tiro: note qualità di vi-no. 12-3. a gran sospiro c’è di que’ ch’atendono: ‘viene ardentemente desiderato da coloro che aspettano’.14. ‘E l’attesa li affligge’. 16-7. ‘Perché si è mosso (o è scappato?) al momento opportuno’ (a sesto: cfr.GDLI s.v. sesto2). 18. Il riferimento pare essere a un condottiero (non è chiaro se Zan Medaglia o un al-tro), equiparato (ironicamente?) ad Alessandro il Macedone. 19. conventare: ‘promettere’. Fa[re] cultopotrebbe equivalere a ‘occuparsi, darsi pensiero’ (con culto ‘coltivazione’, ovviamente nel senso figurato;cfr. GDLI s.v. culto2 e TLIO s.v. colto [2]). Non è purtroppo possibile decifrare le allusioni del testo, equesto condiziona anche la sua interpretazione: pare però di poter capire che mentre «Alexandro» (forseZan Medaglia, forse un altro soldato) si dava da fare (o scappava? Vedi sopra), qualcun altro (chi?) si li-mitava a promettere e la sua massima occupazione era giocare a scacchi. 23-4. baragone: forma di parago-ne, probabilmente tipica senese (vedi il § 5 dell’introduzione). Il significato nel contesto è quello di ‘pro-va, confronto’ (probabilmente nello specifico uno scontro bellico; per significati e espressioni simili, cfr.GDLI s.v. paragone). 28. ‘Quando vi torna bene’. 35-6. ‘E dal momento che avete fatto una tale promes-sa, la vostra fama ne sarà molto avvantaggiata, se…’. 37. Pilosa: allusione al sesso femminile. 41-2. Il fantegrosso è quello armato con armatura pesante, mentre governale qui indicherà una persona che per la suacarica si deve occupare del benessere dei soldati. La forma nosso per ‘nostro’, assieme ad altre con lostesso esito -ss- da -str-, è presente nei dialetti toscano occidentali (e talvolta anche in altre zone della To-
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 63
92. Per questa questione, cfr. il § 8 dell’introduzione. Tali barre nel manoscritto si trovano sia prima chedopo è (Io voglio che voi sacciate, 22 e 25; Ben venga Lapo!, 17), fi’ (Io voglio che voi sacciate, 35) e à (Iovoglio che voi sacciate, 62; Ben venga Lapo!, 13, 21, 25, 27, 29, 31). (Notare che in Ben venga Lapo! le bar-re oblique poste dopo à sembrano cumulare le due funzioni di diacritico e di divisore – cfr. il § 8 dell’in-troduzione –; di conseguenza, nell’edizione del testo sono state mantenute).
scana) per influenze settentrionali, dal momento che per Castellani proviene «dall’Alta Italia» (cfr. CA-STELLANI 2000, pp. 137 e 304); potrebbe essere un settentrionalismo adoperato per esigenze di rima (cfr.per un altro IVb, 5 e 8, e la n. a 5), ma d’altra parte è abbastanza attestato in varie zone della Toscana(così risulta anche dall’interrogazione del corpus TLIO). 44. a randa a randa: ‘a stento, in maniera insuffi-ciente’; o forse meglio ‘in due parole’. 49. Zuccole: derivato da zucca, intesa come il recipiente ricavato dalfrutto della zucca, qui destinato a contenere il vino. 50. Cuccole: oggi la cuccola è sia una varietà di olivesia una razza di galline: è possibile quindi che, in cambio del vino (nel sonetto X apparentemente chiestocome contropartita dei formaggi), la brigata si offra di procurare altro cibo. Un’altra possibilità è quelladi attribuire a cuccola lo stesso valore del probabile derivato cuccoletta, presente nel DLE col significatodi ‘organo sessuale femminile’ e con il seguente esempio: «Col dir monin, monnicchia o cuccoletta, / fan-tolinetta o titoli sì fatti…» preso da NELLI, Satire, vol. II, p. 43. È anche possibile che nessuna di questespiegazioni sia corretta; e l’ambiguità della chiusa, assieme alle indecifrabili allusioni di cui il testo apparecostellato, fa sì che sia impossibile offrirne un’interpretazione non opinabile.
Analisi metrica delle sequenze testuali. 1. Settenario o senario, a seconda della lettura di prezioso (con osenza dieresi). 2-3. Senario e trisillabo; considerandoli assieme (sparirebbe quindi l’irrelata zoppo), com-pongono un ottonario (o un settenario, considerando soprannumeraria l’atona finale di essare). 4. Sette-nario; unendolo alla sequenza successiva, anche in questo caso l’irrelata potrebbe sparire (i due versi as-sieme comporrebbero un endecasillabo). 5-6. Quinario e senario, o endecasillabo con rima interna. 7.Settenario (o, unita a 8, endecasillabo con rima interna). 8-9. Quadrisillabo e settenario, o endecasillabo(con rima interna)? 10-1. Senario e trisillabo, leggibili come un unico settenario (con l’atona finale di pie-ni soprannumeraria). 12. Quinario; potrebbe essere unito al successivo senario dando luogo a un endeca-sillabo con rima interna. 13. Senario sdrucciolo: in questo caso l’irrelata non pare riassorbibile unendo lasequenza alla successiva, dal momento che questa è settenaria. 14-5. Entrambe settenarie, ma leggendo lerispettive ultime parole secondo l’accentuazione normale (si tratterebbe quindi di un caso di rima perl’occhio). 16. Settenario irrelato; unendola alla sequenza successiva si avrebbe un endecasillabo, che re-sterebbe comunque irrelato. 17. Quinario irrelato: unendo la sequenza alla successiva si avrebbe un en-decasillabo, che resterebbe comunque irrelato. 18. Settenario irrelato: impossibile unirlo alla sequenzasuccessiva (quando ricomincia la serie delle rime), dato che si avrebbe un triplo settenario. 19. Due sette-nari; il primo (irrelato) è leggibile anche come senario, con sinalefe iniziale. 20. Settenario. 21. Sequenzaendecasillabica irrelata. 22-4. Settenari. 25. Senario. 26. Settenario. 27-8. Settenario e quinario, oppureendecasillabo con rima interna. 29-33. Serie di sequenze settenarie: l’ultima può essere unita alla succes-siva a comporre un endecasillabo, a patto di leggere la sua ultima vocale come atona soprannumeraria.34-5. Quinario e settenario, unibili ricavando un endecasillabo. 36. Endecasillabo. 37. Settenario. 38-9.Quadrisillabo e ottonario, riunibili in un endecasillabo, che peraltro resterebbe irrelato; non pare possi-bile unire diversamente le sequenze, dal momento che la successiva è settenaria. 40-1. Coppia di settena-ri. 42. Senario (settenario ripristinando la vocale finale di governal). 43-6. Altra serie di settenari. 47-8.Endecasillabi. 49-50. Endecasillabi sdruccioli.
Appendice: i «misticci» delle cc. 84r-85r.
Riproduco la punteggiatura del manoscritto (segnalandone inoltre gli a capo con||), costituita unicamente da barre oblique, con l’eccezione dei casi in cui questedovrebbero svolgere solo funzione di diacritico e non anche di divisore92.
64 MARIA CLOTILDE CAMBONI
93. Le maiuscole, infatti, paiono rientrare fra i segnali delle partizioni del testo. In Ben venga Lapo! ogni‘battuta’ del compratore o del venditore inizia con lettera maiuscola – sia quelle aperte da un separatore,sia quelle, non precedute da separatore, che si trovano subito dopo un a capo –, tranne le due del vendi-tore che, pur non cominciando all’inizio del rigo, non sono separate dalle precedenti dalla barretta (percui cfr. la n. 50). Anche in O prezioso Adobbo (e nello stesso stesso Io voglio che voi sacciate) molto spessoi separatori sono seguiti da lettera maiuscola; nello stesso testo, inoltre, le maiuscole in apertura di rigoseguono sempre un’omofonia (cominciano infatti con lettera maiuscola le sequenze 4, 9, 12 e 47 ed en-trambi gli endecasillabi sdruccioli finali). La maiuscola non è, ovviamente, uno degli elementi migliori daprendere in considerazione per stabilire la suddivisione in sequenze del testo (visti anche i non rari casiin cui dopo il separatore non è adoperata¸ sia in Io voglio che voi sacciate, sia in O prezioso Adobbo). Tut-tavia, non potendo rintracciare un altro elemento (come le rime o l’alternarsi degli interlocutori) che con-sentisse di suddividere ulteriormente il testo, si è optato per la soluzione adottata, che permette anche didare conto di una particolarità della mise en page del manoscritto che altrimenti sarebbe andata perduta.
Io voglio che voi sacciate.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laurenziano Conventi soppressi 122,cc. 84r-85r
La suddivisione in sequenze numerate progressivamente è fatta sulla base deisegni di punteggiatura presenti nel manoscritto. Dato che talvolta la fine di rigosembra poter essere sostitutiva del divisore (l’unica occorrenza rintracciabile diquesto in fine rigo si trova alla fine di c. 84r, e cfr. il § 8) sono stati consideratianche alcuni degli a capo, quelli dopo i quali nel manoscritto si trova una maiu-scola93. Sul margine inferiore della c. 84r si trova una figura con berretto che, lebraccia allargate, pare rivolgersi ai tre frati raffigurati accanto.
Misticcio fece.1 «Io voglio che voi sacciate ch’el ci è arivato || frate poco / 2 e frate meno, / 3 frate rabuf-fato || e frate mal gastigato, / 4 e poco adosso / e meno || in capo, / 5 e siamo cinquecentopiù che le formiche || 6 a quella nostra santa abadia». / 7 «Dè, dimmi, santo || frate, /8 dov’è questa vostra santa abadia?» || 9 «Io vel dirò. / Sta nella valle di santaCornacchia. || 10 Chi v’arivasse, la mattina, / 11 sì avrebbe un cavoletto, || tratto e misso, /12 condito colla stanga dell’uscio. / 13 La sera || avrebbe un picciol pesce, / 14 la sanità col-l’agresto: || saria più sano che luccio! / 15 Avrebbeci ancora un || gran vantaggio: / 16 dellecinque vuova, tre guasti. || 17 Letto da dormire / 18 la santa madre terra, / 19 la matrassa ||del comune / 20 che ve ne stareno vinticinque per cape||zale, / 21 e daresti più volte che lemulina d’Attibogli. || 22 Questa predica ch’io dico è una predica || francesca: / 23 che lepietre pascan l’erba / 24 e le ca||valle cantan la messa, / 25 così è vero, madonna, || 26 comela gallina piscia. / 27 Anda’mene in val d’Arno: || le pietre andavano a gallo, / 28 e ’ pesci,per paura, fugivan || su per le mura. / 29 Anda’ne al ponte ad Era / 30 e chiamai chi || nonv’era. / 31 Risposemi niuno / 33 e montai sur un pruno || e colsi ben trecento stagia de zoc-coli». / 34 Disse il buono || uomo di cui erano le cipolle: / 35 – Che fa’, fi’ della putta? ||36 Perché m’ài colte le mie scalogne, / 37 che le volia || per seme di zucca / 38 per mangiarela quaresima? / 39 – Ecoti || sette lance / 40 con sette fanti in collo. / 41 Io salto uno || spie-do / 42 e pigliai un fossato, / 43 e poi entrai in un campo || di fave. / 44 Ine v’avìa uno /45 che n’avìa morto un altro. || 46 Piglia, non piglia, / 47 dagli e non gli colse, / 48 tre vol-
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 65
te || l’uccisi / 49 e non si morì. / 50 E ’l sangue andò per terra / 51 e non || se ne perdé goc-cia. / 52 Io mi lassai cadere, / 53 e fuggie. || 54 Quand’ero in piano di terza / 55 fonte Bran-da sona||va; / 56 le mura tragono / 57 per ogni romore. / 58 Escìe fuori || una casa; / 59 ilporco si ruppe e la fune se n’andava». || 60 «O Giovannuolo!» / 61 «Ben vegna!» /62 «Che novelle à a Firenze?» || 63 «Buone e belle, al tuo servigio». / 64 «Fusti tu quelloch’uccidesti || l’uomo?» / 65 «Anco fui quel ch’ell’il tolsi». / 66 «Dunque fostù quel || chegli desti!» / 67 «Pigliatelo!» / 68 «I’ non son latte». / 69 «Legatelo!» || 70 «I’ non son por-co». / 71 «Tiratel su!» / 72 «E val l’un du a star giù». || 73 «Tiratel bene / 74 alto!» / 75 «Ioromperei il tetto di notte». /|| 76 «Confessa!» / 77 «I’ non son prete». / 78 «Dì el nome e ’lsopranome!» || 79 Disse il giudice: «Mandalo giù colla mala ventura || ch’egl’è un pazo».
8 abadia è stato scritto, erroneamente, anche prima di santa, e in seguito cancellato 31 niu-no] nimo
Note. 3. rabuffato: vari i significati possibili: ‘spettinato’, ‘disordinato’, ‘turbato’, ‘arrabbiato’, ecc. (cfr.GDLI s.v. rabbuffare). Forse il più probabile è ‘aspramente redarguito’, visto il successivo «mal gastiga-to». 9. Cornacchia: citata forse perché uccello associato all’ingordigia (cfr. Arrighetto, p. 220), visto chedopo si parla di cibi. 11. ‘Colto e subito servito’. 14. L’agresto è un vino o succo acido prodotto con uvaacerba (cfr. TLIO s.v.). La successiva espressione dovrebbe essere equivalente a quella, già attestata inBoccaccio, ‘essere più sano di un pesce’. 16. vuova: ‘uova’; la forma è data come toscano occidentale inCASTELLANI 2000, p. 310. 19-20. matrassa: anche questa forma è data come toscano occidentale da CA-STELLANI 2000, p. 234; lo stesso si può dire della terza persona plurale del condizionale in -eno (cfr.sempre CASTELLANI 2000, p. 331), mentre vinti (vinticinque) per venti è forma comune sia al pisano, siaal senese e all’aretino (cfr. ancora CASTELLANI 2000, pp. 316, 359, 427). 23. pascan: la forma, qui inter-pretata come un indicativo (come il successivo cantan: cfr. CASTELLANI 2000, pp. 321-2), è un altro ele-mento linguistico toscano occidentale (probabilmente il testo nell’antigrafo doveva avere una patina pi-sana, alla quale veramente poco si è sovrapposto di quella senese del copista). 25-6. Cioè, non è vero af-fatto. 31. niuno: sostituito a nimo per ripristinare la rima; la forma nimo (su cui cfr. CASTELLANI 2000, p.316) sarebbe peraltro coerente con la già citata patina toscano occidentale del testo. 33. stagia: ‘perti-che’ (cfr. GDLI s.v. staggio1 e staggia). Siamo in pieno assurdo, dato che vengono quantificati con unamisura di lunghezza gli zoccoli colti su di un pruno; d’altra parte gli stessi paiono poi trasformarsi in ci-polle e successivamente in scalogne. 41. Particolarmente evidente in questo punto del testo come granparte dell’assurdo di esso si fondi su scambi e inversioni che rendono illogico ciò che altrimenti sarebbenormale e persino consueto (non ci sarebbe infatti nulla di strano nel pigliare uno spiedo – inteso comearma – dopo aver saltato un fossato, o viceversa). A questo proposito cfr. anche 39-40 (quando sono lelance ad avere in collo i fanti, anziché il contrario come di solito) e più avanti 59. 47. gli colse: ‘lo colpì’(per gli pronome personale accusativo, cfr. ROHLFS, vol. II, § 462). 54-5. Questa particolare inversione(che parte dal trovarsi nel pian di fonte Branda – locuzione attestata nel corpus TLIO – mentre suonaval’ora terza) ha un interessante parallelo nel sonetto CXXXV del Burchiello, v. 2 «sul pian di terza cheMugnon sonava» (cfr. BURCHIELLO, Sonetti, p. 189 e la n. al passo – p. 190 – dove lo stesso viene chiosa-to come «uno dei consueti scambi»). 56. tragono: quale che sia il movimento che le mura dovrebbero fa-re, è logicamente assurdo che le stesse si muovano per ogni romore. 64-5. Il dialogo qui pare basarsi sulfraintendimento del verbo uccidesti, “interpretato” come ucci (?) complemento oggetto + desti, ‘sei sta-to tu quello che ha dato *** all’uomo?’, a cui l’interlocutore che fraintende risponde ‘sono stato anchequello che glielo ha tolto’. Fusti è forma sia toscano occidentale che senese (cfr. CASTELLANI 2000, pp.332 e 360). 66. ‘Dunque sei stato tu quello che lo ha colpito/ferito!’ (per questo significato di dare, cfr.GDLI. s.v.). 71-3. Il personaggio viene per il precedente fraintendimento sottoposto alla tortura dellacorda; du per ‘due’ parrebbe essere l’ennesima forma toscano occidentale del testo (cfr. CASTELLANI2000, p. 316).
66 MARIA CLOTILDE CAMBONI
94. Ciò non implica una presa di posizione su quale dei due parlasse nella piccola parte di testo che ilcopista non trascrive, quando lascia lo spazio bianco.
Ben venga Lapo!
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laurenziano Conventi soppressi 122,c. 85r
Dialogo scherzoso tra il compratore e il venditore di un cavallo (raffigurato sulmargine destro mentre viene condotto per il morso da un personaggio con berret-to). La numerazione progressiva è stata fatta tenendo conto non della punteggia-tura ma dell’alternarsi dei due interlocutori, per cui le battute del primo sono in-dividuate solo da numeri dispari e quelle del secondo solo da numeri pari94.
Misticcio fece
1 «Ben venga Lapo!» / 2 «O bene o male, noi siamo || pur qui». / 3 «È tuo quelcavallo?» / 4 «Credi che sia || tuo?» / 5 «Vuo’lo vendere?» / 6 «Credi che donare?» /7 «Vuo’ne de||nari?» / 8 «Credi che parole?» / 9 «Che ne vuogli?» / 10 «Io ne voglio || die-ce fiorini d’oro». / 11 «Io te ne vo’ dare nove». / 12 «O nuovi o vecchi, || spendansi egli-no!» / 13 «Che testa à?» / 14 «Di chiatarra». / 15 «Vede?» || 16 «Tanto fusse mio!» /17 «Come è, leale?» / 18 «Non colse mai || denaio di terra». / 19 «Come è di tempo?» /20 «Non si rase mai || barba». / 21 «Che orecchi à?» / 22 «Di porcine». / 23 «Mangia?» /24 «Pure, || s’egli avesse che». / 25 «Che collo à?» / 26 «Di cicogna». / 27 «Che || dossoà?» / 28 «Di cammello». / 29 «Che corpo à?» / 30 «D’apiccare || fiaschi». / 31 «Che codaà?» / 32 «Da tirar carra!» / 33 «Che gambe?» || 34 «Di stanghe». / 35 «Che piedi?» 36 «Dizoppo». / 37 «Che petto?» 38 «Di gratugia». || 39 «Core e’?» / 40 *** 41 «Porta?» / «Pè,trotta?» / 42 «Se ’l || vedessi volare, te ne maraviglieresti». / 43 «Salta?» / 44 «La || forma ela scarpetta […] venga a ma[m]mata || nella fossa!». /
Note. 14. chiatarra: forma di chitarra (cfr. TLIO s.v.). Non è chiaro quale sia la relazione di uno strumentomusicale con la testa di un cavallo: forse la risposta è volutamente assurda (qui e altrove). 16. ‘Magari!’.22. Nel corpus TLIO la forma è attestata solo per l’aggettivo porcino: altro caso di relazione non chiara oassurdità palese. 26. Il ‘collo di cicogna’, attributo in altri contesti positivo, difficilmente può esserlo perun cavallo, che già pare essere mezzo cieco (15-6) e denutrito (23-4). 30. L’espressione appiccare il fiasco aqualcuno vale ‘ingannarlo, frodarlo’ (cfr. GDLI s.v. fiasco, con esempi da Pucci e dal Pataffio); il corpo diquesto cavallo, da immaginare come un vero brocco, è quindi buono solo per ingannare il compratore. 32.tirare il carro può valere ‘fare il lavoro faticoso’ (cfr. GDLI.s.v. tirare); con questo significato o anche insenso proprio, l’espressione difficilmente può essere riferita alla coda di un cavallo. 34. Questa risposta delvenditore potrebbe contenere un doppio senso. Infatti le stanghe possono essere interpretate come termi-ne di paragone per la robustezza delle gambe del cavallo; ma lo stesso termine secondo il GDLI (s.v. stan-ga) in Toscana può figuratamente indicare ‘mancanza di denaro’ e quindi più genericamente ‘penuria, in-digenza’. Le gambe del cavallo, quindi, sarebbero in realtà piuttosto insufficienti. 35-8. Le risposte delvenditore, altrove ambigue o evasive, sono qui nettamente negative. 44. Impossibile recuperare le letterecassate; forse il testo si chiude con un’invettiva del mercante di cavalli, esasperato dalla petulanza del suointerlocutore, in cui sembra essere coinvolta la madre di quest’ultimo (la forma mammata ‘tua madre’ èpresente anche nella novella 165 del Trecentonovelle di Sacchetti: cfr. SACCHETTI, Trecentonovelle, p. 469;per i possessivi enclitici -ma, -ta, in senese tanto diffusi da essere utilizzati anche per il maschile, cfr.CASTELLANI 2000, pp. 358-9).
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 67
Bibliografia
1) Opere collettive, vocabolari, antologie
BilancioniIndice delle carte di Pietro Bilancioni: contributo alla bibliografia delle rime volgari de’ pri-mi tre secoli. Parte prima: rime con nome d’autore, a c. di CARLO e LUDOVICO FRATI, Bolo-gna, tip. Fava e Garagnani 1893.
CLPIOConcordanze della Lingua Poetica Italiana delle Origini, a c. di D’ARCO SILVIO AVALLE,Milano-Napoli, Ricciardi 1992.
DLEVALTER BOGGIONE, GIOVANNI CASALEGNO, Dizionario del lessico erotico, Torino, UTET2004.
EDEnciclopedia dantesca, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da GiovanniTreccani 1970-8, voll. 6.
GDLISALVATORE BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, UTET 1961-2003.
LTQLirici toscani del Quattrocento, a c. di ANTONIO LANZA, Roma, Bulzoni 1973-5, voll. 2.
PDPoeti del Duecento, a c. di GIANFRANCO CONTINI, Milano-Napoli, Ricciardi 1960, voll. 2.
PMTPoesie musicali del Trecento, a c. di GIUSEPPE CORSI, Bologna, Commissione per i testi dilingua 1970.
RdTRimatori del Trecento, a c. di GIUSEPPE CORSI, Torino, UTET 1969.
TLIOTesoro della lingua italiana delle origini, consultabile in rete all’indirizzo www.vocabola-rio.org.
2) Testi
ALANO, PlanctuNikolaus M. Häring, Alan of Lille, «De planctu Naturae», «Studi Medievali», 19 (1978),pp. 797-879.
ArrighettoL’Arrighetto ovvero Trattato contro all’avversità della fortuna, in Il Boezio e l’Arrighetto
68 MARIA CLOTILDE CAMBONI
nelle versioni del Trecento, a c. di SALVATORE BATTAGLIA, Torino, UTET 1929, pp. 211-54.
BECCARI, RimeMAESTRO ANTONIO DA FERRARA (ANTONIO BECCARI), Rime, ed. crit. a c. di LAURA BEL-LUCCI, Bologna, Commissione per i testi di lingua 1967.
BOCCACCIO, FilostratoGIOVANNI BOCCACCIO, Filostrato, a c. di VITTORE BRANCA, in Tutte le opere di GiovanniBoccaccio, Milano, Mondadori 1964, vol. II, pp. 17-228.
BURCHIELLO, SonettiI sonetti del Burchiello, a c. di MICHELANGELO ZACCARELLO, Torino, Einaudi 2004.
CAVALCANTI, RimeGUIDO CAVALCANTI, Rime, con le rime di IACOPO CAVALCANTI, a c. di DOMENICO DE RO-BERTIS, Torino, Einaudi 1986.
CEFFI, Epistoleser FILIPPO CEFFI, Epistole eroiche di Ovidio Nasone volgarizzate, a c. di GIUSEPPE BER-NARDONI, Milano, Bernardoni 1842.
Cronache senesiCronache senesi, a c. di ALESSANDRO LISINI e FABIO IACOMETTI, Bologna, Zanichelli 1939.
DANTE, RimeDANTE ALIGHIERI, Rime, a c. di DOMENICO DE ROBERTIS, Firenze, Le Lettere 2002.
DANTE, Vita NuovaDANTE ALIGHIERI, Vita Nuova, a c. di DOMENICO DE ROBERTIS, in ID., Opere minori, a c.di DOMENICO DE ROBERTIS e GIANFRANCO CONTINI, Milano-Napoli, Ricciardi 1984.
DE’ ROSSI, CanzoniereFURIO BRUGNOLO, Il Canzoniere di Nicolò de’ Rossi. I. Introduzione, testo e glossario, Pa-dova, Editrice Antenore 1974 («Medioevo e Umanesimo», 16).
FRESCOBALDI, RimeMATTEO FRESCOBALDI, Rime, a c. di GIUSEPPE RENZO AMBROGIO, Firenze, Le Lettere1996.
GUITTONE, Lettere 1923Le lettere di GUITTONE D’AREZZO a c. di FRANCESCO MERIANO, Bologna, succ. Romagno-li 1923.
GUITTONE, Lettere 1990GUITTONE D’AREZZO, Lettere, a c. di CLAUDE MARGUERON, Bologna, Commissione per itesti di lingua 1990.
MONTE, RimeMONTE ANDREA DA FIORENZA, Le Rime, ed. crit. a c. di FRANCESCO FILIPPO MINETTI, Fi-renze, Accademia della Crusca 1979.
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 69
NELLI, SatirePIETRO NELLI, Satire alla carlona, Venezia, Gherardo 1546-7.
PANUCCIO, RimePANUCCIO DEL BAGNO, Le rime di Panuccio del Bagno, a c. di FRANCA BRAMBILLA AGENO,Firenze, presso l’Accademia della Crusca 1977.
PETRARCA, DisperseRime disperse di Francesco Petrarca o a lui attribuite, a c. di ANGELO SOLERTI, Firenze, Fi-renze, Sansoni 1909.
PUCCI, CentiloquioANTONIO PUCCI, Il Centiloquio, in Delle poesie di Antonio Pucci, voll. I-IV, a c. diILDEFONSO DI SAN LUIGI, in Delizie degli eruditi toscani, tt. III-VI, Firenze, Cambiagi1772-5.
QUIRINI, RimeGIOVANNI QUIRINI, Rime, a c. di ELENA MARIA DUSO, Padova, Antenore 2000.
SACCHETTI, Rime 1948GIANNOZZO SACCHETTI, Le rime edite ed inedite, a c. di ORETTA SACCHETTI, Roma, Gi-smondi 1948.
SACCHETTI, Rime 2005GIANNOZZO SACCHETTI, Rime, a c. di TIZIANA ARVIGO, Bologna, Commissione per i testidi lingua 2005.
SACCHETTI, TrecentonovelleFRANCO SACCHETTI, Il Trecentonovelle, a c. di DAVIDE PUCCINI, Torino, UTET 2004.
SAVIOZZO, RimeSIMONE SERDINI DA SIENA (SAVIOZZO), Rime, ed. crit. a c. di EMILIO PASQUINI, Bologna,Commissione per i testi di lingua 1965.
Statuti PisaStatuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, a c. di FRANCESCO BONAINI, Firen-ze, Vieusseux 1857.
Statuto Mercanzia seneseLo statuto dell’Arte della Mercanzia senese del 1343, a c. di QUINTO SENIGAGLIA, «Bullet-tino Senese di Storia Patria», XIV (1907), pp. 211-271; XV (1908), pp. 99-139, 141-86;XVI (1909), pp. 187-290.
TINUCCI, RimeNICCOLÒ TINUCCI, Rime, ed. crit. a c. di CLEMENTE MAZZOTTA, Bologna, Commissioneper i testi di lingua 1974.
TORINI, RimeAGNOLO TORINI, Rime, in Vita e opere di Agnolo Torini, a c. di IRENE HIJMANS-TROMP,Leiden, Universitaire Pers 1957, pp. 349-93.
Tristano VenetoIl libro di messer Tristano («Tristano Veneto»), a c. di AULO DONADELLO, Padova, Marsi-lio 1994.
70 MARIA CLOTILDE CAMBONI
3) Studi
AGENO 1964FRANCA BRAMBILLA AGENO, Il verbo nell’italiano antico, Milano-Napoli, Ricciardi 1964.
AGENO 1990FRANCO SACCHETTI, Il Libro delle Rime, a c. di FRANCA BRAMBILLA AGENO, Firenze -Perth, Olschki - Univ. of Western Australia 1990.
BALDUINO 1984ARMANDO BALDUINO, Cino da Pistoia, Boccaccio e i poeti minori del Trecento, in ID., Boc-caccio, Petrarca e altri poeti del Trecento, Firenze, Olschki 1984, pp. 141-206.
BARBI 1915MICHELE BARBI, Studi sul canzoniere di Dante, con nuove indagini sulle raccolte mano-scritte e a stampa di antiche rime italiane, Firenze, Sansoni 1915.
BARBIERI 2002ALVARO BARBIERI, recensione a GIUNTA 2002a, «Stilistica e metrica italiana» 2 (2002), pp.296-300.
BARTOLI 1863I viaggi di Marco Polo secondo la lezione del codice Magliabechiano più antico, reintegratocol testo francese a stampa per cura di ADOLFO BARTOLI, Firenze, Le Monnier 1863.
BELTRAMI 1991PIETRO BELTRAMI, La metrica italiana, Bologna, Il Mulino 1991.
BERISSO 1999MARCO BERISSO, Che cos’è e come si dovrebbe pubblicare una frottola?, «Studi di filologiaitaliana», LVII (1999), pp. 203-33.
BIFFI 1998MARCO BIFFI, Osservazioni sulla lingua di Francesco di Giorgio Martini: la traduzione au-tografa di Vitruvio, «Studi di grammatica italiana», XVII (1998), pp. 37-116.
CAMBONI 2004MARIA CLOTILDE CAMBONI, Un manoscritto miscellaneo di rime e prose volgari: Firenze,Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 122, scuola di dottorato in Studi Ita-lianistici dell’Università degli Studi di Pisa, anno 2001, 2004.
CASINI 1884TOMMASO CASINI, Sopra alcuni manoscritti di rime del sec. XIII, «Giornale storico dellaletteratura italiana», III (1884), pp. 161-91.
CASTELLANI 2000ARRIGO CASTELLANI, Grammatica storica della lingua italiana. I. Introduzione, Bologna, IlMulino 2000.
CRESCIMBENI 1730GIOVANNI MARIO CRESCIMBENI, De’ Comentarj intorno all’Istoria della Volgar Poesia, Ve-nezia, Baseggio 1730 (6 voll.).
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 71
DE ANGELIS 1824LUIGI DE ANGELIS, Biografia degli scrittori sanesi, Siena, Stamperia Comunitativa pressoGiovanni Rossi 1824
FLAMINI 1891FRANCESCO FLAMINI, La lirica toscana del rinascimento anteriore ai tempi di Lorenzo ilMagnifico, Pisa, Nistri 1891.
GEYMONAT 2000«Questioni filosofiche» in volgare mediano dei primi del Trecento, a c. di FRANCESCA GEY-MONAT, Pisa, Scuola Normale Superiore 2000.
GIUNTA 1999CLAUDIO GIUNTA, Chi era il fi’ Aldobrandino, «Nuova rivista di letteratura italiana», II(1999), 1, pp. 27-151
GIUNTA 2002aCLAUDIO GIUNTA, Sul ‘mottetto’ di Guido Cavalcanti, «Studi di filologia italiana», LVIII(2002), pp. 5-28.
GIUNTA 2002bCLAUDIO GIUNTA, Versi a un destinatario. Saggio sulla poesia italiana del Medioevo, Bolo-gna, Il Mulino 2002.
GIUNTA 2004CLAUDIO GIUNTA, Sul rapporto fra prosa e poesia nel Medio Evo e sulla frottola, in Storiadella lingua e filologia per Alfredo Stussi nel suo sessantacinquesimo compleanno, a c. diMICHELANGELO ZACCARELLO e LORENZO TOMASIN, Firenze, Edizioni del Galluzzo per laFondazione Ezio Franceschini 2004, pp. 35-72.
LARSON 2000PÄR LARSON, A ciascun’alma presa, vv. 1-4, «Studi mediolatini e volgari» XLVI (2000),pp. 85-119.
MANETTI 1994FRANCESCO DI VANNOZZO, Rime, ed. crit. a c. di ROBERTA MANETTI, tesi di dottorato inFilologia romanza ed italiana [retorica e poetica romanza ed italiana], VI ciclo, 1994.
MANETTI 2000ROBERTA MANETTI, Rime di Antonio da Ferrara (Antonio Beccari), edite per il corpus te-stuale del Tesoro della Lingua Italiana delle origini, «Bollettino dell’Opera del Vocabola-rio Italiano», V (2000), pp. 251-356.
MANNI 1979PAOLA MANNI, Ricerche sui tratti fonetici e morfologici del fiorentino quattrocentesco,«Studi di grammatica italiana», VIII (1979), pp. 115-71.
PAGNOTTA 1995LINDA PAGNOTTA, Repertorio metrico della ballata italiana – Secoli XIII e XIV, Milano-Napoli, Ricciardi 1995.
PANCHERI 1993ALESSANDRO PANCHERI, «Col suon chioccio». Per una frottola ‘dispersa’ attribuibile a Fran-cesco Petrarca, Padova, Antenore 1993.
72 MARIA CLOTILDE CAMBONI
PASQUINI 1995EMILIO PASQUINI, Intersezioni fra prosa e poesia nelle Lettere di Guittone, in Guittoned’Arezzo nel settimo centenario della morte, Firenze, Franco Cesati Editore 1995.
PELOSI 1990ANDREA PELOSI, La canzone italiana del Trecento, «Metrica», V (1990), pp. 3-162.
ROHLFSGERHARD ROHLFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, Ei-naudi vol. I (Fonetica) 1966; vol. II (Morfologia) 1968; vol. III (Sintassi e formazione delleparole) 1969.
STUSSI 2002ALFREDO STUSSI, Una frottola tra carte d’archivio padovane del trecento, in Antichi testi ve-neti, a c. di ANTONIO DANIELE, Padova, Esedra 2002, pp. 41-61.
ZAMBRINI 1824FRANCESCO ZAMBRINI, Cenni biografici intorno ai letterati illustri italiani, Faenza, Monta-nari e Maraghini 1837.
LE RIME DI ANTONIO DI CECCO DA SIENA 73
Finito di stampare nel mese di settembre 2007in Pisa dalleEDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]