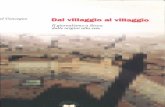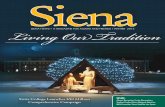L'acqua a Siena nel Medioevo
Transcript of L'acqua a Siena nel Medioevo
Duccio Balestracci
L'acqua a Siena nel Medioevo
Estratto dalvolume
Ars et Ratio
Dalla torre di Babele al ponte di Rialto
Sellerio editore
Palermo 1990
L'acqua a Siena nel Medioevoeli Duccio Baiestracci
Situata su una collina di 320 metri suI Iivello del mare, Sienasorge in mezzo ad un territorio fra i meno ricchi di acque della Toscana. Praticamente, nessun corso d'acqua consistente scorre nellesue vicinanze; solo torrenti 0 corsi rninori.
II problema dell'approvvigionamento dell'acqua si pone in maniera relativa nei secoli dell'alto medioevo perche Ie necessita delcastrum arroccato suI colle di San Quirico possono essere soddisfattedalle fonti che, ai suoi piedi, raccolgono Ie acque di stillicidio.
Probabilmente, inoltre, in epoca altomedievale esiste anche unacquedotto romano, gia rovinato nel IV secolo, forse pero ancorasufIiciente aIle ridotte dimensioni dell'insediarnento.'
II problema, al contrario, comincia a [arsi pressante con Ia rinascita della citra, con un'aumentata richiesta di acqua per I'accresciuta popolazione ed anche per Ie richieste della nascente produzione manufatturiera.i
I F. Bargagli Petrucci" Le [onti di Siena e i loro acquedotti, Siena-Firenze-Roma1903, voll. 2, rist. an. Siena 1974, I, pp. 18-to. II Bargagli Petrucci (da ora citatosemplicernente come BP) redasse all'inizio del secolo una monumentale opera sulleacque a Siena. Se Ia parte monografica - eontenuta nel primo dei 'due volumi - enncora di una qualche utilita, decisamente preziosa e, invece, la parte doeumentariache costituisce iI secondo volume. II Bargagli Petrucci, infatti, raccolse una massadocurnentaria relativa a questo argomento assolutamente eccezionale; si puo affermare che, praticamente, quasi nessun documento pubblico di una qualche rilevanza,relative aile acque ed aile fonti (eompreso fra it 1081 e it 1555, anna della cadutadella repubblica scnese considerate dall'Autore, come nella rnaggior parte delle storieloeali, punto di termine della ricerca su Siena) sfuggl alia ricerca di questo studioso,La stesso autore pero uso solo parte di questa eccezionale raccolta di documenti percornpilare la parte monografica dedicata aile sinp,ole fonti cittadine dedicando, peraltro,solo un veloce capitolo del suo libro aile vicende dei bottini.
2 Sullo sviluppo di Siena si ricorderanno solo alcuni fra i principali studi. Sivedano, dunque, Ie considerazioni di V. Lusini, Note storiche sulla topografia di Sienadel secolo XIII, «Bullettino senese di storia patria », XXVIII (1921), pp. 239-341;P. Nardi, I borgbi di Sail Donato e di San Pietro a Ovile. «Popali s, Con/rode ecompagnie d'armi nella societe senese dei secoli XI-XIII, «Bullettino senese di storiapatria », LXXIII-LXXV (1966-1968), pp. 7-59; L. Bortolotti, Siena, Roma-Bari 1983.
19
Se e degna di fede la cronaca del Bisdomini (del tardo Trecento)la ricerca della ormai famosa vena della Diana (ampiamente irrisa,come si sa, dall'Alighieri) 3 e gia in corso in pieno XII secolo." Chela datazione del Bisdornini sia 0 no fededegna, e comunque un fattosintomatico che la ricerca del mitico fiume venga cronologicamentecollocata proprio nel momenta dello sviluppo urbano di Siena.
Ma, naturalrnente, il comune senese non si limita a progetti coslestrosi: un programma di scavi per incrementare la portata di acquadelle fonti, infatti, egia in atto all'inizio del Duecento,a meta di questo secolo si stanno scavando 0 si sono gia scavati i condotti per Iefonti di Follonica, Val di Montone, Pescaia, Fontebecci, Sella Vetrice." Si tratta, pero, ancora di interventi parziali, limitati ad accrescere .la portata delle singole fonti volta per volta: manca ancora un progetto complessivo che risolva i1 problema alia radice, e manca,inoltre, un grade di competenza tecnica che permetta di approvigionare la citta dentro Ie mura. Tutte Ie fonti, per tutto il Duecento,sono infatti fonti extraurbane a quote piii basse rispetto all'abitatodella citra.
Eppure, anche se non riesce a risolvere ancora it problema dell'approvvigionamento idrico, i1 comune, in questo secolo, incomincia ad intervenire con decisione sulle acque del suo territorio. Nelpiano fra il Merse e i1 Rosia, con I'affermarsi del potere di Siena suIfeudo Ardenghesco, tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo,it comune costruisce una serie di muIini, talvolta appoggiandosiad istituzioni locali, come accade a meta del Duecento quando comune senese ed abbazia vallombrosana di Torri sono comproprietaridi 12 muIini sui Merse," Nasce, insomma, in questo periodo, quellache sara una zona chiave per la macinatura del grano, prima, e zonadi vero e proprio sviluppo «industriale », dopo, quando la forzaidraulica del mulini verra utilizzata - tra la fine del Duecento e i1prirno Trecento - dall'arte della lana cittadina per gli impianti dellegaalcbiere. E incomincia a nascere, contemporaneamente, quel si-
3 Purgatorio, XIII, 151-53.4 Archivio di Stato di Siena (dn ora ASS), Ms. D 36, Crouicbe di Giouanni Bisdo
mini copiate nelli, mesl di Maggio a Giugno 1719 dal Malta Reuerendo Signore Tommaso Mocel1lli, cc. 39-41.
5 DP, II, p. 34. In un documento della Biccberna del 1226 si trova quella ehee forse la prima testirnonianza del terrnine bottino, con il Quale i senesi dcsignavanoil loro acquedotto (ibidem).
6 SuJla comproprieta tra cornune e abbaxia dei muJini suI Merse si veda D.Balestracci, Approouigionamento e distribuiione dei prodotti alimentarl a Siena inepoca comunale. Mulini, mercatl e bottcgbe, «Archeologia medievale. Culturamateriale, insediamentl, territorio », VIII (1981), pp, 137-38.
20
sterna di canalizzazione del piano del Merse, intuibile attraverso latoponomastica gia nel primo Trecento,?
Contemporaneamente, inoltre, it comune interviene sulla regirnazione delle acque nel padule di Orgia, dove nella prima meta delDuecento si costituisce, ancora una volta a danno del feudo ardenghesco, uno dei principali demani della citta, concesso in uso gia nel1240 ad una societa di privati che si inca rica di gestirne it terreno eIe acque," Ed intervienc anche nella Selva del Lago (a nord di Siena,sotto Monteriggioni) dove a meta del Duecento comune di Siena e monastero di Abbazia ad Isola controllano (talvolta anche in modoconflittuale) I'uso del bosco e del lago, soprattutto per quanto riguarda la pesca.?
Non e solo it comune,naturalmente, ad intervenire in questostesso periodo sulle acque del territorio senese: gl] interventi daparte di feudatari 0 di cornunita rurali ci sfuggono completamente.!"ma di quelli di alcune signorie ecclesiastiche abbiamo piu di unaprova. Gia si e accennato agli interventi dell'abbazia di Toni e delmonastero di Abbazia ad Isola; varra la pena ricordare quello che eforse I'esempio piir interessante di intervento sulle acque da parte diuna istituzione ecclesiastica: it piano di canalizzazione cistercensedel Pian di Feccia 11 evidenziato da un gruppo di ricercatori inglesi 12
7 Attestato neUa sua forma cornpiuta dalla cartografia del tnrdo Seicento (ibidem,p. 145).
8 La Societa del Padule si incarica di tenere in funzione i fossati, di controllarue I'arginatura, di mantenere costante iI f1usso delle acque attraverso UM catnrattain muratura, di controllare che non vengano irnpiantnte colture a meno di circa 50metri dai fossati maestri (Statuto della societe del PiaI/O del Padule d'Orgia. 13031376, in Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIlI e XIV, a eura di L. Banchi,II, Bologna 1871, pp. 78-79 85-86, 89, 97, 101, 103, 111).
9 Il Constitute del Comune di Siena dell'anno 1262, ed. L. Zdekauer, pp. 364-69.10 Si puo intuire un uso (rna testimoniato ecccssivamente tardi: /ine '300)
da parte delle cornunita rurali, Ad esempio, la comunita di Monteriggioni si preoccupn della salvaguardia delle acque pubbliche (Statuti del Comune e buomini diAlol/te Riggioni (1380), in Statuti del comunl di Monastero S. Eugenio (1352),MO/l/eriRgioni (1380) e Sovicille (1383), ed. G. Prunai, Firenze 1961, pp. 83-84) equella di Sovicille, addirlttura, si fa carico di acque di privati eventualmente abbandonate (ibidem, PP. 200-01). Non si sa, pero, ancora cosa accada nel XII 0 nelprimo XIII secolo, cosl come si ignora del tutto se l'uso delle acque fosse nffidatosolo a qualche sporadica norma statutaria, 0 solo alia tradizionc, oppurc sc esisrcsscqualche regolamentazione suI tipo del Libro del Agua della Murcia Ira iI Tre c Quattrocento, un vero e proprio codice rurale che disciplinava 10 sfruttumento di questarisorsa, e del quale parlava F. Chacon Jimenez nella sua relazione - ancora inedita alla XV settimana di studio organizzata nel 1983 dall'istituto internazionale di storiaeconomica « Francesco Datini », a Prato su « Le acque Interne - secc. XII-XVIII ».
II II Feccia ~ un immissario del Merse e scorre a nord dell'ahbazla di San Galgano.12 I dati sono emersi nel corso del « Progetto Montarrenti », lin programma di
lavoro degli insegnamenti di archeologia medievale delle Unlversita di Siena e diSheffield coordinate da Riccardo Francovich e Richard Hodges. II progetto, cheprevede oltre agli scavi intorno al castcllo di Montarrenti ed allo studio delle strut-
21
i quali hanno potuto non soItanto rinvenire Ie' tracce rna anehe ipotizzare la struttura ill quelIe ehe sono state identificate'! come pesehiere medievali.
Puo darsi ehe questa intensilicazione di attivita sulIe acque delSenese sia solo da ascriversi a fattori contingenti (espansione delladtta a spese della feudalita; affermazione di signorie ecclesiastlcheparticoIarmente sensibili verso questo problema... ) ma puo darsianehe ehe risenta - almeno in forma indiretta, mediata - di ungenerale clima di « attacco _alI'aequa » ehe caratterizza in questo stessoperiodo gran parte dell'Europa con aspetti e dimensioni mai piuviste dopo il periodo romano: Basrera ricordare, ad esempio, do eheavviene intorno aile aeque in moIte citta delIa Francia Era XI e XIIseeoIo 14 0, per restare a situazioni piu vicine ed aflini, a quantofanno i eomuni di Prato e di Pistoia neI XIII secolo con Ie opere,rispettivarnente, di canalizzazione della Val di Bisenzio 15 e. di eanalizzazione e regimazione delle aeque nella pianura impaludata." E traIaseio deliberatamente di parlare di quanto avviene in Fiandra, datoehe l'argomento esula dalla mia comperenza.'?
In questa clima dunque Ia citra, a meta Duecento, si accingea dare una risposta aile sempre piu imperiose esigenze di acqua avan-.zate sia dalla aumentata popoIazione, sia dalla necessita di non perdere in competitivits con Ie aItre eitta nella produzione, soprattutto, del tessile e dei pellami.
ture del castello stesso anche un'ampia ricognizione topografica suI territorlo circostante, ha pcrrnesso ad un gruppo di ricercatori di Sheffield (D. D. Gilbertson, C.O. Hunt, D. Briggs, C. M. Mills, G. M. Coles, N. M. Thew) di evidenziare i restidelle peschicre medievali. Ringrazio I'amico Riccardo Francovich per avcrmi permesso di accedere alia documentazione ed alia relazione (ancora inedita) su questoargornento.
IJ I ricercatori suflragano la loro tesi basandosi su analoghe situazioni descrittenel snggio di C. Salisbury, The Trent. The Story 0/ a River, «Cuttent Archreology»,n. 74, 1980, pp. 88-91.
14 Si veda, ad esernpio l'utilizzazione di strutture gallo-romane per la canalizzazione di Beauvais, Nirnes e Noyon nell'XI secolo e Ia canalizzazione di Troycs nellaseconda met~ del XII secolo (A. Guillerme, Les temps de l'eau. La cite, l'ea« et lestechniques, Seyssel 1983, pp. 71-72, 75-76).
IS Per l'intervento del comune di Prato sulla Valle del Bisenzio si veda R.Fantnpple, Nascita d'una terra di nome Prato. Secoli VI-XII, in M.VV., Storiadi Prato, I, Fino al secolo XIV, Prato 1981, pp. 235-55.
16 N. Rauty, Sistemazioni fluviali e bonifica della pianura pistoiese durante l'etacomunale, « Bolleuino storico pistoiese », LXIX (1967), in particolare aile pp. 7,16, 20, 21, 24.
17 E che, pure, devette colpire in rnaniera notcvole la fantasia dei conternporaneise Dante faceva riferlmento ai « Fiamminr,hi fra Guzzante e Bruggia » i quali «temcndo iI. fiott~ che 'nver lo~ s'~vventa / fnnno 10 scherrno pcrche 'I mar si fuggia »ese, pol, aggtungeva a 010 di paragone «E quale i padovan lungo Ia Brenta, /per difender lor ville e lor castelli, / anzi che Chiarentana iI caldo senta » (Inferno,XV, 4-9).
22
Eppure, it modo in cui a Siena si cerca di risolvere it problema eancora «scolastico »: il 13 gennaio del 1268, infatti, u Consiglio'Generalc del comune senese delibera su un progetto probabilmente caldeggiato da Provenzan Salvani, figura di spicco delI' elite ghibelIina alpotere in citra, e decide di tentare I'adduzione dell'acqua del lontanofiume Merse. Un progetto decisarnente irrealizzabile per I'epoca, datal'eccessiva distanza fra iI fiume e la citta; data la particolare conformazione orografica che non perrnette pendenze tali da dare suflicientevelocita di scorrirnento all'acqua; e date, infine, Ie limitate conoscenze idrauliche dell'epoca che non avrebbero permesso di superareIe depressioni che interrompono la continuita delle colIine fra ilflume e Siena." Se ha ragione Portoghesi quando scrive che «Lacultura meccanica rnedievale e in gran parte una cultura da ricettarioin cui i problemi sono risolti prima ancora di essere realmente impostati, in cui esistono Ie .prernesse virtuali per raggiungere irnportanti progressi rna non esiste la coscienza rnetodologica che Ii ~en
derebbe possibili »,19 allora si dovra riconoscere che il progetto delMerse e una riprova di questo tipo di cultura.
La palese infattibilita del progetto 10 condanna ad essere accantonato, probabiImente, prima ancora di iniziarlo.
II problema - ancora insoluto - dell'acqua viene ripreso, pero,quaIche decennio piu tardio E questa volta con una impostazionemetodologica forse un po' diversa rispetto al passato. A Siena, inquesta periodo, sono cambiate molte cose: la sconfitta dei ghibellini ha mandato al potere un'elite di stretta osservanza guelfa,composta pressoche esclusivamente da banchieri e grandi mercanti.PI Nove (cosl si chiama l'oligarchia al governo del comune) per laloro stessa estrazione sociale sono particolarrnenre attenti e sensibiIialle esigenze della produzione e, inoltre, dimostrano di possedereun concetto di citra, un progetto urbane, quale nessuno prima diloro (e, vorrei dire, anche dopo 'di loro) aveva dimostrato di possedere. Un sistema viario razionalizzato; una utilizzazione attenta degIispazi pubblici; un concetto chiaro delle funzioni di certi edifici(palazzi pubblici, chiese ...); 21 l'idea di citra, in sintesi, espressa negIi
18 Si veda a tal proposito una relazione tecnica sui progctto duecentesco redatraall'inizio del Noveeento (e pubblicata in BP. I. pp, 35-36) la quale dimostra arnpiamente l'impraticabilita del progetto, stanti Ie conosccnze teeniehe dell'epoea.
19 P. Portoghesi, Injamia delle maccbine. l ntrodutione alla tecnica curiosa,Roma-Bari 1981, p. 13.
20 SuI governo dei Nove si veda la sintesi di W. M. Bowsky, U» comune italianonel Medioevo. Siena JOlla it regime dei Noue 1287-1355, cd. it., Bologna 1986.
21 SuIla progettualita urbanistica dei Nove si veda D. Balestrncci - G. Pieeinni,Siena nel Trecento. Assetto urbnno e strutture edilizie, Fircnze 1977 e, pili recentemente, D. Balestracci, From Development t~ Crisis. Changing Urban Structures
23
alIreschi del Buongouerno del Lorcnzctti.F E un'idea forse pill razionale che in passato del ruolo dell'acqua nella citra.
Una maggiore razionalita, viene cla pensare, non nata dal nullarna probabilmente (i [orse e i probabilmente sono obbligatori in casicome questi) maturata magari attraverso una nuova impostazione delrapporto stesso fra Homo e natura « al di Iuori degli scherni allegoricie teologizzanti che avevano presieduto per secoli all'elaborazione delleenciclopedie, degl] erbari, dei lapidari e dei bestiari medievali »,23
Senza voler Iorzare pitl di tanto questo milieu culturale; senzavoler accentuare al di la della logica la possibile circolazione delleidee (e la lora difIusione) in un'epoca come questa." purtuttavia nonsl potra fare a mcno di constatare che nella Siena di fine Duecento
ill Siena bettocen tbe Tbirtecntb and Fifteenth Centuries, in corso di stamps pergli alli del «22nd International Congress on Medieval Studies », Kalamazoo," Michigan, 7-10 maggie 1987.
22 Si vedano, a questo proposito, Ie considerazioni di C. Frugoni, Una lantanacitta. Sentimcnti e immagini nel Mcdioem, Torino 1983, in particolare aile po, 136-210.
2l C. Vasoli, Scienza e tecnica neli'Occidente cristiano, in AA.VV., Nuoue questioni di storia mcdieuale, Milano 1976, p. 548. Scnza voler forzare 0 enfatizzareil ruolo chc determinati pensatori possono aver avuto sulla loro epoca, non si potri\fare n meno di ricordare I'importnnza di lin Teodorico di Chartres (morto a metadel XII secolo) can la sua spiegazione della natura attraverso considerazioni matemntiche, a quella del conternporanco Guglielmo di Conches can iI suo ricorso adaritrnetica e geometrin per conoscerc positivamente la realla.
Call Ruggero Bacone - si ricordcra - siamo di fronte alh valorizzazione deldominio umano sulln natura: ad un metoda di ricerca basnto sull'arte dell'esperimenta; alia rivalutazione delle arti meccaniche. Pur tralasciando tutta l'attivila deltraduttori dall'arabo che mettono in contatto I'Occidente con In tradizione filosoficae scicntifica greco-arabn estranea alia impostazione del sapere scolastlco, pur tralasciando tu tto questo non si potra fare a meno di sortolincare come, anche nella medicina si respiri adesso un nuovo c1ima: a Bologna - alia mela del XIII secolo compare iI prirno trattato di anatornia topografica dovuto a Guglielmo da Saliceto,e scmpte a Bologna - tra la fine del '200 e I'inizio del '300 - fa la sua comparsaif trattato di anatornia di Mondino de' Liuzzi fondato, certo, ancora su Galcno,rna che presenta anche una impostnzione innovativa non trnscurabile nella descrizione del rnctodi di clissczionc. Se ~ vcro, poi, come sosticne A. Guillerme iLes tempsde l'eau cit., p. 110) che Ira le classi erncrgcnti della societs cittadina circolano trattati igienici come qucllo ducccntesco di Aldobrandino dn Siena, allorn bisognet:'tieordare che proprio Aldobrandino serive che: « fiska e una scienl;a per la quaIe noi sappiamo la nalura delle cose ch'anno corpo [ ... ]. Et possiamo dire chefisica ha due partite. L'un3 si e teoriea e l'ahra e praliea. Per tcoria possillmonoi conoscere et giudicnte tulte Ie cose cclesliali el terrene per natl/to el ben giudieareet conoscere tutti i comandamenti di fisiea. [ ... ] Ma iI maeslro vuole divisare comeI'uomo if suo corpo dee guatdate in sllnitade per pralicll el lasciare slare la teoria»(De regim;ne corporis, volgnri7.7.amento fiorentino del XIV secolo, cil. in A. Garosi,Aldobrolldi/lo d(/ S;ef/a mcdico ill Frallcia /lei sec% XIII /le/la storia e /le/ costumedell'igief/e med;elJ(/li, Bergmllo 1981, p. 417).
24 Come pure qualche storieo ~ stato tentalo di fare. Si vedllno, ad esempio,certe alfermazioni forse un po' accentu31e di G. H. Allard, Les arts mecoltiqtlesoux YCtiX de ['ideolo!!.;e medielJolc, in tcs orts mecQlliques ou Moyell Age, MontrealParis 1982, p. 29 a proposito della scief/tia experil11ef/tolis baconiana, da non risehiaredi confondere con In «scienza sperimenlale» basala (come ad esempio precisa senza
24
e rntzro Trecento, it problema viene aflrontato in una maniera deltutto nuova rispetto al passato.
II governo dei Nove, infatti, afftda ai suoi esperti l'incarico eli elaborare un progetto radieale, che presupponga soIuzioni complessiveal problema dando un taglio netto a tutta Ia politica precedentetesa a costruire bottini di piccolo tratto, destinati a raccogliere glistilIieidi Iocali. Adesso la direzione verso Ia quale ci si rivolge e itnord, pili ricco di falde sotterranee, dove si conta di andare a «catturare » acqua bastante ad alimentare non pili fonti periferiehe esottoquota, rna bensl la stessa fonte di Piazza del Campo, nel centrodeIla citra.
Inoltre, questa volta nonsembra esserci posta per progetti fantasiosi 0 utopistici: l'incarico che nel 1334 viene afftdato a Iacopo diVanni di Ugolino prevedc ora precise soluzioni tecniche in merito a dimensioni (altitudine trium brachiorum et latitudine uniusbrachii et dimidi), tipo di rivestimento (suffidenter muraturn infundo et ex utroque latere... cohopertum cohopertura ad siccum),tempi di realizzazione (ad tres annos proxime venturos), costi (propretio sex milium florenorum de auro).25
II fatto che it progettista non ce Ia facda a tener fede ai suoiimpegni e che nel 1337 sia costretto a chiedere it rifinanziarnento dell'opera non significa nuIla: it progetto non viene abbandonato, enegli anni Quaranta del Trecento prendono it via Ie opere pili consistenti 26 con Ie stesse caratteristiche tecniche gia individuate nelcontratto del 1334 e con innovazioni notevoli rispetto alla tecnicadi escavazione dei condotti duecenteschi. In questi ultimi, infatti,10 scavo parte dalla fonte per rimontare con salita costante, tenendosi(come, ad esempio avviene per it condotto di Fontebranda) Era duestrati geologici: uno di sabbia gialla che Iunziona da Iiltro per l'acquapiovana, e quello sottostante di argilla compatta ed impermeabiteche funziona da coIlettore per l'acqua piovana stessa, Un'opera delgenere e ideale per raccogliere un buon numero di filtrazloni rna eanche estremamente lenta, dato che nella stretta galleria puo lavorare solo un uorno alIa volta. Nel condotto trecentesco, 01 con-
possibilits di equivoci F. Alessio, Introduzione a Ruggero Bacone, Roma-Bari 1985.pp. 103 sgg.) su riproducibilira e verifica di Iaboratorio, e tutta seicentesca.
25 BP, II, p. 191.26 Opere che, peraltro, incontrano la sorda resistenza dei contadini i cui campi
sono attraversati dallo scavo del bottino, NcI 1348, ad esempio, ci si lamentn perche« laboreria [ ...J persepe impedimenta recipiant dapnosa [ ...J per laboratores possessionibus in quibus sunt spiracula buctinorum [ ...] volventes sulcos et foveas superipsis spiraculis et [ ...J per pueros et iuvenes precipue incitatos aliquando levitateac aliquando inductione quorundam quibus prosecutio laboreriorum dictorum nODplacet» (BP, II, p. 222).
25
trario, 10 scavo parte da due punti opposti e tende a ricongiungersi,approssimativamente, a meta del percorso permettendo l'impiego diuna manodopera raddoppiara.
Non sembra cambiare, invece, 10 strurnentario: gli stessi strumenti adoperati nel Duecento vengono utilizzati anche due secoIidopo. Un inventario del 1246 ricorda palette, zapponi, picconi; quelIi del Quattrocento, a loro volta, enumerano zappe, palette, rnarre,picconi a una e due punte per it tufo, mazzapicchi per le pietre,asce per spianare le spalletre, scalpelll." La pendenza del terreno econtrollata unicamente con I'archipendolo (un filo a piombo sostenuto 'da due pali a focelIa) e l'areazione delle gallerie e ottenuta attraverso gli smiragli (aperture nel terreno che servono anche a controllare la direzione del cunicolo ed a estrarre il materiale escavato).
II nuovo bottino viene rivestito in laterizio, un materiale che, pero, non e una novita nel Trecento dato che gia nei bottini duecenteschi 28 se ne riscontra l'uso anche se non in modo cosl massiccio. Rena,calee e caleestruzzo rappresentano i principali materiali di muratura; idocci di terracotta vengono utilizzati, infine, per Ie canalizzazioni dell'acqua all'interno del cunicolo. Forse un intervento degli archeologisulle parti murate dei quasi 25 km. di bottino (ancora esistenti)ci potrebbe dire qualcosa di piii, magari suI tipo di caIce usata (si usavano calci idrauliche come quell a elaborata da Villardde Honnecourt.P per I'intonaco di una cisterna? quanto e estesoI'uso della « caleina balzana» considerata Ia pio resistente?) oppureper capire se it rivestimento del bottino doveva impermeabiIizzarIodel tutto rispetto alle infiltrazioni IateraIi 0 se, al contrario, dovevaIasciare Ia possibilita di raccogliere anche questo tipo di acqua.
Quando I'acqua delle canalette arrivava alle fonti, infine, uscivaattraverso tubature di piombo.P
Un problema che si era presentato fin dal Duecento - quello delIa depurazione delle acque - era stato risolto attraverso Ia costruzione di vasche di decantazione destinate a far depositare il calcaree Ie impurita. Notizie di vasche del genere sono rintracciabili gia nelTrecento 31 ma e a meta del Quattrocento che it comune senese dota
27 BP, II, pp. 79, 349-50.28 Per Fontebranda, ad esempio, si usa iI rnattone di rivestimento (tra la fine
del '200 e iI primo '300) «ita quod putredo prohici vel micri non possit » (BP.II, p, 29), rna gia alla meta del '200 fra Ie spese di manutenzione di questa fontecompaiono anche molte rnigliaia di rnattoni (ibidem, pp. 77-80).
29 P. Portoghesi, Lnianzia delle maccbine cit., p. 79.30 Si veda invece quanta alfermato da M. Bogucka, nel corso del gia citato con
gresso pratese del 1983, a proposito della Polonia del sediceslmo e diciassettesimo secolodove una tecnologia ancora arretrata faceva uso di lubi di legno collocati a 1-2 metri eliprofondita, e limitava I'uso di ferro 0 piombo solamente agli anelli di congiunzione.
31 BP, II, p. 254.
26
l'acquedotto di un sistema di grandi vasche (i galazzonis sotterranee«accio che l'acqua venga chiara a la fonte del Campo ».32
Le conoscenze tecniche dell'epoca erano sernpre elernentari oppure i senesi del Trecento avevano qualche grado di cornpetenza piusofisticata? Quando, ad esempio, nel 1361 l'opcraio ai bottini ispeziona un tratto appena costruito, inserisce fra le parti gia in operaanche una cornpresa fra due localita separate da una profonda vallata. Una depressione del genere non puo essere superata con rnezzinorrnali: se e vero che questa tratto di acquedotto era stato costruito, i problemi possono essere stati risolti soltanto facendo ricorso ad un sifone." anche se l'ipotesi di un utilizzo cost precocedi tale strurnento puo suscitare qualche perplessita.
In linea generale, si direbbe che i governanti senesi trovano inloco le cornpetenze tecniche per la costruzione degli acquedotti. Suquesto cantiere non parrebbe infatti riscontrarsi quella circolazione ditecnologie « straniere » di cui - pure - questa dtta partedpa. Cornpetenze locali, dunque, rna con la significativa eccezione costituitadalla presenza di rnanodopera specializzata proveniente dalle zonerninerarie della Toscana: Massa Marittirna e Montieri in primo luogo.Operai di Montieri Ria sana presenti nel Duecento ai lavori del bottina di Fonrebranda," rna la lora presenza si intensifies can ]0 scavotrecentesco. Quasi la meta degli 'operai specializzati che lavorano albottino fra il 1340 e iI 1341 infatti provengono dalla piccola dttamineraria e si spostano a Siena portandosi dietro un rnanipolo dirnanovali dalla loro stessa terra. La loro presenza, quasi certamente,e legata aUa necessita di superare con competenza alcuni tratti piudiJIidli dell'escavazione per i quali e indispensabile ricorrere a chiha particolare esperienza del lavoro sottoterra.P rna - come si vede sana competenze «esterne» che riguardano solo i lavori di scavo ernai, si direbbe, i problemi idraulici.
Del resto, e sempre aUe rnaestranze locali che si ricorre pertutti quei lavori che, parallelamente allo scavo di questa ramo dell'acquedotto, sana destinati ad incrernentare la portata di acqua deitracciati di bottino gia in funzione. Gianella seconda meta del Duecento, infatti, il cornune si era posto il problema di aurnentare lapor Lata d! alcune fonti cittadine, in particolare di Fontebranda, in-
~2 DP, II, p. 367. Nel 1466 fu progettata nnchc una vnsca di decantazione insuperficie, che peraltro non fu mal realizzata (ibidem, p. 403).
33 JlP, I. p. 221.34 DP, II, p. 152.35 Sulla presenza dei rninatori rnontierini e rnassetani allo scavo dell'acquedotto
si veda D. Balestracci, « Li lauoranti non cognosciutl ». II salariato in una ciua medieuale (Siena 1340-1344), « Bullettino senese di storia patria l>, LXXXII-LXXXIII(1975-1976), pp, 107, 111.
27
torno alla qua Ie si svoJgevano le pill importanti fasi di lavorazionedella lana e delle pelli. Alla fine del secolo si era addirittura cercatodi addurre nel suo condotto un torrente suburbano tutt'altro chericco di acque.l" Nel 1338 - dietro sollecitazione dei lanaioli - ilcomune si decide a varare un progetto destinato ad aumentare inmaniera consistente la portata di acque di questa parte dell'acquedottoe, studia it modo di allacciare al condotto gia esistente una vena anord di Siena (quella dell'Acquacalda),37 con risultati alquanto modesti, si direbbe, dato che una cinquantina di anni pill tardi (1389)si progetta di nuovo un allacciamento rna; questa volta, ancora piiia nord con it Mazzafonda immissario dello Sraggia/"
II problema di fondo, in realta, rimane sempre it solito: i corsid'acqua intorno a Siena sono estrernamente modesti ed ogni tentativoe destina to a sortire risultati insoddisfacenti. Avviene qualcosa delgenere, infatti, anche quando si progetta di spingere sempre piu anord il bottino della Fonte del Campo, che alla fine degli anni Quaranta del Trecento earrivato a Fontebecci e che adesso si cerca di collegare con 10 Staggia. I lavori partono negli anni Cinquanta, rna diedanni dopo gia ristagnano; in questo caso, del resto, I'opera si scontracon un'altra difficoIta oggettiva: pochi chilometri a nord di Siena 10Staggia scorre in territorio Iiorentino."
II progetto Staggia, peraltro, e anche I'ultima pagina del progettoglobale per l'acquedotto senese. Dalla fine del Trecento a tutto il Quattrocento, infatti, gli interventi si rarefanno e si limitano a piccoliallacciamenti e soprattutto a lavori di manutenzione per un'operasoggetta a rapido degrado naturale; in certi casi ci si preoccupa dicontrollare che il bottino non divenga una via di accesso impropriaper la citta.40 Ma, appunto, non si va molto oltre questi interventiminimi.
Del resto, con il Rinascimento non si fa alcun passo avanti significativo nell'uso delle acque rispetto al periodo precedente. Forseper una ragione immediatamente percepibile: it crollo demograficoseguito alla peste del 1348 e it crollo della produzione senese
36 BP, II, p, 11.37 BP, II, p. 197.38 BP, I~, p.. 280.39 BP, II, pp. 243, 250-51, 255-56.43 Gia nel primo Quattrocento si murnno tutti gli accessi ahusivi 01 bottlno per im
pedirc furti di ncque 0 inquinamento del condotto. A meta di questo secolo, invece,ci si preoccupa di sbarrare quegli accessi che potrebbero costituire un ingresso clandestino in citta. II bottino viene, infine, completamente bloccato durante l'ultirnaguerra di Siena fra il 1553 e il 1555 (BP, II, pp. 42,57, 381, 414, 502-03). Quantofosse reale il pericolo di ingressi indesiderati in cilta attraverso i cunicoli dell'acquedotto ~ testimoniato anche per epoche recenti (vedi D. Balestracci, I bottinl. Acquedottl medieuali senesi, Siena 1984, p. 31).
28
che caratterizza la vita di questa citra dalla meta del Trecento in poi."Certo e che dei grandi architetti e ingegneri senesi del Rinascimentosolo Francesco di Giorgio Martini si occupa dell'acquedotto in quaIita di sovrintendente, prima fra il 1469 e il 1473, poi nel 1492, conrapporti che durano ancora qualche anno: 42 per il resto, ne jacopo diMariano detto II Taccola, ne Baldassarre Peruzzi, ne ]acopo Cataneo,ne Vannoccio Biringuccio sembrano aver prestato la loro competenzaal problema delle acque 0 aver contribuito ad accrescere illivello diconoscenze tecniche da applicate al problema dei bottini. Indubbiamente, e stridente il contrasto con quanto avviene conternporaneamente nella vicina Firenze dove le soluzioni spregiudicate di un Btunelleschi denotano ormai un modo di rapportarsi con it dorninio dellatecnica tutto nuovo, non pill legato «al lento sviluppo di una tradizione 0 frutto di una sapienza sedimentata ».43 Il deteriorato rapporto fra Siena e Ie sue acque, del resto, ha in questo periodo uneloquente paradigms: intorno al 1450 comineiano nella Maremmasenese i lavori per costruire un bacino artificiale sui fiume Bruna; ilavori vengono completati nel 1480 e appena un anpo dopo (1481) leacque travolgono una diga evidentemente rnalissirno costruita."
Comunque e lecito, a conclusione, porsi una domanda: tuttiquesti lavori - e in particolare quelli del Trecento - furono realmentela soluzione globale (diciarno pure: razionale) che si cercava? Forsesi potrebbe dire che partirono con tutti i presupposti per esserlo,ma che non 10 furono fino in fondo. Molti problerni, senza dubbio,restarono irrisolti: ne eun chiaro indizio la lamentela che, nel1399, silevava nel Consiglio Generale del comune dove si evocava la mancanzadi suffidente acqua perfino per far muovere i mulini suburbani.i"
Eppure, senza dubbio tutta questa attenzione al problema dell'approvvigionamento idrico servl a qualcosa: contribul a cambiare il rapporto fra i cittadini e le Ioro acque. L'allargarnento della cintamuraria aveva gia da tempo incluso nell'abitato alcune fonti origina-
41 SuI crollo demografico di Siena dopo In peste del 1348 si veda W. M. Bowsky,The Impact of the Dlack Death upon Sienese Government and Society, «Soeculum »,XXXIX (1964), pp. 1-34 e, pili recentemcntc, G. Catoni-G. Piccinni, Famiglie eredditi nella Lira senese del 1453, in Strutture [amiliari. epidemic, migrazioni nell'ltalia medieoale, R cura di R. Cornba, G. Piccinni, G. Pinto, Napoli 1984, in particolare aile pp. 293-94. Sulla erisi della produzione senese si faccia riferimento aS. Tortoli, Per la storia della produzione laniera a Siena ncl Trecento e nei primianni del Qtlatlrocento, « Bullettino scnese di storia patria », LXXXII-LXXXIII (19751976), in pnrticolare aile pp. 229-232.
42 BP, II, pp, 421- 433, 478, 482, 514.43 P. Portoghesi, Inlamia delle maccbine cit., p. 1-1.44 G. Cecchini, Maestri luganesi e comascbi a Sirna tiel secolo XV, in AA.VV.,
Arte e artisti dei lagbi lombardi, Como 1959, pp. 139-143.45 « La dll:' al tempo della state acaro di macinato et questo e per caro d'acqua »
(BP, II, p. 294).
29
riarnente extraurbane, rna do po che it bottino ebbe porta to finalmenteJ'acqua in Piazza del Campo si comincio, da parte dei privati citradini, a richiedere con sempre maggiore frequenza la costruzione dinuove fonti, tutte nel cuore stesso della citra.
Nel 1352 si chiede di utilizzare l'acqua che arriva in Piazza delCampo per azionare i mulini del comune nella sottostante Valle diMontone, rna soprattutto in quello stesso anno, si assiste ad unaIunga serie di petizioni da parte' degli abitanti di varie zone dellucitra i quali chiedono Ia costruzione di nuove fonti offrendosi di sostenerne in proprio Ie spese, come se, in definitiva, Ia presenza delI'acqua nel centro urbano avesse dato il via ad un modo tuttoinedito di convivere con essa. Cosl, nell'aprile del 1352 sono gliabitanti di Ovile ad avanzare Ia richiesta; poi nel maggie queIIi diVallerozzi; nel luglio queIIi di Pantaneto; in agosto Ia gente di Camporegio; in ottobre quella di Stalloreggi e del Casato; in dicembregli abitanti di San Martino. Nel 1356 e Ia volta della popolazionedi Abbazia Nuova, di Salicotto, di San Salvatore, e nel 1360 chiudonola lista delle richieste queIIi di San Vigilio.46
II rapporto fra i senesi e l'acqua, del resto, si evidenzia beneattraverso il ventaglio di motivazioni che, volta per volta, si adduconoper giustificare la richiesta di una nuova fonte. Di una fonte gia esistente si dice, nel primo Trecento, che e utile « precipue occasioneforensium ».47 rna per una da costruire vicino alle carceri negli stessianni in cui si scava il bottino si parla di « necessitatem quam carceratiComunis Senarum propter defectum aque sepius patiuntur ».48 Lefonti, poi, appaiono come una elementare garanzia contro il pericoIodi incendi: quando nel 1356 gli abitanti di Abbazia Nuova e di SanSalvatore chiedono che sianocostruite due nuove fonti ricordano, rispettivamente, come la «contrata dicte Abbatie, tempore alicuius ignis,sit in rnagno periculo (... ) propter fornaces coppariorum et pignattariorurn et orciolariorum et maxime propter. defectum aque qua caretcontrata predicta », e che «Ie contrade di Salicotto e di Sancto Salvatore (... ) sonno in grande necessita di buena aqua per la vita deIIihuomini e persone d'esse contrade ( ... ) si anco per difecto del fuocho,uquale Idio cessi ».49
NeIJa richiesta di sernpre nuova acqua, del resto, non enemmenoassente un concetto di bellezza (a volte perfino maniacale ed esasperato) che attraversa molti secoli della storia urbanistica dl questacitra: «cum copia fontium et aquarum habundantia decoret pluri-
46 BP, II, pp. 229, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 239, 240, 249.47 BP, II, p. 27.48 BP. II, pp. 189-90.49 BP, II, pp. 239-40.
30
mum civitates» 50 si legge in una raccolta di leggi di fine Duecento inizio Trecento; e quando nel1361 si era completata la costruzione dellafonte del Casato ci si lamentava pubblicamente perche era stata collocata sotto it piano stradale, non si vedeva dalla strada principale e,per attingervi I'acqua, bisognava scendere una lunga scalinata « immoquasi in modum cantine ».51
D'altra parte, ben si esprime questo legarne fra acqua e bcllezzadella citta nelle parole di un cronista senese del Quattrocento cheparla di Fontebranda come della «piu bella e abbondante fonte diToscana » 0 in quelle del Concistoro del Comune che definisce (sempre nel Quattrocento) la stessa fonte « una delle piu belle et fructuosefonti d'Italia ». Anche se nulla eguaglia in potenza evocativa di unmodo di sentire comune a tutta una citta, Ie parole di un anonirnocittadino che nel 1397 rivolgendosi ai suoi governanti ricordava che«tutti e forestieri che ci vengono [a Siena] vogliono vedere Fontebranda ».52
Ma it rapporto fra i senesi e l'acqua non si limita alIa sfera pubblica: i bottini trecenteschi mettono, infatti, I'acqua alIa portatadelle case private, sia perche in certe zone cio e permesso dal comune,53 sia perche, dove non e permesso, i senesi it permesso se 10prendono da soli. Nel 1364 si denunda pubblicamente l'uso di rubare l'acqua pubblica e non e un caso che Michel de Montaigne,di passaggio a Siena nel 1581, fra Ie poche cose che annota dellacitta, ricordi che essa possiede un gran numero di fontane dalle qualila maggior parte dei dttadini deriva abusivamente condutture diacqua per uso privato/"
Presentando un progetto di allacdamento di una vena d'acqua aibottini, i governanti senesi scrivevano nel 1360: «aqua unum exquactuor est elementis sine quibus vivere nullus potest ».55 Un'ovvieta, uno stereotipo, certo. Ma uno stereotipo pieno di significate peruna dUa che aveva devoluto energie non trascurabili net lungo tentativo di domesticazione della sua acqua e - in certa misura almeno di razionalizzazione dell'uso di essa.
50 BP, II, p. 20.SI BP,' II, p. 252.S2 Cronaca senese conoscluta sotto il nome di Paolo di Tommaso Montallri. a
cnra di A. Lisini, F. Iacometti, in Rerum Italicarum Scriptores, t, XV, parte VI,Bologna 1931-1939. p. 185 ASS; Concistoro, 487, 1417, matzo 15, c. 15v; ConsiglioGenerate, 198, 1397, febbraio 2, c. 39.
S3 BP, II, p. 269.S4 BP, II, p. 260. M. De Montaigne. [ournal de Voyage en Italie par la Suisse
ct l'Allemagne en 1580 et 1581, Paris 1955, p. 89.S5 BP, II, p. 250.
31