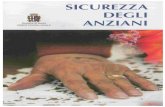L'Acqua e la gestione degli Acquedotti a Roma
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of L'Acqua e la gestione degli Acquedotti a Roma
Indice
Programma Corso2
Mix dei 4 Libri2
Quali sono le fonti Letterarie?2
Gli Acquedotti di Roma e Gestione delle Risorse Idriche a Roma2
Lunghezza degli Acquedotti2
Manutenzione2
Il Personale della Cura Aquarum2
Leggi Sull’Acqua2
Concessione di Acqua ai Privati2
Costruzione di una galleria2
Strumenti di Misurazione2
Strumenti di rilevamento2
Vitruvio2
Costruzione di una Galleria2
Strumenti di Misurazione2
3
Strumenti di Rilevamento2
Tecnica di Scavo di una Galleria2
Gallerie senza Pozzi2
Galleria con Pozzi2
L’Acquedotto di Bologna2
L’emissario del Fucino2
L’Acquedotto Romano del Serino2
L’Acquedotto nell’area Flegrea2
Acquedotto di Avellino e Benevento2
Programma Corso
Storia Romana Prof.ssa Romilda Catalano
Anno Accademico 2013-2014
Contenuti
4
1. Scienza e tecnica nella costruzione di opere idrauliche del mondo romano.
2. Legislazione e amministrazione delle risorse idriche.
3. Rapporto tra opera idraulica e territorio.
Obiettivi
IL CORSO SI PROPONE DI FAR APPROFONDIRE LE CONOSCENZE DI STORIA ROMANAACQUISITE NEL TRIENNIO, E DI GUIDARE GLI STUDENTI ALLA CONOSCENZA E ALLACOMPRENSIONE DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE SCIENTIFICHE E TECNICHE RELATIVEALLA COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE IN EPOCA ROMANA, NONCHÉ ALLAMETODOLOGIA DELLA RICERCA. IN PARTICOLARE:
A- (CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE): L'APPROFONDIMENTO DELLECONOSCENZE DI STORIA ROMANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPEREIDRAULICHE IN EPOCA ROMANA, ED AL TEMA DELLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE NEISUOI DIVERSI ASPETTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI E NELLE SUE IMPLICAZIONI SOCIO-ECONOMICHE.
B- (CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE): LA CAPACITÀ DI SAPERLEGGERE UNA FONTE LETTERARIA O EPIGRAFICA NEL SUO CONTESTO, E DI EFFETTUARE GLIOPPORTUNI COLLEGAMENTI TRA I FENOMENI; LA CAPACITÀ DI UTILIZZARE GLI STRUMENTIDELLA DISCIPLINA E LE CONOSCENZE ACQUISITE (LINGUISTICHE, FILOLOGICHE ESTORICHE) NELL'ESEGESI DEI TESTI ANTICHI NELL'AMBITO DI UNA INDAGINE STORICA; LACAPACITÀ DI PORRE DOMANDE A UN TESTO, DI LEGGERE I DOCUMENTI ED I TESTI DELLATRADIZIONE E DI CONDURRE UNA RICERCA SU ARGOMENTI PERTINENTI ALLA DISCIPLINA,COME NELL'ESEMPIO PROPOSTO: L'INDAGINE SULL'ACQUEDOTTO AUGUSTEO DELLACAMPANIA, INFRASTRUTTURA IDRAULICA CON UNA FUNZIONE ESSENZIALE PERL'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.
C- (AUTONOMIA DI GIUDIZIO): LA CAPACITÀ DI UTILIZZARE IL METODO CRITICO NELLOSTUDIO DELLE FONTI ANTICHE E DELLA BIBLIOGRAFIA MODERNA; LA CAPACITÀ DIDELINEARE AUTONOMAMENTE E CON SENSO CRITICO LE PROBLEMATICHE DI UNARGOMENTO DI RICERCA STORICA E DI IMPOSTARE UN LAVORO RIGOROSO E INNOVATIVO.
D- (ABILITÀ COMUNICATIVE): LA CAPACITÀ DI COMUNICARE I DATI E I RISULTATI DI UNLAVORO STORICO E DI FORMULARE E ARGOMENTARE RIFLESSIONI IN FORMA CORRETTA.
5
E- (CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO): IL PERFEZIONAMENTO DELLE CAPACITÀ DIAPPRENDIMENTO IN PIENA AUTONOMIA; L'ACQUISIZIONE DI UNA CORRETTAMETODOLOGIA DELLA RICERCA.
Prerequisiti
E' NECESSARIA UNA CONOSCENZA DI BASE DEL MONDO CLASSICO, E UNA BUONACONOSCENZA DELLA STORIA ROMANA. AUSPICABILE LA CONOSCENZA DELLA LINGUALATINA E DELLA LINGUA GRECA.
Metodi Didattici
Lezione frontale. Durante il corso sarà dato ampio spazio alla lettura e al commento difonti antiche e di materiale documentario.
Verifica dell'apprendimento
COLLOQUIO ORALE TESO A VALUTARE IL LIVELLO DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA ELA CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE CRITICA DEGLI ARGOMENTI.
Criteri di valutazione dell'esame saranno:
1. capacità di esprimersi con chiarezza e con un linguaggio appropriato, utlizzandotermini specifici della disciplina;
2. capacità di inserire gli eventi della storia in un preciso quadro d'insieme logico,cronologico e geografico;
3. capacità di selezionare i dati, evidenziando correttamente quelli significativi;
4. capacità di articolare un discorso complesso, dimostrando l'acquisizione di unamentalità storica, e la capacità di illustrare le connessioni con altri ambiti disciplinari.
Altre Informazioni
Prerequisito essenziale del corso è una buona conoscenza della Storia romana. Tutti glistudenti che non hanno sostenuto nel triennio un esame di Storia romana, in particolaregli studenti dei corsi magistrali di Filologia Moderna, di Filosofia e di Scienze Pedagogiche,e coloro che seguono il corso singolo, sono tenuti a studiare anche l'intera Storia romana,utilizzando il testo di A. Momigliano, "Manuale di Storia romana", a cura di A.Mastrocinque, Utet, Torino, 2011 (n. 5).
6
I PUNTI 1,2,3 DEL CORSO E I TESTI 1,2,3 E 4 CORRISPONDONO UNITARIAMENTE A 9 CFU; IPUNTI 1,2,3 DEL CORSO E I TESTI 2,3 E 4 CORRISPONDONO UNITARIAMENTE A 6 CFU; IPUNTI 1 E 3 DEL CORSO E I TESTI 2 E 4 CORRISPONDONO UNITARIAMENTE A 4 CFU.
Testi
1. R. CATALANO, "INTUS IN TENEBRIS. SCIENZA E TECNICA NELLE OPERE IPOGEE ROMANE",ARTE TIPOGRAFICA, NAPOLI 2007.
2. A.D. BIANCO, "AQUA DUCTA, AQUA DISTRIBUTA. LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHEIN ETÀ ROMANA", SILVIO ZAMORANI EDITORE, TORINO 2007, (I-III).
3. F. GALLI, "SESTO GIULIO FRONTINO. GLI ACQUEDOTTI DI ROMA", LECCE 1997 (O ALTRAEDIZIONE).
4. R. CATALANO, "ACQUA E ACQUEDOTTI ROMANI. FONTIS AUGUSTEI AQUAEDUCTUS", ARTETIPOGRAFICA, NAPOLI 2003.
5. A. Momigliano, "Manuale di Storia romana", a cura di A. Mastrocinque, Utet, Torino,2011 (per tutti gli studenti che non hanno sostenuto nel triennio un esame di Storiaromana; vedi "Altre informazioni").
7
Mix dei 4 Libri
Gli acquedotti su arcate permettevano di portare l’acqua a grandialtezze, inoltre si costruivano con meno materiale però, avevanobisogno di molta mano d’opera perché erano sottoposte alleintemperie.
Un acquedotto costruito su più arcate è il Pont DuGard( Acquedotto di Nimes), per portare l’acqua a zone più elevate fuusato il sistema del “ sifone rovescio” che però costava troppoperché aveva bisogno di molta mano d’opera.
Il più antico sifone rovescio è quello dell’acquedotto di Alatri.
Il sifone dell’acquedotto di Aspendos è molto particolare poiché èdiviso da due torri idrauliche molto distanti tra loro vi sonoquindi tre sifoni consecutivi. L’acqua defluiva poi nel castellume poi veniva distribuita. Nelle città con più acquedotti l’acquapassava dal castello principale ai castelli secondari e poi venivadistribuita attraverso i calici ( tubi conici di bronzo che non sideformavano).
Secondo Frontino la quantità d’acqua dipendeva dalla posizione delcalice.
Al calice si collegavano tubi di piombo di diverso calibro:Vitruvio e Plinio classificavano i tubi in base al peso; Frontinoli classificava in base al diametro di fatti abbiamo la TabulaFistularum.
Quali sono le fonti Letterarie?
8
Sulla Nascita e la costruzione degli acquedotti romani abbiamo duepietre miliari: “ De Acque Urbis” di Frontino e il “ DeArchitectura” di Vitruvio.
Il trattato sugli acquedotti di Frontino parla dei problemi diapprovvigionamento idrico a Roma. Frontino è stato curatoracquarum ( curatore delle acque) cioè responsabile degliacquedotti e dei servizi connessi, a Roma nel 97 sottol’imperatore Nerva; la sua opera riflette la serietà e lascrupolosità del suo impegno.
L’opera contiene notizie storiche, tecniche, amministrative,legislative e topografiche sui 9 acquedotti esistenti all’epocavisti come elemento di grandezza dell’impero romano e paragonato,per la loro magnificenza, alle piramidi o alle operearchitettoniche greche.
È grazie a lui che abbiamo delle indicazioni sui lavori delleopere idriche che si realizzavano nell’impero romano.
L’altra pietra miliare è l’opera di Vitruvio “ sull’architettura “dedicata ad Augusto, scritta probabilmente tra il 29 e il 23 a.c.,è stata scritta durante il periodo in cui Augusto progettava unrinnovamento architettonico generale dell’edilizia pubblica e cipermette di conoscere i metodi costruttivi degli antichi romani.
L’opera è sopravvissuta grazie ad un'unica copia trovate nelleisole britanniche e portata da Alcuino alla corte di Carlo Magno.È l’unico testo latino di architettura giunto integrodall’antichità quindi è più importante. Vitruvio è statoarchitetto sotto Augusto e scrittore romano ed’è considerato ilpiù famoso teorico dell’architettura. Conosciamo gli acquedottianche grazie alla forma urbis Severiana ma ci sono giunti pochiframmenti.
Frontino è stato un senatore di livello consolare, è stato curatoracquarum sotto l’imperatore Nerva e tre volte console. È natoprobabilmente nel 35 d.c.ed’è morto sotto Traiano nel 103 d.c.
9
Non abbiamo informazioni né sulla famiglia né sui suoi studi.Pubblicò il de acque urbis del 98 d.c.
L’opera di Frontino ci è giunta attraverso un codice manoscrittodel XII sec. Ritrovato nell’abbazia di Montecassino nel 1479 daPoggio Bracciolini e pubblicato per la prima nel 98 d.c.
In qualità di curator acquarum frontino disponeva di tutte leinformazioni che desiderava, ma furono poche le informazioni checi da sulle adduzioni idriche più antiche ideate nella prima etàrepubblicana; è solo a partire dal 32 a.c che la documentazionearchivistica si fa più precisa cioè a partire dalla riforma delsistema idrico ideata da Agrippa.
Egli deplora l’incapacità dei suoi predecessori che non hannorealizzato nessun opera di ripristino o di restauro. Fin dalmomento della sua nomina raccolse note ed appunti, notizie di cuinecessitava egli stesso per svolgere degnamente il suo compito. Ilsuo primo obbligo era conoscere ciò che aveva tra le mani.
L’opera è articolata in 130 capitoli organizzati in un prologo edue libri; gli argomenti sono sostanzialmente divisi in tresezioni:
nella prima sezione egli introduce il tema e descrive gliacquedotti;
nella seconda sezione descrive gli aspetti tecnici;
nella terza sezione elenca le norme legate all’uso delle acque.
Nel suo trattato egli ci dice quali sono gli acquedotti cheentrano a Roma da chi sono stati fondati, come sono staticostruiti, la loro lunghezza e le rispettive erogazioni.
Egli ci fornisce queste informazioni sui primi 9 acquedotti,perché gli altri 2 sono stati costruiti dopo la sua morte (104d.C). Egli indica anche la lunghezza degli acquedotti perchésecondo lui il curator deve sapere quali sono gli acquedotti cherichiedono maggiori spese.
10
Frontino ci indica anche i calibri di distribuzione delle acqueche sono stati stabiliti secondo le unità di misura in pollici eonce. Indica la portata che ogni acquedotto sembrava avere e laquantità che distribuiva secondo le indicazioni dei registriimperiali; di fatti evidenzia come qualche acquedotto distribuissepiù acqua del dovuto.
Ciò è dovuto al fatto che i proprietari terrieri perforavano lecondutture per irrigare i propri giardini per cui gli acquedottirallentavano la loro corsa.
Inoltre evidenzia le truffe che facevano gli aquarii per dareacqua ai locandieri.
Frontino ci elenca anche le regole che il commissario delle acquedeve osservare e le leggi del senato relative alla gestione delleacque.
Il trattato di Frontino è prima di tutto uno scritto politico inquanto tende a demonizzare il comportamento dei precedentiImperatori elogiando invece l’impegno dell’imperatore Nerva.
Gli Acquedotti di Roma e Gestione delle Risorse Idriche aRoma
I romani costruirono altri 200 acquedotti, l’acquedotto divenne unsimbolo di potenza e di modernità, che avevano tutte le città importanti.
Secondo Frontino è la più grande manifestazione della grandezza diRoma, grande impresa di ingegneria idraulica. Anticamente le acqueerano pubbliche e potevano essere usate da tutti liberamente.
Nell’età Monarchica (753 a.C - 509 a.C.) la popolazione prendeva l’acquadal Tevere, dalle sorgenti e dalle cisterne per l’acqua piovana. Riguardo a questo periodo non si sa niente sulla gestione delle acque, tranne che i re etruschi Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo costruirono la Cloaca Massima ( “La fogna più grande” era una grande fognatura per incanalare nel Tevere tutta l’acqua piovana e stagnante per evitare che allagassero la città. È stata
11
costruita alla maniera etrusca e cioè con un arco a volta che la rendeva più stabile e duratura. Inizialmente era un canale aperto che poi è stato chiuso). Successivamente Frontino ci ricorda che in questo periodo i cittadini potevano prelevare solo acqua caducacioè quella che cadeva a terra, in quanto gli antichi preferivano erogare l’acqua per l’igiene della città e per uso pubblico e nonper i privati.
Col passare degli anni Roma divenne una grande metropoli e la popolazione crebbe a dismisura e nacque per questo il problema della gestione delle risorse idriche.
Nell’età repubblicana (509 a.C. - 30 a.C.) la costruzione di operepubbliche avveniva per iniziativa dello stato, i rappresentanti dello stato erano i censori che facevano gare d’appalto per costruire opere pubbliche e gestivano l’agerpublicus. Il senato dava una somma di denaro ai Censori che doveva servire loro per tutta la durata del lustro. I Censori però non si occupavano direttamente dei pagamenti, essi davano i lavori d’appalto e a pagare i lavoratori erano i questori che amministravano l’erario.
I redempores erano i lavoratori della società di appalto; il redemptor è il rappresentante della società.
I Censori provvedevano a rilasciare le concessioni di acqua ed approvavano i lavori di manutenzione degli acquedotti.
I campi che venivano irrigati con acqua pubblica venivano confiscati e si facevano multe anche ai censori che avevano abusato della concessione.
I censori amministravano anche i beni pubblici: strade, edifici einfrastrutture. Era poi prevista una multa per chi inquinaval’acqua pubblica. Secondo alcuni studiosi si occupavano dellagestione delle acque anche gli edili e i questori.
I primi 4 acquedotti sono l’acqua Appia, l’AnioVetus, la Tepulae la Marcia furono costruiti tutti durante il periodo repubblicanoper distribuire l’acqua a Roma furono curati dai Censori.
12
Aqua Appia è l’acquedotto che venne costruito dai censori AppioClaudio Cieco (da cui riprende il nome) e Caio PlauzioVenox nel312 a.C. e captava sorgenti lungo una strada secondaria che sistaccava dalla via Prenestina, tra il VII e l’VIII miglio.
Roma intraprese la sua costruzione durante la seconda guerrasannitica (327-304 a.C.) e in concomitanza con la costruzionedella via Appia, dando prova della propria forza e capacità dipianificazione.
Il condotto era quasi completamente sotterraneo, alla profonditàdi circa 15 m, e la sua lunghezza complessiva era di poco più di11 miglia (11.190 passi), pari a 16,5 km; la portata giornalieracorrispondeva a 841 quinarie, pari a poco più di 34.000 m3.
Dopo l'ingresso in Roma presso Porta Maggiore (nella localitàdetta "ad spemveterem"), si dirigeva verso il Celio e l’Aventino,e terminava nei pressi della porta Trigemina, nel Foro Boario.
Fu restaurato prima nel 144 a.C., ad opera di Quinto Marcio Re,poi in concomitanza con la costruzione dell‘acquedotto dell'aquaMarcia, nel 33 a.C., a cura di Agrippa, e infine tra l’11 ed il 4a.C., ad opera di Augusto, che ne potenziò la portata fino a 1.825quinarie, pari a 75.737 m3 (876 litri al secondo), captando nuovevene d’acqua presso il VI miglio della via Prenestina.
L’ AnioVetus è il secondo acquedotto romano che venne costruitotra il 272 e il 270 a.C., con il bottino della vittoria controTaranto e Pirro, da due magistrati appositamente nominati dalSenato (duumviri aquaeperducendae), i censori Manio Curio Dentatoe Flavio Flacco; fu il secondo ad occuparsi dell’impresa, essendoil collega morto cinque giorni dopo l’incarico. L’acquedotto ebbel’appellativo di "vecchio" (vetus) solo quando, quasi tre secolidopo, fu costruito quello dell’AnioNovus (o "Aniene Nuovo").
Raccoglieva le acque dell’Aniene (Anio) nei pressi di Tivoli,all’altezza del XXIX miglio della via Valeria, circa 850 m a montedi San Cosimato, presso la confluenza nell’Aniene del torrenteFiumicino, tra i comuni di Vicovaro e Mandela, ovvero in una
13
regione della Sabina che era stata conquistata dallo stesso ManioCurio Dentato poco tempo prima.
Il condotto era quasi completamente sotterraneo (alcuni ponti, chene abbreviavano il percorso, vennero edificati in epochesuccessive) e giungeva in città, come l'aqua Appia, nella zonadenominata “ad spemveterem”, per terminare presso la portaEsquilina. La lunghezza dell’acquedotto era di 43 miglia, pari a63,5 km circa, dei quali solo 0,221 miglia erano in superficie, sumuri di sostegno nei pressi dell’attuale Porta Maggiore. Laportata era di 4.398 quinarie giornaliere (pari a 182.517 m3 e2.111 litri al secondo); solo poco più di metà, a causa didispersioni o captazioni abusive, giungeva però a destinazione.
L’Aqua Marcia è il terzo acquedotto e venne costruito nel 144a.C. dal pretore Quinto Marcio Re: per questo compito (e per larestaurazione dei due precedenti acquedotti) gli fu assegnata dalSenato la somma considerevole di 180 milioni di sesterzi.Raccoglieva l’acqua dell’alto bacino dell’Aniene, attingendodirettamente dalle sorgenti, abbondanti e di ottima qualità epurezza, nei pressi dell’attuale comune di Marano Equo, tra Arsolied Agosta, dove ancora oggi è possibile riscontrarne traccenell’ex cava di pietra.
Era considerata la migliore acqua tra quelle che arrivavano aRoma, e Plinio il Vecchio la definì “clarissimaaquarum omnium” e“un dono fatto all’Urbe dagli dei".
La lunghezza dell’acquedotto era di 61,710 miglia, pari a poco piùdi 91 km. Il percorso era sia sotterraneo, sia su arcate (per7,463 miglia, pari a 11 km circa, le prime grandi arcatemonumentali), un tratto delle quali, per circa 9 km.,fiancheggiava la via Latina. Arrivava a Roma nella località "adspemveterem", come gli acquedotti precedenti, scavalcava quindi lavia Tiburtina su un arco che fu poi trasformato nella PortaTiburtina delle mura aureliane e terminava in prossimità dellaporta Viminale. La distribuzione raggiungeva il Campidoglio,
14
mentre un ramo secondario ("rivusHerculaneus") serviva il Celio el’Aventino.
La portata alla sorgente era di 4.690 quinarie, pari a ben 194.365m3 e a 2.251 litri per secondo. Tanta abbondanza di acqua vennesmistata a rinforzo di acquedotti più poveri, come il successivoAquaTepula (92 quinarie) e l’Aniovetus (162 quinarie).
Oltre a numerosi restauri minori, fu in gran parte ricostruito inseguito ad un incremento di portata, pressoché raddoppiata con lacaptazione di una nuova sorgente (detta “Aqua Augusta”), tra l’11e il 4 a.C., al tempo di Augusto. Nel 213, durante il principatodi Caracalla, venne realizzata la diramazione dell’"aquaAntoniniana" per le nuove terme, che attraversava la via Appia suun arco ("arco di Druso"), e un altro ramo secondario fuutilizzato per l’alimentazione delle terme di Diocleziano.
L’abbondanza e l’ottima qualità dell’acqua spinsero in tempirecenti papa Pio IX a ripristinare l’acquedotto, che fu nuovamenteinaugurato l’11 settembre 1870.
AquaTepula è l’ultimo acquedotto dell’età repubblicana, ilquarto, venne costruito dai censori Caio Servilio Cepione e LucioCassio Longino nel 125 a.C. Il nome era dovuto alla temperatura"tiepida", a 16-17 gradi, dell’acqua.
Captava sorgenti situate nella zona vulcanica dei Colli Albani,dette della “Pantanella” e dell’”Acqua Preziosa”, al X migliodella via Latina.
Il percorso dell’acquedotto aveva una lunghezza di 18 km, deiquali 9.580 m sulle arcuazioni dell’Aqua Marcia.
Nel 33 a.C. fu ristrutturato e modificato da Agrippa e fu fattoconfluire nel nuovo condotto dell’Aqua Iulia, dal quale siseparava nuovamente nei pressi della città. Correva, quindi, in uncondotto distinto sopra gli archi dell’aqua Marcia, insiemeall’Aqua Iulia, e giungeva in città “ad spemveterem”, seguendo poilo stesso percorso dell’Aqua Marcia fino alla Porta Viminale, nei
15
pressi dell’odierna Stazione Termini, e poi alla Porta Collina,nell’attuale Via XX Settembre.
La portata giornaliera definitiva, una delle più basse, era di 445quinarie (pari a circa 18.467 m3), 92 delle quali provenivano perdiramazione dall’Aqua Marcia e 163 dall’Anionovus, costruito peròcirca 170 anni più tardi. A queste vanno aggiunte le 1.206quinarie dell’Aqua Iulia, le cui acque arrivavano praticamenteinsieme alla destinazione.
In questo periodo lo stato poteva permettersi la costruzione dinuove strutture o la ristrutturazione di quelle vecchie graziealle multe fatte ai trasgressori delle leggi, alle tasse pagatesui beni demaniali e nelle province ( campi coltivati, pascoli,boschi, miniere, laghi, fiumi, porti che venivano affittati o datiin concessione ai privati.
Agrippa è il primo uomo nella storia di Roma a prendersi curadegli acquedotti scavalcando i censori , può essere quindiconsiderato il precursore del Curator Acquarum istituito poi daAugusto.
Il quinto acquedotto romano venne costruito da Agrippa nel 33 a.C.e prese il nome dalla gens Iulia, il “casato” di cui faceva partel’imperatore Augusto. Venne unito in un unico condotto con quellodell’aquaTepula, ed in seguito restaurato dallo stesso Augusto tral’11 e il 4 a.C.
Raccoglieva l’acqua da sorgenti nel territorio tuscolano, al XIImiglio della via Latina, identificate presso l’attuale ponte degli“Squarciarelli”, nel comune di Grottaferrata. Arrivava a Roma,come gli acquedotti precedenti, nella località “ad spemveterem”,presso Porta Maggiore, e seguiva poi lo stesso percorso dell’AquaMarcia fino alla porta Viminale.
Il percorso complessivo era pari a 15.426 miglia romane, pari aquasi 23 km, dei quali circa 11 in superficie; la portataoriginaria era di 1.206 quinarie (pari a 50.043 m3 al giorno, cioè579 litri al secondo), e in seguito (con il condotto parzialmente
16
fuso con quello dell’AquaTepula) fu accresciuta di 92 quinarieprovenienti dall’Aqua Marcia e di altre 163 dall’AnioNovus.
L’aqua Iulia, così arricchita e fusa con la Tepula, riforniva ilCelio, l’Esquilino, il Viminale, il Quirinale, il Campidoglio, ilPalatino, il Piccolo Aventino e il Foro Romano.
Fu probabilmente una diramazione di questo acquedotto, di cui sonovisibili alcune arcate, ad alimentare la fontana monumentale dipiazza Vittorio, costruita sotto Alessandro Severo (il“nymphaeumAlexandri” o "Trofei di Mario").
Agrippa fece poi costruire 700 cisterne, 500 fontane e 130 “castella” cioè bacini di distribuzione, sui quali eresse 300statue e 400 colonne di marmo. Egli stesso stabilì quanta acquaera destinata all’uso pubblico e quanto all’uso privato.
Il nodo centrale della distribuzione delle acque era il Castellumche era una specie di edificio costruito alle mura della città, alquale era collegata una vasca “ triplice”, cioè divisa in 3 particomunicanti tra loro, che portavano acqua alle tre utenzeprincipali: locus et salientes, alle terme e alle abitazioniprivate.
Agrippa è l’unico a preoccuparsi della manutenzione degliacquedotti, egli infatti aveva 240 schiavi specializzati inidraulica, inoltre aveva redatto i Commentarii che raccoglievanotutte le informazioni sugli acquedotti e contenevano le piante coni corsi delle tubature.
Inoltre Agrippa ha costruito le prime terme ( 25 a.c – 19 a.c.)che erano molto particolari sia per le dimensioni che per lecaratteristiche costruttive e ornamentali.
Successivamente Nerone ( 62 d.c. – 64 d.c.) fece costruire altreterme al Campo Marzio, migliorando la qualità dei servizi offerti.
Molto sfarzose erano anche le terme di Caracalla ( 212-217). Nelcorso degli anni le terme divennero il simbolo della civiltàromana, erano un luogo di incontro e di relax aperto a tutti,ricchi e poveri, uomini e donne.
17
Nell’11 a.c Augusto assunse le competenze della Cura Aquarum che sioccupava della gestione degli acquedotti.
A capo della Cura Aquarum vi era il Curator Aquarum che era un senatoredi livello consolare, nominato dall’imperatore, che doveva controllare ilavori di costruzione e manutenzione degli acquedotti, doveva valutarequali lavori dovevano eseguirsi subito e quali più in là e da chidovevano essere eseguiti, se dai suoi schiavi o dagli appaltatori.
Egli doveva controllare che le fontane pubbliche funzionasseroregolarmente; scrivere nei registri la portata dei singoli acquedotti ele concessioni che venivano date.
Il curator aveva anche potere giurisdizionale, infatti risolveva lecontroversie tra i privati e lo stato, inoltre doveva far osservare leleggi, secondo le quali nessuno poteva prendere acqua pubblica senza laconcessione dell’imperatore.
Al curator erano concessi privilegi e onori, indossava la DogaPraetexta1, aveva diritto alla Sella Curalis2e alla VacatioIndiciis3.
Il suo incarico non aveva limiti di tempo, fra la morte di un curatore ela nomina del successore, c’era un periodo di pausa, durante il qualel’ufficio era amministrato degli Adiutores.
Essi erano senatori di rango inferiore che affiancavano il curatoraquarum, avevano incarichi esecutivi e facevano da intermediari fra ilcurator e il personale tecnico e amministrativo; controllavano i lavoridi manutenzione.
Se il curator era fuori Roma veniva accompagnato dagli Apparitores,schiavi pubblici specializzati: 2 littori, 1 architetto, 1 scriba e 1segretario.
1 Toga praetexta: si trattava di un tipo di toga orlata di porpora. Essaveniva indossata da: Tutti i ragazzi romani liberi, che non avevano raggiuntoancora l'età adulta (fino ai 15-17 anni), veniva indossata delle occasioniformali ed ovviamente era di dimensioni minori rispetto a quella degli adulti.Tutti i maggiori personaggi civili e religiosi, che per la loro funzione eranoconsiderati Magistrati Curuli. Tutti gli ex Magistrati Curuli ed i Dictatores almomento della sepoltura e in altri casi anche durante certe solennità. Secondola tradizione essa era stata indossata da tutti gli antichi Re di Roma. Durantel'impero il diritto di portare questo tipo di toga venne spesso esteso come unonore riservato indipendentemente dalla funzione svolta.
2 Sedile pieghevole simbolo del potere giudiziario.3 ricorso, consiste nella richiesta fatta da un soggetto ad una autorità, di
esaminare una determinata situazione al fine di ottenere un provvedimento18
Per eseguire i lavori di manutenzione, il curator aveva a disposizione i240 uomini di Agrippa, lasciati in eredità ad Augusto, cioè gli schiaviche costituivano la Familia Privata, ma Augusto la donò allo statodivenendo quindi una FamiliaPublica passando dalla potestà di Agrippa aquella del popolo romano.
Ma nel 52 d.c. Claudio aggiunse ai 240 schivi di Agrippa e Augusto, altri460 schiai specializzati in idraulica 8 perché c’era il bisogno di moltamanodopera) creando così una FamiliaCaesaris che veniva pagata dal fiscoimperiale( mentre la Familiapublica era retribuita con i fondidell’aerarium Saturni).
I componenti delle Familiae erano detti Aquarii e si occupavano dellamanutenzione degli acquedotti, per evitare che fossero utilizzatiillecitamente in lavori privati, Frontino introdusse la regola discrivere il giorno prima il programma di lavoro e il giorno dopo siscriveva ciò che era stato effettivamente fatto.
Durante il periodo della Dinastia Giulio Claudia Tiberio non harealizzato grandi opere pubbliche in campo idrico. Con Caligola ( è statoal potere solo per 4 anni poi è stato ucciso; fu dispotico e tiranno e siavrà l’assolutismo imperiale con lui) cominciò la costruzione di 2acquedotti che furono poi terminati dal suo successore Claudio, chelasciò un segno profondo nella Cura Aquarum.
Nel 52 d.c. termino i due acquedotti e chiamo quello che aveva l’acqua dimigliore qualità Aqua Claudia, l’altro AnioNovus che fu poi chiamatoAnioVetus, questo captava le acque nell’alta valle dell’Aniene,direttamente dal fiume, e terminava “ad spemveterem”, presso PortaMaggiore.
Il percorso dell’AnioNovus era il più lungo di tutti, misurando quasi 87km (58.700 miglia), dei quali 73 in canale sotterraneo e 14 insuperficie. Di questi ultimi, circa 7 km coincidevano con le arcuazionidell’aqua Claudia a cui, a partire dal VII miglio della via Latina,l’AnioNovus fu sovrapposto.
La portata giornaliera, la maggiore di tutte, era di 4.738 quinarie, paria 196.627 m3 e 2.274 litri al secondo.
Claudio decise di prosciugare il Lago Fucino per avere nuovi terrenicoltivabili, fu scavata una galleria sotterranea per poi defluire le
19
acque ma siccome non c’era molto dislivello, l’impresa non andò a buonfine.
Egli introdusse inoltre, un nuovo funzionario, il Procurator Aquarum cheera un liberto dell’imperatore che funzioni tecniche e amministrative; inquesto modo l’imperatore aveva nelle mani la gestione del servizio e ilsenato aveva sempre autorità. Nerone non creò nuovi acquedotti ma estesel’Aqua Claudia.
In età Flavia Vespasiano e Tito si dedicarono soprattutto allariparazione della rete idrica e Domiziano estese ancor di più l’AquaClaudia, fino al Palatino, per dare acqua alle residenze imperiali.
Dagli Antonini ai Severi ( II sec. d.c.) Nerva nominò, nel 97 d.c.,Curator Aquarum Frontino, uomo di grande merito.
Con Traiano e Adriano vi sono molti funzionari chiamati Procuratores,cavalieri o liberti imperiali.
In questo periodo furono fatti interventi per migliorare la rete idrica.
Nel 109 d.c. Traiano costruì un nuovo acquedotto Aqua Traiana ( sul qualenon abbiamo informazioni perché Frontino era già morto).
Frontino dice che nell’età flavia e nell’età di Nerva in ogni quartierec’erano un paio di acquedotti e buona acqua potabile, inoltre le cittàerano più pulite.
Nerva vuole dare di nuovo potere al Senato, e non ai liberti, si alleoinfatti con esso e per questo si organizza una congiura che è stata poisventata, Nerva avrà paura e si avranno le guerre civili.
Con Traiano ci sarà un risveglio economico e un rinnovamento del Senato;il procurator è un cavaliere.
Con Diocleziano ( dopo 3 secoli) abbiamo il ConsularisAquarum, dopo il330 abbiamo il PrefectusUrbis. Oggi Magistrato delle Acque e del Po’.
Nel Tardo Impero ( Età Severiana) cambia l’organizzazione della curaaquarum.
Con Settimio Severo abbiamo il Curator Aquarum et Minuciae, cioè ilcuratore delle acque si occuperà anche della distribuzione del frumento.
20
Con Settimio Severo e Caracalla furono restaurati gli acquedotti Marcia,Iulia e Claudia, mentre Alessandro Severo fece costruire l’ultimo grandeacquedotto antico l’AquaAlexandrina.
Nel corso del IV secolo accanto alla figura del Curator Aquarum abbiamola figura del ConsularisAquarum che verranno poi entrambe sostituitedalla figura del ComesFormarum, un console. La figura del ProcuratorAquarum scompare alla fine del 3° secolo.
All’inizio del 6° secolo gli acquedotti romani erano ancora efficienti,ma poi i Goti, con l’assedio di Vitige, li ruppero tutti, cominciandocosì il periodo di decadenza degli acquedotti.
Lunghezza degli AcquedottiFrontino essendo curator aquarum e quindi responsabile dellamanutenzione degli acquedotti, ci indica anche la loro lunghezza,perché sostiene che è necessario sapere quali sono gli acquedottiche necessitano di maggiori spese.
I vari acquedotti giungono a Roma a quote diverse, quindi alcuniportano l’acqua ai quartieri più elevati, mentre altri non possonoessere condotti ad un’ altezza superiore.
Il più alto è l’AnioNovus, poi l’Aqua Claudia e poi l’Aqua Iulia,l’AquaTepula, l’Aqua Marcia che è uguale all’Aqua Claudia; i piùbassi sono l’Aqua Appia e l’Aqua Augusta.
Manutenzione
Gli acquedotti si deterioravano continuamente, quindi ilcommissario delle acque doveva consultare diversi architetti perrendersi conto di ciò che si doveva aggiustare subito e ciò chesi poteva rimandare, e inoltre se possono intervenire i suoioperai o dovevano intervenire gli appaltatori.
Ci sono riparazioni esterne che si possono fare senza fermarel’acqua, cioè quelle che riguardano la muratura; altre invece chesi devono fare per forza fermando l’acqua, come pulire le tubature
21
dagli accumuli del deposito che formano una crosta che riduce ilflusso dell’acqua, oppure il degrado dei rivestimenti stagni.
Il Personale della Cura Aquarum
L’organizzazione della Cura Aquarum era questa:
a capo della Cura Aquarum ( ufficio) vi era il Curator Aquarum( Console), affiancato da 2 Adiutores ( senatori) di rangoinferiore a essi è subordinato un Procurator ( introdotto daClaudio) che è un liberto dell’imperatore, ma con Traiano ilProcurator è un cavaliere; alle dipende del procurator vi sono 2familiae: FamiliaPublica ( con Agrippa e Augusto) costituita da240 schiavi e FamiliaCaesaris ( con Claudio) costituita da 460schiavi. Le Familiae si occupavano della manutenzione idrica.
Per realizzare gli acquedotti c’era bisogno di:
un Architectus che faceva il progetto e dirigeva i lavori,ricoprendo il ruolo del nostro ingegnere.
Un Geometres che misurava i campi e studiava i caratteritopografici dell’area dove avveniva la costruzione.
Un Gromaticus che determinava la superfice dei terreni.
Un librator che doveva avere competenze sia teoriche che manuali.
Spesso i militari dell’esercito venivano utilizzati per realizzaregli acquedotti, perché costavano di meno ed erano abituati allavoro intenso.
Gli aquarii membri delle Familie ( schiavi) che si occupavanodella costruzione e manutenzione degli acquedotti.
Poi vi erano fontanieri, muratori, pavimentatori etc.
Gli Apparitores erano coloro che accompagnavano il CuratorAquarum.
StatioAquarum = ufficio della Cura Aquarum.22
Nel corso degli anni non si parla più di Procurator Aquarum, masin parla di Procuratores, per cui o i procurator si susseguivanocontinuamente perché il loro servizio era breve, oppure vi eranopiù procuratores contemporaneamente.
Leggi Sull’AcquaPer quanto riguarda le leggi sull’acqua, bisogna innanzi tuttofare una distinzione tra acqua interna e acque del mare:
Le acque del mare hanno delle leggi proprie;
Le Acque interne comprendono quelle sotterranee e quellesuperficiali: le acque sotterranee fanno parte del sottosuolo,anche se poi vengono scoperte e portate in superficie, perchévengono estratte con mezzi artificiali.
Le sorgenti naturali, invece, pur derivando da acque sotterranee,sono considerate acque superficiali, perché scaturisconospontaneamente, in modo naturale.
Le acque superficiali sono quelle che scorrono sul suolo e dalpunto di vista giuridico si dividono in acqua viva e acquacorrente: l’acqua viva è quella che nasce da una fonte o da unaltro caput aquae per un tempo illimitato; l’acqua corrente èquella che scorre per gravità all’interno di un alveo naturale.
Se l’alveo è artificiale allora si parla di “ AquaDucta”. L’acquapiovana è considerata superficiale.
L’acqua inoltre si divide in pubblica se si trova su un terrenopubblico, privata se si trova su un terreno privato.
L’Acqua Ducta, incanalata per approvvigionare un centro abitato,rimane pubblica fin quando non viene concessa a privati.
23
L’Acqua Profluens, quella dei fiumi per intenderci è un benecomune per cui tutti ne potevano fare uso.
Nell’età arcaica le acque erano pubbliche e potevano essere usateda tutti liberamente.
Le prime concessioni idriche per uso privato furono quelle in etàmonarchica di acqua caduca, cioè quella in eccesso che cadeva interra riservata alle terme e alle lavanderie. Nel diritto classicol’acqua privata non veniva utilizzata solo da privati ma anche daaltri.
La più antica tra le servitù relative alle acque è la Servitù diAcquedotto che nel diritto romano comprendeva sia la presadell’acqua, sia la conduzione verso altri fondi, indicate conl’espressione AquamDucere. La servitù di acquedotto potevacostruirsi solo Ex Capit cioè dove l’acqua ha origine, peròsiccome spesso i fondi dove si voleva portare l’acqua erano moltodistanti dal caput ( fonte) si consenti che la derivazione fossecollocata in un punto più vicino al fondo di interesse.
Altre servitù concesse all’uso delle acque erano:
ServitusPecoris ad AquamAppellandi che consentiva di portare abere il bestiame presso l’acqua altrui. ServitusAquaeVenas nonIncidendi per cui il proprietario del fondo non poteva tagliare lavena d’acqua che scaturiva nel fondo altrui.ServitusAquaeImmittendae cioè il proprietario del fondo superiorepoteva immettere l’acqua in quello inferiore.ServitusAquaeEducendae per cui egli poteva attrarre nel propriofondo le acque che scorrevano nel sottofondo altrui.
Concessione di Acqua ai Privati
Il primo a stabilire un ordinamento per le concessioni di acqua fuAugusto: i cittadini che volevano l’acqua per un uso privato dovevanofare una richiesta all’imperatore che rilasciava la licenza imperiale,
24
che veniva consegnata al curator aquarum che ne prendeva atto e delegavaal procurator. Il procuratore doveva punzonare con i livellatori unapresa pari alla quantità di acqua concessa, l’apertura non doveva esserené maggiore né minore.
Nessun cittadino poteva quindi prendere acqua senza autorizzazionedell’impero e non poteva prenderne più della quantità concessagli. Iprivati che avevano ricevuto la concessione non potevano assolutamenteprendere acqua dagli acquedotti pubblici, ma dovevano prenderla daidepositi pubblici e metterla in depositi costruiti da essi stessi neiluoghi indicati dai commissari ( curator). In questo modo prendonol’acqua dai depositi pubblici, i cittadini non sapevano il luogo in cuisi trovavano il condotto e i tubi pubblici.
Il diritto di concessione idrica non si poteva trasmettere agli eredi, néal nuovo acquirente, mentre alle terme pubbliche la concessione eraperpetua. Anche l’acqua caduca ovvero quella in eccesso che cadeva daidepositi, si poteva prendere solo tramite la concessione.
Le prese inoltre dovevano essere messe a livello, perché quelle poste piùin basso pescavano più acqua, mentre quelle poste più in alto nepescavano di meno, perché la corrente dell’acqua è attirata dalla presapiù bassa.
Spesso gli idraulici imbrogliavano per vendersi l’acqua ad esempio:
quando i tubi non avevano le prese, essi allargavano o stringevanoi fori come volevano
oppure quando una concessione idrica passava ad un nuovoproprietario, essi facevano un foro nuovo nel deposito e sivendevano l’acqua che usciva dal vecchio foro.
Inoltre alcune persone spesso foravano i tubi che attraversavano lacittà per prendersi l’acqua, per cui solo una piccola quantitàd’acqua arrivava per l’uso pubblico.
Il commissario doveva evitare che i cittadini imbrogliassero, dovevaispezionare i condotti fuori città e controllare le concessioni. Tutticoloro che prendevano l’acqua senza permesso o danneggiavano l’acquedottovenivano multati, se a danneggiare era un schiavo a pagare era ilpadrone. I cittadini non dovevano neanche inquinare le acque pubbliche.
25
Spesso anche gli aquarii si facevano corrompere dai cittadini in cambiodi denaro.
Frontino ci dice che nel 11 d.c. sotto il consolato di Tuberone e PaoloFabio Massimo furono introdotte delle leggi riguardo la costruzione e lamanutenzione degli acquedotti e la distribuzione delle acque.
Tale normativa viene codificata in 4 Senatus Consulta:
il primo stabilisce che nessun privato può prendere acqua daicanali pubblici, chi ha la concessione deve prenderla dal castello.
Il secondo stabilisce che la concessione non si trasferisce néall’erede né al nuovo proprietario del fondo; il nuovo proprietarioha 30 giorni di tempo per fare la pratica amministrativa.
Il terzo stabilisce che quando si restaura un acquedotto èpossibile prendere dai privati, terra, mattoni, legna, tutto ciòche serve per la manutenzione. Ovviamente questi privati eranoquelli della terra su cui era costruito l’acquedotto. Se ilproprietario non voleva vendere quella porzione di terrenonecessaria a costruire l’acquedotto allora lo stato compraval’intero terreno e una volta finiti i lavori rivendeva il terrenocircostante al vecchio proprietario. Molti però rompevano gliacquedotti o mettevano vicino agli acquedotti alberi, edifici etc.
Il quarto stabilisce, quindi, di rimuovere tutto ciò chedanneggiava gli acquedotti, intorno ai quali doveva esserci unospazio libero.
Successivamente nel 9 a.c., con Augusto abbiamo la LexQuinctia ma leggeche stabilisce multe salate per chi danneggia gli acquedotti, per chiinquina l’acqua e per chi costruisce qualcosa vicino agli acquedotti,intorno ai quali non dovevano esserci nemmeno alberi.
26
Costruzione di una galleria
Vitruvio è un architetto che ha avuto poco successo in campoprofessionale, ha scritto molto ma costruito poco. La sua opera ècostituita da 10 libri nei quali egli parla di vari argomenti: 7libri di architettura, 1 libro di idraulica, 1 di astronomia, 1 dimeccanica.
I lavori di costruzione di una galleria si dividono in due fasi:Fase progettuale e fase esecutiva . La fase progettuale prevede ilrilievo topografico , il calcolo delle quote ,la definizione deltracciato, la determinazione dei costi. Il progetto di costruzionedi un acquedotto ea affidata ad un architetto, coordinato da unlibrator (ingegnere idraulico) accanto a loro c’era il discenslibratorum, un apprendista ingegnere . Secondo Vitruviol’architetto doveva avere una formazione culturale completa che
27
riguardasse tutte le discipline ; doveva essere dotato di abilitàmanuale e doveva avere pazienza, virtù e speranza . Ovviamente nonera facile trovare architetti con tutte queste qualità. Il ruolodell’architetto era un importante ruolo sociale.
FASE ESECUTIVA: prevede l’impianto dei cantieri, l’inizio deilavori , la soluzione dei problemi che si presentano ,ilcompletamento dell’opera e il colludo. La costruzionedell’acquedotto era affidata ad appaltatori, i redemptores;successivamente la manutenzione era affidata al curator aquarum.Per impiantare il cantiere c’era bisogno di molti specialisti delsettore: muratori, costruttori di archi, tagliatori di pietre,intonacatori, stuccatori. Per realizzare un acquedotto siutilizzavano vari strumenti che sono descritti nell’opera diVitruvio. Egli nel libro X descrive tre macchine di sollevamento.La prima è la più semplice e serve a sollevare carichi minori, edè costituita da una sola carrucola e una corda da trazione;
La seconda serve a sollevare carichi maggiori, le travi sono piùlunghe e resistenti, vi sono tre coppie di carrucole al posto delverricello c’è il tamburo;
La terza è la più complessa, poiché, ha tre corde di trazione etre carrucole : è chiamata polyspastos in quanto è ai numerosigiri delle pulegge che deve la sua estrema comodità e rapidità. Inbase al peso che si doveva sollevare si sceglieva la gru piùadatta; per scavare una galleria di solito si sceglieva lamacchina di sollevamento più semplice.
Strumenti di Misurazione
I tecnici dispongono di alcuni strumenti elementari che siutilizzano nell’elaborazione grafica del progetto e nelleoperazioni di misura e di verifica sul terreno. Fra gli strumentipiù antichi abbiamo:
Il compasso che è lo strumento più diffuso in epoca romana maha origini più antiche, Ovidio ne attribuisce la creazione al
28
nipote di Dedalo, che lo creò per caso. Serve a tracciare uncerchio, i romani conoscevano quattro tipi di compasso: a puntecurve, con perno, con vite filettata, e chiavetta per sceglierel’apertura voluta, di riduzione, con le aste unite da un pernointermedio per fare multipli e sottomultipli di una misura.
La regula, riga pieghevole. Il filo a piombo per indicare unalinea verticale. La squadra per tracciare angoli retti, la perticaper misurare brevi distanze, l’archipendolo (libella) chiamato “livella del minatore” serviva a verificare che un piano fosseorizzontale si usava nelle misurazioni sotterranee.
Strumenti di rilevamento
Ci sono poi strumenti più complessi che si usano per i rilievitopografici:
groma : è il più noto strumento di rilevamento romano, serviva atracciare linee dritte e angoli retti. Era composta da una crocedi ferro con quattro bracci perpendicolari, dai quali pendeva unfilo a piombo; la croce era unita ad un braccio di sostegno mobilee da un’asta di supporto con la punta che si conficcava nelterreno. Uso: l’asta di supporto si conficcava nel terreno vicinoal punto di difrazione da definire e traguardando dai fili dipiombo all’asta stessa si tracciava una linea retta tra i duepunti; Il filo di piombo doveva essere parallelo all’asta. L’unicoesemplare di questo strumento è stato trovato a Pompei nel 1912.Questo strumento si utilizzava per tracciare allineamenti nellezone pianeggianti.
Nelle zone montuose invece, si usava la tecnica chiamatacultellatioche consisteva nell’effettuare misurazioni orizzontalia gradini.
Poi c’era il chorobates che si usava nei lavori di livellamento.Non abbiamo nessun esemplare, ma Vitruvio ce lo descrive: è unregolo di legno lungo circa sei metri, ha due lacci all’estremitàe ai lati del regolo vi sono due fili di piombo appesi.
29
Vi era poi la dioptra che serviva per il rilevamento del terreno,degli acquedotti, ma anche per le osservazioni astronomiche. Eraun disco graduato, montato su un piedistallo. Infine ci stava lalivella ad acqua che era costituita da una sbarra di legno lunga 2metri che conteneva un condotto collegato all’estremità con duetubi di vetro.
Vitruvio
L’opera di Vitruvio, il De Architectura, è stata realizzata probabilmentetra il 29 e il 23 a.c., nel periodo in cui Augusto progettava unrinnovamento generale dell’edilizia pubblica, ed’è ad egli dedicata.
Quest’opera ci permette di conoscere il livello delle conoscenze tecnichepossedute nell’antichità ed i metodi costruttivi degli antichi romani.
Secondo Vitruvio l’acqua è un bene primario necessario all’esistenza manon sempre si trovavano corsi d’acqua che sgorgano naturalmente, per cuiquando questi non ci sono è necessario scavare sottoterra per trovare lesorgenti e portarle in superfice.
Ovviamente bisogna scavare nelle zone più umide e non dove il terreno èarido, la zona giusta si trova guardando l’esalazione dei vapori.
Dopo aver trovato il posto giusto si scava un pozzo e se si trova unasorgente di acqua, se ne scaveranno altri intorno e le acque verranno
30
convogliate in un solo punto mediante condotti sotterranei che devonoessere in pendenza.
L’acqua salubre e gradevole va ricercata soprattutto nelle zone dimontagna, dove essa è protetta dal sole grazie alla presenza di unamaggiore vegetazione.
Per verificare la salubrità delle acque deve essere fatta una analisidelle persone che abitano in quella zona, se hanno un colorito florido,un fisico robusto e gli occhi non infiammati, allora l’acqua è buona.
Inoltre bisognava verificare se il condotto era in pendenza per evitarezone piane dove l’acqua si sarebbe ristagnata e brusche cadute avrebberodanneggiato il condotto. Per verificare la pendenza si inserivano deicapisaldi nel tracciato.
Secondo Vitruvio l’acqua piovana è la più leggera in quanto vienefiltrata dall’aria e torna a terra ma per essere eccellente deveattraversare tubi di terracotta e la cisterna deve essere chiusa.
Secondo Plinio invece l’acqua piovana è la più sporca. Entrambi peròsostenevano che il sapore dell’acqua dipendeva dalla natura del terrenoin cui scorre.
Secondo Vitruvio le acque termali hanno virtù terapeutiche, secondoPlinio non è così, anzi è sbagliato stare troppo tempo nell’acqua calda.
Solitamente un acquedotto è alimentato da uno o più sorgenti, le acquevengono convogliate in bacini di raccolta, Caput Aquae, in muraturaimpermeabilizzata, e poi defluiscono nella Piscina Limaria che è unavasca di sedimentazione che purifica l’acqua; essa può essere costituitada una vasca oppure da più vasche comunicanti fra loro. L’acqua viene poidistribuita attraverso tubi di terracotta o tubi di piombo. Col passaredei tempi i canali di terracotta sono andati in disuso, perché con ilmiglioramento delle tecniche, l’acqua scorreva direttamente nei canali.
I tubi di terracotta venivano utilizzati solo per portare all’acqua nelleabitazioni private, perché l’acqua che scorre in tubi di terracotta è piùsalubre rispetto all’acqua che scorre i tubi di piombo.
Negli acquedotti antichi i condotti erano sotterranei per cui non c’erapericolo che venissero distrutti, ma poi quando si acquisto maggiorcontrollo sul territorio, furono costruiti tratti esterni che erano
31
utili a distribuire l’acqua su lunghi percorsi. Quando fra la sorgente ele mura della città vi è una montagna, è necessario scavare una galleria.
I romani costruirono gallerie senza pozzi e gallerie con pozzi. Legallerie senza pozzi sono quelle che hanno 2 uscite, cioè che vengonoscavate da entrambi i lati della montagna.
In alcuni casi si ricorreva a gallerie, ma se fra la città e la sorgented’acqua c’erano le montagne, si scavano gallerie sotterranee.
A tal proposito ricordiamo l’esperienza del Librator (oggi diremoingegnere idraulico)Namio Dato che per realizzare l’acquedottoToudjaSaldae cominciò a scavare da entrambi i lati della montagnama i due scavi non si incontrarono mai. Successivamente egli fuchiamato per seguire da vicino i lavori che aveva progettato.Ricordiamo inoltre un resoconto del suo intervento che ci è giuntoinaspettatamente intatto.
Inoltre Plinio e Svetonio ricordano la galleria sotterranea fattacostruire da Claudio per prosciugare il lago Fucino, e Tacitoricorda che quando l’opera fu inaugurata, si notò che c’era statoun errore nel calcolo delle quote dell’emissario ( Lago Albano)per cui in alcune zone l’acqua ristagnava.
Nel I sec. a.c. si costruivano sempre più acquedotti su arcate chepermettevano di raggiungere altezze considerevoli e richiedevanouna minore quantità di materiale, però essi erano più soggetti arestauro perché sottoposti alle intemperie.
Un esempio di acquedotto costruito su più arcate è il Pont DuGard(Acquedotto di Nimes).
Per portare l’acqua a quote più elevate, si usò il sistema delsifone rovescio che però fu usato raramente dai romani perchecostava troppo e necessitava di continua manutenzione.
Il più antico sifone rovescio che abbiamo è quello dell’acquedottodi Alatri ( ciità alleata dei Romani). È inoltre moltointeressante l’acquedotto di Aspendos che è costruito in modomolto particolare: il sifone è diviso da due torri idraulichemolto distanti fra loro, vi sono quindi 3 sifoni consecutivi. Alla
32
fine del percorso la condotta dell’acquedotto si immetteva in unbacino di distribuzione CastellumDividiculum dal quale iniziava larete urbana. Vitruvio dice che l’acqua veniva distribuita nellacittà attraverso tre vasche collegate al serbatoio:
La prima vasca distribuiva l’acqua alle fontane pubbliche; La seconda vasca la distribuiva alle terme e ai teatri
(pagando un’imposta allo stato); La terza vasca alle case;
Il sistema indicato da Vitruvio, però, non risolveva i problemilegati alla distribuzione dell’acqua nelle città che avevano piùacquedotti.
In queste città l’acqua dal castello principale andava ai castellisecondari e poi cominciava la distribuzione sia pubblica cheprivata.
L’erogazione avveniva attraverso calici ( tubi conici di bronzoche quindi non si deformavano) secondo Frontino la quantitàd’acqua dipendeva dalla posizione del calice.
Al calice si collegavano Tubi di piombo ( che venivano costruitidai plumbarii) di diverso calibro;
Vitruvio e Plinio classificavano i tubi in base al pesoconsiderando, quindi, la larghezza della sfoglia di piombo;Frontino invece classificava i tubi in base al diametro, abbiamoinfatti la Tabula Fistularium. Sulle tubature si potevano incidereil nome dell’imperatore, del procurator aquarum, del costruttoreetc.
Costruzione di una Galleria
Vitruvio è un architetto che ha avuto poco successo in campoprofessionale, ha scritto molto ma costruito poco. La sua oper è
33
costituita da 7 libri di architettura, 1 libro di idraulica, 1 diastronomia, 1 di meccanica.
In essa egli ci descrive la costruzione di una galleria, chepresenta difficoltà di varia natura. I lavori si articolano in 2fasi:
Fase Progettuale: Prevede il rilievo topografico, il calcolo dellequote, la definizione del tracciato, la determinazione dei costi.
Il progetto di costruzione di un acquedotto era affidato a unarchitetto, coordinato di un librator ( ingegnere idraulico),accanto a loro c’era il discens librato rum un apprendistaingegnere.
Secondo Vitruvio l’architetto doveva avere una formazioneculturale completa che riguardasse tutte le discipline; dovevaessere dotato di abilità manuale e doveva avere pazienza, virtù esperanza.
Ovviamente non era facile trovare architetti con tutte questecaratteristiche.
Il ruolo dell’architetto era di grande importanza sociale.
Fase Esecutiva: prevede l’impianto di cantiere, l’inizio deilavori, la soluzione dei problemi che si presentano, ilcompletamento dell’opera e il collaudo.
La costruzione di un acquedotto era affidata ad appaltatori,redemptores; successivamente la manutenzione era affidata alcurator aquarum. Per impiantare il cantiere c’era invece bisognodi molti specialisti del settore: muratori, costruttori di archi,tagliatori di pietre, intonacarsi, stuccatori.
Per realizzare un acquedotto si utilizzavano diversi strumenti chesono descritti nell’opera di Vitruvio.
Egli nel libro X descrive tre macchine di sollevamento.
La prima è la più semplice e serve a sollevare carichi minori, ècostituita da una sola carrucola e da una corda da trazione. La
34
seconda serve a sollevare carichi maggiori, le travi sono piùlunghe e resistenti, vi sono tre coppie di carrucole, al posto delvermicello c’è il tamburo. La terza è la più complessa, ha trecorde di trazione e tre carrucole; è chiamata polyspatos, inquanto è ai numerosi giri delle pulegge che deve la sua estremacomodità e rapidità.
In base al peso che si doveva sollevare si sceglieva la gru piùadatta; per scavare una galleria di solito si sceglievano macchineelevatorie semplici.
Strumenti di Misurazione
I tecnici dispongono di alcuni strumenti elementari che siutilizzano nell’elaborazione grafica del progetto e nelleoperazioni di misura di verifica sul terreno.
Tra gli strumenti utilizzati dagli antichi romani abbiamo:
il compasso (circinus) che è lo strumento più diffuso in epocaromana, ma ha origini più antiche, Ovidio ne attribuiscel’invenzione al nipote di Dedalo che lo ha creato per caso.
Serve a tracciare un cerchio, i romani conoscevano 4 tipi dicompasso:
a punte curve; con perno; con vite filettata e chiavetta per scegliere l’apertura
voluta di riduzione, con le aste unite da un perno intermedioper fare multipli e sottomultipli di una misura.
La regula(modulus), riga pieghevole.
Il filo a piombo (perpendiculum) per indicare una lineaverticale, era un semplice filo metallico con un peso a una delleestremità.
La squadra (norma) per tracciare angoli retti, era uno strumentodi uso comune dello structor.
35
La pertica (decempeda) per misurare brevi distanze, le estremitàerano ricoperte di capsule di bronzo, costituite di un gambograduato e da una base cilindrica piatta, liscia o con rigatureeffettuate al tornio, in modo permettere l’allineamento di unapertica con un'altra delle stesse dimensioni.
L’archipendolo (libella) chiamato “livella del minatore” servivaa verificare che un piano fosse orizzontale, si usava nellemisurazioni sotterranee, era formato da due aste unite aun’estremità da un perno e collegate da un’asta trasversale,disposta parallelamente ad un piano orizzontale di riferimento. Alcentro dell’asta orizzontale era segnata una tacca e al perno erafissato un filo a piombo: la superficie misurata risultavaperpendicolare quando il filo intersecava la tacca.
Strumenti di Rilevamento
Ci sono poi strumenti più complessi che si usano per i rilievitopografici:
Groma è il noto strumento di rilevamento romano, serviva atracciare linee dritte e angoli retti. Era composta da unacroce di ferro con quattro bracci perpendicolari, dai qualipendeva un filo a piombo (perpendiculum); la croce era unitaad un braccio di sostegno mobile e da un’asta di supporto conla punta che si conficcava nel terreno. La groma siutilizzava fissando l’asta si supporto in prossimità delpunto di stazione da definire o già esistente, si facevaruotare il braccio mobile fino a portare l’asse della croce acoincidere con questo punto. Facendo poi ruotare la croce inmodo da orientare un suo asse nella direzione prescelta, erapossibile procedere all’operazione di traguardo da un filo dipiombo al corrispondente opposto. L’unico esemplare di questostrumento è stato ritrovato a Pompei nel 1912. Questostrumento serviva a creare allineamenti nelle zonepianeggianti.
36
Nelle zone montuose invece si usava la tecnica dellaCultellatio che consisteva nell’effettuare misurazioniorizzontali a gradini, in zone scoscese.
Chorobates si usava nei lavori di livellamento. Non abbiamonessun esemplare, ma Vitruvio nel libro VII dellaArchitettura, lo descrive. E’ stato utilizzato per misurarepiani orizzontali e fu particolarmente importante nellacostruzione di acquedotti.Simile alla moderna livella a bolla, il chorobates consistevain una trave di legno di 6 m di lunghezza detenuto da duegambe di sostegno e dotato di 2 linee a piombo ad ogniestremità. Le gambe sono unite alla trave da due astediagonali con tacche incise. Se le tacche corrispondenti allelinee piombo abbinate sui due lati, ha mostrato che il fascioera livello. Sulla parte superiore della trave, unascanalatura o canale è stata intagliata. Se la condizione eratroppo vento per i fili a piombo per lavorare in modoefficace, il geometra può versare acqua nella scanalatura emisurare il piano per il controllo del livello dell'acqua.
Dioptra serviva per il rilevamento dei terreni, degliacquedotti etc. ma anche per le osservazioni astronomiche.Era un disco graduato montato su un piedistallo.
Livella ad Acqua era costituita da una sbarra di legno lungadue metri che conteneva un condotto collegato alle estremitàcon due tubi di vetro; ogni tubo era incassato in unalloggiamento di legno con scala nature interne, nelle qualiscorreva una piastrina con una fessura, che si regolava conuna vite fino a raggiungere il livello dell’acqua.
Il rilievo e l’allineamento si effettuano con le livelle:
La più semplice è costituita da un tubo di vetro o di legnolungo un palmo e mezzo
Un’altra livella è costituita da una lastra metallica a formatriangolare; sul lato di base vi sono due ganci alleestremità a cui soni legate due corde e al centro vi è unacordicella di seta con un piombino. Si usava tendendo le due
37
corde, il piombino deve mantenere una linea verticale se ilpiano è allineato, se invece si sposta, il piano non èallineato.
Tecnica di Scavo di una Galleria
Alla base della tecnologia idraulica romana c’erano probabilmentele tecniche costruttive dei Qanat utilizzati nel mondo arabo; iquanat forse sono stati usati in Grecia e a Roma con le dovutemodifiche e miglioramenti.
Il Quanat è un acquedotto di pianura sotterraneo costruito interritori aridi, per condurre le acque, attraverso un percorsosotterraneo, in un luogo prestabilito nel quale dovranno essereutilizzate.
In questo modo, si potevano trasportare grandi masse di acquasenza il rischio che evaporassero a causa del grande calore. Latecnica dei Quanat è nata nelle zone iraniane e si è poisviluppata in tutto l’oriente; queste gallerie si diffusero poi intutto il mondo antico.
Vitruvio ci dice che spesso nelle gallerie vi erano infiltrazionid’acqua, crolli o la presenza di gas. Per quanto riguarda leprime, nelle gallerie con pozzi, l’acqua si drenava con macchineaspiranti.
Nelle gallerie a doppio ingresso, invece, si scavava la galleriesuperiore lievemente in salita, in modo da incontrare l’altrotratto come su un dosso.
Per quanto riguarda le esalazioni di gas Vitruvio dice che siccomela terra emanava gas strani, prima di fare scendere gli addettiallo scavo, bisognava calare una lampada accesa, se questarimaneva accesa si potrà scendere senza pericolo, se invece sispegneva, a destra e a sinistra del pozzo si scavavano due bocchedi aereazione, cosi le esalazioni di disperdevano.
Il gas all’interno del pozzo si può produrre per tre motivi:38
Eccessiva profondità del pozzo; Lunghezza della galleria eccessiva; Putredine della terra;
Gallerie senza PozziLe gallerie a due uscite ( o senza pozzi) erano, di solitediritte, mentre quelle con i pozzi potevano anche non esserlo. Lapiù famosa gallerie senza pozzi è quella dell’acquedotto di Samo,costruita dall’architetto Eupalino nel 6° sec. a.c. e descritta daErodoto.
Ha due aperture ( cioè è scavata da entrambe le estremità) ed’ècostruita da due gallerie sovrapposte (nord-sud).
Per fare incontrare le due gallerie furono fatti più tentativi, efu più volte corretta la direzione. È la prima galleria costruitacon un approccio basato sulla geometria, Eupalino nella galleriaNord aumentò l’altezza del soffitto, nella galleria Sud modificòil livello del pavimento. È un grande capolavoro dell’ingegneriagreca.
L’Acquedotto Formina di Narni fu costruito forse da Nerva nel Isec. d.c., portava l’acqua alle mura di Narni. La galleria furealizzata scavando dalle due parti del monte e dopo vari scavigli operai riuscirono a far incontrare le due parti dellagalleria. Gli operai utilizzarono per questa galleria ilchorobates e la groma; è lunga 13 km.
L’acquedotto di Toudja-Saldae si trova nell’attuale Algeria ed’èstato costruito dal librator Nonio Dato. Durante i lavori cifurono dei problemi, in quanto gli operai non seguirono ilpercorso stabilito e le due parti non si incontrarono. Volendorisolvere il problema, il governatore della città mandò unalettera al librator ( ingegnere idraulico) che aveva progettatol’opera che andò sul posto seguendo i lavori di persona. È raropoter attribuire un acquedotto a colui che lo ha progettato, maquesto è stato firmato. Ancora oggi troviamo all’inizio della
39
condotta una iscrizione che cita l’autore con un immagine di treteste di donna che rappresentano la pazienza, la virtù e lasperanza ( che erano le tre caratteristiche di un ingegnere).
L’emissario del lago di Albano e quello di Nemi sono statirealizzati con la stessa tecnica utilizzata per la galleria diSamo. L’emissario di Albano fu costruito quando il lago di Albanoinondò le terre circostanti proprio quando non vi erano statepiogge. Quindi grazie all’emissario i terreni potevano essereirrigati. Secondo Cicerone è stato costruito nel periodo dellaguerra contro Veio, quando le acque del lago crebbero molto; unnobile di Veio disse che, secondo una profezia, Veio non potevaessere presa finché il lago non fosse giunto a traboccare, se leacque fossero state scaricate in mare sarebbe stata una rovina ,se si fossero incanalate sarebbe stata una vittoria per il popoloromano. Fu così scavato l’emissario del lago di Albano. La stessavicenda viene raccontata da Livio.
L’emissario del lago di Nemi riversa le acque del lago nella valledi Ariccia. Fu realizzato nel 4° sec. a.c. ad opera degli Aricini.In tempi remoti si era visto che il livello delle acque del lagoera alto e le acque sommergevano gran parte del terreno, oggichiamato il giardino, dove si trovavano le rovine del tempio diDiana. La storia dell’emissario si intreccia proprio con il cultoa Diana. Gli Aricini volevano costruire un tempio ( quellodedicato a Diana appunto) sul lago e per farlo avevano necessitàdi rendere stabile il livello delle acque; iniziarono a scavare dadue parti opposte con la dolabella (dalla parte del lago e dallaparte della valle di Ariccia) si incontrarono. Dove terminava ilcondotto le acque venivano incanalate in un fosso chiamatocunicolo Aricino. Il condotto segue un percorso tortuoso checonduce ad una galleria molto grande, dove è possibile trovare unadiramazione (detta discenderia) che porta al punto di partenzadello scavo, infatti per non scavare sotto al livello del lagol’ingresso veniva effettuato a diversi metri sopra quello attuale.Nel condotto ci sono poi 3 bypass (deviazioni o diramazioni) 1creato per sostituire un tronco di galleria ostruito da una frana,e due per arginare la durezza di estese zone basaltiche.
40
Nel medioevo l’emissario si riempì di terra a causadell’alluvione. Nel 1927-28 ci furono lavori di restauro. Adifferenza del lago di Albano dove abbiamo molti riferimentistorici e bibliografici, l’emissario del lago di Nemi vienericordato solo da Strabone. Anche l’emissario del lago di Albanoha tre bypass.
Galleria con Pozzi
Vitruvio ci fornisce delle informazioni relative alla costruzionedi gallerie, egli dice che se fra le mura della città e lasorgente ci sono delle montagne, bisognerà costruire una galleriasotterranea.
Se la montagna è fatta di roccia o tufo, il canale si può scavaredirettamente, se invece il suolo è di terra o sabbia si eleverannonella galleria pareti con soffitti per condurre l’acqua, e ipozzi saranno costruiti in modo da trovarsi ogni 240 piedi.
Le gallerie con pozzi sono molti più numerose di quelle a scavocieco (senza pozzi), esse sono costruiti allo stesso modo deiqanat. I pozzi permettono di entrare all’interno della galleria edestrarre il materiale di scavo attraverso le macchine disollevamento.
Alla fine dei lavori i pozzi venivano coperti costruendo unmuretto sul quale viene poi posta una lastra, per evitare chepossano entrare nella galleria acqua piovana e terriccio.
Rimuovendo la lastra si poteva entrare in galleria per effettuarelavori di manutenzione.
L’Acquedotto di Bologna
Contrariamente alla loro abitudine di costruire gli acquedotti mediantecondotti aerei, i Romani realizzarono questa opera completamente ingalleria (in parte nella roccia ed in parte in terreni rinforzati).
41
L'acquedotto risale al I secolo a.c. probabilmente grazie all'imperatoreAugusto. L'acquedotto attinge dal fiume Setta in quanto i romanicompresero fin da allora che le acque del Reno non erano pure e potabilicome quelle del Setta.
L'acquedotto preleva l'acqua presso Sasso Marconi e, passando daCasalecchio di Reno sotto il Colle della Guardia, la convogliava ingalleria fino a raggiungere l'Aposa, (sotto Palazzo Pizzardi nellaodierna via d'Azeglio angolo via Farini) dove una vasca di decantazione(castellum) schiariva l'acqua prima di distribuirla a tutta la cittàmediante il sistema tipicamente romano delle fistulae aquariae (tubi dipiombo o terracotta).
Circa un quinto dell'approvvigionamento idrico attuale della cittàdi Bologna è fornito da un acquedotto che è attivo da circa 2000anni.
I romani si approvvigionavano di acqua dal tunnel che scavaronointorno al 100 a.C. Essi avevano capito già all'epoca che l'acquadel Setta era più pura di quella del Reno. Infatti l'acquedottoprelevava l'acqua a Sasso Marconi dal fiume Setta e la convogliavafino al palazzo oggi dell'Ente Ferrovie, angolo via d'Azeglio convia Farini, dove c'era una vasca di decantazione. Poi da lìattraverso il sistema delle fistulae aquariae (tubi di piombo) sidistribuiva l'acqua a tutta la città. Resta da dire che, secondouno studio del 1897 del prof. Floriano Brazzola, l'antico cunicoloromano continuava fino a Rioveggio, ma di questo tratto si sonoperse le tracce.
I numeri di questa grande opera di ingegneria sono impressionanti.Il condotto ha una sezione libera di m. 0,6×1,9. Funziona agravità naturale con pendenza dell'1‰, per una lunghezza di 18chilometri e un dislivello di 18 metri. Oggi misura precisamente18.147 metri per effetto delle modifiche effettuate durante ilavori di riattivazione. Il tunnel oggi finisce dove c'è lacaserma dei Vigili del Fuoco in viale Aldini, dopo avereattraversato, a decine di metri sotto terra, il territorio diCasalecchio di Reno e i colli di San Luca e di Casaglia.
42
Alle cure degli ingegneri e alle maestranze dei romani seguironole invasioni barbariche, così che non si fecero più opere dimanutenzione. Quindi l'acquedotto cominciò a gettare meno acqua,fino a restare praticamente chiuso. Poi se ne perse anche ilricordo.
Il primo a parlare di questa grande opera idraulica fu nel XIVsecolo il frate Leandro Alberti, nelle Historie di Bologna esuccessivamente ne scrisse Cherubino Ghirardacci nella suaHistoria di Bologna, ma le loro informazioni erano alquantoimprecise. L'acquedotto fu realmente riscoperto da SerafinoCalindri, il primo a studiare con impegno il tunnel e adescriverlo nel suo Dizionario corografico, georgico,orittologico, storico relativo alla Montagna e collina delterritorio bolognese. Ma devono passare ancora molti anni primache si arrivi, dopo 15 secoli d'abbandono, al recupero delmanufatto. I lavori furono eseguiti tra il 1876 e il 1881; lacerimonia di inaugurazione si tenne il 5 giugno 1881. Autore delrestauro fu l'ing. Antonio Zannoni. I giornali dell'epoca dannogrande spazio all'avvenimento. Oltre agli articoli di cronaca,pubblicano un'ode all'acqua, un distico Vincenzo Mignani e unapoesia di Corrado Ricci dedicate all'ing. Zannoni.
L’emissario del Fucino
Nel 137 a.c. raggiunse il limite di 171,5 krnq, come testimoniato daGiulio Ossequente che informa che il lago "cinque miglia inondò". In etàcontemporanea dal Settecento, ma soprattutto nel 1816, raggiunse l'areadi 165.1 kmq, tanto da affrettare le opere di prosciugamento borboniche.L'innalzamento dei livelli lacustri nel corso della prima metà del Isecolo a.c. dovettero portare ad un primo progetto di intervento diregolarizzazione dei limiti lacustri in età cesariana. Questo fenomeno diescrescenza lacustre era probabilmente dovuto alla diffusione dellapratica pastorale della transumanza "orizzontale" e del relativo tagliodei boschi, attività che a partire dalla seconda metà del Il secolo a.C.;avevano portato nell'alveo lacustre un maggiore aff1usso di acquetorrentizie e ghiaia dai vicini monti.
43
Questo fenomeno aveva aumentato il livello medio delle acque e resoimpossibile la coltivazione dei terreni intorno al perimetro lacustre.Questo spiega le possibili richieste di intervento da parte dellaaristocrazia terriera locale (albense e marsa) e la realizzazione delprogetto cesariano, mai portato a termine per la morte dello stessoimperatore. Nel 52 d.C. l'imperatore Claudio portava a termine, oltre cheil prolungamento della via Valeria dal Fucino fino ad Ostia Atemi (laClaudia Valeria), il suo Emissario che regolerà gli incostanti livellilacustri con un limitato prosciugamento del Fucino, prosciugamento chepermetterà la coltivazione regolare delle terre emerse.
Un lavoro colossale per l'epoca voluto dall'imperatore, basato in parte,come abbiamo già detto su un precedente progetto cesariano, allo scopo direndere coltivabile l'area intorno al lago e di rendere maggiormentenavigabile il Liri. Lo scopo di Claudio non era quello di prosciugare illago (siccare) ma quello di emittere (Dione Cassio) cioè di renderestabilmente coltivabili le terre intorno al lago. Della grandiosa operaromana parlano Plinio il Vecchio, Svetonio, Tacito e Cassio Diane (l-IIsecolo).
La durata dei lavori fu di ben 11 anni, dal 41 al 52 d.C., con l'impiegodi 30.000 opcrai. Ma le difficoltà sono ben espresse da Plinio ilVecchio, l'unico testimone oculare dell'impresa, con l'accuratadescrizione del traforo, dell'estrazione dei materiali di risulta daipozzi con apposite macchine, la galleria scavata nella solida roccianella quasi totale oscurità; cose che colpirono lo studioso romano «quceneque concipi animo nisi ab iis, qui videre. neque enarrari humanosermone possunt!» (ti: it.): «che non possono essere concepite se non dachi le vide, né il linguaggio umano è capace di descriverle!».
Una stima credibile del numero degli operai che lavorarono nell'internodel condotto idraulico si può riconoscere nel numero di 2.400 unità esolo con il concorso di militari, curatori, artigiani, direttori edaffossatori del canale a cielo aperto si può raggiungere la somma di30.000 uomini descritta da Svetonio. La prima inaugurazione del 52 d.C.con la grandiosa naumachia, fu alterata dall afflusso debole delle acquenella vasca d'ingresso quanto furono tolte le paratie lignee, ma sostan-zialmente il deflusso fu lento e modesto, tanto da organizzare unaseconda inaugurazione dopo che il direttore dei lavori claudiano, illiberto Narcisso, aveva approfondito le condotte di presa sul terrapieno.
44
La seconda apertura avvenne alcuni mesi dopo, coronata anch' essa da unospettacolo gladiatorio, ma il maggiore afflusso fece sobbalzare il palcoligneo imperiale e provocò la rottura di parte della diga d'ingresso.Naturalmente i successivi interventi di restauro fino alla morte diClaudio, resero stabile l'emissario che assolse alla sua funzione distabilizzare i livelli lacustri. Con Traiano abbiamo notizia diinterventi sull' opera con i suoi lavori di restauro durati dal 114 al117, restauri necessari che portarono a riparare, nell'interno delcondotto sotterraneo, i danni provocati da una frana fra i pozzi 19 e 20.
Dell'impresa idraulica di Traiano sul Fucino abbiamo ad Avezzano unatestimonianza diretta da un'iscrizione su base marmorea ricavata sottol'altare maggiore della ricostruita chiesa collegiata di San Bartolomeodi Avezzano, di cui abbiamo conoscenza a partire dal 1651. In essavengono ricordati i lavori dall'imperatore per il miglioramento delleopere di prosciugamento del Fucino e per aver recuperato i terrenirioccupati dal lago dal cattivo funzionamento delle opere di presa: Imp.Ca:sari.Divi / Nervale.Fil.Nervale / Traiano.Optimo / Aug.Germanico /Dacico.Parthico / pont. max. trib. pot.XXI.im[p.xIIj / coso VI. patri.patria: / Senatus.Popolusq.Rom[anll5) /ob. Reiciperatos. agros.et.possess [ores. reductos] / quos.lacus. Fucini. violen[tia.exturbaratj212(ti: it.): "All'imperatore Cesare, figlio del Divo Nerva, Nerva TraianoOttimo Augusto Germanico Dacico Partico, Pontefice Massimo, munito ditribunizia potestà per la XXI volta, [acclamato imperatore 12 volte,]console per la VI volta, Padre della Patria, il senato e il Popolo Romano(dedicò) per aver recuperato i campi e [aver ricondotto] i proprietariche la violenza del lago Fucino [aveva cacciato]".
Non possiamo non immaginare che nei proprietari, possessores, di cuifurono recuperati i campi invasi dalle acque fucensi, fossero anche gliAvidii e i Marcii albensi con i loro possessi presso l'Emissario". Solocon i sostanziali miglioramenti di Adriano che «Fucinum emisit» fra il120 e il 137, si ebbe il prosciugamento di gran parte del lago adesclusione della depressione del Bacinetto, depressione che rimase atestimoniare per tutta l'età antica l'esistenza del Fucino. Con i lavoriadrianei fu realizzato il lungo canale all'aperto che dall'imboccodell'Incile fu portato fino a quota 650, quindi ai bordi delladepressione del Bacinetto (Borgo Ottomila) con una pendenza dell' l %.
Quindi fu Adriano che portò a termine l'opera di prosciugamento parzialedel lago, tale da giustifìcare la frase di Elio Sparziano nella suaHistoria Augusta che l'imperatore «Fucinum lacum emisit»,
45
A controllo dell'emissario, dall'età di Claudio fino al IV secolo, fuaddetto un distaccamento (Statio) di marinai (classiarii) della flottapretoria di Ravenna, mentre la cura era affidata a procuratori imperiali.Di quest'ultimi conosciamo Onesimo e Nobile, due liberti imperialiincaricati di controllare il funzionamento dell'opera.
Del primo sappiamo che eresse sulla testata dell'Emissario all'Incile unpiccolo tempio dedicato al culto della famiglia dei Cesari, ai Lari ed alFucino: Onesinus.Aug(usti).lib(ertus). / procturator). /fecit.imagi-nibus.et. / Laribus. cultoribus / Fucini. Del secondo conosciamol'iscrizione funebre che era murata nell'altare della chiesa di SantoPadre in Penna del "Cunicolo maggiore" dell'Emissario:Nobilis.proc(urator) / Augiusti) / hic.humatus. est. (tr. it.): "Nobile,procuratore dei Cesari (per l'Emissario) è qui sepolto't-!". Nel tardoimpero, nella seconda metà del IV secolo, la Marsica fu interessata da unterribile terremoto che provocò, oltre le prevedibili distruzioniurbanistiche nei centri municipali, l'interruzione del canale di presa acielo aperto ed il crollo delle opere sulla testata dell' lncile dell'emissario romano sul Fucino.
Le recenti ricerche di Carlo Giraudi dell' Enea hanno dimostrato che neltardo impero romano il canale all'aperto fu diviso in due tronconi da duefaglie provocate da un forte terremoto: la faglia più interna al lagoprovocò una contropendenza sul canale verso Pescina, causando il lentoinsabbiamento dello stesso. La data del terremoto è stata ora precisatadal Letta in un suo recente studio e collocata verso l'anno 375 comedocumentato anche dalle pesanti distruzioni segnalate a Benevento perquesta data. La testimonianza di un terremoto che segnò la prima fase diabbandono dell'insediamento urbano sul finire del IV secolo, è attestataanche ad Alba Fucens, secondo il Mertens, in base a livelli stratigraficidatati da monete di Costanzo Il e Valente riferibili nell'arco compresofra il 346 e il 367.
Il Letta ha invece dimostrato che i livelli stratigrafici e le monetedatano il terremoto poco dopo la metà del secolo poiché nella città èpresente un miliario di Magnenzio del 350-352 ed ancora nel 362 sidedicavano sul foro di Alba opere pubbliche, come documentato da unaiscrizione colà rinvenuta: quindi il terremoto che determinò la fine delfunzionamento regolare dell'emissario romano va datato fra il 362 e il380 d.C.
46
L'Emissario fucense è certamente da considerare una delle più grandiopere idrauliche del mondo antico con il suo canale di presa a cieloaperto rivestito di pali di legno, il suo lncile monumentale, il canalecoperto scavato nelle rocce del Monte Salviano e sulle argille dei PianiPalentini per una lunghezza di km 5,653 e dotato di ben 40 pozziverticali, 10 cunicoli inclinati (discenderie) e testata di sboccomonumentale sul corso del fiume Liri a Capistrello. Lo sbocco sul Liri èancora ben visibile in località Pisciacotta (Capistrello) con il suo altofornice e il sentiero dell'antica via Traiana e Sorana sovrastante lostesso con il suo ponticello legato sulla destra a scavalcare "ilFossato".
Ebbene sulla stesso lato, a destra, si notano i resti di una parete diroccia regolarizzata con tagli artificiali che, probabilmente, doveva inantico contenere un monumento celebrativo dell'impresa imperiale diClaudio. Le prime testimonianze sull'area dell' Emissario nel medioevosono del IX secolo, ma fanno riferimento a documenti del secoloprecedente, atti in cui l'area e definita col termine di Forme. Il primodocumento è dell'anno 873, con la chiesa sancti Antimi ad Formas postasul versante palentino, capistrellano, a contatto dei cunicoli maggioridell' Emissario romano, di cui abbiamo successiva notizia nel settembredel 981-82, col nome di Sancti Antini in Vicu.
L’Acquedotto Romano del Serino
E' noto che una delle prime opere pubbliche di Augusto inCampania, fu la costruzione di un grandioso Acquedotto, che dallesorgenti del Serino, sull'altopiano Irpino, portava abbondante efresca acqua ai principali Centri della Campania, ed attraversava,ora con condotti sotterranei, ora con ponti, canali, tutta lapianura campana, lungo la direttrice che toccava Sarno, PalmaCampania, S. Gennaro Ves., Casalnuovo, San Pietro a Patierno,Napoli, Pozzuoli, fino al Capo Miseno, alla famosa piscinaMirabile. Costruita in età augustea a Miseno, sul lato nord-ovest
47
del Golfo di Napoli, originariamente era una cisterna di acquapotabile. Il nome attuale le fu attribuito nel tardo Seicento. Sitratta della più grande cisterna nota mai costruita dagli antichiromani, ed aveva la funzione di approvvigionare di acqua lenumerose navi della Classis Misenensis, poi divenuta ClassisPraetoria Misenensis Pia Vindex, che trovava ormeggio e ricoveronel porto di Miseno.
La cisterna venne interamente scavata nel tufo della collinaprospiciente il porto, ad 8 metri sul livello del mare. A piantarettangolare, è alta 15 metri, lunga 72 e larga 25, con unacapacità di 12.600 metri cubi. È sormontata da un soffitto convolte a botte, sorretto da 48 pilastri a sezione cruciforme,disposti su quattro file da 12.
L'acqua veniva prelevata attraverso i pozzetti realizzati sullaterrazza che sovrasta le volte con macchine idrauliche, e da quicanalizzata verso il porto. La struttura muraria è realizzata inopus reticulatum e, così come i pilastri, è rivestita di materialeimpermeabilizzante. Una serie di finestre lungo le pareti lateralie gli stessi pozzetti superiori provvedevano all'illuminazione eall'aerazione dell'ambiente. Sul fondo, nella navata centrale, sitrova una piscina limaria di 20 metri per 5, profonda 1,10 metri,che veniva utilizzata come vasca di decantazione e di scarico perla pulizia e lo svuotamento periodico della cisterna.
La piscina mirabilis costituiva il serbatoio terminale di uno deiprincipali acquedotti romani, l'acquedotto augusteo, che portaval'acqua dalle sorgenti del fiume Serino, a 100 chilometri didistanza, fino a Napoli e ai Campi Flegrei. Parte dell'anticacisterna è aperta ai visitatori.
Fino al settembre del 1966, nessuno aveva scoperto a che punto sidiramasse la biforcazione dell'Acquedotto Augusteo, verso Nola,quando per un caso fortuito, si è potuto stabilire con certezza illuogo della deviazione. Infatti il Prof Michele Davino (scomparsoalla fine del 1987), scriveva nel 1983 che durante i lavori discavo per la costruzione di una vasca terminale di una fognatura,nel territorio di S. Gennaro Vesuviano (località Rummafavi), venne
48
alla luce un piccolo edificio, sbriciolato ben presto dalle ruspeche scavavano. Si salvò soltanto una lapide con una iscrizione e,cosa più importante, 8 Fistule di piombo, che confermavanol'esistenza, se non altro, dell'abitazione di un custode od altroaddetto all'Acquedotto.
E' da premettere che alla fine degli anni 1930, nella stessa zona,nel fondo di un contadino, che era intento, in piena estate, allairrigazione del proprio campo, si aprì una voragine, dalla qualevenne alla luce un antico condotto in muratura: non era altro cheun ramo dell'antico Acquedotto Augusteo.
Ma sia dell'edificio del 1966, che del condotto del 1930 non si èsaputo più niente, mentre l'iscrizione, salvata da unprovvidenziale intervento, non era altro che un cippo sepolcrale,di relativa importanza, di un certo Caio Rufo.
Negli 1930, durante i lavori di allacciamento della SorgenteAquaro all'Acquedotto di Napoli, fu scoperta una grande e bellaiscrizione dell'età di Costantino, che ci dava notizia circa irestauri compiuti negli anni 323/324 (D. C. ), ed i nomi delleCittà che beneficiavano dell'Acquedotto, che erano (forse inordine di importanza): Pozzuoli, Napoli, Nola, Atella, Cuma,Acerra, Baia e Miseno; mentre nel 1939, un'altra lapide, scopertaalle sorgenti dell'Acquedotto Napoletano, confermava i lavoriportati a termine nel 330, da Costantino il Grande e dai figliCrispo e Costantino II. Nelle città menzionate manca, naturalmentePompei, perché già sepolta dall'Eruzione del 79 D. C.
Anche Matteo della Corte, direttore degli Scavi di Pompei, nel1939, scriveva che il fondatore dell'Acquedotto Romano del Serinonon era stato Claudio, bensì Augusto e che la vera denominazionefosse: Acquaeductus Fons Augustei.
D'altra parte nei pressi di Montella (Alta Irpinia), si trova unalapide che porta la seguente iscrizione: Acquaeductus FonsAugustei... Puteoli, Neapolis, Nola, Atella, Acerrae, Cuma,Misenum.
49
Ai tempi dello storico Nolano Ambrogio Leone (1500), Nola nonaveva altre sorgenti, o altre acque, tali da poter alimentare unacquedotto urbano, ed i ruderi di un piccolo acquedotto nelVallone di Lauro, non poteva che raccogliere scarse acque, per lopiù periodiche, che certamente non potevano far fronte allenecessità dei cittadini di Nola! Questi ruderi, scorti dal Leonenei pressi di San Paolo Belsito, potevano forse appartenere ad unramo dell'Acquedotto Augusteo, che staccandosi dal formaleprincipale, portava acqua a Nola seguendo le falde della collinadi Cicala, e raggiungeva un serbatoio nei pressi di San Giovannidel Cesco (ai piedi della stessa Cicala).
Poco più di trenta anni dopo la morte del Leone (1560 circa),l'Architetto Pietro Antonio Lettieri, in una sua accorta relazionefatta al Viceré don Pedro di Toledo (come riferisce il Giustinianinel Dizionario del Regno di Napoli), scriveva " et sopra dettaAcqua, non solamente serviva alli Loci sopradd., ma alcuni altriatteso dal pred. Acquedotto, che era nello piano de Palma, se nederivava un ramo de formale, che andava alla Città di Nola; equesti anni passati, quanno Nola fò fortificata, fu ritrovataditto formale ne li fossi della Città".
Dopo tre secoli nel 1840 l’ingegnere Abate decise di ripristinarel’acquedotto per garantire l’approvvigionamento idrico della cittàdi Napoli; Abate ricostruì il tracciato dell’acquedotto e ritennenecessario fare l’espurgo delle condotte. Nel 1861 il consigliomunicipale di Napoli diede i soldi ad Abate per permettergli difare degli studi necessari a ripristinare la condotta.
Abate fornì una descrizione dell’intero percorso dell’acquedottoed individuò i tratti da rifare. Egli pensava che l’acquedottopotesse essere diviso in sei grandi tratti:
Il primo andava dalle Sorgenti Acquaro a Pelosi fino aContrada (AV);
Il secondo passava sotto i monti e il piano di Forino (AV)con una galleria di circa sei metri, opera davverostraordinaria per la durezza nella roccia nella quale erastata scavata;
50
Il terzo percorre tutta la piana di Montoro (AV), fino aMercato San Severino ed arriva a Castel San Giorgio;
Il quarto tratto attraversa il Monte Paterno con una gallerialunga circa due chilometri, che fu oggetto di studiodell’Abate che voleva conoscere il modo in cui i romanifacevano passare gli acquedotti attraverso i monti. Eglientrò nei cunicoli e individuò molti pozzi spiraglio e alcunicunicoli obliqui.
Il quinto tratto comincia con una caduta di circa 24 metri;si dirige ad Episcopio e alla Foce del Sarno.
Il sesto tratto giunge nei pressi di Palma, in questa zona vierano due diramazioni, una per Nola, e l’altra per Pompei. Lacondotta principale si dirige verso Napoli, toccando SanGennaro Vesuviano, Nola, Marigliano, Pomigliano d’Arco, SommaVesuviana e Santa Anastasia. Il suo percorso terminava nellaPiscina Mirabilis, sopra il porto di Miseno.
L'Acquedotto Nolano si distaccava dal formale principaleall'altezza di Palma Campania, e con un condotto sotterraneoraggiungeva il Castello distributore di Nola, mentre un altroandava ad alimentare la Città di Pompei: l'Acquedotto di Nola,come quello di Pompei, può essere dunque riferito tra gli anni29/26 A. C., al primo ritorno di Augusto dall'Oriente, ma di quelramo Nolano dell'Acquedotto Augusteo, nel Cinquecento, nonrimaneva nemmeno una pietra.
Lo storico Remondini, (XVIII secolo) infine, ci spiega che siraccoglieva l'acqua pubblica, in un luogo chiamato Castello, peruso e comodo della Città di Nola, alla sua custodia era destinatauna persona col titolo di Castellano, ed aveva l'autorità divendere quest'acqua o di donarla, insieme agli Edili Curuli ed iCensori, i quali erano molto severi e castigavano chiunqueviolasse gli acquedotti od il Castello, o ne usurpava maggiorcopia di quella concessa.
Si distribuiva per Tegole, a foggia di canale o di canale a foggiadi incurvate tegole...
51
Vi era una legge ed un decreto, che si concedeva l'acqua dinovanta tegole a persona, cioè quella che sgorgava da un forofatto in un marmo della grandezza di novanta delle memorate misuree non di più.
L’Acquedotto nell’area FlegreaQuesto acquedotto fu costruito probabilmente per rifornire maggiormentel’area flegrea. Questa zona era frequentatissima, ma soprattutto era zonadi villeggiatura, lo stesso Nerone veniva qui a passare le vacanze.Agrippa però nel 37 a.c. fece costruire in questa zona il Portus Iuliusun porto militare che consentisse di allestire una flotta e di addestraregli equipaggi, in vista della guerra navale contro Sesto Pompeo. Percostruire il porto, Agrippa fece tagliare l’istmo costiero del LagoLucrino e lo collegò a lago d’Averno. Ma il Porto Iulius si rivelòinadatto a ospitare un porto militare in quanto le sue acque erano pocoprofonde e molto sabbiose. Questo porto fu utilizzato soprattutto ai finicommerciali, li approdavano le navi granarie provenienti dell’Egitto.
Fu scelto come porto militare Miseno che era collegato al Mar Morto.
L’acquedotto riforniva anche Pompei, anche se non è presente sulla lapidedi Serino perché nel 79 d.c. come sappiamo c’è stata l’eruzione delVesuvio. Pompei è la città che più di tutte ci permette di studiarel’evoluzione del sistema idrico.
Fino all’età di Augusto l’acqua veniva presa da profondi pozzi, conl’arrivo dell’acquedotto cambio il sistema di approvvigionamento, l’acquagiungeva al Castellum aquae, un ripartitore principale, nei pressi diPorta Vesuvio. Siccome vi era un dislivello considerevole tra ilcastellum e il punto più basso della città, questo avrebbe comportato unapressione eccessiva, gli ingegneri fecero convogliare l’acqua verso iserbatoi di piombo ( Castellum Plumbeum) posti su pilastri ( CastelloSecondaria) dal più grande al più piccolo, in questo modo l’acqua perdevapressione prima di essere distribuita.
Ci fu così una grande distribuzione di acqua. La rete idrica fudanneggiata dal terremoto del 62 d.c. e i cittadini dovettero ricorrereall’acqua delle cisterne e dei pozzi.
L’acquedotto serviva come già detto prima anche Nola.
52
Essa è la prima città ad essere rifornita secondo l’epigrafe di Serino.L’approvvigionamento idrico della città è sempre stata al centro di unaparticolare questione: Ambrogio Leone nel suo “ De Nola” aveva sostenutoche nella città giungeva solo l’acqua di un ruscello proveniente daAvella (AV) e quella di un acquedotto din scarsa portata che iniziava aLauro (AV), quindi sosteneva che Nola avesse acqua sufficiente solo asoddisfare i bisogni primari dei cittadini.
Lettieri contestò la tesi di Leone, ma la questione rimase irrisolta.Leone voleva soprattutto dimostrare che erano false le affermazioni diGellio e Servio, i quali, ritenevano che Virgilio, nell’Eneide, avesseomesso il nome di Nola perché risentito in quanto gli era stata negatal’acqua per il suo podere.
Non si sa se sia vero, ma comunque c’erano delle norme, bisognava dareacqua a tante città e alla base navale di Miseno.
Acquedotto di Avellino e BeneventoDalle sorgenti di Serino cominciava un acquedotto che alimentava le cittàdi Avellino e Benevento.
Dal Caput Aquae la condotta si estendeva lungo la valle del Sabato, checosteggiava il Monte Castello e giungeva fino ad Atripalda. Il suo corsocontinuava poi fino a Prata Principato Ultra e giungeva ad AltavillaIrpina, dove si univa a un’altra piccola fonte e raggiungeva la Rocca deiRettori.
53