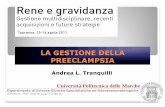gestione delle maxiemergenze in area sismica
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of gestione delle maxiemergenze in area sismica
gestione dellemaxiemergenzein area sismica
D. Pantalone – a. agostini – a. De Paola – i. grieco – r. gattai
edizioni minerva medica
gestione dellemaxiemergenzein area sismica
Dal territorio all’ospedale
ISBN: 978-88-7711-845-5
© 2016 – EDIZIONI MINERVA MEDICA S.p.A. – Corso Bramante 83/85 – 10126 TorinoSito Internet: www.minervamedica.it / e-mail: [email protected]
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Antonella AgostiniCorso di laurea di Infermieristica, Università degli Studi di Firenze
Alberto De PaolaCorso di laurea di Infermieristica, Università degli Studi di Firenze
Riccardo GattaiDipartimento di Chirurgia e Medicina Translazionale, Università degli Studi di Firenze
Ilaria GriecoCorso di Laurea di Infermieristica, Università degli Studi di Firenze
Desiree PantaloneDipartimento di Chirurgia e Medicina Translazionale, Università degli Studi di Firenze
prefazione
Nell’Aprile 2013 si è tenuto il Seminario “La gestione delle maxiemergenze in area sismica dal territorio all’ospedale, nell’adulto e nel bambino” la sede è stata l’Autodromo Internazionale del Mugello nella sala stampa per le prime due giornate e Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lo-renzo per la giornata conclusiva. La scelta della sede è caduta nell’area del Mugello in quanto zona sismica. L’evento è stato organizzato dalla Università degli Studi di Firenze come semina-rio congiunto per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con il Corso di Laurea in Infer-mieristica. Il seminario, inoltre, era aperto agli Specializzandi della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e alle altre Scuole di Specializzazione in area Emergenza e Urgenza. Data la rilevanza dell’argomento e la partecipazione di esponenti di altre Regioni ed Esteri, il seminario è stato accreditato tramite l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggia per gli ECM (18 ECM), e aperto alla partecipazione del personale sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi stessa e della AS 10 di Firenze.
All’evento hanno partecipato:− il Dr. L. Bussolin, Direttore Trauma Center Pediatrico Azienda Ospedaliero Universitaria
A. Meyer Firenze;− il Dr. G. Calzeroni, Direttore f.f. SS Coordinamento maxi emergenza aziendali ASF 10;− la Dr.ssa S. Cimbanassi, Dipartimento Trauma Team Ospedale Niguarda Ca’ Granda,
Milano;− il Dr. M. Cipriani, Staff Direzione Struttura Organizzativa 118 Firenze;− il Dr. D. De Luca, Direttore Unità funzionale Gestione Emergenze Grandi Opere;− il Dr. M. De Luca, Referente Progetto di simulazione AOU Meyer;− la Dr.ssa M. Ghinaglia, Coord. infermieristico DEU Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano;− il Dr. S. Grifoni, Direttore SODC PS-Osservazione breve, Azienda Ospedaliero Universi-
taria Careggi;− il Dr. F. Grossi, Resp. Simulazione Emergenza, Università degli Studi di Firenze;− il Prof. A. Leppaniemi, Direttore del Dipartimento di Chirurgia d’Urgenza, Mehilati Ho-
spital, Università di Helsinki, Finland;− il Dr. E. Lumini, Resp. Unità Prof. EBM e Ricerca, Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi;− il Dr. M. Mangini, Resp. Simulazione Emergenza, Università degli Studi di Firenze;− il Dr. A. Marzio, Centrale Operativa 118 DEUA, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano;− il Dr. A. Peris, Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione d’Emergenza, Azienda Ospedalie-
ro Universitaria Careggi;
iV gestione delle maxiemergenze in area sismica
− la Dr.ssa S. Pagliai, Coordinatore Infermieristico Struttura Organizzativa 118 Firenze;− il Dr. G. Tugnoli, Direttore SSD Chirurgia del Trauma, AUSL Bologna;− il Dr. A. Vigna, Assessorato politiche per la salute Regione Emilia Romagna;− il Prof A. Vignoli, Prof. Ordinario, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Uni-
versità degli Studi di Firenze.
indice
Prefazione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… iii
caP. 1 il mugello come area sismica ……………………………………………………………………………………………………………………… 1A. Vignoli
caP. 2 autosoccorso in appennino in caso di catastrofe ………………………………………………………………………… 15M. Cipriani, S. Pagliai
caP. 3 esperienza di applicazione della pianificazione delle maxi emergenze nel territorio emilia romagna ………………………………………………………………… 22M. Vigna
caP. 4 la pianificazione della maxi emergenza in regione lombardia …………………………………………… 28A. Marzio
caP. 5 la competenza culturale nelle maxi emergenze …………………………………………………………………………… 37E. Lumini
caP. 6 simulazione di maxi-emergenza in area sismica ………………………………………………………………………… 41M. Mangini, F. Grossi
caP. 7 il trattamento delle grandi emergenze: trattamento su base regionale e ospedaliera …………………………………………………………………………………… 46A. Leppäniemi
caP. 8 l’esperienza dell’ospedale maggiore di Bologna dal due agosto ad oggi ……………………… 53G. Tugnoli
caP. 9 PeimaF - Piano di emergenza interna per il massiccio afflusso di malati ……………………… 59S. Cimbanassi, M. Ghinaglia
caP. 10 Piano di emergenza intraospedaliera: esperienza aoU-careggi ………………………………………… 62S. Grifoni, E. Aletto
Vi gestione delle maxiemergenze in area sismica
caP. 11 icU, un modello per le maxi emergenze: partire dalla organizzazione della risposta al trauma ………………………………………………………………… 71A. Peris
caP. 12 Piano sanitario aziendale per le emergenze. azienda sanitaria 10 Firenze …………………… 76G. Calzeroni, A. Lagi
caP. 13 esperienza dell’aoU meyer, il paziente pediatrico nel trauma ……………………………………………… 82L. Bussolin
caP. 14 la simulazione nell’emergenza pediatrica ……………………………………………………………………………………… 100M. de Luca
Il Mugello è un’area sismica conosciuta già nella storia più antica.Nel 1542 un terremoto danneggiò gravemente gran parte del castello di Scarperia, e altri luo-ghi tra cui Gagliano, Sant’Agata, Barberino, Bosco ai Frati, Luco, provocando la morte di circa 150 persone. Fu traslata a Firenze l’immagine della Madonna del Sasso che ricevette offerte e omaggi dalle famiglie cittadine. Nel 1919 il terremoto colpì una vasta area dell’Appennino Tosco-Emiliano, in particolare il Mugello. Le prime scosse si avvertirono nella mattinata di questo giorno d’estate del primo dopoguerra con epicentro nel paese di Vicchio; la scossa maggiore fu di grado IX della scala Mercalli, gli esiti furono drammatici: al bilancio finale si contarono oltre 100 morti, 400 feriti e migliaia di senzatetto.Più di recente, nel settembre 2007, l’area del Mugello è stata interessata da una sequenza sismi-ca durante la quale sono stati registrati sedici eventi con magnitudo massima di 2,4 Richter.Il 1° marzo 2008, alle ore 08:43 ora italiana, una scossa di magnitudo 4,2 Richter è stata avvertita in un raggio relativamente ampio intorno alla zona del Mugello, fra i comuni di Barberino del Mugello, Vernio e Castiglione dei Pepoli. Nel corso delle ore successive è seguito
Fig. 1.1. Rischio sismico.
A. Vignoli
Il Mugello coMe area sIsMIca
cap. 1
� gestIone delle MaxIeMergenze In area sIsMIca
uno sciame sismisco caratterizzato da altre due scosse di intensità moderata (rispettivamente di magnitudo 4,1 Richter registrata alle ore 09:43 locali e di magnitudo 4.0 Richter registrata alle 11:43 locali) e molte altre di bassa intesità. Il 14 settembre 2009, alle ore 22:05 ora italiana, una scossa di magnitudo 4,2 Richter è stata avvertita in un raggio relativamente ampio intorno alla zona del Mugello.La posizione e l’intensità dei terremoti non è distribuita uniformemente sulla superficie terre-stre ma sono concentrate lungo linee ben definite. Il generarsi di terremoti segue il fenomeno della tettonica a placche. La tettonica a placche studia i meccanismi di generazione dei terre-moti lungo i contorni delle crosta terrestre. La crosta terrestre è costituita da una serie di strati sottili ma relativamente rigidi che scorrono l’uno rispetto all’altro. I margini di placca sono di tre tipi a seconda del movimento che vi si verifica. Le placche scorrono l’una rispetto all’altra, margini a scorrimento laterale, le placche si avvicinano l’una dall’altra, margini convergenti o subduzione e le placche si allontanano l’una dall’altra, mar-gini divergenti.Il movimento terrestre genera delle onde sismiche che vengono classificate in (Fig. 1.4):• onde P (primarie);• onde S (secondarie);• onde di superficie (Raleygh o Love).
Fig. 1.2. Tettonica a placche: studia i meccanismi di generazione dei terremoti lungo i con-torni delle placche. La crosta terrestre è costituita da una serie di strati sottili e relativamente rigidi che scorrono l’uno rispetto all’altro (da: http://it.wikipedia.org).
Il Mugello come area sismica �
Fig. 1.3. Margini di placca: 1) astenosfera; 2) litosfera; 3) punto caldo; 4) crosta oceanica; 5) placca in subduzione; 6) crosta continentale; 7) zona di rift continentale (nuovo margine di placca); 8) placca a margine convergente; 9) placca a margine divergente; 10) placca a margine trasforme; 11) vulcano a scudo; 12) dorsale oceanica; 13) margine di placca convergente; 14) strato vulcano; 15) arco isola; 16) placca 17) astenosfera; 18) fossa (da: http://it.wikipedia.org).
Fig. 1.4. Onde sismiche.
� gestIone delle MaxIeMergenze In area sIsMIca
scale dI IntensItÀ dI un terreMoto
Scala magnitudo RichteR
Quantifica l’energia sprigionata dal fenomeno sismico su base strumentale:
ML = log10 A - log10 A0
dove A è l’ampiezza del movimento del suolo registrata da un sismografo Wood-Anderson; A0 è l’ampiezza del movimento del suolo registrata da un sismografo Wood-Anderson durante un evento convenzionale
Scala magnitudo del momento SiSmico
Conosciuta anche con l’acronimo inglese MMS (Moment Magnitude Scale), è utilizzata dai sismologi per misurare le dimensioni dei terremoti in termini di energia scatenata. Fu svilup-pata negli anni settanta come aggiornamento della scala Richter degli anni trenta. Come la scala Richter, la scala di magnitudo del momento sismico è una scala logaritmica, pertanto a un incremento di un’unità di magnitudo corrisponderà un aumento moltiplicativo dell’energia coinvolta; essendo i valori della scala pari ai 3/2 del logaritmo decimale del momento sismico (a meno di una costante), un terremoto è circa trenta volte più energetico per ogni unità di magni-tudo di differenza (più precisamente 10 3/2 ≈ 31,6 volte).
Scala meRcalli
Definisce l’intensità del terremoto in funzione degli effetti che questo provoca sulle cose e/o sulle persone. Il I grado della scala corrisponde a un terremoto non avvertito da nessuno, men-tre il XII grado corrisponde alla distruzione totale.La scala Mercalli, così come la scala Magnitudo, per essendo utile da un punto di vista compa-rativo tra terremoti diversi, non fornisce dei criteri per il progetto di strutture antisismiche.
progettazIone delle strutture antIsIsMIcHe
Ai fini della progettazione è utile la storia temporale dell’accelerazione del terremoto prodotta dalla trasmissione delle onde sismiche e dalla forza di inerzia da loro prodotta. Quest’ultima si propaga dalla base di un edificio fino ai piani superiori in modo crescente, e subisce anche l’influenza del tipo di suolo dove sono costruiti gli edifici. Le componenti dell’accelerazione (Fig. 1.5), forniscono una descrizione completa di un terremoto infatti contengono informa-zioni su: • ampiezza: è caratterizzata dal valore di picco dell’accelerazione;• frequenza: è determinata tramite la trasformata di Fourier dell’accelerazione; • durata: è definita dall’intervallo di tempo tra il primo e l’ultimo picco di accelerazione
superiori ad una certa soglia.
Il Mugello come area sismica �
In corrispondenza di strati deformabili le accelerazioni di picco aumentano e il contenuto in frequenza si sposta verso frequenze più basse. Le previsioni dei terremoti il dove, quando, con quale intensità, non sono presumibili. Non sono disponibili modelli che consentono di rispon-dere a queste domande sulla base dei dati relativi alla sismica storica. Ma sono possibili esempi di previsioni, c’è una probabilità del 62% che almeno un terremoto di magnitudo superiore a 6,7 si verifichi nella zona della baia di San Francisco prima del 2032. C’è una probabilità com-presa tra 10% e il 21% che si verifichi una rottura lungo la foglia alpina della Nuova Zelanda prima del 2021. C’è una probabilità compresa tra 27% ed il 55% che si verifichi un terremoto di magnitudo 7 a Istambul prima del 2031.L’evoluzione storica della normativa sismica in Italia fa riferimento alla prima norma sismica pubblicata in Italia, il Regio Decreto 18 aprile 1909, che prevedeva tra i sistemi costruttivi consentiti per le nuove costruzioni la muratura animata (nota anche come muratura baracca-ta), usata in Calabria sin dalla fine del 1700 proprio come “sistema antisismico” efficace contro i terremoti. Questo sistema consisteva nella realizzazione di edifici a più piani con pareti costituite da intelaiature formate da elementi verticali, orizzontali e diagonali di legno, riem-pite con porzioni di muratura. La muratura baraccata era inoltre l’unica soluzione ammessa all’epoca per la realizzazione di edifici multipiano (Fig. 1.6). Dopo il terremoto del 29 dicembre 1908 a Reggio Calabria e Messina (XI grado della scala Mercalli con 80.000 morti), fu emanato il Regio Decreto n.193 del 18 Aprile 1909 che diede inizio alla classificazione sismica del territorio italiano, poi ampliata con il RD 15.07.1909 n. 542. Vengono tradotte in legge le esperienze maturate in ambito scientifico. Le norme tec-
Fig. 1.5. Accelerazione.
� gestIone delle MaxIeMergenze In area sIsMIca
niche, escludevano la possibilità di edificare su siti inadatti; consentivano di edificare nuove costruzioni solo con specifiche tecnologie usando muratura animata, squadrata, listata e telai. Imponevano il rispetto di dettagliate regole costruttive l’utilizzo di cordoli, sbalzi e strutture non spingenti. Limitavano l’altezza degli edifici e il numero dei piani, prescrivevano di con-siderare forze statiche orizzontali e verticali proporzionali ai pesi per tener conto dell’azione sismica, e definivano la larghezza minima delle strade e gli spazi tra gli edifici (Tab. 1.I).Nel 1916 iI Decreto Legge n. 1526, e i Regio Decreto n. 2089/1924, n. 431/1927 e n. 431 del 1927 introdussero due categorie sismiche (la I e la II) a differente pericolosità.Nel periodo 1935-1937 vennero emanate le nuove norme sulle costruzioni in zona sismica, RDL 2125/1937. Il 25 novembre veniva emanata la legge 1962, n° 1684: “Provvedimenti per l’edilizia con parti-colari prescrizioni per le zone sismiche”. La Legge 64 del 1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” è una pietra miliare nel percorso delle norme, stabilisce un nuovo quadro di rife-rimento per la normativa sismica (per chi fosse interessato a completare le conoscenze sulla normativa si consiglia di consultare i Decreti Ministeriali che stabiliscono esattamente i campi in cui tali decreti dovranno essere applicati: edifici, ponti, dighe). Nel 1975, 1981, 1984 e 1996, sono stati emanati Decreti contenenti norme tecniche specifiche per la progettazione nelle zone sismiche. Dal 1984 è stato introdotto il coefficiente di protezione sismica con la suddivisione degli edifici in livelli di protezione in base all’uso:
Fig. 1.6. Evoluzione storica della normativa sismica
tabella 1.I. coMunI InserItI nella lIsta delle zone sIsMIcHeAreA etneA (terremoto 1911) rD 573/1915
Marsica (30.000 morti) 1915
Alto Adriatico, Riminese 1916
Val Tiberina 1917
Appennino Romagnolo 1918
Mugello, Toscana Meridionale, Garfagnana 1920
Colli Albani 1927
Friuli 1928
Territorio Bolognese 1929
Irpinia, Marche 1930
Monte Baldo 1932
La Maiella 1933
Monti Nebrodi 1967
La Valle del Belice 1968
Tuscania 1971
Friuli 1976
Calabria 1978
Valnerina 1979
Basilicata 1980
Il Mugello come area sismica �
• 1) abitazioni correnti;• 2, 3) affollate;• 3, 4) edifici strategici (tra questi sono compresi gli ospedali).
Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a diversa severità (classificati complessivamente dai Decreti Ministeriali, emanati dal Ministero dei Lavori Pub-blici tra il 1981 e il 1984, 2965 comuni italiani su di un totale di 8102, vale a dire il 45% della superficie del territorio nazionale, nel quale risiedeva il 40% della popolazione). Nel 2003 sono stati emanati i criteri per una nuova classificazione sismica del territorio nazio-nale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territo-rio, ossia sull’analisi della “probabilità” che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo, generalmente 50 anni da evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo (Fig. 1.7).Il 20 marzo 2003 viene pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 (Gazzetta Ufficiale n.105, 08-05-2003). Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, alle quali lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (D.lgs 112/98 e DPR 380/01 – “Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone (Tab. 1.II). Le aree nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale sono a severità decrescente (zona 1, zona 2, zona 3, zona 4).
� gestIone delle MaxIeMergenze In area sIsMIca
tabella 1.II. classIFIcazIone sIsMIca attuale
Zona 1È la zona più pericolosa, dove in passato si sono avuti danni gravissimi a causa di forti terremoti
Zona2Nei comuni inseriti in questa zona in passato si sono avuti danni rilevanti a causa di terremoti abbastanza forti
Zona 3I comuni inseriti in questa zona hanno avuto in passato pochi danni. Si possono avere scuotimenti comunque in grado di produrre danni significativi
Zona 4È la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse
Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, che diviene zona 4, nel quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. In tal modo, i numeri della nuova classificazione diventano: • 725 comuni in zona 1;• 2344 comuni in zona 2;• 1544 comuni in zona 3;• 3488 comuni in zona 4.
L’attività di prevenzione di maggior rilievo è stata condotta attraverso l’attuazione dell’Ordinanza 3274/2003. Le novità normative introdotte con l’ordinanza sono state recepite e affinate nelle re-centi Norme Tecniche delle Costruzioni (DM. 14 gennaio 2008 Ministero delle Infrastrutture). Un capitolo importante per la prevenzione riguarda la sicurezza delle opere strategiche per la protezione civile (ospedali e centri operativi misti) e rilevanti (scuole, edifici con grandi affollamen-ti e ponti soggetti a grande traffico).
Fig. 1.7. Classificazione sismica.
Il Mugello come area sismica �
Per promuovere questa attività è stato istituito, (Legge Finanziaria del 2003), un fondo dedi-cato al finanziamento delle verifiche sismiche e degli interventi di riduzione della vulnerabilità delle opere strategiche e rilevanti di competenza dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali. Questa iniziativa ha attivato circa 7000 verifiche di opere pubbliche e 200 interventi di ade-guamento sismico, e ha sensibilizzato le amministrazioni pubbliche al problema del rischio sismico.Le norme tecniche e la classificazione del territorio sismico sono alla base della prevenzione per la costruzione di nuovi edifici. Gli obiettivi della normativa sono:• protezione delle vite umane (obiettivo etico);• limitazione dei danni culturali (obiettivo economico); • salvaguardia dell’operatività di strutture importanti per la protezione civile (obiettivo logi-
stico).
Requisiti prestazionali:• requisito di non collasso, per azioni di progetto non associate ad eventi sismici o comunque
rari non si deve verificare alcun collasso globale o locale, in modo che a seguito dell’evento stesso, la struttura, pur subendo danni di grave entità conservi la propria integrità e la pro-pria capacità portante;
• requisito di limitazione del danno per azioni di progetto, associate ad eventi sismici fre-quenti, fa si, che non si verifichino danni tali da causare la perdita di funzionalità della struttura con conseguenti interruzioni d’uso.
Nel 2005, la principale novità della norma consiste, nell’abbandono del carattere convenziona-le e puramente prescrittivo, a favore di un’impostazione prestazionale, dove gli obiettivi della progettazione vengono dichiarati assieme alla giustificazione dei metodi che vengono utilizzati allo scopo. Quale che sia la metodologia di calcolo utilizzato, il fine ultimo di una corretta progettazione è il raggiungimento di un prestabilito livello di sicurezza dei riguardi delle prestazioni attese in funzione dell’importanza dell’opera e della sua vita utile.I concetti base nelle costruzioni dei nuovi edifici sono la sicurezza nei confronti di stati limite, vita utile di progetto e classi d’ importanza, robustezza nei confronti di azioni accidentali, dura-bilità dell’opera.“Norme tecniche per le costruzioni” (DM 14/01/2008): definiscono i principi da adottare per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni nei riguardi delle prestazioni ri-chieste in termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità secondo il metodo semiprobabilistico agli Stati Limite. Si intende per stato limite una condi-zione superata la quale la struttura in esame o uno dei suoi elementi costitutivi non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. Sono norme di carattere “prestazionale”, ossia si prefiggono degli obiettivi, cioè i livelli di sicurezza da raggiungere, mentre per i metodi utilizzati per raggiungere tali obiettivi si lascia libertà di scelta al progettista il quale dovrà giustificare in modo adeguato le scelte operate.Le azioni sismiche di progetto sono fornite a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione che è definita convenzionalmente in termini di accelerazione orizzontale massima attesa e ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione orizzontale.
Il Mugello come area sismica 11
In Italia la “pericolosità sismica di base” è stata determinata su tutto il territorio nazionale dal-l’INGV (PROGETTO INGV-DPC S1) attraverso un reticolo di riferimento con maglia di passo minore di 10 km per periodi di ritorno ricadenti in un intervallo di riferimento compreso tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi (dati consultabili sul Sito Internet http://esse1.mi.ingv.it/). La classi�cazione sismica del Mugello fa riferimento alle testimonianze del terremoto del 1542 e del 1919 più quelli del settembre 2007 del 1° marzo 2008 e del 14 settembre 2009 (Fig. 1.8).
L’aggiornamento della classi�cazione sismica della regione toscana è stato eseguito in attuazio-ne delle o.p.t.c.m. 3519/2006 ed ai sensi del DM 14 gennaio 2008. L’analisi sismica alla base del presente aggiornamento ha prodotto un superamento della zona 3s, nella quale erano stati inseriti i comuni a bassa sismicità, e in base ad un controllo sui territori comunali adiacenti alle aree appenniniche che in Toscana, costituiscono le zone a maggiore pericolosità sismica si è giunti ad una proposta di aggiornamento della classi�cazione sismica cosi riassumibile: Per i comuni di Stazzema,Villa Basilica, Marliana, Pelago e Talla si propone l’innalzamento alla zona sismica 2. I rimanenti comuni (168), classi�cati con deliberazione GRT n°431 del 19 giugno 2006 in zona sismica 3 e 3s possono essere confermati in zona sismica 3. Non si ritiene, in�ne, di apportare modi�che per ciò che concerne i comuni già classi�cati con Deliberazione GRT n.431 del 19 giugno 2006 in zona sismica 2 e in zona sismica 4. In tale ottica in data 6 agosto la Giunta Regionale ha approvato la proposta di “Regolamento di attuazione dell’arti-colo 117, comma 2, lettera g della legge regionale 3 gennaio 2005 n°1 (Norme per il governo del territorio). Veri�che nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a veri�ca”. Tale regolamento prevede una distinzione della zona 3 in fasce di pericolosità al �ne di di�erenziare l’entità dei controlli in maniera proporzionale alla pericolosità del sito:• fascia A = ag >0,15 g percentuale di controllo pari al 40% dei preavvisi;• fascia B = 0,15 g <ag <0,15 g percentuale di controllo pari al 10% dei preavvisi;• fascia C = ag <0,15 g percentuale di controllo pari al 5% dei preavvisi.
L’altro elemento del rischio sismico da prendere in considerazione è la vulnerabilità, cioè la propensione degli edi�ci a subire danni al veri�carsi di un evento sismico. Prendendo in analisi le caratteristiche delle abitazioni esistenti possiamo valutarne la vulnerabilità. Considerando solo le zone con la vecchia classi�cazione, il 60% delle abitazioni non è stato realizzato tenendo conto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Considerando anche l’ultima classi�cazione introdotta con l’Ordinanza n.3274 del 2003, buona parte degli edi�ci costruiti in zona non classi�cata circa il 64%, sono anch’essi da considerarsi non protetti.I programmi di adeguamento e miglioramento sismico del patrimonio edilizio esistente ha creato delle schede per il rilievo della vulnerabilità, che valuta la propensione degli edi�ci a subire danni al veri�carsi di un evento sismico. Sono già state messe a punto varie schede per il rilievo della vulnerabilità sismica degli edi�ci a seconda della tipologia strutturale a cui essi appartengono. Inoltre, con il passare degli anni, sono stati proposte modi�che alle schede esi-stenti e sono state studiate e sperimentate nuove schede per una valutazione speditiva di I livel-lo (schede conoscitive senza valutazione numerica) e II livello o schede delle carenze strutturali (schede più dettagliate che consentono una valutazione numerica). Quelle di maggior rilievo sono state messe a punto dal S.S.N. e dal G.N.D.T. La valutazione numerica indica l’ indice di vulnerabilità V che rappresenta la qualità sismica dell’edi�cio.
1� gestIone delle MaxIeMergenze In area sIsMIca
L’ultimo elemento che determina il rischio sismico è l’esposizione intesa come quantità e valore dei beni che sono presenti nell’area soggetta al evento. Si può suddividere in: prima dell’evento, intesa come la quantità ed entità dei beni esposti, (potenziali danni all’edificio strutturali e non struttu-rali, perdita di efficienza del servizio e delle vittime) e dopo l’evento, cioè il valore delle deprivazio-ni causate dal terremoto, perdite economiche, artistiche, culturali, vittime, feriti e senza tetto. L’esposizione sismica è il primo problema da affrontare per valutare correttamente il rischio sismico, è l’analisi di ciò che è esposto a questo rischio. Gli elementi esposti al rischio sono costituiti da tutto ciò che è stato realizzato dall’uomo, la cui condizione e il cui funzionamento può essere danneggiato, alterato o distrutto dall’evento sismico. Il primo obiettivo di un programma generale di protezione dai terremoti è la salvaguardia della vita umana. Per questa ragione è molto importante valutare il numero delle persone coinvolte, ossia dei morti e dei feriti. I motivi che determinano la perdita di vite umane possono essere di diverso tipo, crollo di edi-fici, ponti e altre costruzioni, ma anche incidenti stradali, attacchi di cuore ed altro. A questi si aggiungono quelli legati a fenomeni innescati dal terremoto, come cadute di rocce, frane, maremoti, inondazioni e incendi. Da alcune statistiche effettuate sui principali terremoti nel mondo è stato rilevato che circa il 25% dei morti causati da un terremoto sono dovuti a danni non strutturali degli edifici e a fenomeni successivi al terremoto e innescati da questo.Generalmente è possibile stimare, con un certo margine di errore e specialmente per i ter-remoti più forti, quante persone sono rimaste coinvolte, attraverso calcoli che si basano sul numero degli edifici crollati o danneggiati. Per poter effettuare queste stime sono necessarie alcune considerazioni sul numero delle persone che abitano nell’edificio, l’orario in cui avviene il terremoto, la capacità di scappare delle persone o di proteggersi, il tipo di coinvolgimento che può subire la persona, morte o ferite e la possibilità di morire anche successivamente alle attività di soccorso. È molto difficile stimare con precisione le conseguenze di un terremoto in termini di vite uma-ne nei diversi momenti del giorno e dell’anno. Il numero di persone che risiedono in un’abita-zione, infatti, varia da regione a regione, dalla città alla campagna e dipende dalle dimensioni della famiglia. Inoltre, durante il giorno, il numero delle persone presenti in un’abitazione varia notevolmente. Negli ultimi 60 anni il numero dei disastri naturali, a livello mondiale, è costantemente au-mentato. Inoltre, l’evento sismico, rappresenta il caso peggiore per il sistema ospedaliero, in quanto è causa sia di un aumento della richiesta clinica dal territorio, sia di una riduzione delle performance del sistema. Inoltre, la valutazione sismica degli aspetti non strutturali in ospeda-le è fondamentale rispetto ad altri edifici. Gli elementi non strutturali, impianti e tecnologia, rappresentano il 90% del valore economico totale della struttura ospedaliera.Data la complessità dei sistemi ospedalieri moderni e vista l’importanza sociale che ricoprono, l’argomento è stato oggetto di studio (A Methodology for Earthquake Risk Mitigation of Health Structures). L’obiettivo del lavoro è stato quello di fornire un sistema di supporto decisionale veloce, economico ed affidabile che fornisse ai decisori istituzionali informazioni chiare ed utili sul rischio sismico dei propri ospedali e sul rapporto costo-efficacia dei principali inter-venti di miglioramento simulati dallo strumento dai punti di vista organizzativi, tecnologici, impiantistici e strutturali.
Il Mugello come area sismica 1�
La metodologia di analisi ha incluso due fasi principali, la quantificazione numerica dell’ impat-to del sisma in termini di feriti e danni attesi alla specifica struttura ed in relazione, successiva-mente, alla valutazione della perdita di performance rispetto al bisogno territoriale. La seconda fase rappresenta il cuore del modello di supporto decisionale che prevede la simulazione degli interventi di riduzione del rischio, includendo il costo ed il miglioramento atteso della perfor-mance rispetto alla situazione attuale. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPCN) ha agito sul versante della pianifi-cazione dell’emergenza, collaborando con il Ministero della Salute all’emanazione di apposite linee guida che collocano la funzione di assistenza sanitaria nell’ambito della più generale risposta del sistema di Protezione civile. In particolare nel 1998 sono state emanate le Linee Guida per la pianificazione intraospedaliera in caso di una maxi emergenza, che definiscono le modalità di gestione dell’ospedale quando si verifichi un massiccio afflusso di feriti a causa di un incidente esterno o un danneggiamento dell’ospedale a causa di un incidente esterno. Nel 2001 sono stati emanati i “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”, che definiscono criteri e principi omogenei fra le regioni al fine di consentire una efficace cooperazione di tutti gli organi deputati a garantire i soccorsi sanitari in emergenza so-vra-regionale. Le raccomandazioni congiunte USA Italia per il miglioramento della sicurezza sismica degli ospedali italiani sono le ATC51 del 2002 e le ATC51-2 del 2003. La valutazione dell’esposizione delle strutture ospedaliere è un tema complesso che può essere affrontato solo con un approccio interdisciplinare tenendo conto della strategicità delle singole realtà mediche e la loro distribuzione territoriale. La valutazione del rischio sismico delle strutture ospedaliere in toscana è nata dalla collabo-razione tra università e la direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà della regione toscana e il coordinamento regionale prevenzione sismica, secondo quanto previsto dall’O.P.C.M. n.3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classi-ficazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. L’O.P.C.M. 3274 richiede la verifica di sicurezza sismica degli edifici pubblici strategici e degli edifici indicati come rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. Gli edifici ospedalieri rientrano in questa categoria.Per l’attuazione del programma hanno collaborato, Università degli Studi di Firenze con Fa-coltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICeA), la Facoltà di Architettura - Dipartimento di Costruzioni e Restauro e l’Università degli Studi di Pisa con la Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria Civile. L’obiettivo era quello di valutare la vulnerabilità sismica dei presidi ospedalieri e la redazione di una graduatoria delle priorità di intervento.La valutazione della vulnerabilità sismica mediante schedatura rappresenta un metodo di in-dagine speditivo su larga scala, non ha lo scopo di valutazioni deterministiche o assolute ed è mirata ad indirizzare indagini più dettagliate ad un livello superiore. Permette di individuare le strutture più vulnerabili e stilare una graduatoria per le verifiche di II livello e delle priorità di intervento.L’elaborazione dei risultati porta a gli Indici di Vulnerabilità che identificano, pur in modo sintetico, il livello di criticità sismica proprio dell’edificio, indipendentemente dal suolo in cui sorge e dalla rilevanza di destinazione d’uso riservata all’Unità Strutturale. Per tener conto della sismicità del suolo in cui sorge ciascuna Unità Strutturale è stato determinato l’Indice di
1� gestIone delle MaxIeMergenze In area sIsMIca
Rischio Sismico che raggruppa in sé due dei tre fattori di rischio nei riguardi del terremoto, ovvero la vulnerabilità dell’edificio e la pericolosità del suolo.È opportuno sottolineare che un’indagine di questo tipo è svolta per parametri sintetici e quin-di, se considerata sul singolo edificio, è ben lungi dall’esaurirne la valutazione di affidabilità sismica. La sua funzione è quella di dare un quadro, desunto da parametri oggettivi e unifor-mi, sull’intero patrimonio edilizio considerato (circa 5.128.000 m3).La presente indagine ha riguardato gli immobili a destinazione ospedaliera o ad essa funzio-nale tralasciando i distretti sanitari, le sedi amministrative, i servizi territoriali ecc. Non sono stati esaminati i fabbricati in via di dismissione o comunque in presenza di ipotesi progettuali di nuove strutture ospedaliere nè gli immobili ospedalieri la cui progettazione è stata eseguita successivamente all’entrata in vigore del D.M. 1984. Gli Indici di Vulnerabilità sono stati raggruppati in istogrammi che evidenziano le criticità sismiche degli edifici sia per numero di Unità Strutturali sia per volume di edificato. I risultati vengono suddivisi per Regione, per Ti-pologia Strutturale e per Azienda. L’analoga elaborazione ha interessato l’Indice di Rischio. Il quadro d’ insieme del rischio sismico degli ospedali toscani è complessivamente soddisfacente. Gli immobili oggetto di indagine coprono un ventaglio temporale piuttosto vasto, anche se la maggior parte delle costruzioni nuove o ristrutturate in modo importante è posteriore agli anni ‘70. Il livello di pericolosità sismico del sito è connaturato da una certa disuniformità del territorio toscano, ravvisando le zone di maggiore intensità sismica nella dorsale appenninica e territori limitrofi. L’indice di rischio sismico fornisce un dato tendenzialmente rassicurante sul patrimonio immobiliare toscano. Tuttavia, vale la pena evidenziare che solo con il DM 14.01.2008, in vigore dal 01.07.2009, vi sono precisi obblighi dei progettisti nei confronti dei cosiddetti “elementi non strutturali”. Se non si riscontrano rischi significativi degli immobili ospedalieri nei riguardi del collasso strutturale, altrettanto non si può sostenere per le eventuali criticità di elementi accessori o non strutturali come pareti di tamponamento o divisorie, cornicioni, gravi appesi, impiantistica varia, grandi infissi o pareti vetrate.Lo studio evidenzia il rischio realistico che, in occasione di un sisma di media intensità se non distruttivo, pur senza danni strutturali significativi possa perdersi l’operatività di una o più parti dei complessi ospedalieri toscani. Il tema è molto ampio, normativamente nuovo e richiede ulteriori sforzi di indagine.