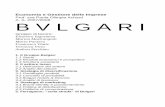Cedui di castagno. Indirizzi per la gestione e la valorizzazione
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Cedui di castagno. Indirizzi per la gestione e la valorizzazione
Realizzazione a cura di:IPLA S.p.A. Istituto per le Piante da Legno e l’AmbienteC.so Casale 476, 10132 Torinowww.ipla.org
Testi e immagini a cura di:Paolo Ferraris*, Pier Giorgio Terzuolo*, Giovanni Boano**, Pier Paolo Brenta*, Giuseppe Della Beffa*, Franco Gottero*,Mario Palenzona*
* IPLA S.p.A. Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente** Museo di Storia Naturale della Città di Carmagnola
Crediti fotografici:La foto a pag. 39 è di Renzo Lencia*; la foto degli alberi morti in piedi a causa del mal dell’inchiostro a p. 40 è di MarcoCorgnati (Regione Piemonte - Settore Foreste); le fotografie delle pp. 31-32 sono state riprodotte per gentile concessio-ne del Parco Naturale Alta Valle Pesio.
Coordinamento del progetto:Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore ForesteDirigente responsabile: Franco Licini, funzionari incaricati: Lorenzo Camoriano e Franca De Ferrari.www.regione.piemonte.it/foreste/it/
Coordinamento editoriale e progettazione grafica:Blu Edizionivia Po 20, 10123 Torinowww.bluedizioni.it
Forma raccomandata per la citazione:FERRARIS P., TERZUOLO P.G., BOANO G., BRENTA P.P., DELLA BEFFA G., GOTTERO F., PALENZONA M., Cedui di ca-stagno: indirizzi per la gestione e la valorizzazione.Regione Piemonte, Blu Edizioni, 2003 pp. 43.
Avvertenze per la lettura:La nomenclatura, le superfici delle Categorie e dei Tipi forestali aggiornati sono contenuti rispettivamente nel volume I Tipiforestali del Piemonte, nelle Norme Tecniche per la Redazione dei Piani Forestali Aziendali e nel report «La carta foresta-le del Piemonte - Aggiornamento 2016». I riferimenti normativi forestali, paesistico-ambientali e Rete Natura 2000 conte-nuti nel presente volume fanno riferimento alle corrispondenti norme in vigore nell’anno di stampa della pubblicazione. Idocumenti normativi e tecnici aggiornati sono consultabili ai seguenti indirizzi (sitografia aggiornata giugno 2018):
• www.regione.piemonte.it/foreste/it/• www.sistemapiemonte.it• www.regione.piemonte.it/parchi/cms
© Regione Piemonte, 2000© Blu Edizioni, 2000Prima edizione, 2000; seconda edizione aggiornata e integrata, 2003.
2
3SOMMARIO
Presentazione 4Premessa 5
Il castagno: caratteri distintivi, ecologia e distribuzione 7Quali obiettivi per i cedui castanili? 12
Produzioni ottenibili 14Quando è possibile migliorare un ceduo di castagno? 16Chiarimenti tecnici per la realizzazione degli interventi 19Le situazioni ricorrenti e le possibili scelte selvicolturali 21
Garantire la perpetuità del bosco valorizzando i popolamenti misti 28La conservazione della fauna 31
La produzione di funghi 33Le normative vigenti 35
Le avversità del castagno 39Bibliografia 4212
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PRESENTAZIONE4I cedui castanili, così ampiamente estesi in Pie - monte, occupano un posto di rilievo fra le for-mazioni forestali, ma forniscono prodotti cheormai hanno limitato interesse economico e so-no quindi frequentemente abbandonati o malgestiti.Valorizzare e indirizzare questi popolamentiverso forme e sistemi a maggiore maturità e sta-bilità perché siano in grado di dare produzio-ni di migliore qualità, conservando e recupe-rando la diversità ambientale, floristica e fau-nistica del territorio, costituisce l’obiettivo
ge ne ra le di lungo periodo cui mirano la Re gio -ne Piemonte e gli altri Enti che operano sulter ritorio.Il presente manuale, riedizione rivista e ag-giornata della precedente ormai esaurita, vuo-le incentivare la gestione e il recupero dei ce-dui castanili, dal momento che l’abbandonodel bosco e, più in generale, delle attività agro-forestali non può che avere ricadute negativeper il territorio e per l’intera comunità.
L’Assessore Roberto Vaglio
PREMESSAIl castagno occupa un posto di rilievo tra le spe-cie forestali piemontesi per la superficie che ri-copre, per l’interesse produttivo e per l’impor-tante funzione ecologica che svolge. L’obiettivodel presente volume è quindi divulgare i risultatie le proposte derivanti da anni di attività di ri-cerca e sperimentazione sul campo condottedall’Istituto per le Piante da Legno e l’Am bien -te di Torino, volte ad approfondire le conoscenzeecologiche e selvicolturali delle formazioni ca-stanili e a favorire l’impiego del legno median-te il miglioramento degli assortimenti ottenibili. I destinatari a cui si è fatto riferimento nella for-
mulazione di questo testo sono soprattutto iproprietari (imprenditori agricoli, altri soggetti pri-vati, Comuni) e gli operatori forestali (le «ditte bo-schive»), ma anche i tecnici impegnati nellaprogettazione e nella direzione lavori di interventiselvicolturali finanziati tramite il Piano di svilup-po rurale o effettuati direttamente dagli Enti pub-blici. Si conclude sottolineando che l’obiettivodegli interventi illustrati è ottenere assortimentidi qualità, richiesti dal mercato, perché da que-sto dipende la spinta al miglioramen to, o al su-peramento, delle tecniche selvi colturali tradi-zionali finora applicate.
5
CARATTERI DISTINTIVI
Il genere Castanea, insieme con il faggio e lequerce, appartiene alla famiglia delle Faga -ceae. In Europa il genere è rappresentato dauna sola specie indigena: Castanea sativa(Mill.). Il castagno è un albero molto longevo,alto fino a 30-35 m, con tronco eretto e robu-sto, assai ramificato a costituire una chioma vi-gorosa, ampia ed espansa.
La corteccia è liscia, brillante, bruno-rossa-stra da giovane, ornata da lenticelle suberosetrasversali, volgente con l’età al grigio olivaceo,in seguito rugosa, profondamente screpolatalongitudinalmente e con andamento a spirale.
Le foglie sono semplici, alterne, brevementepicciolate (0,5-2 cm) e ornate da stipole lineariprecocemente caduche; la lamina fogliare èoblunga, lanceolata (10-20 x 4-8 cm) e breve-mente acuminata all’apice, ornata ai margini danumerosi denti in corrispondenza delle singolenervature secondarie, di colore verde scuro,glabra e lucida nella pagina superiore, più pal-lida e opaca nell’inferiore, con 10-20 paia di ner-vature fortemente rilevate sulla pagina inferiore.
I fiori sono unisessuati e si sviluppano solo afogliazione completa. Quelli maschili sono dis-posti in amenti eretti lunghi 10-20 cm; quellifemminili, solitari o raggruppati in numero di 2-3 (5), sono localizzati alla base delle infiore-scenze maschili e protetti da un involucro ver-de destinato a costituire la cupola. Le piante so-no monoiche e la fecondazione incrociata èentomofila; questo giustifica il grande interes-se del castagno anche come specie mellifera.
Le cupole (volgarmente ricci), dapprima ver-di, indi bruno-giallastre, sono spinescenti esubsferiche, con diametro di 5-6 cm nelle va-rietà selvatiche, e anche di 10 cm nelle varie-tà coltivate per il frutto.
I frutti, comunemente detti castagne, sono
degli acheni, da 1 a 3 per riccio, hanno peri-carpo liscio e coriaceo, biancastro da immaturoindi bruno scuro, ornato alla base da un’ampiacicatrice (ilo) e all’apice da una torcia costitui-ta dai residui degli stili disseccati.
IL CASTAGNO: CARATTERI DISTINTIVI,
ECOLOGIA E DISTRIBUZIONE
Fronda di castagnocon infruttescenze.
71
Le radici sono molto robuste, ramificate manon molto profonde.
Il legno è differenziato con alburno bianco-gial-lastro e durame bruno, semiduro (densità di580 kg/m3), durevole per la ricchezza di tannini(sostanze antisettiche) e facilmente lavorabile.
ECOLOGIA
L’areale primario del castagno è di difficile ri-costruzione perché, grazie alla sua polivalen-za, questo prezioso albero è stato introdotto inmoltissimi Paesi. La sua area colturale è oggivastissima; in Europa si estende a tutto ilMediterraneo, dalla Crimea alla PenisolaIberica. In Piemonte vegeta sulle Alpi e sugliAppennini tra i 200 e i 900 m, raggiungendo ta-lora i 1100 m di quota. È una specie eliofila chetrova le condizioni per il migliore sviluppo neiterreni acidi o almeno neutri, e vive nell’oriz-zonte climacico delle latifoglie eliofile (rovere,roverella e cerro), ma secondariamente anchein quello del faggio, di cui ha sostituito le for-mazioni esistenti per spinta dell’uomo.Costituisce per lo più formazioni pure perché,grazie al vigore dei polloni, soffoca e relega auna posizione subordinata le altre specie ar-boree presenti; tuttavia, con interventi selvi-colturali mirati o eseguiti con particolari atten-zioni è possibile modificarne il comportamen-to, ottenendo popolamenti misti, anche se incontinua evoluzione.
IL CASTAGNO IN PIEMONTE
La superficie forestale del Piemonte, secondoi dati dell’inventario forestale nazionale (IFNI,1985), raggiunge complessivamente 743.000ettari ed è costituita da boschi di latifoglie perben 474.300 ettari, ivi comprese le superficidei boschi misti a prevalenza di latifoglie e i po-polamenti a produzione speciale; della super-ficie occupata da latifoglie i popolamenti go-vernati a ceduo risultano il 72% (342.000 etta-
ri) ed i cedui di castagno puri assommano a64.800 ettari, entità pari a oltre il 17% del tota-le a livello italiano e seconda solo alla Toscana.Passando ad esaminare le conoscenze più ap-profondite specifiche per il Piemonte, dalla car-ta forestale regionale (IPLA, 1981 – scala1:100.000) le formazioni castanili in purezzaoccupano 96.708 ettari, oltre a ben 267.500 et-tari di boschi misti di latifoglie (secondo l’IFNIerano 216.000).La nuova carta forestale regionale (IPLA, 1998- in corso, scala 1:25.000), rilevata sul campoper i Piani forestali territoriali e finora comple-ta per le zone montane e parte delle colline,consente di conoscere con maggiore dettagliola superficie e composizione dei boschi pie-montesi, articolati secondo i tipi forestali re-gionali (IPLA, 1996-2001). Da tale documento,su circa 900.000 ettari di superficie forestale, ri-sultano oltre 196.000 ettari di boschi a preva-lenza di castagno, quindi con attribuzione a ta-le categoria di quasi il 40% dei boschi prece-dentemente indicati come misti; in effetti icastagneti, essendo stati diffusi dall’uomoovunque possibile a spese di querceti e fag-gete, dopo decenni di evoluzione spontaneasono sempre più infiltrati da altre latifoglie,spesso pioniere.La tabella a pagina 9 riporta le superfici dei ca-stagneti suddivise per province; si precisa chei dati non sono del tutto completi per quanto ri-guarda le province di Cuneo e Asti, essendoancora in corso i rilievi nelle colline del Roeroe del Monferrato, che porteranno a minimi in-crementi.Passando ad analizzare i castagneti secondole forme di governo, anch’esse desunte daiPiani forestali territoriali, dominano nettamen-te i cedui semplici matricinati (75%), seguitida quelli composti, mentre sporadici (1265 et-tari) sono i popolamenti inquadrabili come fu-staie da legno. Infine i castagneti da frutto in at-tualità di coltura coprono poco più di 10.000 et-tari; questi, non contemplati negli obiettivi delpresente lavoro, risultano fortemente ridotti ri-spetto alla storica diffusione della coltura spe-cializzata, confluendo dopo l’abbandono nei
88
9cedui misti con altre latifoglie, anche se occorreprecisare che la scala cartografica non con-sente di cogliere numerosi appezzamenti an-cora coltivati da frutto di superficie unitaria in-feriore all’ettaro.Data l’entità della superficie dei castagneti, as-sume particolare interesse accennare alla lo-ro articolazione in Tipi forestali, anche in rela-zione alle diverse potenzialità gestionali, pro-duttive e di successione che questi esprimono;di seguito vengono quindi date alcune indica-zioni generali sulla caratterizzazione dei diver-si Tipi, rimandando alle schede in fase di pub-blicazione sul sito della Regione Piemonte perinformazioni più analitiche.
Castagneto mesoneutrofilo a Salvia glutinosa delle AlpiComprende popolamenti puri o più spesso inmescolanza con altre latifoglie subordinate, inparticolare ciliegio tra quelle di pregio, taloracon conifere. Si tratta di cedui semplici o fustaiesopra ceduo, spesso a struttura irregolare e co-pertura colma, in parte originatisi per l’abban-dono della coltura da frutto; sono cenosi pre-senti in diversi ambiti stazionali, tendenzial-mente mesofile per disponibilità idrica, daneutrofile a debolmente acidofile riguardo al-la reazione dei suoli.
L’estensione cartografata sfiora gli 80.000 et-tari, localizzati prevalentemente nei settori esal-pici e mesalpici di tutte le valli alpine, con mag-giore frequenza a partire dalla Valle Tanaro fi-no alla Valle Chisone; secondariamente anchenel Piemonte settentrionale.Il sottobosco, oltre alla specie caratterizzante dacui deriva il nome, è spesso dominato da rovi,ai quali si alternano specie quali polmonaria egeranio nodoso o, localmente, tappeti di ede-ra e ridotte macchie di Ruscus aculeatus, comenell’alto Cana vese. Lo strato arbustivo è pocodenso e assai variabile per composizione.Si tratta dei popolamenti con le migliori po-tenzialità per lo sviluppo della produzione di le-gname di castagno con altre latifoglie conso-ciate, anche di pregio, in stazioni potenzialiper querceti di rovere misti con faggio, talorafarnia e altre specie mesofile.
Castagneto acidofilo a Teucrium scorodonia delle Alpi Comprende una parte considerevole dei ca-stagneti (oltre 73.000 ettari cartografati), puri oin mescolanza con individui sporadici di rovere, betulla o faggio e, più raramente, conconifere; il governo tradizionale è a ceduosemplice o composto. Sono cenosi da meso-file a mesoxerofile, marcatamente acidofile, si-
Superficie dei castagneti in Piemonte (Piani Forestali Territoriali 1999-2003)
Provincia Cedui semplici Cedui Fustaie Castagneti Totaleo matricinati composti da frutto
Alessandria 17.715 1.529 66 10 19.320Asti 1.766 100 0 10 1.875Biella 13.711 3.374 157 16 17.257Cuneo 53.489 11.513 613 8.767 74.382Novara 8.056 255 30 5 8346Torino 29.043 11.380 301 1.024 41.748Verbano-Cusio-Ossola
21.294 3.612 67 220 25.192
Vercelli 3.214 5.425 31 7 8.678Totale 148.288 37.188 1.265 10.059 196.798
tuate sui medi e bassi versanti dell’arco alpinocentro-settentrionale.Il sottobosco è generalmente caratterizzatodalla specie che dà il nome al Tipo, con gra-mineti (luzule, molinia), felce aquilina solo pres-so le chiarie e, alle quote superiori (nella fasciadel faggio) facies con mirtillo; lo strato arbustivoè poco sviluppato o quasi assente.Le potenzialità produttive sono spesso buone,ma molto variabili in relazione alla profondità efreschezza dei suoli e all’esposizione.
Castagneto acidofilo a Physospermumcornubiense dell’Appennino e dei rilievicollinari interniComprende popolamenti di castagno, puri o inmescolanza con rovere e latifoglie d’invasione,localmente roverella e robinia, con raro pino sil-vestre; il governo è sempre a ceduo o fustaiasopra ceduo, spesso a struttura irregolare.Costituiscono cenosi da mesofile a mesoxe-rofile, da acidofile a mesoneutrofile, la cui dis-tribuzione, con circa 20.000 ettari complessi-vi, è frammentaria nei rilievi collinari interni,dalle Colline del Po (es. Riserva naturale Boscodel Vaj-Castagneto Po) alle Langhe, e sull’Ap -pen nino alessandrino non calcareo (es. Parconaturale Capanne di Marcarolo), in prevalenzasu serpentini (Valli Erro, Orba e Lemme fino al-la bassa Val Borbera); nuclei di ridotte dimen-sioni sono localizzati nel Roero e in tutto ilMon ferrato (es. Parco naturale di RocchettaTanaro).Il sottobosco oltre alla ombrellifera caratteriz-zante, spesso con bassa copertura, presentauno strato arbustivo sviluppato solo presso lechiarie (ginepro comune, calluna), ed uno stra-to erbaceo in cui si riscontrano tappeti di gra-minoidi e felce aquilina. Le potenzialità produttive per il castagno da le-gno sono complessivamente modeste, datele stazioni non sempre adatte a tale specie, incui venne diffusa dall’uomo in tempi più o me-no antichi per la produzione del frutto e dellapaleria viticola. Molti popolamenti non più ce-duati sono attualmente in successione versoboschi misti in stazioni potenziali per rovere o
roverella; tuttavia nelle migliori condizioni difertilità il castagno può esprimere buone qua-lità, in cenosi possibilmente consociate conrovere e ciliegio.
Castagneto neutrofilo dell’Appennino e dei rilievi collinari interniComprende popolamenti di castagno puri o inmescolanza con roverella, cerro, carpino neroed orniello. Si tratta di cedui o fustaie sopra ce-duo, spesso a struttura irregolare, costituenti ce-nosi da mesofile a mesoxerofile, tipicamenteneutrofile.La distribuzione, con circa 15.000 ettari com-plessivi, risulta frammentaria nei rilievi collinariinterni meridionali (in particolare Langhe, ValliBormida e Uzzone) fin sulle colline a sud diAcqui Terme e nell’Appennino calcareo-marno -so delle Valli Curone e Borbera. Più sporadiconelle colline del Monferrato, Roero e Collinedel Po.Trattandosi sovente di popolamenti abbando-nati da anni ed in successione, lo strato arbu-stivo ed arboreo inferiore può localmente esseredenso, ricco e strutturato; il manto erbaceo pre-senta facies a graminoidi (Sesleria cylindrica eBrachy podium rupestre) o miste.La potenzialità per lo sviluppo di castagnetida legno è variabile, in media modesta e co-munque non in popolamenti puri.
Castagneto da frutto Comprende i popolamenti puri di castagno adalto fusto, solitamente innestati, soggetti a cu-re o per lo meno alla raccolta dei frutti. Si trat-ta di fustaie coetaneiformi, monoplane, spes-so con soggetti monumentali plurisecolari, co-stituenti cenosi da mesoxerofile a mesofile perdisponibilità idrica, da acidofile a neutrofile ri-guardo alla reazione dei suoli.Il Tipo è diffuso in particolare dalla Valle di Su -sa a gran parte delle vallate cuneesi, con areeestese dalla Valle Stura di Demonte alla ValleTanaro (Boves, Chiusa di Pesio, Valle Ellero,Val le Mongia, Bagnasco); nuclei più sporadi-ci si riscontrano sui rimanenti rilievi dell’arco al-pino, generalmente in prossimità degli abitati,
10
11
in forme relittuali nelle Langhe (CN e AT), nelRoero (CN) e nella fascia appenninica.Tra la vegetazione di accompagnamento pre-dominano le specie prative, a gramineti, deri-vanti dallo sfalcio o dall’eliminazione del sot-tobosco eseguiti per facilitare la raccolta delfrutto; le specie arbustive e suffruticose sonoquasi totalmente assenti.Se ne auspica il mantenimento come colturaspecializzata da frutto, con rilevante valorepaesaggistico, e pertanto non viene preso inconsiderazione nella trattazione gestionale delpresente manuale.
La già ricordata importanza in termini di esten-sione regionale dei boschi a prevalenza di ca-stagno, che costituiscono la categoria più rap-presentata, quasi doppia rispetto al faggio,determina, a fianco della qualità dei prodotti ot-tenibili, l’interesse per questa specie.Il cartogramma a fianco illustra la distribuzio-ne aggiornata del castagno.
Distribuzionedel castagno in Piemonte
Avviare i popolamenti forestali tradizional-mente governati a ceduo verso forme e
sistemi a maggiore maturità e stabilità, recu-perando e conservando la diversità ambienta-le, floristica e faunistica del territorio, costitui-sce l’obiettivo generale e di lungo periodo cuimirano le proposte contenute nel presentescritto.Questo è in sintonia con il diverso peso che ne-gli ultimi anni hanno assunto le funzioni del bo-sco, per il nuovo modo di vederne e conside-rarne servizi e benefici, complice il sempre piùlimitato interesse economico per i tradizionaliassortimenti ritraibili, cui solo poche eccezio-ni sfuggono.Ciò premesso, è possibile delineare obiettivi eformulare proposte di gestione polifunzionaliche tengano conto della opportunità produtti-va del bosco nel breve periodo, in sinergiacon gli obiettivi di lungo termine, quali quelli na-turalistici, paesistico-ambientali e di difesa delterritorio.Occorre poi ricordare che l’ampia diffusione diquest’albero è da collegare anche al passatolargo impiego dei frutti nell’alimentazione uma-na; attualmente produzioni un tempo collaterali,come quella di funghi nel sottobosco, hannoassunto maggiore importanza, mentre, es-sondosi ridotto l’interesse per il frutto, questo
è diventato sostentamento ricercato dalla fau-na selvatica.Trattandosi per lo più di boschi di proprietà pri-vata, gli obiettivi perseguiti dal proprietario po-tranno essere di volta in volta diversi. L’effettodelle scelte ricade però sull’intera collettività(si pensi per esempio alla fondamentale fun-zione dei popolamenti forestali nella difesa delsuolo); in alcuni casi un uso produttivistico deiboschi può essere a tutto vantaggio del pro-prietario e del suo bilancio aziendale, in altri lavalenza naturalistica può imporre di conciliaregli interessi del singolo con quelli della comu-nità. In ogni caso, il motore primo delle sceltedel proprietario è il risultato economico con-seguibile, pertanto una crescita del prezzo di
QUALI OBIETTIVI PER I CEDUI CASTANILI?
13
122
Aspetto di un popolamento alcunianni dopo il primo
diradamento selettivo.
vendita del legname ritraibile può determinarenuovo interesse per i boschi di castagno. La domanda di legno di castagno è oggi elevataper assortimenti di qualità destinati alla fale-gnameria, ai palchetti e anche all’industria delmobile; si accompagna alla necessità di am-pliare la gamma di impieghi dei legnami di pro-duzione nazionale e comunitaria, anche se gliassortimenti attualmente ritraibili sono di dimen -sioni limitate. L’am pia diffusione sul territorio ela relativa rapidità di crescita permetterebberopoi di disporre di notevoli masse di legno allespalle delle quali si può costruire e stabilizzareuna filiera legno attiva, capace di remunerare lage stione del bosco, riportandovi capitali da
que sto derivati, con positive ricadute sugliaspetti e sulle funzioni sociali. In quest’ottical’auspicato miglioramento dei popolamenti esi-stenti potrebbe fornire una produzione di qua-lità con interessanti sbocchi di mercato, già in-travedibili oggi.Lo stesso effetto può essere ottenuto con in-centivi economici, eventualmente erogabili daEnti pubblici, che contribuiscano a sostenereil costo degli interventi selvicolturali.Basandosi su tali considerazioni, questo volu-me affronta il problema della produzione le-gnosa ottenibile e delle tecniche selvicolturalicon cui può essere incrementato il valore del le-gname.
13
Fustaia di castagno.
T ra le diverse funzioni del bosco, in questasede si approfondisce il tema della produ-
zione legnosa. In tal senso riveste un notevole interesse l’in-dividuazione nella nostra regione di popola-menti di castagno potenzialmente idonei a for-nire assortimenti di qualità, visti anche gli otti-mi risultati ottenuti dalla vicina Francia dove, purin un contesto ambientale e sociale diverso, già
da tempo è stata applicata una selvicoltura perla produzione di legname da opera.
La scelta dell’obiettivo produttivo risulta uncompromesso fra la migliore scelta tecnica,dipendente dalla potenzialità della stazione edel popolamento, e la migliore scelta econo-mica per investimenti iniziali, rischi e remune-razione in tempi più o meno lontani.In questo ambito la scelta produttiva può indi-rizzarsi con flessibilità verso assortimenti di-versi: la particolare situazione italiana imponedi non puntare alla produzione di un unico ti-po di assortimento, in quanto le condizionistazionali sono molto variabili all’interno dellamedesima unità gestionale e possono inoltresussistere opportunità di mercato variabili dazona a zona.La produzione dei popolamenti potrà riportarei maggiori vantaggi economici se sarà indirizzataprioritariamente verso i seguenti assortimenti.
• Tronchetti: misurano generalmente, in fun-zione delle esigenze di mercato, 2 o 2,5 mcon un diametro minimo in punta di 18-20cm. Sono ottenuti da polloni di 20-25 cm didiametro a 1,3 m di altezza, di età compre-sa tra i 30 e i 40 anni, e vengono impiegatiper i lavori di falegnameria e per l’industriadel mobile. A fronte di un valore commerciale limitato, ri-chiedono turni (numero di anni che inter-corrono fra l’impianto o la rinnovazione di unpopolamento coetaneo e il taglio di utilizza-zione) di produzione di minor durata.
• Tronchi: hanno diametro minimo in punta di18-20 cm, ma lunghezza maggiore, fino a 6m; se ne possono ricavare assortimenti dasega ed eventualmente da tranciatura.Derivano da piante di 35-40 cm di diametroa 1,3 m di altezza (circonferenza di 110-130cm), con età di 40-50 anni. I tronchi sani, rettilinei e privi di grossi nodisono facilmente commerciabili e realizzanoottimi prezzi sul mercato.
PRODUZIONI OTTENIBILI143
Tavole di castagno.
15
Nelle stazioni di buona produttività è possibi-le ottenere tronchi di dimensioni commercia-bili con l’applicazione di una appropriata sel-vicoltura che esca dal tradizionale regime delceduo semplice a turni brevi, ora per altro infrequente stato di abbandono colturale, e cheproponga trattamenti selettivi a favore dei mi-gliori polloni.
Nell’ambito dell’obiettivo produttivo è inoltreimportante tenere conto di quelle nicchie dimercato in cui, per effetto degli usi e delleconsuetudini locali, è richiesta la produzionedi particolari assortimenti (pali, paleria agricola,bacchettame, doghe) la cui commercializza-zione è resa più attiva e vantaggiosa quandovi è la possibilità di garantire continuità di pro-duzione.
Le seguenti produzioni, per quanto assai dif-fuse, sono da ritenersi collaterali.
•Assortimenti da triturazione: vengono uti-lizzati per l’estrazione del tannino e la pro-duzione di pannelli, ma il basso prezzo rea-lizzato non giustifica la scelta di questoobiettivo, che al più dovrebbe risultare dauna ottimizzazione della ripartizione dei pro-dotti nell’ambito di una filiera legno funzio-nante.
• Legna da ardere: in questo senso il legno dicastagno non è apprezzato a causa dell’eleva -to contenuto di tannini, dilavabili solo median -te lunga stagionatura esterna; la legna da ar-dere di castagno è pertanto oggetto di con-sumi familiari e di un commercio marginale.
Preparazione di assortimenti da paleria.
Generalmente è possibile migliorare i ceduidi castagno in modo che si possa racco-
gliere domani una produzione di maggior va-lore, ma non sempre ciò è facile ed economi-camente vantaggioso.È più agevole migliorare i giovani popolamenti,meno le formazioni di età intermedia, quasi im-possibile quelle di età avanzata. Inoltre, nellavalutazione del popolamento, bisogna consi-derare che il giudizio può essere diverso da zo-na a zona della stessa particella, ma anche chegli interventi di miglioramento non possono es-sere «puntuali» e limitati a piccole estensioni.Prima di operare delle scelte, per altro spessoonerose, è perciò necessario valutare singo-larmente i molti fattori che le rendono più o me-no valide. Occorre quindi verificare se sussi-stono alcune condizioni fondamentali:– se la stazione è favorevole al castagno;– se le condizioni fitosanitarie sono buone;– se le qualità legate a fattori ereditari si espri-mono favorevolmente;
– se le condizioni evolutive e colturali sonoidonee.
La stazioneSe è favorevole si potrà constatare un buon svi-luppo del popolamento in altezza, determina-to da un continuo e regolare ritmo di crescita.
La tabella che segue evidenzia i livelli di staturaminimi capaci di garantire risultati soddisfa-centi agli interventi selvicolturali di migliora-mento con prevalenti finalità produttive.
Età dei polloni Statura (m)5 anni 610 anni 915 anni 1220 anni 1525 anni 18
Se la stazione è di difficile accesso, l’esboscodi assortimenti di pregio, normalmente allesti-ti con lunghezze da 3,5 a 6 m, potrebbe esse-re complesso e costoso.
Le condizioni fitosanitarieIl cancro corticale non dovrebbe essere ri-scontrabile su più del 50% dei polloni domi-nanti, ma soprattutto questi devono dimostrarecapacità di reazione con buona cicatrizzazione,segno della presenza di forme ipovirulente delfungo patogeno. Forti attacchi della malattiadeterminano la presenza di disseccamenti del-la vegetazione facilmente osservabili, nonché l’e-missione di getti epicormici nella zona imme-diatamente sottostante il cancro.
Fattori ereditariParticolare vigoria e ottima forma del fustopossono essere caratteristiche trasmesse pervia ereditaria, come pure la predisposizionealla cipollatura. Questo difetto, collegato forsea tutti i fattori considerati finorapiù che a quel-li ereditari, è una fessurazione interna al fustodovuta al distacco per una certa lunghezzadegli anelli di accrescimento annuale, tale darendere inutilizzabile il tronco in segheria. Lasua presenza non è visivamente rilevabile su al-beri in piedi, ma talora ne è nota agli utilizza-tori la maggiore o minore diffusione locale;inoltre è sicuramente più frequente nei soggetti
QUANDO È POSSIBILE MIGLIORARE
UN CEDUO DI CASTAGNO?164
17
di diametro ed età elevati, come le matricine,ed è anche favorita da irregolarità nei ritmi in-crementali dovute a interventi selvicolturalitroppo energici. In ogni caso, è necessarioche la presenza di questi difetti non sia gene-ralizzata e che esista un numero adeguato disoggetti di qualità.
Le condizioni evolutivo-colturaliL’origine del popolamento e gli interventi sel-vicolturali di gestione eseguiti in passato pos-sono aver determinato insufficiente o irregola-re distribuzione delle ceppaie sul terreno, esau-rimento o indebolimento delle stesse pereccessivo invecchiamento o per tagli troppo al-ti sulla ceppaia, irregolarità nel numero e nel ri-scoppio dei polloni dovute a transito o dan-neggiamento. Le condizioni selvicolturali pos-sono quindi ripercuotersi sul valore dell’areabasimetrica (somma delle superfici delle se-zioni a petto d’uomo di tutti gli alberi di un so-prassuolo o di un popolamento, normalmen-te espressa in metri quadrati per ettaro), stret-tamente dipendente dal diametro dei fusti e dalloro numero. In altri casi le decisioni dovrannotenere conto della presenza di altre specie ar-boree più o meno diffuse nei popolamenti,quali faggio, rovere e robinia, verso le quali puòanche essere indirizzata la gestione del po-polamento.Questi giudizi analitici permettono una corret-ta valutazione della situazione esistente; tutta-via è opportuno in alcuni casi formulare ungiudizio di insieme che chiarisca se esistonosoggetti da reclutare per costruire popolamentimigliorati, sui quali sia sensato indirizzare gli in-terventi selvicolturali per concentrare l’accre-scimento legnoso, aumentando in modo si-gnificativo le possibilità di mercato del pro-dotto e di conseguenza il suo valore.A tale scopo, per aiutare il proprietario a espri-mere un giudizio complessivo sul suo popo-lamento, si è predisposto il seguente schemache guida e facilita la valutazione delle poten-zialità e della suscettibilità al miglioramento, pri-mo passo verso la scelta degli interventi selvi-colturali.
Ceduo maturo migliorabile in vistadella produzione di legno di qualità; ègià stato eseguito untaglio fitosanitariocon asporto della necromassa.
Schema predisposto per la valutazione del popolamento riportante le condizioninecessarie e compatibili con l’obiettivo di miglioramento del soprassuolo esistente
Condizioni da osservare Giudizi
Fattori stazionali
Accrescimento in altezza Maggiore dei valori in tabella A
(vedere tabella a pagina 16) Uguale ai valori in tabella BMinore dei valori in tabella C
Facile AAccesso per l’esbosco Difficile B
Molto difficile C
Condizioni fitosanitarieAl 30% dei polloni A
Diffusione dei cancri corticali Al 50% dei polloni BA più del 50% dei polloni C
Ottima ACicatrizzazione dei cancri Buona B
Nulla C
Caratteri ereditariRettilinei, eretti e vigorosi A
Conformazione dei polloni dominanti Significativa presenza di polloni validi BMolti nodi, rami epicormici, polloni inclinati, curvi, senescenti C
Assente APresenza e predisposizione alla cipollatura Occasionale B
Nota da tempo C
Condizioni selvicolturaliUniforme A
Distribuzione delle ceppaie e copertura del suolo Presenza di alcuni vuoti e copertura rada BCeppaie distanti e vuoti di copertura C
Meno di 15 anni AEtà Tra 15 e 25 anni B
Con più di 25 anni C
Valutazione complessiva dei giudiziLe risposte tipo C indicano condizioni di partenza particolarmente difficili che, pur non precludendo la via al mi-glioramento, richiedono sforzi rilevanti per conseguire obiettivi per lo più non economicamente convenienti. Le ri-sposte tipo A indicano condizioni di partenza ottimali, tali da garantire un alto margine di successo agli interven-ti di miglioramento, la cui realizzazione viene consigliata senza ulteriore indugio. Risposte intermedie alle due so-pradette indicano condizioni in cui le possibilità di successo sono buone, ma i tempi richiesti sono più lunghi in quanto,in alcuni casi, gli interventi di miglioramento sono realizzabili solo in seguito a un nuovo inizio del ciclo.
18
SFOLLO
È un intervento selettivo massale, forte e pre-coce, mirante a ridurre anticipatamente il nu-mero di polloni sulle ceppaie salvaguardandoi soggetti originatisi da seme: va realizzatoquando i primi hanno un’altezza tra 6 e 9 m, cioèun’età di 6-10 anni, lasciando i migliori polloniper ogni ceppaia. I polloni abbattuti non sonocommerciabili e vanno lasciati sul posto. Puòessere realizzato anche con la sola roncola.
DIRADAMENTI SELETTIVI
Questi interventi costituiscono un’ottima tecni-ca di valorizzazione a breve termine dei popo-lamenti migliori ben dotati di polloni d’avveni-re. L’obiettivo è costituire con questi una fustaiada polloni ovvero un ceduo a turno prolunga-to, con rinnovazione mista da seme e da cep-paia.La scelta dei polloni da abbattere deve esserepreceduta dall’individuazione e marcatura deisoggetti migliori tra gli alberi d’avvenire (can-didati), procedendo per ipotetiche celle al cuicentro vi sono i soggetti designati. Questi de-vono essere riconosciuti, oltre che per la buo-na distribuzione sul terreno, per il vigore vege-tativo, la qualità del fusto, la posizione lateralee la solida inserzione sulla ceppaia. Si indivi-dueranno quindi i concorrenti dominanti e co-dominanti da prelevare. Il popolamento che nederiverà sarà costituito dai migliori soggetti re-peribili nel piano dominante, accompagnati daun ben più alto numero di indifferenti la cuipresenza completerà la copertura e favorirà ilcorretto sviluppo dei primi, limitandone anchela ramosità principale e avventizia. Nel caso didiradamenti in popolamenti con soggetti filati oancora significativamente affetti da cancro cor-ticale dovrà essere rilasciato un numero mag-giore di alberi d’accompagnamento, per con-sentire un’eventuale successiva sostituzione,negli interventi successivi, dei candidati morti.• Primo diradamento. Si tratta di un interven-
to selettivo di forte intensità e di tipo alto,cioè a carico delle piante che costituiscono ilpiano dominante, eseguito per favorire la cre-scita equilibrata dei soggetti migliori (candi-dati), nonché per stimolare gli incrementi dia-metrici e lo sviluppo delle chiome depressedalla concorrenza. L’esecuzione del primodiradamento è indicata in cedui in cui, a cir-ca 10-15 anni dall’ultima utilizzazione, siapossibile individuare nel piano dominantesoggetti di buon portamento non ancora ec-cessivamente snelli, per cui non vi sia rischiodi schianti o incurvamenti in seguito all’inter-ruzione della copertura. Dai polloni abbattu-ti possono essere ricavati assortimenti da pa-leria agricola (20%) e legna da ardere o da tri-turazione (80%), ma è necessario accertarsidell’economicità dell’esbosco; ove non fosseconveniente, il materiale può essere lasciatosul letto di caduta ed eventualmente prelevatocon il successivo intervento.
• Secondo diradamento. L’intervento è tecni-camente analogo al precedente, e mira a ri-durre ulteriormente gli alberi che accompa-gnano i soggetti d’avvenire già rilasciati. Èperò importante verificare che questi ultimipresentino ancora le qualità per cui eranostati scelti; sovente infatti schianti, morte percancro e perdita di vigore impongono la loro
CHIARIMENTI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI EVENTI 19195
sostituzione con le piante indicate come in-differenti nel primo intervento. A seconda del-le condizioni del soprassuolo questa opera-zione potrebbe già portare il popolamento auna densità di poco superiore a quella finale.Dai polloni abbattuti possono essere ricavatiassortimenti per paleria agricola e piccole tra-vature (30%), legna da ardere o da triturazio-ne (70%). Ulteriori indicazioni sono contenu-te nella relativa scheda tecnica (vedi p. 24).
• Diradamenti successivi. Sono interventiselvicolturalmente proficui che, per quantodifficilmente proponibili nel nostro contesto,sono necessari quando l’obiettivo produttivo,individuato come prioritario, richiede un ul-teriore aumento della spaziatura dei soggettimigliori, destinati a raggiungere la fine del tur-no, a scapito dei soggetti codominanti.
DIRADAMENTO LIBERO POSTICIPATO
Con questo termine si intende un intervento diselezione massale che mira a favorire i mi-gliori individui del ceduo maturo e ultramatu-ro, in vista della produzione di legname daopera. Prima di eseguirlo occorre valutare sevi sono almeno 600-800 soggetti a ettaro vita-li e promettenti, di cui almeno 1/3 con fusto di-ritto, senza difetti apparenti, con chioma benequilibrata, distanziati fra loro di 8-10 m, ingrado di garantire il risultato economico pro-duttivo con un solo intervento di diradamentoe con taglio di utilizzazione entro 10-15 anni.Quando sussistono queste condizioni si puòeseguire il diradamento libero posticipato: lapercentuale di legname da opera può essere in-crementata prolungando il turno e ricavando nelcontempo assortimenti capaci di coprire com-pletamente i costi dell’intervento intercalare.Il prelievo interesserà i soggetti concorrenti equelli di cattivo portamento; evitando di inter-rompere la copertura delle chiome, si rilasce-ranno complessivamente 600-800 alberi a et-taro, a seconda dello sviluppo. Dai fusti ab-battuti dovrebbero essere ricavati tronchi dasega (20%), palerie agricole (20%) e legna da
ardere o da triturazione (60%). Quando non siaprioritario l’aspetto produttivo si può operareanalogamente in popolamenti più giovani; ov-viamente, nella previsione di più di un inter-vento, bisognerà aumentare opportunamenteil numero degli allievi iniziali rilasciati.
TAGLI DI UTILIZZAZIONEE RINNOVAZIONE
• Taglio di rinnovazione anticipato. È esegui-to quando, non essendo stati effettuati inter-venti selvicolturali, il soprassuolo è di scarsaqualità e vitalità e un proseguimento del tur-no non aumenterebbe sostanzialmente la per-centuale di assortimenti di maggior valore, ri-schiando anzi di compromettere la stabilità ela perpetuazione del bosco per collasso col-turale. Dal taglio si dovrebbero ricavare tron-chetti (20%), paleria agricola grossa (10%), le-gname da triturazione e da ardere (70%).
• Taglio finale. Questo intervento ha il dupliceobiettivo di prelevare la massa legnosa prin-cipale e di garantire la perpetuazione del po-polamento in modo ottimale (cfr. capitolo 7).L’operazione dovrebbe essere eseguita aun’età di 40-50 anni su popolamenti con den-sità compresa tra 400 e 600 piante a ettaro, aseconda del numero e dell’intensità degli in-terventi precedenti. Dai fusti abbattuti si pre-vede di ricavare assortimenti per la tranciatu-ra (10%), tronchi e tronchetti da sega (70%),e una ridotta parte di legna da ardere o da tri-turazione e tannino (20%). La qualità del pro-dotto ottenuto, nonché la percentuale degli as-sortimenti ricavati, dipenderanno direttamen-te dagli interventi effettuati in precedenza edalla qualità del materiale di partenza.
• Taglio finale dopo diradamento libero. Sidifferenzia dal taglio precedente perché puòessere ritardato anche di una decina d’annirispetto ai popolamenti a regime gestiti contagli colturali intercalari. Dai fusti abbattuti sidovrebbero ricavare tronchi e tronchetti dasega (60%) e una più alta quota di legna daindustria e da ardere (40%).
20
P er individuare le scelte selvicolturali più ap-propriate presentiamo uno schema realiz-
zato grazie all’analisi di parcelle a diversi sta-di di sviluppo, collocate in contesti di differen-te fertilità e sottoposte a interventi diversi pertipo e intensità.Lo schema predisposto presenta una struttu-ra principale ciclica alla quale vengono ricon-dotti, a seguito di alcune condizioni, i diffe-renti stadi iniziali.L’ingresso nello schema può avvenire in diversipunti a seconda della situazione riscontrata,generalmente riconducibile ad una delle se-guenti, per le quali è stata indicata sommaria-mente anche la serie di interventi ritenuti più ap-propriati.
Bosco tagliato a rasoÈ questa la situazione che si presenta alla con-clusione del turno tradizionale dei cedui a re-gime, oppure in seguito al taglio di rinnova-zione di popolamenti troppo invecchiati, o do-po il taglio finale dei popolamenti già sottopostia interventi selvicolturali. Eventuali irregolaritànella disposizione delle ceppaie dovranno es-sere colmate con il reclutamento della rinno-vazione da seme o con l’impianto di qualchesoggetto di pregio (rovere, ciliegio, tiglio, ace-ro, frassino). Dopo il riscoppio dei polloni, cherisulta in genere soddisfacente anche su cep-paie vecchie, nei primi anni le forti densità ini-ziali si ridurranno gradualmente per effetto del-la concorrenza. Ciò nonostante si prevede auna età di 6-10 anni, in preparazione di un fu-turo diradamento possibilmente di tipo seletti-vo alto, uno sfollo dei polloni, eseguibile conla roncola, anche senza il prelievo del materialetagliato.
Ceduo giovaneSi tratta di un soprassuolo di 10-15 anni in cuinon si è ancora intervenuti dall’ultima utilizza-zione e che conta un numero molto elevato dipolloni (>2.500 P/ha). L’emissione di nuovipolloni è cessata e i più giovani e dominatisono destinati a morire per effetto dell’om-
breggiamento di quelli che hanno ormai pre-so il sopravvento. Questi ultimi, dal momentoche per specie eliofile come il castagno lacompetizione sulle ceppaie e poi fra le ceppaieè massima, sono molto snelli, privi di rami la-terali e con un’altezza di 9-12 m circa. È que-sto il momento della designazione degli indi-vidui dominanti e codominanti di buon porta-mento a favore dei quali iniziare precocementegli interventi selettivi. Le prove sperimentalihanno infatti evidenziato come diradamentiselettivi precoci di tipo alto permettano di con-centrare l’incremento diametrico sui soggettipiù promettenti. Nel caso si ritardasse l’inter-vento, lo sviluppo interesserebbe un numeromaggiore di polloni, esasperando la competi-zione sulle singole ceppaie e impedendo co-sì il più rapido accrescimento dei polloni d’av-venire.
Ceduo maturoLa maturità dei cedui a regime è indicata dal-la fine del turno consuetudinario, variabile infunzione degli assortimenti desiderati, quindi aseconda della zona tra 20 e 25 anni, raramentedi più; l’età massima di riferimento può esse-re quella indicata per definire i cedui abban-donati, ossia il triplo del turno minimo previstodalle Prescrizioni di massima (9x3=27 anni).
LE SITUAZIONI RICORRENTI E LE POSSIBILI
SCELTE SELVICULTURALI 216
22Si
tuaz
ione
inizi
ale
Cond
izion
iAs
sorti
men
tiEt
àAl
tezz
aDe
nsità
12
34
56
(ann
i)(m
)(n
°/ha
)
Risco
ppio
dei p
ollon
i50
00-7
000
dopo
il tag
lio ra
so
Cedu
o +
di 30
00 po
lloni
Sfollo
100
--
--
-6-
106-
925
00-3
500
giova
ne–
di 30
00 po
lloni
Cedu
o matr
icina
toma
tricin
e vali
de+
di 20
00 pi
ante
1º-
8020
--
-11
-15
10-1
325
00-3
000
o con
rise
rvema
tricin
e non
valid
eDi
rada
mento
–di
2000
pian
tese
lettiv
o di
tipo a
lto fo
rte
Cedu
oso
ggett
i pro
mette
nti2º
matur
oso
ggett
i non
prom
etten
tiDi
rada
mento
-70
30-
--
20-2
518
1300
-150
0se
lettiv
o
Cedu
o in e
voluz
ione
sogg
etti d
i alta
quali
tà3º
oltre
il tur
noso
ggett
i di b
assa
quali
tàDi
rada
mento
-60
20-
20-
28-3
522
-24
700-
900
cons
uetud
inario
Dira
dame
ntose
lettiv
olib
ero
posti
cipato
-60
20-
20-
30-4
020
(600
-800
)
Tagli
o anti
cipato
-70
1020
--
30-4
0
Tagli
o fina
le-
20-
3040
1040
-50
22-2
640
0-50
0
Tagli
o fina
le do
podir
adam
ento
posti
cipato
-40
-40
20-
50-6
060
0-80
0
t
tt
tt
t
t
t
t
t
t
t t t tttt
tt t t t t
t
MODELLO
DELLESCELTESELVICOLTURALIPERILCASTAGNO
INSTAZIONIDIMEDIAEBUONAFERTILITÀ
A seconda di diverse situazioni iniziali sono indicati gli interventi consigliabili, i parametri dendrometrici di riferimento e
le stime degli assortimenti ritraibili. Assortimenti: 1 non commerciabile - 2 da triturazione, da ardere - 3 paleria agricola -
4 tronchetti da sega (lung. 2 m.) - 5 tronchi da sega (lungh. min. 2,5 m, ø min. 18 cm in punta) - 6 tronchi da trancia (lungh.
min. 2,5 m, ø min. 30 cm in punta).
23
In questa situazione, e in presenza di sogget-ti promettenti, è possibile intervenire a favoredi questi ultimi con un diradamento, eventual-mente ripetuto alcuni anni dopo, e con la po-sticipazione del taglio finale. In caso contrarioè preferibile utilizzare l’intero soprassuolo.
Ceduo in evoluzione oltre il turno consuetudinarioQuesta situazione, assai diffusa oggi nei nostricedui, è legata all’abbandono di molte pro-prietà. I polloni sono numerosi su ogni ceppaia,ma solo un numero molto ridotto di fusti haportamento valido, mentre frequenti sono i sog-getti morti in piedi, inclinati o fortemente colpi-ti da cancro corticale. La forte concorrenza perla luce si sviluppa prima fra i singoli polloni poifra le stesse ceppaie, fino a provocare il dis-seccamento delle meno vigorose.Il superamento naturale di tale stato, che preludeal collasso colturale, può richiedere molti anni,durante i quali l’unica produzione ottenibile èquella di legna da ardere. Spesso risulterà sen-z’altro opportuna la scelta dello sgombero an-che anticipato del soprassuolo. In altri casi la si-tuazione potrebbe essere recuperabile per lapresenza di soggetti ancora validi: allora si po-trà eseguire un diradamento di media intensità,per avere assortimenti di maggiori dimensioniprolungando opportunamente il turno.
Ceduo matricinato o con riserveIl soprassuolo è formato da due piani di chiome: – quello dominante delle matricine o riserve,per le quali è previsto un turno più lungo, masempre multiplo di quello del ceduo;
– quello dominato e continuo, costituito daipolloni del ceduo.
Nel caso in cui il ceduo sia giovane e le matri-cine non siano tarate e molto ramose si puòprocedere a interventi selettivi d’intensità va-riabile a seconda della densità iniziale, dopoaver scelto i migliori soggetti d’avvenire (can-didati, cioè soggetti che per le loro positivequalità vengono destinati a costituire l’ossatu-ra del soprassuolo che giungerà alla fine delturno) sia fra i polloni sia fra le stesse matrici-
ne. Le altre matricine, di età più avanzata, cheraggiungeranno quindi la maturità prima deicandidati, potranno essere inserite nel popo-lamento delle piante d’accompagnamento o,se ancora possibile, eliminate. Nel caso le ma-tricine siano numerose e non presentino buonportamento non resta che andare al taglio dirinnovazione anticipato, perché difficilmentesi potrà reperire un numero sufficiente di pol-loni con buona possibilità di avvenire.Nel caso fossero presenti riserve di specie di-verse dal castagno, in particolare querce, fag-gio e latifoglie nobili, queste andranno semprevalorizzate; potranno essere asportate, se dicattivo portamento, solo quando ne è assicu-rata la rinnovazione, poiché sono elementi delbosco naturale importanti per la stabilità e l’e-voluzione dei popolamenti.
Aspetto ricorrentedei popolamenti inassenza di interventiselvicolturali.
24
Scheda tecnica 1. Diradamento selettivo di tipo alto
24
Situazione successiva al diradamento
Sono stati abbattuti solamente gli alberi le cui chiomecompetono con la cima dei candidati e alcuni soggettiindifferenti.
Diradamenti 1° 2° 3°
Età (anni) 11-15 20-25 28-35Densità (n°/ha) 2600-3000 1300-1500 700-900Statura (m) 10-13 18-20 22-24Candidati (n°/ha) 200-250 150-200 150-200
Diradamenti 1° 2° 3°
Densità (n°/ha) 1300-1500 700-900 400-500
Situazione iniziale
Nel popolamento si trovano, distribuiti con una certa re-golarità e in numero sufficiente, i candidati (C), i con-correnti (x), i soggetti indifferenti (i), i fusti dominati e gliarbusti d’accompagnamento (senza contrassegno).
Consiste nell’eliminazione di soggetti del piano domi-nante o codominante volta a favorire la ripresa dello svi-luppo delle chiome di quelli prescelti come candidati,che costituiranno l’ossatura del popolamento destina-to ad arrivare alla fine del turno. La scelta viene effet-tuata sulla base della disposizione sul terreno, del vi-gore vegetativo, del portamento e della qualità del fu-sto. Il diradamento interessa i soggetti diretti concorrentidei candidati e, solo marginalmente, la categoria diquelli indifferenti, con funzione d’accompagnamento,il cui numero sarà gradualmente ridotto anche con gli
interventi successivi; non è interessato il piano dominato,per altro scarsamente rappresentato nei castagneti.Negli schemi selvicolturali questo tipo di intervento èproposto all’età di 11-15, 20-25 e 28-35 anni.Il materiale di risulta del primo diradamento è soloparzialmente commerciabile come piccola paleria agri-cola; il secondo e il terzo forniscono invece un buonquantitativo di paleria, a fianco di un modesto quanti-tativo di tronchetti.Il taglio finale è previsto, se sono stati eseguiti i dovu-ti diradamenti, all’età di 40-50 anni.
5
5 5
5
25
Ceduo adulto: situazione precedente il diradamento.
Ceduo adulto: situazione seguente il diradamento.
26
Scheda tecnica 2. Diradamento libero posticipato
Situazione seguente il taglio
Sono stati rilasciati i soggetti validi (k), gli alberi d’ac-compagnamento (+) e i giovani polloni dominati costi-tuenti il sottobosco.
Densità (n°/ha) 600-800
Situazione iniziale
Popolamento non diradato in cui la regolare distribu-zione dei polloni e il sufficiente numero di piante nateda seme permettono la scelta di soggetti validi (k) e dialberi d’accompagnamento (+) spaziati di 8-10 m.
Età (anni) 30-40Statura (m) 20-23Densità (n°/ha) 1000-1500
Prevede il taglio dei polloni deperienti, di cattivo por-tamento, di quelli dominati o in stretta concorrenzacon i soggetti prescelti, rilasciando quindi un ridotto nu-mero di soggetti d’accompagnamento.L’obiettivo è la valorizzazione dell’ossatura del popola-mento, d’altra parte già esistente, destinata a un’uti-lizzazione posticipata che risulta economicamente piùvantaggiosa.Negli schemi selvicolturali questo intervento è propo-
sto nei cedui che hanno già superato il turno consue-tudinario; è realizzabile quando vi siano 600-800 sog-getti vitali e promettenti a ettaro, di cui almeno 1/3 ingrado di garantire, per la loro qualità, il risultato pro-duttivo atteso dopo il prolungamento del turno.L’intervento risulta conveniente dal punto di vista eco-nomico per la quantità e la dimensione del legname uti-lizzato.Il taglio finale è previsto all’età di 50-60 anni.
27
Ceduo invecchiato, che primadell’intervento presenta grossipolloni ancora vigorosi e di buon portamento, in gradodi proseguire il turno dopo il diradamento.
Situazione dopo il taglio: si noti la presenza di alcuni
faggi salvaguardati nell’intervento.
Nel caso del castagno, la perpetuità puòessere assicurata sia per via gamica, dal-
la nascita diretta del seme a terra, sia per viaagamica, dal ricaccio di polloni dalle ceppaiedopo la ceduazione. Il secondo sistema ga-rantisce un più rapido sviluppo del sopras-suolo nei primi anni, ma può essere poi d’o-stacolo a causa della distribuzione e dell’in-vecchiamento delle ceppaie o della cattivainserzione dei polloni su di esse.È sempre auspicabile che una parte, per quan-to limitata, dei soggetti nati da seme sopravvi-va e sia favorita in tutti gli interventi per garan-tire nel tempo la sostituzione delle vecchieceppaie e il rinnovo del patrimonio genetico.Giungendo a fine turno con un basso numerodi fusti per unità di superficie, l’apporto deisoggetti nati da seme sarà più importante.Nei castagneti piemontesi, a differenza di quan-to succede oltralpe, non vi sono le condizioniper proporre l’impianto artificiale successivo al-la devitalizzazione delle vecchie ceppaie; inalcuni casi, però, potrebbe essere opportunoricorrere all’impianto nelle radure o nei vuoti la-sciati da una loro cattiva distribuzione sul ter-reno.
L’esecuzione di un taglio di sementazionequalche anno prima dello sgombero del so-prassuolo può essere utile quando sia eleva-ta la presenza di altre specie arboree d’inte-resse. Normalmente la loro diffusione è ga-rantita dal seme proveniente dalle parcelleforestali circostanti. Questo taglio, eliminandofino al 75% del soprassuolo esistente, ha loscopo di aumentare lo spazio aereo disponi-bile per le chiome delle piante ancora vigoro-se, che possono quindi rispondere alla mag-giore disponibilità di luce e acqua con ab-bondanti fioriture e completa maturazione deisemi. L’apertura del soprassuolo permetteinoltre una più rapida degradazione della so-stanza organica accumulatasi, creando con-dizioni ottimali per l’emergenza e lo sviluppodei giovani semenzali, che andranno favoriti ascapito dei polloni concorrenti.
GARANTIRE LA PERPETUITÀ
VALORIZZANDO I POPOLAMENTI MISTI28
Fustaia adulta a densità finale, prima dei tagli di
rinnovazione.
7
29
Per ridurre la monospecificità dei popolamen-ti e aumentarne la naturalità e la stabilità, gli in-dividui vitali di specie diverse dal castagno do-vranno essere salvaguardati in tutti gli inter-venti. Negli ambienti montani, per esempio, il faggioè un chiaro segnale della vegetazione poten-ziale della stazione; la sua presenza è infatti ab-bastanza frequente nei cedui castanili collocatialle quote e nelle zone che rientrano nel suoareale originario. Nell’ambito di queste aree,dove spesso oggi il castagno ha un ruolo mar-ginale, sarà opportuno accelerare il processodi avviamento a fustaia con interventi attivi diconversione, favorendo gli esemplari di faggioaffrancati e il novellame nato da seme.Talora nei cedui castanili sono presenti la be-tulla e il pioppo tremolo, specie pioniere che,per esigenze ecologiche e rapidità di diffusio-ne e di crescita negli stadi giovanili, sono ingrado di colonizzare chiarie e radure. Si trattapertanto di indicatori ecologici di scarso inte-resse produttivo, il cui ciclo si chiude general-mente in tempi brevi, che ove ancora dominantie vitali devono essere rilasciati.L’ontano e il salicone sono invece espressio-ne di condizioni stazionali caratterizzate da unelevato tenore di acqua nel suolo.L’acero e il frassino si diffondono talora nellestazioni più fresche, d’impluvio, non ottimali peril castagno.Nei cedui di castagno, in alcune località, sonopresenti conifere originatesi per dissemina-zione naturale da vicini popolamenti, anchefavorite dall’attività trofica di uccelli o roditori.Per queste piante, come per tutte quelle nateda seme e di specie diverse dal castagno, lePMPF vietano l’utilizzazione secondo le mo-dalità e i tempi del ceduo; il loro destino èquindi legato alla capacità di adattarsi allascarsità di luce e alle diverse condizioni pe-doclimatiche, che ne condizionano sviluppo ediffusione.L’impianto di conifere nei cedui è oggi unatecnica poco diffusa per motivi ecologici e peri forti investimenti iniziali richiesti. Visto che fi-nora i risultati non sono stati soddisfacenti,
questa tecnica non è ritenuta opportuna inambienti piemontesi.Negli ambienti collinari è invece tipica la pre-senza della robinia, facilitata in passato dalladebolezza del castagno colpito da attacchi dicancro corticale e da utilizzazioni ravvicinateche, scoprendo in parte o totalmente il suolo,ne hanno consentito la diffusione, sia da semesia da polloni radicali. La sua presenza puòrappresentare un’alternativa nella scelta del-l’obiettivo produttivo, considerato il maggiorprezzo che spunta sul mercato come legnada ardere. Diversamente, nell’ambito dei ceduicastanili a regime o che, con l’applicazionedelle indicazioni presentate, torneranno a es-serlo, il contenimento del numero di individuidi robinia sarà garantito da interventi mirati: ne
Aspetto di una parcella 5 anni dopoil diradamento. Sinoti la vegetazionedei giovani faggi.
30
può contenere la diffusione il taglio dei pollo-ni presenti, possibilmente prima del momentodegli interventi di diradamento, perché, man-cando sufficiente luce al suolo, i nuovi ricaccisaranno poco vigorosi. I tagli a raso ne favori-scono invece la diffusione a macchia d’olio.Le querce, e in particolare la rovere, sono ele-menti localmente rimasti a testimoniare la ve-getazione potenziale di molte stazioni collinarie pedemontane; diffuse al margine delle for-mazioni castanili e nello strato di fustaia nel ca-so di cedui composti, esse sono in grado di raf-
forzare la propria presenza numerica solo quan-do vengono attentamente poste in riserva e di-fese durante le utilizzazioni.
Si rammenti infine l’importanza della conser-vazione e dell’introduzione nei cedui di alcunelatifoglie nobili quali ciliegio, tiglio, acero.L’interesse per queste specie è giustificatodall’importante ruolo ecologico che ricopro-no, dai vantaggi garantiti dalla diversità biolo-gica dei boschi misti e dal legname di pregioche queste possono fornire.
Popolamento misto sottoposto a un primo diradamento con predesignazione di candidati. Si notano ricacci di castagno dominanti.
La fauna dei castagneti, specialmente perquanto riguarda i vertebrati, presenta note-
voli affinità con quella dei boschi di rovere.Fra gli anfibi la specie più comune è la sala-mandra pezzata o salamandra gialla e nera, cuispesso troviamo associato il rospo comune ela rana temporaria. Fra i rettili, animali che preferiscono gli am-bienti più luminosi e di margine, oltre all’ubi-quitaria lucertola muraiola, troviamo il ramarroe alcuni ofidi, quali il biacco, il saettone e la vi-pera aspide.Ben più ricco risulta il popolamento dei mam-miferi, molti dei quali trovano nelle castagneun’importantissima risorsa alimentare. Fra que-sti, oltre a numerosi micromammiferi quali itopi selvatici e varie specie di arvicole, vannosenz’altro citati il moscardino, il ghiro e loscoiattolo, a loro volta predati dai mustelidi (inparticolare la faina) e dalla volpe.
Nella nostra regione è in netto aumento il po-polamento di ungulati e in numerose aree col-linari e montane si sono affermati i cervidi. Il ca-priolo e il cervo sono frequenti nella zona al-pina, mentre in ambiente appenninico si èsempre più diffuso il daino, specie a distribu-zione naturale prevalentemente mediterranea,comparso in seguito a immissioni di soggettieseguite a scopo venatorio.Di recente si è imposto all’attenzione dell’opi-nione pubblica per l’aumento numerico il cin-ghiale, la cui dieta autunnale è in gran parte co-stituita proprio dalle castagne. Questi frutti, d’al-tra parte, sono appetiti anche dai camosci, perlo meno dove questa specie, legata principal-mente agli alti pascoli e agli ambienti rupestri al-pini, scende nei boschi di latifoglie, fatto menoraro di quanto comunemente si pensi.L’avifauna è rappresentata da un buon nume-ro di specie, anche se l’ambiente più favorevoleper molte di esse, in particolare per quelleecologicamente più esigenti, è costituito dai ca-stagneti da frutto. Qui si riproducono infattinumerose specie di uccelli legate per la nidi-ficazione alle cavità dei vecchi tronchi. Oltre aipicchi (picchio verde, picchio rosso maggioree minore), alla colombella, piuttosto rara intutta Italia, e all’allocco, rapace notturno am-piamente diffuso nei boschi di latifoglie, nei
LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA
831
Capriolo nel sottobosco.
castagneti da frutto si riscontrano elevate den-sità di passeriformi decisamente più scarsi inaltri tipi di bosco: fra i più interessanti citiamoil rampichino, il picchio muratore, la cinciarel-la, il codirosso e la rara balia dal collare, chein Italia settentrionale nidifica solo in questoambiente in pochissime località climaticamentefavorevoli. Ben più poveri in densità e numerodi specie risultano i cedui, specialmente quel-li invecchiati e omogenei, dove la specie do-minante è il pettirosso, accompagnata da po-che altre.Tuttavia, la pratica del ceduo può favorire al-cune specie che tendono a scomparire daipopolamenti uniformi di media età: l’usignolo,per esempio, raggiunge massime densità cin-que anni dopo il taglio, mentre il succiaca-pre, un uccello insettivoro notturno in dimi-nuzione in tutta Europa, si insedia nelle radu-re create dalla ceduazione nei primissimi annidopo il taglio.Per ospitare una fauna ricca e varia nei boschidi castagno è quindi opportuno mantenereuna struttura quanto più diversificata, sia oriz-zontalmente sia verticalmente. Si tratta cioè di
favorire lo sviluppo lineare dei margini fra le zo-ne boschive e quelle aperte, con la creazionee il mantenimento di sentieri, il modellamentodei confini del bosco, la creazione di radurepermanenti o temporanee, queste ultime tipi-che della gestione applicata su particelle fo-restali contigue di diversi stadi di sviluppo,nonché la crescita, anche a gruppi, di arbustie alberi di altre specie, capaci di integrare l’a-limentazione degli animali o di fornire idoneisupporti per la nidificazione. Fra le specie ar-boree da preferire si citano il faggio, la rovere,i sorbi e alcune conifere; fra quelle arbustive ilnocciolo, i biancospini, il lampone e varie spe-cie di rovi.Anche la presenza di biomassa al suolo, so-prattutto se rappresentata da tronchi marce-scenti, è certamente un elemento favorevole al-la ricchezza di invertebrati e di conseguenza al-le numerosissime specie di vertebrati che daquesti dipendono per l’alimentazione, senzatrascurare che proprio gli invertebrati e in par-ticolare gli insetti costituiscono, anche in que-sto ambiente, la frazione di gran lunga più im-portante della biodiversità complessiva.
32Sopra,
un cervo;a destra,
un cinghiale.
Il castagno, albero squisitamente micotrofo,svolge la propria attività nutrizionale dal suo-lo grazie a un diversificato e intenso rapporto disimbiosi ectomicorrizica con numerose speciedi funghi superiori. Tra questi sono ampiamenterappresentati i principali generi di basidiomicetia cappello, non ultimi quelli che suscitano nel-la nostra regione i maggiori interessi economi-ci e alimentari: boleti del «gruppo porcino» eovuli. Anche questi, al pari degli altri miceticomponenti la flora simbiontica e saprofitariadel bosco, sono condizionati nella presenza ediffusione dall’età, dalla struttura e più in ge-nerale dallo stadio evolutivo del soprassuolo. Èinfatti noto che nelle successive fasi di svilup-po che accompagnano una formazione fore-stale dall’età giovanile alla maturità e, infine, al-la senescenza, vengono a crearsi mutamentipedoclimatici altamente selettivi sia sulla com-posizione della micorrizia, sia sulla comparsastagionale delle fruttificazioni fungine.Nel caso delle selve castanili di origine antro-pica per eccellenza, da sempre la presenzadell’uomo e l’intensità e frequenza degli inter-venti influenzano la produzione di boleti. In ta-li boschi monospecifici la forma di governo apiù elevata e riconosciuta capacità funghige-na è sicuramente il castagneto da frutto che,gestito secondo i criteri plurisecolari dettatidalla tradizione, si presenta come alto-fustorado e luminoso con suolo inerbito, sfalciatoe/o pascolato, liberato in previsione della ca-duta delle castagne di ogni vegetazione arbu-stiva spontanea e della stessa lettiera, accu-mulata e interrata al piede degli alberi o in bre-vi e superficiali fosse aperte in pendiceparallelamente alle curve di livello. Queste ca-ratteristiche di soprassuolo, che consentono al-le cultivar più esigenti della specie, quali i ri-nomati «marroni», di esprimere al meglio tuttele potenzialità di fruttificazione, corrispondonoottimamente alle esigenze ecologiche dei bo-leti che, in tali nature, pur con i condizionamentidettati dall’andamento meteorologico estivo eautunnale, ripropongono annualmente la com-parsa delle loro ricercate fruttificazioni.
Nei castagneti abbandonati, sia per ragionisocioeconomiche, sia perché più intensamentecolpiti dal cancro corticale, l’involuzione ve-getativa dei grandi soggetti produttori e il pro-gressivo sviluppo delle specie arboreo-arbu-stive del sottobosco creano condizioni edafichesempre meno idonee alla diffusa presenza e al-la ricorrente fruttificazione di questi funghi. Sutali realtà il ritrovamento di porcini o ovuli è ingenere confinato a naturali chiarie, in borduredi bosco, lungo strade o sentieri, ove il pas-saggio dell’uomo e degli animali, unitamentea superficiali e locali fenomeni di erosione ge-nerati dagli eventi meteorici, ostacolano l’in-staurarsi al suolo di una copertura vegetalesoffocante e favoriscono, invece dell’accumu-lo, la decomposizione e mineralizzazione del-la lettiera.Nel caso del bosco ceduo il mantenimentodelle migliori capacità funghigene è stretta-mente legato alla periodicità delle utilizzazioni:il taglio genera un brusco arresto delle fruttifi-cazioni ma induce, con l’intensa insolazione delsuolo e il rimaneggiamento superficiale dellostesso causa le operazioni di esbosco, unarapida riattivazione dei processi di incorporodella materia organica nel primo orizzonte delprofilo, grazie anche all’azione della microflo-ra e della microfauna a ciò deputate.
LA PRODUZIONE DI FUNGHI
933
34
Con lo sviluppo dei ricacci dalle ceppaie, al se-condo-terzo anno di vegetazione dal tagliovengono a crearsi nelle stazioni idonee, postesu suoli acidi da rocce silicatiche e caratteriz-zate da un regime termo-udometrico tenden-te al caldo-asciutto, le condizioni più favorevolialla fruttificazione della Amanita caesarea che,in presenza di favorevoli precipitazioni di fine
estate-inizio autunno, esprime il massimo del-le potenzialità per due-tre anni da questo sta-dio di sviluppo del soprassuolo. Successi -vamente, con l’accrescimento dei giovani pol-loni e sino al compimento del turno breve,entro 10-15 anni dalla precedente utilizzazione,il bosco offre un buon habitat alla comparsa deiboleti, che via via rarificano nel ceduo maturo,confinandosi di preferenza alle chiarie, so-spendendo poi progressivamente le propriepresenze nelle formazioni che evolvono oltre ilturno consuetudinario. Boletus aereus eBoletus reticulatus, elettivi di boschi luminosi e«caldi», sono i primi a risentire gli effetti indot-ti sul pedo-clima dalla chiusura della vegeta-zione; Boletus edulis e Boletus pinicola, spe-cie tipicamente autunnali rispetto alle prece-denti, conservano più a lungo le capacità dimanifestarsi in forma di fruttificazione.In base a quanto sinteticamente espresso, lamessa in atto di programmi di valorizzazionedei cedui castanili basati su diradamenti se-lettivi del soprassuolo ai vari livelli di età puòquindi oggettivamente risultare favorevole, ol-tre che all’obiettivo primario di miglioramentodegli assortimenti ritraibili, anche alle poten-zialità funghigene di tali selve.
34
Boletus aereus, Porcino.
Iboschi, in relazione alle funzioni che svol-gono, forniscono molteplici servizi all’uomo,oltre ai prodotti diretti legnosi e non; sonoquindi soggetti a numerose norme che ne re-golano la gestione, in particolare ai fini di con-servazione naturalistica, paesaggistico-am-bientale, di protezione dell’assetto territoriale edel clima. Risulta pertanto importante richia-mare quelle più direttamente connesse allepratiche selvicolturali, fornendo indicazioni perla corretta applicazione delle procedure con l’a-dozione delle tecniche colturali proposte conil presente manuale.
NORME PAESISTICO-AMBIENTALIE DI CONSERVAZIONE DELLA NATURA
Come tutte le aree boscate ovunque ubicate icastagneti sono soggetti al vincolo paesistico-ambientale ai sensi delle norme sulla tuteladelle bellezze ambientali statali (Testo unico DL490/99, integrante la L. 1497/39 e la L. 431/85- Galasso) e regionali attuative (per il PiemonteL.R. 20/89 e s.m.i.). Esse innanzitutto impon-gono una specifica autorizzazione per le mo-dificazioni d’uso del suolo in aree boscate, in-clusi i progetti di viabilità forestale.Per quanto concerne più direttamente la sel-vicoltura, sono sottoposti ad autorizzazione gliinterventi di utilizzazione boschiva che non co-stituiscano tagli colturali. Nel merito la normaregionale precisa che non sono soggetti ad au-torizzazione paesistica gli interventi selvicoltu-rali eseguiti nel rispetto delle Prescrizioni diMassima e di Polizia Forestale (PMPF) di cui al-la legge forestale nazionale (R.D. 3267/23 esuccessivo regolamento del 1926), con le ec-cezioni sotto specificate; la stessa L.R. 20/89stabilisce che la validità delle PMPF è estesaa tutti i boschi, e quindi ai castagneti, su tuttoil territorio regionale, anche al di fuori delle zo-ne a vincolo idrogeologico. Restano comunquesempre soggetti ad autorizzazione ai fini pae-sistico-ambientali i tagli di maturità nelle fu-staie e le ceduazioni su superfici accorpate
superiori a 10 ettari, con o senza rilascio di ma-tricine. Alcune circolari ministeriali, facendo riferimentoalla L. 431/85, ed in attesa dell’adeguamentodella PMPF alla mutata situazione evolutivo-colturale dei boschi, prescrivono di valutareattentamente la casistica dei cedui non piùgestiti a regime, stabilendo di volta in volta sepossano ancora considerarsi tali i boschi inspontanea conversione a fustaia, con le con-seguenze normative del caso (divieto di ce-duazione, avviamento a fustaia o autorizza-zione per il taglio).Da tali norme sono esclusi i soli castagneti dafrutto in attualità di coltura specializzata, chenon rientrano nella definizione di aree bosca-te di cui al D.Lgs. 227/2001 recante «Norme perla modernizzazione del settore forestale»; es-so lascia tuttavia alle Regioni la facoltà di inte-grare la definizione generale di area boscata.In Piemonte la frequente situazione di discon-tinuità colturale, nonché le valenze ecologi-che e sociali di tali soprassuoli, portano a con-siderare gran parte dei castagneti da frutto co-me bosco.
Per quanto riguarda la conservazione dellanatura, esistono norme statali (L. 394/91) e re-gionali (L. 12/90 e s.m.i.) per l’istituzione, la pia-
LE NORMATIVE VIGENTI
1035
36
nificazione e la gestione delle Aree protette; al-l’interno delle aree protette istituite gli inter-venti selvicolturali sono normati da specificipiani forestali, in assenza dei quali sono sta-bilite specifiche procedure autorizzative.Altre norme rilevanti in campo di tutela natu-ralistica sono le direttive europee per la tuteladegli habitat e delle specie vegetali e animalid’interesse comunitario (Direttive 79/409/CEE– Uccelli e 92/43/CEE – Habitat), recepite dalGoverno Italiano; ai sensi di tali norme a curadi ciascuna Regione sono stati individuati Sitidi conservazione, coincidenti o meno con areeprotette già istituite, ufficializzati e trasmessiall’Unione Europea. Giova ricordare che i ca-stagneti, pur molto comuni da noi, costitui-scono un habitat forestale di interesse comu-nitario, peraltro ben rappresentato nei nume-rosi parchi e riserve naturali del Piemonte.
PIANIFICAZIONE FORESTALEE NORME SELVICOLTURALI
La Legge forestale regionale vigente (L.R.57/79) prevede la redazione di piani forestaliper la gestione dei boschi, con priorità per lezone soggette a vincolo idrogeologico, le areeprotette e i boschi pubblici; al di fuori dellearee protette sono pochi i boschi soggetti aPiano d’assestamento forestale in vigore, epochissimi di questi riguardano proprietà pri-vate o comunque castagneti. Negli ultimi annila Regione Piemonte ha portato avanti e so-stanzialmente completato (2003) la pianifica-zione forestale a scala territoriale (di ComunitàMontana o altre aree forestali omogenee), conla redazione di piani forestali territoriali i qualicontengono carte e indirizzi gestionali detta-gliati; tali documenti, pur non essendo anco-ra cogenti a termini di legge, costituiscono pergli operatori un valido strumento conoscitivo edi orientamento.In assenza di Piani di gestione forestale ap-provati, il quadro normativo attuale per la sel-vicoltura è dato in tutti i casi dalle PMPF; que-ste erano redatte su base provinciale prima
del trasferimento delle funzioni forestali alleRegioni. Per il Piemonte con un recente prov-vedimento (DGR 66-884/2000) le PMPF sonostate integrate, rendendole omogenee per lediverse province e specificando le procedureda osservare, in particolare per i boschi non fa-cilmente inquadrabili nell’impianto normativooriginario a seguito dell’abbandono colturale odella modificazione dei turni consuetudinari diutilizzazione. Di seguito si richiamano norme eprocedure relativamente alla gestione dei ca-stagneti.Per i cedui è prescritto un turno minimo di 9 an-ni; non è invece fissato un turno massimo, inquanto il castagno non perde la facoltà pollo-nifera con l’invecchiamento. Per i cedui semplici puri è prescritto un rilasciodi almeno 20 matricine per ettaro, anche agruppi. I popolamenti in cui siano presenti al-meno 30 matricine o riserve ad ettaro di spe-cie diverse dal castagno (esclusa robinia) so-no da assimilare a cedui composti, vale a direalla forma di governo misto e promiscuo a fu-staia e ceduo, e pertanto al momento del taglioè prescritto il rilascio di 140 piante/ha ripartitesu più classi di età; in carenza di altre speciepossono essere reclutate matricine di casta-gno, queste ultime sempre a gruppi. Per gli interventi di ceduazione è richiesta la co-municazione per superfici superiori ai 5.000metri quadri, ed autorizzazione ai fini paesisti-ci per lotti estesi oltre 10 ettari. Per l’abbatti-mento delle matricine/riserve nei cedui com-posti è richiesta comunicazione fino a 20 pian-te, autorizzazione per entità superiori, secondole modalità di seguito specificate per le fustaie,cui esse sono assimilate.Riguardo alle fustaie, il R.D.L. 973/31 reca nor-me specifiche per la tutela dei castagneti ad al-to fusto, mirate a controllarne l’abbattimento in-discriminato per la fornitura di materiale alle in-dustrie del tannino; essa prescrive un iterautorizzativo per gli abbattimenti dei castagni.Per il solo castagno è consentita la conversio-ne da fustaia a ceduo per motivi fitosanitari(attacchi di cancro corticale). Tale norma spe-cifica è da ritenersi superata dalla legge fore-
37
stale regionale (L.R. 57/79) la quale, in assen-za di Piani forestali approvati, prescrive l’auto-rizzazione per i tagli di piante d’alto fusto di tut-te le specie, con procedure diverse a secondadell’ubicazione (competenza regionale in zo-ne a vincolo idrogeologico o aree protette, co-munale al di fuori).Più specificamente per i tagli di maturità nellefustaie il turno minimo fissato dalle PMPF è di70 anni, con autorizzazioni (forestale comun-que e paesistico-ambientale in caso di tagliodell’intero soprassuolo su oltre 1000 metri qua-dri) per tagli che interessano più di 20 piantee comunicazione per un numero inferiore.
Riguardo alle epoche d’intervento nei boschi,il taglio dei cedui può essere eseguito dal 16ottobre al 31 marzo per altitudini non superio-ri a 800 metri; dal 1° ottobre al 30 aprile per al-titudini comprese tra 800 e 1200 metri. Gli sfol-li, i diradamenti, i tagli di conversione e le uti-lizzazioni nelle fustaie possono essere eseguitiin qualunque periodo dell’anno.
INDIRIZZI PER L’INQUADRAMENTODEI POPOLAMENTI ATTUALI
Una consistente parte dei castagneti sono de-finibili come cedui semplici con o senza ma-tricine, talora come cedui composti (fustaie so-pra ceduo o cedui sotto fustaia a seconda del-lo strato prevalente), con matricine e riservescarse ed irregolarmente distribuite. La mag-gior parte dei soprassuoli non sono a regime,e si presentano in evoluzione libera per ab-bandono colturale oppure utilizzati a intervalliben oltre i turni consuetudinari; le classi di etàprevalenti variano tra i 25 ed i 40 anni, quindioltre il triplo del turno minimo di cui alle PMPF.In talune stazioni si assiste ad uno spontaneoprocesso di affrancamento di polloni e/o cep-paie, che denotano una successione verso lastruttura e la biomassa proprie delle fustaie: intali casi i popolamenti devono inquadrarsi co-me cedui in conversione, ricadenti pertanto atutti gli effetti nel regime normativo delle fu-
staie. Spesso invece si notano processi di in-vecchiamento del ceduo con senescenza ge-neralizzata e tendenza al collasso colturale,che non fanno prevedere per il soprassuolo at-tuale una tendenza all’autostabilizzazione enon rendono applicabili le norme proprie del-le fustaie.Nel caso del castagno non vi è il rischio diperdita della facoltà pollonifera delle ceppaie,tuttavia con l’invecchiamento alla selezione trapolloni sulle singole ceppaie subentra la fasedi competizione tra ceppaie, con morte di quel-le più deboli e affrancamento di polloni con-cresciuti sulle dominanti. Inoltre anche ope-rando tagli di rinnovazione tipici delle fustaie,le ceppaie delle piante portaseme ricacciano,e nei casi più favorevoli si può ottenere un po-polamento di origine mista da seme e da pol-loni; pertanto la gestione del castagneto da le-gno non è inquadrabile nettamente né nei ce-dui né nelle fustaie, ma in una forma di governomisto fustaia-ceduo, a sua volta con caratteri-stiche diverse dai tradizionali cedui composti,le cui regole gestionali oggi non sono appli-cabili per la produzione di legname. Anche ilturno minimo di 70 anni imposto dalle PMPFper le fustaie di castagno può essere eccessi-vo rispetto alle potenzialità d’incremento del-la specie e per le fustaie derivate da polloni;queste, in virtù della loro rinnovazione mista ga-mica e agamica, possono essere gestite conmaggiore flessibilità senza comprometterne lacontinuità. Pertanto al fine di evitare sia contenziosi, epossibili sanzioni, a seguito di diverse inter-pretazioni delle norme, sia interventi pregiudi-zievoli per il futuro del bosco, si ritiene oppor-tuno consigliare, nell’ambito della comunica-zione preventiva prevista per le utilizzazioni, diverificare con i tecnici incaricati dell’assisten-za tecnica, del controllo e della vigilanza, l’ef-fettiva situazione dei popolamenti, soprattuttoquando questi abbiano superato il triplo del tur-no minimo previsto per i cedui (27 anni).Talora si riscontrano castagneti cedui con ri-serve più o meno numerose di altre specie,soprattutto faggio, querce e sporadiche latifo-
glie nobili; in questi casi si tratta in effetti di unaforma di governo misto, a ceduo composto,generalmente con prevalenza dello strato aga-mico sotto fustaia. Spesso le riserve sono innumero inferiore alle 140 per ettaro prescritteper tale forma di governo dalle PMPF, tuttaviai popolamenti non si possono ricondurre a ce-dui matricinati, in quanto le piante da seme nonsono della stessa specie del ceduo e non pos-sono svolgere una funzione selvicolturale es-senziale delle matricine, ovvero rigenerare leceppaie senescenti.Dal punto di vista normativo quindi lo strato difustaia è soggetto alle prescrizioni per taleforma di governo, ed in caso di utilizzazionedel ceduo, le riserve devono essere rispar-miate e ricondotte per lo meno al numero mi-nimo attuale di legge (140/ha); in questi casisi consiglia di reclutare prioritariamente tutte
le specie diverse dal castagno, anche a grup-pi, con preferenza per quelle costruttrici del-le cenosi naturali (querce e faggio), con glieventuali castagni (spesso derivati da polloni)a gruppi intorno a queste. Sia nei cedui sem-plici sia in quelli composti non ha invece uti-lità pratica rilasciare matricine isolate di ca-stagno, regolarmente distribuite sulla super-ficie, in quanto soggette a deperimento edanni tecnologici del legname (cipollatura,nodi da rami epicormici).La redazione di piani di gestione forestale a li-vello aziendale per le proprietà estese o as-sociate, o di schede di popolamento per lepiccole, delineando nel medio-lungo periodoobiettivi ed interventi, può semplificare il si-stema normativo attuale, basato su prescri-zioni che affrontano la gestione dei cedui nel-la sua generalità ed episodicità.
38
La vitalità dei castagneti sino ai nostri gior-ni è stata compromessa soprattutto dagli
attacchi di due funghi patogeni: Chrypho -nectria parasitica, responsabile del cancrocorticale e Phyto phtora cambivora, agente delmal dell’inchiostro. A queste due avversità, che in passato hannoconcorso non poco al degrado e all’abban-dono di vaste aree castanili, si è aggiunto og-gi l’insetto galligeno Dryocosmus kuriphilus, ci-nipide orientale di recente introduzione.
Il cancro della corteccia, segnalato per laprima volta in Italia nel 1938, è storicamente lapiù grave e diffusa malattia del castagno.I sintomi sono rilevabili sui polloni e sui giovanirami con la comparsa di tacche rosso matto-ne depresse, poi fessurate, che nel tempotendono ad assumere un andamento avvol-gente; forma, dimensione ed evoluzione diqueste aree variano non solo in funzione del-
l’organo colpito, ma soprattutto dal livello diaggressività del patogeno. Sulle parti infette itessuti corticali appaiono variamente ipertro-fici e crepacciati; al di sotto compaiono le frut-tificazioni del fungo sotto forma di pustolearancioni ed in seguito si formano strati di mi-celio feltroso. Le piante infette sono facilmente individuabiliper la presenza di branche o rami secchi eseccaginosi, che dalla parte inferiore tendonoa sviluppare nuovi ricacci di sostituzione del-la vegetazione sovrastante uccisa dal parassita.Da molti anni si manifestano nuovi tipi di can-cri da ceppi di fungo ipovirulenti, che tendonoa cicatrizzare con vistosi rigonfiamenti e chenon causano la morte della parte colpita: so-no caratterizzati da una minore aggressivitàe, diffondendosi nella popolazione del pato-geno, hanno innescato un processo evolutivobenigno della malattia che è alla base della ri-presa vegetativa dei castagneti europei.
Il mal dell’inchiostro deve il suo nome al co-lore nerastro che assumono le radici colpite eagli essudati tannici che gemono dalla basedel fusto. La malattia è stata osservata e stu-diata fin dall’Ottocento, ma il patogeno è sta-to individuato solamente nel 1917.Si manifesta con improvvisi ingiallimenti fo-
LE AVVERSITÀ DEL CASTAGNO
Ramo di castagnocon evidenti sintomiattribuibili al fungoChryphonectriaparasitica, agentedel cancro della corteccia. Sono visibili le zoneinfette di colore rossastro, le lacerazioni corticalie la reazione di rigonfiamento.
3911
A fianco, fusto di castagno
scortecciato per evidenziare le caratteristiche macchie nere provocate daPhytophtora
cambivora.
A destra, esemplaridi castagno morti in piedi a seguito
di attacchi diPhytophtora
cambivora.
gliari ed il progressivo e spesso repentino av-vizzimento delle fronde; caratteristica di que-sta patologia è il mantenimento, sull’alberoappena morto, delle foglie secche e dei ricci.Scortecciando la zona del colletto si eviden-ziano a carico dei tessuti conduttori e genera-tivi (cambio) tipiche necrosi a forma di fiamma,che emanano un caratteristico odore di so-stanze tanniche fermentate. Poiché i propaguli del patogeno si diffondonotramite l’acqua, per prevenirne la diffusione èmolto importante evitare ristagni idrici, mante-nere ben drenati i terreni e, soprattutto, evita-re il ruscellamento dagli appezzamenti conpiante colpite ai boschi ancora sani.
L’imenottero cinipide Dryocosmus kuriphi-lus, originario della Cina, è stato segnalatoper la prima volta in Europa nel Cuneese nel2002, dove ha già causato gravi danni, anchese su zone per ora circoscritte. L’arrivo in Italiaè probabilmente legato all’introduzione di ma-teriale propagativo di castagno da frutto dall’E -stre mo Oriente o dal Nord America.L’insetto provoca la formazione di galle ton-deggianti, di 5-20 mm di diametro, di colore
40
verde o rossastro, su foglie, germogli e infio-rescenze, compromettendo lo sviluppo vege-tativo delle piante e la loro fruttificazione. Colpisce, oltre alle specie orientali e nordame -ricane, anche gli ibridi ed il castagno euro-peo, sia selvatico che innestato.L’insetto attacca unicamente il castagno e pre-senta una sola generazione all’anno. Da finegiugno a fine luglio fuoriescono dalle galle so-lo femmine adulte, in quanto specie parteno-genetica, che appena sfarfallate depongononelle gemme presenti da 100 a 200 uova. Allaripresa vegetativa nell’anno successivo, la lo-ro attività trofica determinerà la formazionedelle caratteristiche galle.Per contenere la propagazione del parassita,molto probabile sia per cause antropiche chenaturali, sarà importante evitare la diffusionedi materiale infestato dalle zone colpite o li-mitrofe.In Piemonte è già stata avviata la sperimenta-zione tramite lotta biologica, con l’introduzio-ne del parassitoide specifico, l’imenottero cal-cidoideo Torymus sinensis, che in Giappone hadato buoni risultati.
Galle diDryocosmus kuriphilus e deformazioni fogliari.
41
A.A.V.V., Il castagno nella regione padano alpi-na: diffusione, trattamento, patologia, RegioneLombardia, Atti Convegno del 17 marzo 1978.
—, Castagno 2000, Atti del Convegno, Cameradi Commercio, Industria, Artigianato e Agri -coltura di Cuneo, Pianfei (CN) 9 novembre1990.
—, «Châtaignier: vers la production de boisd’oeuvre», Forêt Entreprise, 22, I.D.F., Paris1987.
—, «Châtaignier: des taillis à ne pas négliger»,Forêt Entreprise, 44, I.D.F., Paris 1987.
—, Le conversioni dei cedui: un’analisi delleesperienze e degli indirizzi tecnici ed eco-nomici. E.N.C.C., Roma 1987.
—, Cipollatura e caratteristiche strutturali di unceduo di castagno nel Pie monte settentrio-nale, Dipartimento Agro SelviTer del l’Uni ver -sità di Torino, Relazione finale CEE, DG XII,1993.
—, Congresso Internazionale sul Castagno,Atti Comunità Montana dei Monti Martani edel Serano, Università di Perugia, Spoleto1993.
—, Il legno di castagno e douglasia dellaToscana. Qualità del legno e selvicoltura.Classificazioni e valori caratteristici del le-gname strutturale. Quaderno ARSIA 9/99,Firenze 1999.
—, «Pourquoi e comment cultiver le chatai-gnier?», dossier di Forêt Entreprise, n. 149,I.D.F., Paris 2003.
—, Un nuovo pericoloso parassita del casta-gno. Il cinipide galligeno Dryo cosmus kuri-philus Yasumatsu. Regione Piemonte,Direzione Sviluppo dell’Agri col tura, SettoreFitosanitario, 2003.
—, Vademecum per la valorizzazione com-merciale del legname tondo, a cura di PaoloMori, ARSIA, Regione Toscana, EditoreCom pagnia delle Foreste, Arezzo 2002.
AMORINI, E., BRUSCHINI, S., FIORAVANTI,M., MACCHIONI, N., MANETTI, M.C., THI-BAUT, B., UZIELLI, L., Studi sulle cause di in-sorgenza della cipollatura nel legno di ca-stagno. Atti Convegno nazionale sul casta-gno, Cison di Valmarino (TV) 1997.
BERNETTI, G., Selvicoltura speciale, UTET,Torino 1995.
BIGNAMI, G.R., SALSOTTO, A., Civiltà del ca-stagno, L’Arciere, Cuneo 1983.
BOGGIA, L., «Conclusioni sulla castanicolturanazionale», in Cellulosa e Carta, n. 4, 1988.
BOUNOUS, G., Tra i castagni del cuneese,Edizioni Metafore 1999.
— (a cura di), Il castagno. Coltura, ambiente edutilizzazioni in Italia e nel mondo. Edagricole,Bologna 2002.
BOURGEOIS, C., Le châtaignier, un arbre, unbois, I.D.F., Paris 1992.
BRUSSINO, G., BOSIO, G., BAUDINO, M.,GIORDANO, R., RAMELLO, F., MELIKA, G.,«Pericoloso insetto esotico per il castagnoeuropeo», L’informatore agrario, 37, pp. 59-61, 2002.
CANTIANI, M., «Ricerche alsometriche e den-drometriche sui cedui di castagno dei MontiCimini», in L’Italia Forestale e Montana, n. 18,Firenze 1963.
CAVA, S., CIANCIO, O., «Osservazioni speri-mentali sui cedui originatisi per conversionedi castagneti da frutto», in Annali Ist.Sperimentale Selvicoltura, n. 6, Arezzo 1975.
CIELO, P., THIBAUT, B., ZANUTTINI, R., «Ele -men ti prefiniti per pavimenti di legno realiz-
BIBLIOGRAFIA4212
43
zati con assortimenti di castagno prove-nienti da bosco ceduo», in Monti e Boschi,n. 6, 1996.
GIORDANO, G., Tecnologia del legno. Vol. III,Parte seconda: I legnami del commercio,UTET, Torino 1988.
HUBERT, M., Amélioration des taillis par bali-vage intensif, I.D.F., Paris 1983.
I.N.P.L., «Inventario dei cedui di castagno efaggio in Provincia di Cuneo nelle valli Stura,Grana, Maira», in Esperienze ed inda gini peruna selvicoltura moderna, Atti del conve-gno, Regione Piemonte, vol. II, 1979.
I.P.L.A., Conoscenza e valorizzazione dei boschidi castagno in Piemonte, Relazione finaleM.A.F, 1990.
—, Nuovi metodi di selvicoltura e tecnologie in-novative per la valorizzazione del legno di ca-stagno come materia prima per lavorazioniindustriali, Relazione finale, CEE-DG XI I-Regione Piemonte, 1993.
I.P.L.A., REGIONE PIEMONTE, I boschi e la car-ta forestale del Piemonte. Guida, Napoli 1981.
—, I Tipi forestali del Piemonte (edizione ag-giornata in corso di pubblicazione sul sitowww.regione.piemonte.it), 1997.
—, Boschi collinari, Blu Edizioni, Peveragno(CN) 2001.
—, Alberi e arbusti. Guida alle specie sponta-
nee del Piemonte, Blu Edizioni, Peveragno(CN) 2002.
—, Norme tecniche per la pianificazione fore-stale territoriale (in corso di pubblicazione sulsito www.regione.piemonte.it), 2003.
LEIBUNDGUT, H., «Il trattamento dei boschi del-la regione castanile del Cantone Ticino», inSchweiz. Z. Forstwes., n. 126, Zurich 1975.
MACCHIONI, N., PIVIDORI, M., «Qualità dellegno del ceduo di castagno: gestione deipopolamenti», in Silvae Pedemontis 2(1),Ed. Ass. Forestale del Piemonte, 1996.
M.A.F., I.S.A.F.A., Inventario Forestale Nazionale1985: sintesi metodologica e risultati. Roma1988.
NICOLOTTI, G., DELLA BEFFA, G., MONDI-NO, G.P., PALENZONA, M., Alberi monu-mentali in Piemonte. Priuli e Verlucca 2002.
PALENZONA, M., FERRARA, A.M., PREVOSTO,M., «L’economia del castagno nell’Italia set-tentrionale», in Cellulosa e Carta, n. 3, 1987.
PICCIOLI, L., Monografia del castagno, G.Spinelli e C., Firenze 1922.
PIVIDORI, M., Analisi dendroecologica di ceduidi castagno. Atti del I Congresso SISEF,Legnaro (PD) 1997.
PONTI, I., LAFFI, F., Malattie crittogamiche del-le piante da frutto, Schede fitopatologiche,Edizioni L’informatore Agrario 1988.