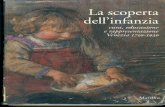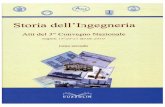Dimensioni culturali nella vita degli italiani ( Cultural dimension inside Italian society)
L'attidografia nella storia degli studi
Transcript of L'attidografia nella storia degli studi
Comitato scientifico: Cinzia Bearzot, Franca Landucci, Philip A. Stadter, Giuseppe Zecchini.
PP Bearzot Landucci.qxd 10-11-2010 15:36 Pagina 2
a cura di
CINZIA BEARZOT
FRANCA LANDUCCI
Storie di Atene,storia dei GreciStudi e ricerche di attidografia
ST
OR
IA |
RIC
ER
CH
E
PP Bearzot Landucci.qxd 10-11-2010 15:36 Pagina 3
www.vitaepensiero.it
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limitidel 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previstodall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico ocommerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essereeffettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso diPorta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail: [email protected] e sito webwww.aidro.org
© 2010 Vita e Pensiero - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 MilanoISBN 978-88-343-1950-5
La pubblicazione di questo volume ha ricevuto il contributofinanziario dell’Università Cattolica.
PP Bearzot Landucci.qxd 10-11-2010 15:36 Pagina 4
INDICE
Introduzione VII
ROBERTO NICOLAIL’attidografia come genere letterario 3
GIORGIO CAMASSAL’attidografia nella storia degli studi 29
GABRIELLA OTTONEL’ jAttikh; xuggrafhv di Ellanico di Lesbo. Una Lokalgeschichtein prospettiva eccentrica 53
CINZIA BEARZOTL’orientamento politico degli attidografi: ancora sul caso di Androzione 113
PAOLO A. TUCIClidemo di Atene 129
MARCELLO BERTOLIL’Atthis di Fanodemo nell’Atene licurghea 181
VIRGILIO COSTACecrope il fondatore e le origini della monarchia ateniesenell’Atthis di Filocoro 215
FRANCA LANDUCCIIstro il Callimacheo 231
MILENA RAIMONDIL’attidografia dall’erudizione tardoellenistica agli storici ateniesi Dexippo e Praxagora 255
00_indice:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina V
GIORGIO CAMASSA
L’attidografia nella storia degli studi
per C.
Nel 1941 Felix Jacoby, esule ad Oxford da due anni, indirizzò alsegretario ai delegati della Clarendon Press una lettera, con cuichiedeva se la casa editrice dell’Università fosse disposta a pubbli-care un libro di circa seicento pagine sugli storiografi locali ate-niesi, da intitolare The Atthidographers. Mortimer Chambers, che hadedicato alla figura e all’opera di Jacoby saggi fondamentali1,ricorda quale fosse la risposta: il titolo proposto era eccessivamen-te complesso e sarebbe stato necessario chiarirlo; inoltre, per lastampa si sarebbe dovuto aspettare sino alla fine della guerra (l’e-stensore della lettera si espresse, con invidiabile understatement bri-tannico, in questi termini: «fino a che l’emergenza sarà supera-ta»). Pochi anni dopo, nel 1946, Jacoby e la moglie consegnaronoalla Clarendon Press un enorme manoscritto che, secondo uncomputo approssimativo, avrebbe prodotto più di milleottocentopagine a stampa: prender in considerazione l’idea di pubblicareun’opera di pari dimensioni era, per la casa editrice oxoniense,semplicemente impossibile. Si addivenne a un onorevole compro-messo, suggerito da H.T. Wade-Gery. L’introduzione, nella suainterezza, sarebbe stata pubblicata come un libro a parte dallaClarendon Press; l’amplissimo materiale restante confluì invecenei Fragmente der griechischen Historiker. L’introduzione pubblicata aparte, nel 1949, è Atthis. The Local Chronicles of Ancient Athens.
Atthis è un libro superbo, di straordinario valore scientifico2. Èanche, però, un’opera che segna il culmine di un processo di
1 The Genesis of Jacoby’s Atthis, in E.M. CRAIK (ed.), ‘Owls to Athens’. Essays on ClassicalSubjects Presented to Sir Kenneth Dover, Oxford 1990, pp. 382-390; ID., La vita e la carriera diFelix Jacoby, in C. AMPOLO (a cura di), Aspetti dell’opera di di Felix Jacoby2, Pisa 2009, pp. 5-29.2 Un confronto con i risultati cui perviene L. Pearson (The Local Historians of Attica,Lancaster [Pennsylvania] 1942) sarebbe ingeneroso.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 29
affrancamento intellettuale. Infine è, in certo senso, una condan-na. Vorrei render conto di ognuna di queste affermazioni. PerchéAtthis sia un libro di straordinario valore scientifico è presto detto:perché pone con rigore un problema capitale – quello dei rap-porti fra storiografia panellenica (grande storiografia) e storio-grafia locale (orografia)3 – e lo risolve brillantemente. Non solo:costruisce un’immagine coerente dell’attidografia in quantoparte della storiografia locale. Perché Atthis sia un libro che segnail culmine4 di un processo di affrancamento intellettuale e checostituisce, forse proprio per questo, un prodotto cospicuo dellapiù grande cultura del Novecento, è chiaro: perché rifiuta in bloc-co, con argomenti difficilmente contestabili, un’idea che era statacara ai mentori della giovinezza di Jacoby, più esattamente aWilamowitz5 il quale traeva spunto, a sua volta, da Mommsen(anche con Mommsen, del resto, Jacoby aveva collaborato). Lacronaca preletteraria degli exegetai, preteso analogon degli annalespontificali romani, base a partire da cui, una volta intervenuta lapubblicazione di un’Atthis anonima intorno al 380, si sarebbe svi-luppata l’attidografia6, si scioglieva sotto la critica affilata e inin-terrotta di Atthis come neve al sole. L’attidografia nasce, secondoJacoby, in tutt’altro modo: come ramificazione secondaria, che sidiparte dalla linea principale della storiografia panellenica.Perché Atthis sia una condanna è illustrato molto chiaramente, adesempio, da Oswyn Murray, là dove afferma che tuttora, nel benee nel male, per accettarne o rovesciarne le tesi principali, nonpossiamo che prendere le mosse da Jacoby7. Altrimenti detto, non
GIORGIO CAMASSA30
3 Contro l’identificazione fra storiografia locale e orografia si sarebbe pronunciato K.von Fritz (Griechische Geschichtsschreibung, I. Von den Anfängen bis Thukydides, Berlin1967, I. 1 pp. 96-97; I. 2, pp. 74-75 nota 80).4 Mi esprimo in questi termini perché non mancano in precedenza puntatepolemiche di Jacoby verso Wilamowitz: v. ad es. il famoso articolo del 1909 (Über dieEntwicklung der griechischen Historiographie und den Plan einer neuen Sammlung dergriechischen Historikerfragmente, «Klio», 9 [1909], pp. 80-123, 113-114) in cui viene cri -ticata l’altrettanto celebre lecture di Wilamowitz (Greek Historical Writing, Oxford 1908,p. 6), per l’idea secondo cui Erodoto avrebbe rigettato le cronache impersonali, chedovevano essere a lui note.5 Aristoteles und Athen, I-II, Berlin 1893.6 V. la nota precedente.7 Herodotus and Oral Tradition Reconsidered, in N. LURAGHI (ed.), The Historian’s Craft inthe Age of Herodotus, Oxford 2001, pp. 314-325, 319.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 30
siamo liberi di pensare il problema della storiografia locale ingenere, e dell’attidografia in particolare, senza riferirci ad Atthis.Ribadirò8 che c’è qualcosa di singolare in questa situazione9:Jacoby, forse anche per affrancarsi definitivamente da chi avevadominato la sua formazione intellettuale, è proteso a dimostrarecon insistenza martellante che la teoria degli exegetai cara aWilamowitz (e, per interposta persona, a Mommsen) è destituitadi fondamento; noi, consapevoli fra l’altro della nostra minoritàrispetto ai giganti di un tempo, siamo in qualche misura schiac-ciati dalla grande, quasi fantasmatica, presenza di Atthis e nonriusciamo a lasciarci alle spalle quest’opera straordinaria. Infondo, non c’è da stupirsi: il discorso scientifico, lo sappiamo, èun groviglio di ragioni emotive e intellettuali.
Entrando direttamente in tema, mi soffermerò ora su alcunedelle tesi fondamentali di Atthis, che ho selezionato in ragionedella loro importanza: sarà più agevole, così, metter a fuoco glisviluppi del dibattito nell’ultimo sessantennio.
Prenderò le mosse precisamente dal rapporto fra grande sto-riografia e storiografia locale delineato da Jacoby, un rapportoper cui la nascita della storiografia locale – nella quale rientra l’at-tidografia – sarebbe determinata dalla maturazione della storio-grafia panellenica. All’atto di procedere a una ricognizione inquesto campo, vorrei comunque ripetere che la categorizzazionedel discorso storico dei Greci, in Jacoby, non si limita affatto allacoppia storiografia panellenica10/storiografia locale, ma è infini-tamente più complesso. Jacoby distingueva, infatti, cinque speciedel discorso storico dei Greci: genealogia (mitografia), etnogra-fia, cronografia, Zeitgeschichte (= storiografia a carattere panelleni-co, che si concentra sui grandi fatti contemporanei, o quasi con-temporanei, all’autore), storiografia locale11. Negli ultimi decen-
L’ATTIDOGRAFIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 31
8 Cfr. G. CAMASSA, Gli «elementi della tradizione»: il caso dell’Athenaion Politeia, in G.MADDOLI (a cura di), L’Athenaion Politeia di Aristotele 1891-1991. Per un bilancio dicento anni di studi (Acquasparta, 27-29 maggio 1991), Napoli 1994, pp. 149-165, 151-152.9 E, se si vuole, in questa parziale coazione a ripetere.10 Le cui radici affondano, secondo Jacoby e non solo secondo Jacoby, nell’epos.11 In effetti la storiografia locale è, agli occhi dello Jacoby della piena maturità (neriporto gli ipsissima verba), anche «a genus of literature, not a species or subspecies»(Atthis, p. 68).
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 31
ni alcuni12 hanno messo in discussione la validità di questa cate-gorizzazione del discorso storico dei Greci e lo sviluppo della sto-riografia greca come delineato da Jacoby13, con i suoi impliciti oespliciti giudizi di valore; per ciò che concerne la coppia storio-grafia panellenica/storiografia locale, occorre comunque rilevareche i tentativi di delineare, a fronte del modello jacobiano, solu-zioni organiche a una questione estremamente intricata, anzitut-to per la povertà e la controvertibilità dei dati in nostro possessosui primi storiografi locali, sono meno numerosi di quanto sisarebbe portati a credere.
La via più semplice per controbattere la tesi jacobiana è (stata)quella di asserire che la storiografia locale non può che precede-re la grande storiografia e di trovare conferma al proprio convin-cimento nel famoso quinto capitolo del De Thucydide di Dionigi diAlicarnasso, ma un percorso siffatto è sicuramente esposto a duecontestazioni fondamentali: l’affermazione secondo cui la storio-grafia locale deve precedere la grande storiografia rischia di esse-re un articolo di fede, se non è comprovata da argomenti irrefu-tabili; quanto al passo di Dionigi, può contenere un tentativo diricostruzione della storia della storiografia greca in fondo nonmeno arbitrario dei nostri, se espone una teoria antica anzichéportare alla luce tradizione genuina. La via cui ho appena fattocenno – pretesa ‘naturalità’ della precedenza della storiografialocale a fronte di quella panellenica, sostanziata dal riferimento a
GIORGIO CAMASSA32
12 Forse più che alcuni, sembra si possa ormai parlare di una sorta di Tendenz. Non èqui mia intenzione elencare tutti i dati bibliografici pertinenti: v. comunque, anzi-tutto, le ampie analisi generali di S.C. HUMPHREYS, Fragments, Fetishes, and Philosophies:Towards a History of Greek Historiography after Thucydides, in G.M. MOST (ed.), CollectingFragments/Fragmente sammeln, Göttingen 1997, pp. 207-224; G. SCHEPENS, Jacoby’sFGrHist: Problems, Methods, Prospects, ibidem, pp. 144-172; J. MARINCOLA, Genre,Convention, and Innovation in Greco-Roman Historiography, in C.S. KRAUS (ed.), TheLimits of Historiography: Genre and Narrative in Ancient Historical Texts, Leiden-Boston-Köln 1999, pp. 281-324. Inoltre, N. LURAGHI, Introduction, in ID. (ed.), The Historian’sCraft, pp. 1-15, partic. 4-8. Quanto ai contributi di R.L. FOWLER, v. infra, pp. 33-34.Sintesi delle argomentazioni prodotte contro lo schema di sviluppo della storiografiagreca prospettato da Jacoby, ad esempio, in J. MARINCOLA, Introduction, in ID. (ed.), ACompanion to Greek and Roman Historiography, Malden (Massachusetts)-Oxford-Carlton(Victoria) 2007, I , pp. 1-9, 6-7; v. anche P. HARDING, Local History and Atthidography,ibidem, pp. 180-188, 185-186 (dov’è accennato un interessante raffronto fra storio -grafia locale antica e moderna). 13 Uno sviluppo che sarebbe, inter alia, essenzialmente teleologico.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 32
Dionigi – è dunque, a mio avviso, una scorciatoia suggestiva maimpraticabile e, come tale, andrebbe evitata.
Passerò adesso a esaminare qualche contributo che mi è sem-brato non inficiato da presupposti indimostrabili. La mia selezio-ne è arbitraria e idiosincratica. Inoltre, mi sono concentratosoprattutto sui lavori apparsi negli ultimi quindici anni, poichénon mancano le rassegne da cui desumere le linee della ricercanegli anni antecedenti.
Che cosa può esserci di più sensato – si dirà – di una verifica ditutti i dati riguardanti gli storiografi che sembrerebbero imme-diatamente antecedenti o contemporanei a Erodoto? Lungo que-sto itinerario si è mosso, in un primo lavoro, Robert L. Fowler14:egli pensa che diversi autori, e fra costoro diversi storiografi,avrebbero potuto essere noti a Erodoto15. Lo stesso elenco diDionigi16 sarebbe suscettibile di ampliamenti – restando all’inter-no di quell’elenco, gli indizi più consistenti si concentranocomunque, in base all’analisi di Fowler, soprattutto su Ellanico eCarone di Lampsaco. Tuttavia, lo stesso Fowler deve rilevare nellapremessa del suo pregevole saggio «l’assenza di una cronologiacerta», deve concedere insomma che non è possibile giungere aconclusioni cogenti in ordine ai rapporti cronologici fra l’operadi Erodoto e quella dei suoi ‘contemporanei’. Di qui, il tentativoda parte di Fowler di irrobustire la sostanza delle sue argomenta-zioni individuando, ad esempio, le caratteristiche salienti di ognisingolo storiografo per procedere così alle opportune compara-zioni17, che permettono di individuare un sostrato comune e disottrarre Erodoto al suo ‘splendido isolamento’. Fowler è tornatoin almeno un’altra occasione18 sulla problematica che qui ci inte-
L’ATTIDOGRAFIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 33
14 Herodotus and His Contemporaries, «The Journal of Hellenic Studies», 116 (1996), pp.62-87.15 A rigore, per dimostrare l’eventuale anteriorità della storiografia locale rispettoalla panellenica, bisognerebbe che le opere chiamate in causa fossero precedenti aErodoto e iscrivibili con certezza entro la categoria delle storie locali.16 È da osservare che Fowler assume il passo dionigiano come un’evidenza che nonnecessita, a sua volta, di una disamina preliminare, atta a stabilire se esso contengauna ricostruzione storiografica antica.17 Attraverso un’analisi narratologica.18 V. anche il suo Herodotus and His Prose Predecessors, in C. DEWALD - J. MARINCOLA
(eds.), The Cambridge Companion to Herodotus, Cambridge 2006, pp. 29-45, con ulterio -ri dati bibliografici.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 33
ressa, ma, per quanto sia affascinante ragionare in termini di sto-riografia locale e panellenica che esistono l’una accanto all’altrasin dalla nascita delle poleis19, una simile prospettiva20 è, a mepare, alquanto astratta. E non mi riesce francamente di condivi-dere l’assunto dell’artificiosità della distinzione, da parte nostra,fra grande storiografia e storiografia locale. Gli antichi – va da sé– riconoscevano l’esistenza dei generi letterari e la validità delle‘leggi’ (sia pure da intendere in senso flessibile) che ad essi pre-siedevano21. Riconoscevano, inoltre, che scrivere storia panelleni-ca e scrivere storia locale non era propriamente la stessa cosa22.
Vengo a un altro esempio che ho prescelto per illustrare lo svi-luppo della ricerca postjacobiana in tema di rapporti fra grandestoriografia e storiografia locale. Leone Porciani non si nascondei punti deboli della tesi di Jacoby (è davvero possibile che l’inte-resse per la storia locale si sia risvegliato quando, secondo Jacoby,Erodoto non aveva ancora ultimato la sua opera e si dedicavainvece a recitarne alcune parti?); tuttavia – argomenta –, è diffici-le dimostrare che esistesse una storiografia locale (scritta) prima
GIORGIO CAMASSA34
19 Early Historie and Literacy, in LURAGHI (ed.), The Historian’s Craft, pp. 95-115, partic.95-96.20 Una prospettiva senza dubbio interessante, perché vita poleica e vita panellenica siintersecano costantemente in Grecia, sin dall’età arcaica (v. ad esempio G. CAMASSA,Forme della vita politica dei Greci in età arcaica e classica, Bologna 2008): si tratta però divedere se lo ‘schema’ sia applicabile anche alla nascita della storiografia.21 Cfr. specialmente L.E. ROSSI, I generi letterari e le loro leggi scritte e non scritte nelle let-terature classiche, «Bulletin of the Institute of Classical Studies», 18 (1971), pp. 69-94.Altri dati bibliografici, ad esempio, in MARINCOLA, Genre, Convention, and Innovation,pp. 281-282 (note). E v. in questo volume il contributo di Roberto Nicolai.22 Mi limito qui a ricordare alcune formulazioni dionigiane, che ripropongono conogni probabilità una nomenclatura corrente: Ant. Rom. VII 70, 2; Thuc. 7, 1; 9, 3; Din.11, 17 (in questi passi ricorre, variamente declinata, l’espressione topikh; iJstoriva); v.anche Pomp. 5, 1 (topikh; uJpovqhsi"). Importante, naturalmente, anche il passo diDionigi (Ant. Rom. I 8, 3) in cui si distingue la storiografia politico-militare dallePoliteiai e da opere di storiografia locale come le Atthides. A parte topikov", un altroaggettivo qualificativo con il quale occorre confrontarsi è ejpicwvrio": v. in propositoD. AMBAGLIO, jEpicwvrio". Un termine tecnico storiografico?, in Storiografia locale e storio-grafia universale. Forme di acquisizione del sapere storico nella cultura antica. Atti delCongresso (Bologna, 16-18 dicembre 1999), Como 2001, pp. 7-21, con ampia docu-mentazione – ma, sulla tematica sfiorata nel testo, è da tener presente l’intero volu-me da cui cito; pertinenti, inoltre, le considerazioni svolte da G. SCHEPENS, AncientGreek City Histories. Self-Definition through History Writing, in K. DEMOEN (ed.), The GreekCity from Antiquity to the Present. Historical Reality, Ideological Construction, LiteraryRepresentation, Louvain-Paris-Sterling (Virginia) 2001, pp. 3-25, ove ulteriori dati.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 34
dello sviluppo della grande storiografia. Riassumerei i risultatidell’ampia indagine di Porciani come segue: il quinto capitolodel De Thucydide di Dionigi di Alicarnasso, che postula l’esistenzadi un manipolo di autori di storie locali alle spalle di Erodoto e diTucidide, è il frutto di ricostruzioni erudite, non preserva tradi-zione genuina; per affrontare correttamente il problema dei rap-porti fra grande storiografia e storiografia locale bisogna tenerconto, invece, dell’immenso e vario patrimonio di tradizioni oraliesistente in Grecia, un patrimonio organizzato nella «storia loca-le-genealogica orale» e rifluito, attraverso i lovgoi ejpitavfioi, nellagrande storiografia panellenica a carattere contemporaneo23.Secondo me, Porciani ha indubbiamente ragione nel valorizzarelo stratificato e variegato patrimonio di tradizioni orali che hannoalimentato ciò che l’autore definisce «storia locale-genealogicaorale»; non saprei dire, tuttavia, se un anello essenziale della cate-na sia rappresentato – nonostante la loro indubbia importanza –dai lovgoi ejpitavfioi24.
Un tentativo di dimostrare come la storiografia locale sia perpiù di un verso interconnessa con la grande storiografia e, soprat-tutto, come la prima non sia da relegare in un orizzonte banal-mente localistico è stato ora portato avanti, in un’opera di note-voli proporzioni, da Katherine Clarke25. Ma, ancora una volta, allatesi di Jacoby si riconosce un’incontestabile, sebbene parziale,plausibilità. Il paragrafo intitolato «Tracing the History of LocalHistoriography»26, di cui credo si debbano condividere alcuneaffermazioni, reca un sottotitolo emblematico: «ResurrectingJacoby’s Atthis».
Avviandomi a concludere su questo punto, vorrei esprimere lamia idea: sebbene sia opinabile il tentativo da parte di Jacoby di
L’ATTIDOGRAFIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 35
23 L. PORCIANI, Prime forme della storiografia greca. Prospettiva locale e generale nella nar-razione storica, Stuttgart 2001. V. peraltro, in proposito, E. GABBA, Alle origini della sto-riografia greca, «Athenaeum», 90 (2002), pp. 521-524. Quindi, sempre di L. PORCIANI,Il problema della storia locale, in AMPOLO (a cura di), Aspetti dell’opera di Felix Jacoby 2, pp.173-184.24 Da tener presente, al riguardo, in primis N. LORAUX, L’invention d’Athènes. Histoire del’oration funèbre dans la ‘cité classique’, Paris-La Haye-New York 1981. Altri dati biblio -grafici in PORCIANI, Prime forme, passim. 25 Making Time for the Past. Local History and the Polis, Oxford 2008.26 Ibidem, pp. 175-193.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 35
negare l’esistenza di qualsiasi traccia di opere di storiografia loca-le prima dell’ultimo terzo del V secolo27 (un nome per tutti:Carone di Lampsaco)28, sinora non sono emerse le prove dellapresenza di un’orografia come forma letteraria chiaramentecostituita durante i secoli che precedono il V e ancora per unaparte dello stesso V secolo; in altre parole, gli indizi disponibilinon consentono, a tutt’oggi, di accertare una fioritura della sto-riografia locale prima dello sviluppo della storiografia panelleni-ca29. Inoltre – e il punto sembra decisivo – v’è uno scarto (se sipreferisce un salto di qualità) fra la storiografia panellenica e lastoriografia locale, che impedisce di vedere in quest’ultima lamatrice della prima30. La grande storiografia nasce in Grecia incircostanze storiche molto precise31. La grande storiografia, ricon-nettendosi all’intento dell’epos, vuole tramandare il ricordo dellegrandi gesta panelleniche e, proprio per questo, si colloca su unpiano diverso rispetto alla storiografia locale32.
Dopo aver dedicato al tema dei rapporti fra le due storiografieuno spazio adeguato, mi limiterò a una semplice constatazione
GIORGIO CAMASSA36
27 V. ad esempio Atthis, p. 200.28 Si terranno presenti in particolar modo i contributi di Luigi Piccirilli (Carone diLampsaco e Erodoto, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», S. III, 5 [1975],pp. 1239-1254) e Mauro Moggi (Autori greci di Persikav, II. Carone di Lampsaco, nellastessa rivista, S. III, 7 [1977], pp. 1-26).29 Il che non significa, ovviamente, negare che vi fosse una congerie di opere di carat-tere diverso, genealogico ad esempio, cui gli storiografi di tutti i tipi potevano attingere.30 Sulla dissimmetria fra storiografia locale e storiografia panellenica insistono J.MA.CANDAU MORÓN - F.J. GONZÁLES PONCE - A.L. CHÁVEZ REINO, Crónicas, fundaciones y elnacimiento de la historiografía griega, in J.MA. CANDAU MORÓN - F.J. GONZÁLES PONCE - G.CRUZ ANDREOTTI (eds.), Historia y mito. El pasado legendario come fuente de autoridad.Actas del Simposio Internacional celebrado en Sevilla, Valverde del Camino y Huelvaentre el 22 y el 25 de abril de 2003, Málaga 2004, pp. 13-29.31 La storiografia greca (panellenica), come per altro verso la storiografia ebraica,sorge in un quadro storico-politico, che è anche geopolitico, efficacemente delineatoda A. MOMIGLIANO, The Classical Foundations of Modern Historiography, Berkeley-LosAngeles-Oxford 1990, pp. 5-28.32 L’esistenza di una storiografia locale a fronte di una storiografia ‘generale’, notoincidentalmente, non costituisce uno sviluppo senza paralleli nel mondo antico. Unconfronto di notevole interesse può essere impostato, ad esempio, con l’Anatolia itti-ta, su cui v. A. UCHITEL, Local versus General History in Old Hittite Historiography, inKRAUS (ed.), The Limits of Historiography, pp. 55-67, con le controargomentazioni diG.S. SHRIMPTON, Beyond The Limits. New Thoughts on the Origin and Development ofAncient Historical Writing, «Ancient History Bulletin», 15 (2001), pp. 50-62, 52-53.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 36
per quanto concerne la cronaca (preletteraria) ipotizzata daWilamowiz, in base a un modello che è, in ultima analisi, di ascen-denza mommseniana. Alla cronaca (preletteraria) degli exegetaida cui sarebbe nata, in Attica, la storiografia locale non crede, perquanto so, più nessuno. Sotto questo profilo, direi, la ‘vittoria’(che – come ho già detto – è anche un radicale affrancamento diJacoby rispetto alle posizioni dei suoi mentori) è stata completa33:non mi soffermerò, pertanto, su una questione che da decenninon è più attuale.
Qualche serio problema, a mio avviso e non soltanto a mioavviso, invece persiste in ordine alla temperie storico-politica estorico-culturale in cui nasce l’orografia. E, all’interno dell’oro-grafia, in particolare l’attidografia. Partirò dal generale (storio-grafia locale) per arrivare al particolare (attidografia). Volendoformulare l’interrogativo di fondo in termini sintetici ma comun-que inequivocabili: perché ha inizio l’orografia? Parlo qui ovvia-mente dell’atto con cui le storie locali vengono messe per iscrittoe non dei fattori di lungo periodo che si suppone siano alla basedell’orografia34. Conosciamo la risposta fornita da Jacoby: la sto-riografia panellenica mette in moto una sorta di emulazione com-petitiva, in ragione della quale ci si concentra sulle glorie (oggi,nel nostro stile un po’ corrivo, diremmo sulle identità) locali, chevengono illustrate appunto dall’orografia. Ecco gli ipsissima verbadell’autore di Atthis: «La specie [si noti, ancora una volta, la tas-sonomia aristotelico-linneana] delle cronache locali è sorta per-ché le varie città cercarono di assicurarsi, nella storia greca, unposto che la grande storiografia non assegnava loro»35. Manifesteriserve esprimeva più di venticinque anni fa Charles W. Fornara.Il suo ragionamento non è banale e ne riproduco, per chiarezza,i passaggi principali: «La caratteristica saliente dell’orografia è ilsuo provincialismo. Sebbene eventi di importanza nazionalepotessero naturalmente esser registrati quando si ripercuotevano
L’ATTIDOGRAFIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 37
33 Mi è caro ricordare uno scritto – importante in ordine a varie questioni sfiorate inqueste pagine – di Filippo CÀSSOLA, Problemi della tradizione orale, «Index», 28 (2000),pp. 1-34, 4-5.34 La distinzione non è forse inutile. P. Harding tende a ricondurre «l’impulso a com-porre ‘storia locale’» al tempo della colonizzazione «e, probabilmente, a prima anco-ra» (Local History, p. 187).35 P. 201.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 37
sulle vicende della città-stato, l’orografia non era destinata a sfrut-tarli. [...] La finalità dell’orografia non era [...] patriottica nelsenso generale del termine sostenuto da Jacoby – il patriottismodelle rivendicazioni rivali da parte degli appartenenti all’una oall’altra città, di città che desiderano che il mondo ellenico cono-sca le loro imprese neglette –, ma al massimo un amore per lacittà che sollecita il desiderio di metter in mostra i suoi docu-menti e di fornire una sequenza cronologica degli avvenimentiper essa importanti»36. Oggi qualcuno tende a vedere la questio-ne in termini diversi da quelli che prospettava Fornara. Ho giàfatto riferimento al recente tentativo, da parte di K. Clarke, di isti-tuire una serie di interconnessioni fra le storie locali e la grandestoriografia. All’esigenza di sottrarre l’orografia al suo ipoteticolocalismo.
Tuttavia, dubito che anche l’ammettere un’ispirazione nongrettamente localistica per la produzione orografica apra di persé la strada a una comprensione delle ragioni specifiche che sonoalla base della sua fioritura. Poiché possiamo parlare con qualchecognizione di causa delle storie locali di Atene e poiché siamo quiriuniti per occuparci in primo luogo proprio dell’attidografia,tenterò di delineare il quadro in cui essa vide verosimilmente laluce. Beninteso, le idee che esporrò riprendono spunti che sonopresenti anche nella riflessione di altri37.
Occorre, credo, tenere nel debito conto la frattura politica chesi consuma per ben due volte, ad opera degli oligarchi, nella sto-ria della democrazia ateniese: sul finire del penultimo decenniodel V secolo e dopo la conclusione disastrosa della guerra delPeloponneso. Questa duplice frattura determinò un trauma e, aseguire, un più accentuato ripiegamento degli Ateniesi su sé stes-si e sul loro passato38. Un risultato tangibile di questo travaglio si
GIORGIO CAMASSA38
36 The Nature of History in Ancient Greece and Rome, Berkeley-Los Angeles-London 1983,pp. 20-21 (il corsivo è dell’autore).37 Mi limiterò, nelle note successive, solo a qualche rinvio per non appesantire ecces-sivamente l’apparato erudito. 38 Cfr. G. CAMASSA, Les (nouvelles) lois de Clisthène et leur histoire, relazione tenuta in occa-sione di un recente Colloquio Internazionale: Clisthène et Lycurgue d’Athènes. Autour dupolitique dans la cité classique (Paris, Institut National d’Histoire de l’Art, 30-31 janvier2009), con ulteriore bibliografia. Spunti suggestivi già in HUMPHREYS, Fragments,Fetishes, and Philosophies, partic. pp. 216-218.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 38
coglie, fra l’altro, nella decisione di inventariare la legislazioneesistente: in questa cornice vengono all’occorrenza ripubblicatitesti arcaici. Più in generale, la risposta alla crisi è rappresentatadall’edificazione di un sistema politico ben diverso dalla demo-crazia del V secolo: in una parola, di un’altra democrazia39.Tuttavia, la duplice soluzione di continuità del 411 e del 404 – losappiamo – non esce dal cilindro di Clio come il classico coniglio.Se si vogliono capire davvero le dinamiche in atto, si deve tenerconto di tutte le tessere di un articolato e tormentato mosaico.
Da anni si era manifestata, e la guerra aveva acuito, una certadisaffezione rispetto al presente della polis, col risultato di inco-raggiare evasioni o proiezioni all’indietro (verso il mondo diieri)40 e in particolare coloro che non si riconoscevano nei prin-cìpi fondanti della democrazia si erano concentrati sul passatopiù o meno immaginario di Atene, alla ricerca di valori da pro-porre, strumentalmente, in antitesi a quello che ritenevano unregime opprimente. L’uso – che è, in effetti, uno stravolgimentoa fini propagandistici – della figura e dell’opera di Clistene daparte di Clitofonte41, durante un’assemblea che precede l’instau-razione del regime dei quattrocento, è la spia di un atteggiamen-to senza dubbio diffuso entro la cerchia degli oppositori, ‘radica-li’ o ‘moderati’ che fossero. Intravediamo la nascita e le tensionialle quali è sottoposta la parola d’ordine della pavtrio" politeiva,utilizzata in un celebre testo di Trasimaco42, un sofista impegnatonel dibattito politico e culturale, cui verosimilmente partecipa daposizioni avverse alla democrazia. Proprio il termine patrios sem-bra aver conosciuto, ad Atene, nei decenni finali del V secolo unanotevole fortuna43. Non a caso, ovviamente.
L’ATTIDOGRAFIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 39
39 V. in proposito M.H. HANSEN, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes.Structure, Principles and Ideology2, trad. ingl., London 1999.40 Puntualmente raccolte dai comici: qualche riferimento in CAMASSA, Les (nouvelles)lois de Clisthène.41 Aristotele, Athenaion Politeia, 29, 3 (d’ora in poi quest’opera di Aristotele o di scuo-la aristotelica sarà citata come AP). V. da ultimo al riguardo CAMASSA, Les (nouvelles)lois de Clisthéne.42 DK 85 B 1.43 Notevole un passo di Tucidide (II 16, 2): dia; panto;" h\n aujtoi'" ejk th'" kata; to;ajrcai'on politeiva" pavtria («da sempre, a partire dal più antico ordinamento politi-co, si erano trasmessi di padre in figlio» [riferito a iJerav]). Il discorso dovrebbe aquesto punto ampliarsi a pavtrio" novmo" – e pavtrioi novmoi (capitale un altro passo di
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 39
In una cornice segnata, abbiamo visto, da spinte centrifughe sicolloca l’avvento dell’antiquaria. Non c’è dubbio che l’antiquaria,come ha scritto Roberto Nicolai, sia «necessaria a creare e raffor-zare l’identità e il senso di appartenenza a una comunità»44, maviene da chiedersi se la fortuna dell’antiquaria, nell’Atene di fineV secolo, non dipenda anche da una presa di distanze dalla poli-tica nella sua dimensione partecipativa, dal presente della polis.Ad ogni modo, i sofisti, com’è noto, fornirono un contributodecisivo allo sviluppo dell’antiquaria. Arnaldo Momigliano hascritto a tale riguardo pagine molto suggestive, cui rimando sen-z’altro45, anche se non condivido la riduzione, che vi si compie,dell’archaiologia all’antiquaria, poiché archaiologia significa sin dal-l’inizio «storia antica»46.
Siamo pronti, ormai, a considerare la nascita dell’attidografia.L’interesse per la ricostruzione del passato, visto come baluardorispetto alle insidie del presente (un presente che proietta dun-que a ritroso i suoi interrogativi, le sue incertezze sul tempo remo-to) di Atene, nasce proprio dalla congiunzione degli sviluppi poli-tici di cui abbiamo cercato di render conto e della formazione,forse correlata alla crisi politica, di una sensibilità antiquaria (mal’antiquaria – si noti – non si riversa tout court in una determinataforma storiografica, nemmeno nella storiografia locale). In unsimile scenario, la pubblicazione della lista arcontale ateniese47
potrebbe aver fornito a una personalità come quella di Ellanicodi Mitilene48 lo stimolo per ordinare la materia disponibile, a
GIORGIO CAMASSA40
Tucidide [VIII 76, 6], con le notazioni di S. HORNBLOWER, A Commentary on Thucydides,III, Oxford 2008, pp. 980-981, ove bibliografia) –: qualche osservazione in propositonel contributo di cui supra, nota 38.44 The Place of History in the Ancient World, in MARINCOLA (ed.), A Companion, I, pp. 13-26, 17.45 V. specialmente The Classical Foundations, pp. 59-63.46 G. CAMASSA, Tempo delle origini e misurazione del tempo, «Quaderni di Storia», 28(2002), nr. 55, pp. 55-65, partic. 59-60.47 IG, I3 1031.48 Si pone qui un notevole problema: che cosa poteva aver indotto Ellanico a scrivereun’Atthis? Secondo Jacoby (Die Fragmente der griechischen Historiker, III b [Supplement],I [Text], Leiden 1954, pp. 20-21), in un’epoca caratterizzata da scelte di campo mar-catamente e smaccatamente filospartane da parte delle comunità che avevano fattoparte dell’impero (valga l’esempio di Samo!), il Mitilenese sarebbe stato mossoinvece da una calda simpatia per Atene, magari per chi vi aveva restaurato la
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 40
comporre un vasto affresco (l’Atthis) governato da un principioannalistico. La pubblicazione della lista arcontale ateniese, qualeche ne sia l’anno preciso, dovette assolvere per Ellanico la stessafunzione che aveva avuto la disponibilità della lista delle sacerdo-tesse di Hera ad Argo: egli era di nuovo in possesso, questa voltaper la storia di Atene, di un solido ancoraggio, di una sorta di«polo fisso nella fuga dei fenomeni» di cui la storiografia greca,manchevole di una salda cornice cronografica, aveva assoluta-mente bisogno49. Questo il quadro che mi sentirei di proporreper spiegare l’avvento dell’attidografia. Mi rendo conto del fattoche focalizzare la propria attenzione sulle origini dell’attidografiacomporta il rischio di una parcellizzazione indebita (l’attidogra-fia è parte di un tutto, l’orografia), ma non si può rinunciare aconfrontarsi con il caso su cui siamo meglio informati, appunto lestorie locali di Atene.
Passiamo a considerare un altro problema. Una parte deboledell’Atthis di Jacoby sarebbe da individuare nell’attribuzione ditendenze politiche nettamente contrapposte agli attidografi.Ognuno ricorda lo schema: democratici vs conservatori più omeno moderati; Clidemo da un lato, Androzione e altri sul fron-te opposto. Gli studi, estremamente acuti, di Phillip Harding50
potrebbero aver fatto giustizia di una tesi che, almeno nella sua
L’ATTIDOGRAFIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 41
democrazia; diversa la prospettiva di P. Harding (Androtion and the Atthis. TheFragments Translated with Introduction and Commentary by P.H., Oxford 1994, pp.48-49; The Story of Athens. The Fragments of the Local Chronicles of Attika, Edited andTranslated and with an Introduction and Commentary by P.H., London-New York2008, pp. 5-6). Sulla difficoltà di attribuire una precisa cifra politica a Ellanico e allasua Atthis, v. anche D. AMBAGLIO, L’opera storiografica di Ellanico di Lesbo, in Ricerche distoriografia antica, II, Pisa 1980, pp. 9-192, 50-54. Personalmente tendo a pensare cheEllanico, straniero proveniente dal mondo degli alleati-soggetti nel quale si fron-teggiavano atteggiamenti contrapposti rispetto ad Atene, poligrafo straordinaria-mente versato in campo mitografico, storico e cronografico, abbia intercettato l’oriz-zonte d’attesa del pubblico ateniese (un orizzonte di attesa di cui ho tentato difornire le coordinate nelle pagine precedenti), inaugurando con la sua Atthis unaforma storiografica. E v. in questo volume il contributo di Gabriella Ottone.49 Per i problemi inerenti alla cronografia, v. ora A. MÖLLER, The Beginnings ofChronography: Hellanicus’ Hiereiai, in LURAGHI (ed.), The Historian’s Craft, pp. 241-262;EAD., Felix Jacoby and Ancient Greek Chronography, in AMPOLO (a cura di), Aspetti dell’ope -ra di Felix Jacoby 2, pp. 259-275, con la bibliografia anteriore.50 Penso anzitutto alle sue più recenti monografie, cui ho fatto riferimento supra, allanota 48: da esse si potrà risalire alla vasta congerie di saggi che le hanno preparate.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 41
forma più radicale, non sembrerebbe sostenuta da adeguateprove documentarie.
Qualche piccolo affondo si rende qui indispensabile. È notoche la democrazia riformata ateniese per larga parte del IV seco-lo non subisce, proprio perché riformata, proprio perché è un’al-tra democrazia rispetto a quella del V secolo, attacchi frontali. Suquesto sfondo occorre proiettare l’attività politica e l’opera sto-riografica degli attidografi. Jacoby pensava, lo abbiamo appenarilevato, che Clidemo avesse scritto la sua Atthis in base a una pro-spettiva dichiaratamente filodemocratica e Androzione, per con-verso, in base a una prospettiva conservatrice (conservatricemoderata). Riservandoci di riparlare di Clidemo, sarà bene con-centrarci per un momento su Androzione51, più esattamente sulsuo profilo di uomo pubblico.
Come Harding non si è stancato di sottolineare, Androzionefu un politico impegnato, di successo e longevo, nell’Atene del IVsecolo. Riconsideriamone per sommi capi la carriera52. Dopo il378/377 (?) è presidente dell’assemblea (FGrHist 324 T 4); forsenel 376/375 o un anno dopo raccoglie gli arretrati dell’eisphora(FGrHist 324 T 6); dal 358/357 al 357/356, o per meglio direquanto meno per questi due anni, presta servizio come governa-tore di Arcesine sull’isola di Amorgo e la popolazione locale glirende merito per la sua generosità (FGrHist 324 T 7); nel 356/355è membro della boule (FGrHist 324 T 9); nel 355/354, conMelanopo e Glaucete, viene inviato come ambasciatore pressoMausolo di Caria (FGrHist 324 T 8). Fermiamoci qui. Harding habuon gioco nell’osservare come, per un uomo che sarebbe ani-mato da una tendenza politica conservatrice (conservatricemoderata), questo sia un bell’exploit in seno al regime democrati-co. Rispetto a una tale considerazione potremmo obiettare, a
GIORGIO CAMASSA42
51 In genere, per quanto riguarda Androzione, ci si riferirà in questo volume al con-tributo di Cinzia Bearzot. L’amichevole cortesia dell’autrice mi ha permesso di leg-gere il testo di due suoi saggi in corso di stampa, dove vengono affrontate questioninodali ai fini di una più precisa determinazione della personalità dell’attidografo:Androzione rhetor kai demagogos, in Gli storici greci in frammenti e il lessico Suda. Attidell’Incontro Internazionale (Vercelli, 6-8 novembre 2008); La testimonianza diDemostene su Androzione, in Ex fragmentis/per fragmenta historiam tradere. IIGiornata di studio sulla storiografia greca frammentaria (Genova, 8 ottobre 2009).52 V. in proposito anche L. MOSCATI CASTELNUOVO, La carriera politica dell’attidografoAndrozione, «Acme», 33 (1980), pp. 251-278.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 42
nostra volta, che anche altri politici e generali i quali occupanoun posto di spicco nell’Atene del IV secolo non sono certo con-vinti sostenitori degli ideali democratici53. Ma, rileva Harding,Androzione aveva qualche motivo per nutrire riserve o risenti-mento verso la democrazia che gli assicurava il successo? Certo,Androzione è figlio di Androne e un Androne è implicato neglieventi del 411, tuttavia non v’è certezza assoluta circa il fatto chel’Androne di cui era figlio Androzione fosse lo stesso Andronecoinvolto nella instaurazione del regime dei quattrocento. E sem-bra strano che Demostene, nell’orazione contro Androzione, nonrinfacciasse all’avversario del momento una vituperabile apparte-nenza politica di chi gli aveva dato i natali.
Sin qui ho riassunto alcuni dei risultati delle indagini diHarding. Il quale ha perfettamente ragione nel metterci in guar-dia da quella che definirei l’arbitraria combinazione di un’asseri-ta appartenenza allo schieramento dei conservatori moderati –che è da dimostrare per Androzione – e di una pretesa tendenzapolitica attribuita a ciò che resta della sua opera storiografica.D’altra parte, ampliando il discorso ora anche a Clidemo, credoche occorra fare qualche ammissione. Esaminerò in modo curso-rio due frammenti, rispettivamente di Clidemo e di Androzione,che costituiscono un possibile banco di prova della tesi di Jacobysugli schieramenti politici degli attidografi e delle controargo-mentazioni di Harding.
Poiché Clidemo è il più antico degli attidografi ateniesi, parti-rò proprio da lui54. È difficile non vedere – a me sembra – che latradizione valorizzata da Clidemo (FGrHist 323 F 21; F 119Harding55), secondo cui prima di Salamina sarebbe statoTemistocle grazie a un espediente a distribuire ad ognuno degliAteniesi che stavano per imbarcarsi la somma indispensabile perprovvedere ai bisogni del momento, risponde a un’esigenza: sitratta di rivendicare per Temistocle e lo schieramento democrati-co, in polemica con la versione (documentataci dall’AP 23, 1-2)
L’ATTIDOGRAFIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 43
53 Un caso paradigmatico è quello di Focione, su cui C. BEARZOT, Focione tra storia etrasfigurazione ideale, Milano 1985.54 V., in questo volume, il contributo di Paolo A. Tuci.55 Fornisco qui e in seguito la numerazione dei frammenti degli attidografi anche se -condo la più recente edizione che si deve a P. Harding (v. supra, nota 48).
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 43
secondo la quale sarebbe stato invece l’Areopago a farsi carico diquella misura, il provvedimento decisivo ai fini dell’esito dell’im-minente battaglia. A me pare proprio che di una Tendenz sia quilegittimo parlare. Sotto questo profilo Jacoby56 aveva qualchebuona ragione da far valere. Personalmente, credo inoltre che ildibattito in corso negli anni di Clidemo sulla responsabilità dellemisure assunte in vista – ergo sull’attribuzione del merito della vit-toria – di Salamina ci riconduca alla lotta che si consuma nelperiodo immediatamente successivo al 480 fra le fazioni57, con ilconnesso corteo di interessate ricostruzioni dell’antefatto dell’e-pico scontro58. La disputa che negli anni ’70 del V secolo dovevaessere stata di bruciante attualità riemerge per mano di quanti,nel IV, si confrontavano con la ricostruzione del glorioso passatodi Atene59. Si noti che, durante il IV secolo, assistiamo alla ripresadi un ruolo significativo dell’Areopago nella vita politica di Atene,con la conseguenza che schierarsi a favore di Temistocle odell’Areopago quale dieu caché della vittoria di Salamina – una vit-toria sentita come fondamentalmente ateniese – era una sceltaricca di implicazioni nell’orizzonte politico coevo.
GIORGIO CAMASSA44
56 Atthis, pp. 75-76; Die Fragmente der griechischen Historiker, III b (Supplement), I (Text),pp. 81-82.57 Da una parte i Filaidi che si rappacificano con gli Alcmeonidi, dall’altra Temistoclee una parte dei Licomidi.58 Cfr. G. CAMASSA, Democrazie ateniesi di età classica: V e IV secolo, in M. GIANGIULIO (acura di), Storia d’Europa e del Mediterraneo, I. Il mondo antico. Sezione II. La Grecia, IV,Roma 2008, pp. 211-246, 215-216. Ma è da vedere anzitutto P.J. RHODES, A Commentaryon the Aristotelian Athenaion Politeia, rist. integr. Oxford 1993, pp. 287-289.59 Il brano di Clidemo è stato fatto oggetto, specie dopo Jacoby, di una lunga serie diinterpretazioni e valutazioni contrastanti (l’ultimo studio edito a me noto è di R.FABIANI, Considerazioni sulla ricostruzione del passato in Clidemo, in P. DESIDERI - S. RODA
- A.M. BIRASCHI [a cura di], Costruzione e uso del passato storico nella cultura antica. Attidel Convegno Internazionale di Studi [Firenze, 18-20 settembre 2003], Alessandria2007, pp. 157-170, 168-169). Si può risalire all’ampia bibliografia che si è sedimenta-ta sul frammento da due lavori apparsi in anni recenti: J. MCINERNEY, Politicizing thePast: The Atthis of Kleidemos, «Classical Antiquity», 13 (1994), pp. 17-37, 34-37; M.BERTI, L’egemonia dell’Areopago ad Atene ([Aristot.], Ath. Pol., 23, 1-2), in S. CATALDI (acura di), Poleis e Politeiai: Esperienze politiche, tradizioni letterarie, progetti costituzionali.Atti del Convegno Internazionale di Storia Greca (Torino, 29-31 maggio 2002),Alessandria 2004, pp. 133-151, 143-147 (di quest’ultimo saggio non condivido, tut-tavia, le conclusioni). Nel suo studio d’assieme sugli attidografi (The Story of Athens,pp. 104-105), P. Harding ha ribadito il punto di vista che aveva precedentementeesposto (Atthis and Politeia, «Historia», 26 [1977], pp. 148-160, 153-154).
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 44
Passo ora al frammento di Androzione (FGrHist 324 F 34; F 93Harding) su cui si sono versati fiumi d’inchiostro. L’attidografo –per quanto ci consta – faceva della seisachtheia di Solone anzichéun epocale ‘scuotimento’ dei debiti una misura finalizzata a ridur-re, attraverso una svalutazione della mina, l’entità degli interessiche i debitori avrebbero dovuto restituire60. Credo che non sia deltutto corretto assumere l’esistenza di richieste tendenti alla can-cellazione dei debiti, nell’Atene del IV secolo, come experimentumcrucis rispetto alla dimostrazione di una tendenza – conservatricemoderata – da ascrivere all’Atthis di Androzione (Harding ha ten-tato di dimostrare, contro Jacoby61, che tali richieste non esisteva-no). Androzione avrebbe potuto farsi portavoce di un’interpreta-zione ‘minimalista’ della seisachtheia, nel senso di una riduzionedegli interessi, perché proiettava all’indietro – alle riforme solo-niane – una soluzione che nel mondo greco di metà IV secoloveniva indicata al problema dell’eccessivo indebitamento, unasoluzione che consisteva appunto nella riduzione degli interessida corrispondere. È vero che la fonte principale che siamo ingrado di addurre a sostegno di questa ‘lettura’ coincide con EneaTattico (14), il quale, nella fattispecie, raccomanda a una cittàsotto assedio62 la riduzione o la cancellazione degli interessi (senon addirittura del capitale), ma dovremmo prender in conside-razione l’eventualità che il programma difensivo esposto da Enea
L’ATTIDOGRAFIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 45
60 Il provvedimento soloniano avrebbe avuto, secondo Androzione, un carattere uma-nitario (filanqrwvpeuma). Quando si recò con Glaucete e Melanopo come amba -sciatore presso Mausolo, Androzione si rese colpevole di malversazione. Al terminedi una complessa vicenda, si era fatto concreto per lui il rischio di essere imprigio-nato, se non avesse restituito in tempi rapidi la somma illecitamente detenuta: lalegge di Timocrate riportata da Demostene (XXIV 39), che formalmente si propone-va di mitigare le severe disposizioni previste dal diritto attico contro i debitori pub-blici, era in realtà finalizzata ad alleggerire la posizione di Androzione e dei suoi col-leghi. Nell’orazione demostenica, filavnqrwpo" ricorre più volte per denotare il pre-sunto carattere del provvedimento voluto da Timocrate (su tutto ciò, v. D. ASHERI,Leggi greche sul problema dei debiti, «Studi Classici e Orientali», 18 [1969], pp. 5-122, 31-33). Viene da chiedersi se il lessico utilizzato da Androzione per la seisachtheia nonrifletta anche il suo ‘vissuto’ di debitore pubblico. Tale del resto, stando aDemostene, sarebbe stato anche suo padre...61 V. rispettivamente JACOBY, Atthis, p. 74 e, soprattutto, Die Fragmente der griechischenHistoriker, III b (Supplement), I (Text), pp. 99, 144-146; HARDING, Androtion, p. 133(entrambi con importanti rinvii).62 Dunque, in una situazione assolutamente peculiare!
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 45
Tattico63, in un’età tormentata, trovasse ascolto presso l’opinionepubblica greca o contenesse addirittura un’indicazione di massi-ma che ‘era nell’aria’64. Ove si potesse sostenere che esiste unarelazione fra l’interpretazione della seisachtheia sostenuta daAndrozione e il programma esposto, ad esempio, da Enea Tattico,si sarebbe pur tentati di chiedersi se il ‘minimalismo’ o il ‘revisio-nismo’ storiografico di Androzione non sia la controprova di unascelta storiografica da riconnettere a un orientamento ideale epolitico65. Ma chi volesse sottoscrivere su questa materia una con-clusione sicura si esporrebbe a qualche rischio: in fondo, abbia-mo solo degli indizi e delle congetture su cui lavorare.
Provo a concludere sulle tendenze politiche degli attidografi.È possibile, come dice Harding66 (facendo riemergere, mutatismutandis, una posizione che era già stata cara a Wilamowitz)67,che gli attidografi fossero in linea di massima inclini a un atteg-giamento favorevole alla democrazia riformata, ma ciò non toglieche persistano zone d’ombra. Cercherò di essere ancora più chia-ro: la prospettiva storiografica di Androzione non sembra sovrap-ponibile a quella di Clidemo, ma non siamo autorizzati a fare sen-z’altro – con Jacoby – di Clidemo il campione dell’attidografiademocratica e di Androzione il campione dell’attidografiaimprontata al conservatorismo, sia pur moderato.
Tratterò per ultime due questioni nodali, cui non potrò dedi-care lo spazio che meritano. Si tratta rispettivamente di ciò che
GIORGIO CAMASSA46
63 Il passo di Enea Tattico è stato infinitamente discusso: la bibliografia pertinente èradunata in due commenti apparsi nello stesso anno, cui rimando senz’altro (D.WHITEHEAD, Aineias the Tactician. How to Survive under Siege, Translated withIntroduction and Commentary by D. W., Oxford 1990, partic. p. 137; M. BETTALLI,Enea Tattico. La difesa di una città assediata (Poliorketika), Introduzione, traduzione ecommento a cura di di M. B., Pisa 1990, partic. p. 258).64 Ricordo che, teste lo Pseudo-Demostene (XVII 15), la lega di Corinto proibiva interalia la cancellazione dei debiti, ma il parallelismo con il frammento di Androzione èmeno stringente che nel caso di Enea Tattico.65 Nonostante la cauta generalizzazione che suggella il suo intervento, anche P.J.Rhodes sottoscrive la tesi secondo cui la lettura della seisachtheia proposta daAndrozione, ad esempio, ha un carattere ‘militante’ (The Atthidographers, in H.VERDIN - G. SCHEPENS - E. DE KEYSER [eds.], Purposes of History. Studies in GreekHistoriography from the 4th to the 2th Centuries B.C. Proceedings of the InternationalColloquium [Leuven, 24-26 May 1988], Leuven 1990, pp. 73-81).66 Androtion, partic. p. 49.67 Aristoteles und Athen, I, pp. 278-279 (v. anche p. 277).
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 46
Jacoby definiva con formulazione felice «gli elementi della tradi-zione»68 e, ancora, della relazione fra Atthides e Politeiai.
L’enucleazione, da parte di Jacoby, degli «elementi della tradi-zione» utilizzati nelle Atthides e, in genere, nelle opere storiogra-fiche era corretta: tradizione orale e documenti – fra cui un postodi primaria importanza spetta, per quanto riguarda la storiografialocale dell’Attica, alla lista arcontale. Certo, l’idea che oggi ci fac-ciamo della tradizione orale e della sua interazione col discorsoscritto è più complessa di quella che ne aveva Jacoby69. Questo,però – occorre ammetterlo –, è quasi un truismo. Non rinuncereicomunque a far valere un’esigenza: quella di riequilibrare inmodo sostanziale il rapporto fra tradizione orale e documenti,visto che l’esistenza e la disponibilità di documenti, anche perl’Atene arcaica vorrei sottolineare, è fuori discussione.Naturalmente, dire che i documenti esistevano ed erano disponi-bili non significa dire che essi, per necessità di cose, fossero uti-lizzati dagli storiografi in generale e dagli attidografi in particola-re. Ma si impone qui una chiara indicazione di metodo.
Alcuni assunti che si sono perpetuati per il prestigio di chi liaveva formulati e, a volte, per la passività di chi li ha recepiti –assunti che riguardano l’indifferenza degli storiografi antichi peri documenti, la quale sarebbe da spiegare con la loro scarsità econ la rudimentalità degli archivi70 – fortunatamente sono statimessi in discussione negli ultimi decenni: lo storiografo, possia-mo oggi dire con tranquillità, fa uso dei documenti71, non hariserve a farvi ricorso, senza trasformarsi per questo in antiqua-rio72. La questione dell’assiologia è, in effetti, capitale per lo sto-
L’ATTIDOGRAFIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 47
68 Atthis, pp. 169-215.69 Lo ha rilevato ancora di recente P. HARDING, Local History, p. 187.70 V. ad esempio M.I. FINLEY, Problemi e metodi di storia antica, trad. it., Roma-Bari 1987,p. 27.71 Beninteso con modalità non univoche. In una letteratura che si avvia a diventaremolto copiosa, ricordo L. CANFORA, Trattati in Tucidide, in L. CANFORA - M. LIVERANI -C. ZACCAGNINI (a cura di), I trattati nel mondo antico. Forma ideologia funzione, Roma1990, pp. 193-216; A.M. BIRASCHI - P. DESIDERI - S. RODA - G. ZECCHINI (a cura di), L’usodei documenti nella storiografia antica. Incontri Perugini di Storia della storiografia, XII(Gubbio, 22-24 maggio 2001), Napoli 2003 e, da ultimo, P.J. RHODES, Documents andthe Greek Historians, in MARINCOLA (ed.), A Companion, I, pp. 56-66. 72 Cfr. G. CAMASSA, Gli archivi memoria dell’ordine del mondo, «Quaderni di Storia», 30(2004), nr. 59, pp. 79-101, 95-97. Ma v. anche infra, nota 74.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 47
riografo. La feroce critica di Polibio (XII 11, 2) nei confronti diTimeo, per via del feticismo del materiale documentario cui lostorico di Tauromenio era incline, fa scuola.
Quanto agli attidografi, è opportuno affrontare il problemadell’utilizzazione dei documenti da parte loro tenendo conto didue aspetti: l’uno inerente a una sfera che definirei potenziale,l’altro inerente a una sfera attuale. Gli interrogativi sono, insom-ma, i seguenti: qual era l’organizzazione degli archivi durante ilV, il IV e la prima parte del III secolo73? Dai frammenti degli atti-dografi emerge un’effettiva utilizzazione del materiale documen-tario, genuino o spurio che fosse? Circa il primo punto, indaginicome quelle di Sickinger e, in anni più vicini, di Pébarthe74 con-sentono di apprezzare l’importanza assunta dagli archivi ad Ateneper l’età che ci interessa. In ordine al secondo punto, più di unframmento degli attidografi permette di asserire che il materialedocumentario fu senza dubbio messo a frutto dagli storiografilocali di Atene75. Un notevole esempio potrebbe essere quellodella lista completa dei generali ateniesi inviati a Samo nel441/440, lista che viene riportata da Androzione (FGrHist 324 F38; F 134 Harding)76. È superfluo sottolineare quanto sia prezio-so il dato di cui possiamo così disporre, quasi un caso da manua-le (di Quellenforschung).
Vengo alla relazione fra Atthides e Politeiai. Jacoby aveva benchiare le differenze fra l’una e l’altra forma letteraria. Vorreiriportare una delle sue prese di posizione sull’argomento. LePoliteiai – egli asseriva – si occupano soltanto della «costituzione»(noi diremmo dell’ordinamento politico); nelle Atthides la «costi-tuzione» è «semplicemente una parte della storia di Atene e leAtthides includono non una costituzione, ma varie costituzioni [anumber of them]»77. Che si accetti in toto o in parte questa for-mulazione di Jacoby, l’esigenza di tener ferma una distinzione fraAtthides e Politeiai va sottoscritta. Si tratta, però, di trarre le conse-
GIORGIO CAMASSA48
73 Intorno al 250 le Atthides si esauriscono.74 V. rispettivamente J.P. SICKINGER, Public Records and Archives in Classical Athens,Chapel Hill-London 1999; C. PÉBARTHE, Cité, démocratie et écriture. Histoire de l’al-phabétisation d’Athènes à l’époque classique, Paris 2006.75 V. adesso HARDING, The Story of Athens, pp. 3-4, con la bibliografia precedente.76 V. ancora HARDING, Androtion, pp. 44-45, 143-148.77 Atthis, p. 213.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 48
guenze da un tale stato di cose78. Si tratta anche di ampliare il dis-corso e di procedere a un’attenta definizione dello spazio occu-pato dalla storiografia locale, dall’antiquaria, dalle Politeiai 79.Cercherò di esser chiaro, a costo di sembrare schematico. Leragioni di uno storiografo sia pure locale e le ragioni di un anti-quario non coincidono (o non coincidono completamente), seb-bene il primo debba non di rado far uso di ciò che la ricerca delsecondo ha messo a sua disposizione. Perché non coincidono?Occorre anzitutto tener conto del problema dell’assiologia. Manon si tratta solo del problema dell’assiologia80. È infatti diversol’ordinamento della materia, un ordinamento che, nel caso dellastoriografia locale, è annalistico. Quanto alle Politeiai – mi riferi-sco qui in primo luogo a quelle di Aristotele e della sua scuola –,sono caratterizzate da un duplice fuoco: storico-antiquario e teo-rico. Se si preferisce, teorico e storico-antiquario. Ci dovremmoguardare, in ragione di ciò, da un appiattimento di un’operacome l’AP (anche nella sua prima parte!) sugli attidografi, quasiche l’unica Politeia aristotelica superstite fosse una sorta di copiaconforme delle versioni tràdite dall’uno o dall’altro attidografo.Purtroppo, questo è accaduto molte volte nella storia degli studi,ma negli ultimi decenni la prospettiva è cambiata. I convegnitenutisi nel centenario del rinvenimento dell’AP, gli studi diPhillip Harding – per limitarci a qualche esempio significativo –hanno messo in luce che nell’AP non vengono solo excerpiti gliattidografi, che Aristotele e i suoi scolari misero a frutto fonti plu-rime, svolgendo ricerche, anche d’archivio, autonome. Non èaffatto escluso che l’AP utilizzasse documenti che potevano esse-re sfuggiti all’attenzione degli storiografi locali e non solo degli
L’ATTIDOGRAFIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 49
78 In ordine alla dipendenza della superstite Politeia aristotelica dagli attidografi: v.quanto segue nel testo.79 L’argomento è difficile e insidioso: v. di recente soprattutto G. SCHEPENS - J. BOLLANSÉE,Frammenti di politeiai, nomoi e nomima. Prolegomeni ad una nuova edizione, in CATALDI
(a cura di), Poleis e Politeiai, pp. 259-285; G. SCHEPENS, Storiografia e letteratura anti-quaria. Le scelte di Felix Jacoby, in AMPOLO (a cura di), Aspetti dell’opera di Felix Jacoby2,pp. 149-171; B. BRAVO, Felix Jacoby, Arnaldo Momigliano e l’erudizione antica, ibidem, pp.227-257; ID., Antiquarianism and History, in MARINCOLA (ed.), A Companion, II, pp. 515-527; K. CLARKE, Making Time for the Past, partic. pp. 180-183 (tutti con ampia biblio-grafia).80 Che si pone, evidentemente, in termini differenti per uno storiografo panellenicoe per uno storiografo locale.
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 49
storiografi locali. Soprattutto, non dobbiamo dimenticare che,nella scuola di Aristotele, interessi storico-antiquari e interessiteorici si sostentano vicendevolmente. Ciò che induce, una voltadi più, a stabilire una linea di demarcazione rispetto alle formeletterarie che alle Politeiai sembrerebbero apparentate.
Giunto alla conclusione del mio percorso, è opportuno stilareun bilancio molto sintetico e indicare, se del caso, qualche pro-spettiva per chi voglia continuar ad arare il campo dell’attidogra-fia o territori contermini. L’Atthis di Jacoby non è superata: con-tiene molte sfide che sollecitano tuttora l’intelligenza critica. Ladefinizione dei rapporti fra grande storiografia e storiografialocale continua a essere a mio avviso problematica e non siamo ingrado di sostenere che la storiografia locale, in quanto forma let-teraria costituita, abbia preceduto la storiografia panellenica. Cipossiamo ragionevolmente attendere, nei prossimi anni, sviluppirisolutivi? Il pessimismo, fortunatamente, viene messo in crisi dascoperte come quella del nuovo Simonide. In precedenza ho cer-cato di dimostrare che l’attidografia nasce in una ben precisatemperie storico-politica e storico-culturale: concentrazione pourcause sul passato di Atene e sviluppo di una sensibilità antiquariacostituivano una humus estremamente propizia per l’avvento ditale forma letteraria. Questa prospettiva forse è suscettibile diesser ulteriormente affinata. Quanto agli interessi politici degliattidografi, sono certo ipotizzabili o ricostruibili, ma occorre evi-tare in proposito ogni schematismo. Gli «elementi della tradizio-ne» di cui gli storiografi locali di Atene potevano valersi consisto-no principalmente da un lato nella tradizione orale, dall’altro neidocumenti, che sono stati messi a frutto in modo consistente.Anche qui c’è materia su cui può esercitarsi chi abbia energie esenso critico. Infine, è bene non confondere nella notte in cuitutte le vacche sono nere attidografia, antiquaria e Politeiai.Soprattutto, dovremmo sempre tener presente che l’AP ha utiliz-zato – anche nei capitoli che ne costituiscono la prima parte –non solo gli storiografi locali di Atene, ma fonti plurime.
ABSTRACT
Jacoby’s Atthis appeared in 1949 and discussion on the theories it upheldhas continued ever since. Apart from general issues on the development
GIORGIO CAMASSA50
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 50
and identification of five Greek historical writing types – genealogy, eth-nography, chronography, Zeitgeschichte and local history – the mainobjections concern:
a) the relationship between «great» and «local» historiography(Jacoby thought the latter presupposed the former but research after hismasterful book moved to a far different approach);
b) the political character of the Atthides, after works by Cleidemosand Androtion (strongly supported by Jacoby, but denied by others,Harding particularly);
c) the characterization of «the elements of tradition», essentially oraltradition and documents (which research after Jacob quite obviouslyviews in terms other than his);
d) the relationship between Atthides and Politeiai (which Jacoby deci-dedly distinguished, though perhaps not altogether consistently).
This paper proposes a balance of the debate, and suggests a viewpointon the factors supporting a new interest in the past of Athens during thelatter decades of the fifth century BC. As regards Jacoby’s legacy, OswynMurray is anyhow right in saying: «It would be a true revolution if wecould be persuaded to cease from either repeating or contradicting theviews of Jacoby: but I remain sceptical whether that is yet possible».
L’ATTIDOGRAFIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 51
03_Camassa:Cisa 8 11/11/2010 8.44 Pagina 51