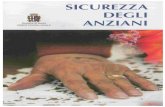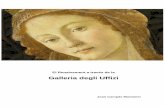La catalogazione degli incunaboli.
Transcript of La catalogazione degli incunaboli.
e n i L ^ librari
I
Regione 'Toscana Cjiunta 'J{ejjionaie .': ^Dipartimenio i^ir4zume e Cùhura [' Serz'izio 'fieni librari
MAGGIO ' DEUABIBIIOEA
Il onore dt j^accohiéa 'Mauro Querrim
votutm Ili
MGUAGGIO DELUBEKTOA Sedi il onore É mmm raccoCti da Mauro Qmrrini
voCwne II
!B^£Ìone Toscana giunta Higgùmak 1994
LA CATALOGAZIONE DEGLI INCUNABOLI
di Alberto Petrucciani Università di Pisa
E ' convinzione diffusa che per la descrizione del libro antico in cataloghi di biblioteca non sono sufficienti, o addirittura non sono applicabili, i princìpi generalmente seguiti nella catalogazione corrente [...]. Essendo la descrizione catalografica riferita essenzialmente ad aspetti connotativi legati alla storia del libro, il catalogatore deve conoscerli se vuole leggerli criticamente e rappresentarli in modo adeguato. In questo consiste il problema della descrizione del libro antico, che è poi il problema della descrizione del libro di ogni tempo.
Diego Maltese, Appunti sul libro antico
Negli ultimi dieci anni si è discusso non poco di catalogazione del libro antico, oltre che di recupero conoscitivo e bibliografico dei fondi storici, anche se l'attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sul Censimento delle edizioni italiane del X V I secolo promosso dall'Istituto centrale per i l catalogo unico, lasciando in ombra da una parte le problematiche piìl strettamente bibliografiche e dall'altra -nella sostanza, al di là di un generico consenso e di eccezioni anche molto avanzate ma isolate - quelle dello "scavo" nei fondi antichi delle nostre biblioteche.' Passata quasi inosservata la conclusione deìVIndice generale degli incunaboli - nel 1981, lo stesso anno del seminario «Libri antichi e catalogazione» che dava pubblico avvio al censimento delle cinquecentine - credo sia stata inattesa l'uscita quasi contemporanea, qualche anno fa, di diversi cataloghi di incunaboli,^ alcuni dei quali di
1. Per una rapida ma stimolante riflessione sulle maggiori iniziative recenti cfr. Lorenzo Baldacchini, Bibliografia retrospettiva e cooperazione: bilancio di un decennio, in: Biblioteche insieme: gli spazi della cooperazione. Atti del XXXVIII Congresso nazionale dell'Associazione italiana biblioteche. Rimini, 18-20 novembre 1992, [Roma]: AIB, 1993, p. 135-144.
2. Biblioteca della Collegiata, Broni, Codici e incunaboli, [Broni (Pavia): s.n.], 1988 (curato da Mino Baldi con la consulenza di Roberto Galletti); Anna Gonzo, Gli incunaboli e le cinquecentine della Parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento presso la Biblioteca diocesana tridentina "A. Rosmini" di Trento, [Trento]: Provincia autonoma di Trento, 1988 (e anche il catalogo della mostra curata, per la parte incunabolistica, ancora dalla Gonzo: Biblioteca comunale, Trento, "Pro bibliotheca erigenda". Manoscritti e incunaboli del vescovo di Trento Johannes Hinderbach (1465-1486), [Trento]: Provincia autonoma di Trento-Biblioteca comunale, 1989); Rosalia Bigliardi-Edoardo Pierpaoli-Costantino Urieli, Incunaboli e raccolte librarie a Jesi tra XV e XX secolo, Jesi: Biblioteca comunale, 1988 (catalogo della mostra); Giuliano Laurentini, Incunaboli e cinquecentine della Biblioteca dei Cappuccini di Firenze,
- 5 6 7 -
Alberto Petrucciani
notevole impegno, tali da suscitare interesse anche fuori dai nostri confini.^ La Giornata di studio sugli incunaboli organizzata dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze i l 3 ottobre 1990"* costituì anch'essa, credo, una felice sorpresa, e le possibilità di cooperazione intemazionale offerte dal progetto di Incunable Short-Title Catalogue (ISTC) della British Library hanno trovato in poco tempo una rispondenza probabilmente inaspettata.̂ Nella mia esperienza di catalogatore di incunaboli, per caso più che per vocazione, sono rimasto colpito da quanto questo campo - per tradizione piuttosto appartato - si riveli ricco di suggestioni e di insegnamenti di larga applicabilità, per un complesso di ragioni che vanno dall'effetto straniante del trattare un materiale piuttosto diverso dal libro a stampa "maturo", alla complessità delle questioni bibliografiche incontrate, alla ricchezza del confronto tra lavoro catalografico e sistemazione repertoriale, fino alla varietà, sincronica e diacronica, degli elementi di storicità degli esemplari. Pur diffidando delle paradigmaticità forzate, mi sembra che si possa dire che questo campo costituisce un laboratorio in cui le problematiche della
Firenze: Biblioteca provinciale dei Cappuccini, 1988; Alberto Petrucciani, Gli incunaboli della Biblioteca Durazzo, Genova: Società ligure di storia patria, 1988 (Atti della Società ligure di storia patria. N.S.; 28, fase. 2); Biblioteca Marucelliana, Catalogo incunaboli, a cura di Piero Scapecchi, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1989; Bruno Giglio-Ilo Vignono, Incunaboli, cinquecentine e loro filigrane, impronte, P.D.P., P.A.G.I., della Biblioteca capitolare d'Ivrea, Ivrea: Bolognino, 1989; Maria Gabriela Nico Paolini, Gli incunaboli della Biblioteca della città di Arezzo (già Fraternità dei Laici), [Firenze]: Giunta regionale toscana; Milano: Bibliografica, 1989; Marco Paoli, Le edizioni del Quattrocento in una raccolta toscana. Gli incunaboli della Biblioteca statale di Lucca, Lucca: Pacini Pazzi, 1990-1992; Lorenzo Baldacchini, Gli incunaboli della Biblioteca Piana, Cesena: Banca popolare dell'Emilia Romagna, 1992.
3.1 cataloghi della Biblioteca Durazzo, della Marucelliana, di Arezzo e di Lucca, insieme al catalogo di ima mostra curata ptire da Marco Paoli (Possessori e immagini negli incunaboli della Biblioteca statale di Lucca: mostra bibliografica, Lucca, 9-23 dicembre 1989, Lucca: Pacini Pazzi, 1989), sono stati recensiti da Marcella Leembruggen su «The library», 6th ser., 13 (1991), n. 3, p. 281-284. La pubblicazione di questi cataloghi ha fornito lo spunto anche ad una nota di Alfredo Serrai, Intorno agli incunabuli ed ai cataloghi di incunabuli (Schegge; 73), «Il bibliotecario», n. 20/21 (giu.-set. 1989), p. 209-211.
4. Questo contributo riprende, rielaborandola, la relazione dal titolo Lo stato della catalogazione che presentai in quella circostanza.
5. Sulla partecipazione italiana - e soprattutto della Biblioteca nazionale centrale di Roma -ali'ISTC cfr. la relazione di Paolo Veneziani, Informatica e incunaboli: dall'IGI ad una base di dati, nei già citati atti del Congresso dell'Affi del 1992, p. 149-156, e la scheda di Pasqualino Avigliano, L'IGI e la base dati ISTC, «Bollettino AIB», 34 (1994), n. 3, p. 333-338. Proprio al congresso di Rimini Veneziani notava quanto «radicalmente e rapidamente» la prospettiva fosse mutata dal suo intervento, del 1985, al secondo seminario sulla trasmissione dei testi a stampa nel periodo moderno (L'Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia, in: Trasmissione dei testi a stampa nel periodo moderno. II Seminario internazionale, Roma-Viterbo 27-29 giugno 1985, a cura di Giovanni Crapulli, Roma: Ed. dell'Ateneo, 1987, p. 311-319). Il progetto dell'ISTC era stato presentato in italiano, nel 1989, da Lotte Hellinga e Marcella Leembruggen, La "base dati" internazionale degli incunaboli (ISTC) alla British Library, «La bibliofilia», 91 (1989), n. 1, p. 81-94. Cfr. anche Bibliography and the study of 15th-century civilisation. Papers presented at a colloquium at the British Library, 26-28 September 1984, edited by Lotte Hellinga and John Goldfinch, London: The British Library, 1987. : . . , , ,v . . H , - . , , - . • . . . • • . .
- 5 6 8 -
La catalogazione degli incunaboli
catalogazione di fondi antichi emergono con particolare evidenza non appena la tradizione incunabolistica, raffinata e solida ma un po' isolata e in qualche punto invecchiata, venga apertamente messa a confronto con le grandi correnti della bibliografia descrittiva e della teoria catalografica. Nello stesso tempo mi sembrano emergere -contrariamente alle apparenze - gravi carenze negli strumenti di lavoro, a cui non può piti supplire la "scuola" di poche grandi istituzioni. Mi auguro, quindi, di aggiungere un contributo non inutile alla scarsissima bibliografia a disposizione di chi affronta lavori di questo tipo, potendo contare quasi soltanto sull'esempio di alcuni buoni cataloghi, raramente italiani. Prima di esaminare, con la scorta di qualche esempio, quali siano le finalità a cui devono rispondere oggi dei cataloghi di incunaboli (ma i l discorso si può spesso estendere a ogni catalogo di libri antichi) e quali siano almeno alcuni dei principali problemi, molto concreti, da affrontare, mi sembra che non si possa eludere una questione preliminare. Vale (ancora) la pena di compilare cataloghi di incunaboli? Non si tratterà di un'impresa inattuale, se non proprio inutile? Non c'è dubbio che i l Quattrocento sia, rispetto ai secoli successivi, )iù largamente dotato di strumenti di ricerca bibliografica, ma 'impressione abbastanza diffusa che poco resti da fare per la migliore
conoscenza degli incunaboli mi sembra piuttosto superficiale. Non è inutile ricordare che i l campo è bibliograficamente molto ostico, perché, per esempio, circa la metà delle edizioni conosciute manca di indicazione di luogo, di data o di tipografo, perché comunque gli elementi di identificazione delle edizioni sono scarsi, ambigui, poco evidenti, perché molte edizioni si sono conservate in una sola copia (è stato stimato che, delle edizioni giunte fino a noi, una su cinque sia conosciuta in un unico esemplare) o in pochissime (il che, oltre a complicare spesso i l lavoro descrittivo, rende indispensabile per lo studioso un censimento di esemplari i l più possibile esauriente), perché molti libri sono arrivati a noi mutili, manipolati o a frammenti. Sotto un profilo più storico che bibliografico, è anche da notare che per questo periodo le informazioni sui processi di produzione, di circolazione, di raccolta, di fruizione vanno molto spesso tratte solo dall'esame bibliologie© (si potrebbe dire "archeologico"), essendo inesistenti o insufficienti le fonti informative collaterali, manuali tipografici e altre descrizioni tecniche, testimonianze memorialistiche e carteggi, documenti contabili, ecc. Esistono, si è detto, molti strumenti, a partire dall'IGI, unica grande impresa bibliografica (portata a termine, s'intende) che i l nostro paese possa finora vantare. Un'impresa che è oggetto di meritata ammirazione anche in paesi assai più avanzati del nostro sotto i l profilo bibliografico. Ma in che misura gli strumenti bibliografici a nostra disposizione rispondono alle esigenze della ricerca?
- 5 6 9 -
Alberto Petrucciani
Nonostante le aggiunte e correzioni raccolte, con gli indici, nel sesto volume dell'IGI, è chiaro che i l lavoro di aggiornamento deve continuare - nelle forme rese possibili dalle nuove tecnologie e dalla cooperazione internazionale - per registrare nuovi ritrovamenti o nuove attribuzioni e datazioni ma anche perché i l contributo iniziale è stato spesso incompleto e talora approssimativo.^ Sul piano piii strettamente bibliografico la ricognizione delle edizioni del Quattrocento è tutt'altro che completa. Le stime sul totale delle edizioni pervenute fino a noi hanno oscillato da ventimila a quarantamila e si vanno solo oggi assestando intomo alle trentamila o poco meno. Oltre 26.000 sono quelle finora censite nella base dati più completa, VIncunable Short-Title Catalogue della British Library. I ritrovamenti, comunque, continuano con regolarità, sia pure alla spicciolata, e permangono moltissimi problemi di datazione ed attribuzione, che almeno per aree particolarmente problematiche - per esempio quella fiorentina - richiederebbero un riesame complessivo, attraverso ricerche approfondite e anche tecnicamente sofisticate. Basta pensare a quanto poco si è fatto sulla carta, nonostante il pionieristico inquadramento del problema, già negli anni Cinquanta, da parte del Ridolfi,^ e al campo del tutto nuovo che si è aperto nell'ultimo decennio con l'analisi degli inchiostri al ciclotrone, applicata per la prirna volta, in California, alla Bibbia delle 42 linee e ad altri incunaboli.^ Sono ancora migliaia le edizioni per cui mancano descrizioni dettagliate ed attendibili secondo gli standard consueti in questo campo (quelli, diciamo, del BMC e del GW). E questi stessi standard sono ormai chiaramente datati: i l primo volume del catalogo del British
6. Del resto, il sesto volume ha già dato un contributo non indifferente con l'aggiunta di 595 edizioni e di parecchie migliaia di esemplari (Paolo Veneziani, Prefazione, nell'Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia, VI, Roma: Libreria dello Stato, 1981, p. 6). Ogni nuovo catalogo a stampa porta con sé segnalazioni di esemplari o anche di edizioni non censite: è il caso del catalogo marucelliano, di quello di una raccolta ecclesiastica trentina (nel quale, anche per la particolare collocazione geografica, su cinquanta edizioni ve ne sono ben dieci non presenti nell'IGI), di quello un po' stravagante della Capitolare di Ivrea, con oltre metà dei 104 esemplari non registrati nell'IGl, e con ben undici esemplari unici in Italia. Aggiungo, per inciso, che non sempre queste indicazioni sono attendibili. In un catalogo recente le concordanze con i numeri dell'IGI, fatte peraltro a rovescio, evidenziano quattro edizioni non presenti nel censimento nazionale. Una verifica, però, riduce i quattro casi a zero: per due edizioni il riferimento ali'IGI manca per errore materiale, una non è stata individuata per problemi di intestazione, l'ultima è stata trasferita, nell'IGI e in altri repertori, al primo Cinquecento.
7. Cfr. Roberto Ridolfi, Le filigrane dei paleotipi. Saggio metodologico, Firenze: Tip. Giuntina, 1957, e La stampa in Firenze nel secolo XV, Firenze: Olschki, 1958. Negli stessi anni AUan Stevenson avviava la sua ricerca sul cosiddetto "Messale di Costanza" che credo costituisca tuttora il più esauriente ed appassionante case study nell'ambito dell'indagine scientifica sulla carta. Cfr. il suo The problem of the Missale speciale, London: The Bibliographìcal Society, 1967. . • . .
8. Cfr. Richard N. Schwab, Thomas A. Cahill, Bruce H. Kusko, Daniel L . Wick, Cyclotron analysis ofthe ink in the 42-line Bible, «Papers of the Bibliographical Society of America», 77 (1983), p. 285-315, e gli studi successivi pubblicati nella stessa rivista.
- 5 7 0 -
La catalogazione degli incunaboli
Museum uscì nel 1908, i l primo del GW nel 1925, e in entrambi i casi l'ideazione è decisamente anteriore.̂ Particolarmente debole è in questi standard la descrizione fisica, dal formato alla collazione. L'indicazione del formato anche in repertori come il GW è di limitata attendibilità e comunque apparente, basata solo sulla posizione dei filoni e della filigrana. Oggi invece vorremmo sapere quale era i l formato originale, e magari anche il tipo, della carta impiegata, se i l foglio veniva tagliato prima della stampa, come accadeva tipicamente per le più antiche edizioni apparentemente in quarto, e quindi, per quanto possibile, quale fosse l'effettiva unità di lavoro. Per la collazione, poi, non sono state raccolte adeguatamente le acquisizioni della bibliografia analitica, per esempio per la descrizione di fascicoli con composizione irregolare. Resta inoltre l'intero problema delle varianti (bibliografiche, non testuali), finora trascurate o trattate senza chiari criteri di metodo classificatorio.'' Dal loro studio possono invece venire importanti acquisizioni conoscitive sulle tecniche e i metodi di lavoro in un periodo così alto e poco documentato. Questo - insieme a quello delle particolarità e delle vicende storiche degli esemplari, su cui torneremo - era il terreno di lavoro che già additava più di vent'anni fa Francesco Barberi recensendo il quarto e il quinto volume dell'IGL'^ Sempre sul piano bibliografico, è ancora parziale e limitata l'identificazione e segnalazione delle opere e dei contributi anche minori dei singoli autori, così come l'attribuzione delle opere anonime. Vi sono opere pubblicate nel Quattrocento con titoli e attribuzioni diverse e non sempre nei maggiori repertori le troviamo identificate e riunite. Molto interessante è anche i l tentativo, avviato nel GW, di approfondire l'analisi oltre i l livello dell'opera in senso catalografico, raggruppando le edizioni in famiglie accomunate da un'evidente dipendenza o affinità. Non si tratta, naturalmente, di rubare i l mestiere ai filologi, ma di registrare organicamente i risultati dei lavori specialistici e quando questi non soccorrono di proporre un primo inquadramento. Su un piano bibliologico e bibliografico, ripeto, non filologico, e cioè basandosi sulla presentazione dell'edizione stessa e sulla sua composizione materiale, non su una collazione testuale. Va da sé che
9. Catalogue of books printed in the XVth century now in the British Museum [ora British Library], London: the Trustees, 1908- ; Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Leipzig [poi Stuttgart]: Hierseraann, 1925-.
10. Su questo punto rimando alle osservazioni esposte nella premessa al mio Gli incunaboli della Biblioteca Durazzo cit., p. 181-182.
11. Per esempio, in parecchi casi uno o più repertori attribuiscono un numero a sé a mere varianti accidentali o dovute a correzioni durante la tiratura su elementi bibliograficamente dì rilievo come la data.
12. Le due recensioni, uscite su «La bibliofilia», 68 (1966), p. 315-320, e 76 (1974), p. 146-150, sono state poi raccolte in Per una storia del libro. Profili note ricerche, Roma: Bulzoni, 1981, p. 48-56 e 57-63. Sull'importanza delle varianti è tornato con forza Paolo Veneziani, L'Indice generale degli incunaboli cit., p. 315-318.
- 5 7 1 -
Alberto Petrucciani
questo tipo di informazioni ha anche una ricaduta su questioni prettamente incunabolistiche, per esempio sulla datazione. Al di là di questioni piuttosto astratte di priorità, quindi, i l lavoro bibliografico sugli incunaboU resta, e resterà, lungo. Ma qui è piuttosto l'ambito catalografico che ci interessa. Un catalogo collettivo o un censimento, anche al di là delle possibili lacune o inesattezze, è per forza di cose quasi sempre limitato alla segnalazione dell'esistenza di un esemplare di una certa edizione in una certa biblioteca. Alla semplice localizzazione l'IGI aggiunge una indicazione generica - e in pratica non sempre affidabile - di completezza o incompletezza (l'asterisco) e, in casi particolari, informazioni diverse (varianti, stampa su pergamena, ecc.). Un catalogo deve dire molto di più: altrimenti si tratta effettivamente di un'impresa in larga misura inutile. Un catalogo deve in primo luogo informare sulle peculiarità storiche del singolo esemplare (ornamentazione, note di possesso, legatura, ecc.) oltre che, dal punto di vista bibliografico, apportare nuovi elementi, se e quando emergono dagli esemplari esaminati, sulle questioni bibliografiche irrisolte o controverse. Non si tratta - è sempre utile ribadirlo - di ridescrivere per esteso edizioni già descritte, ma di dare, in forma più economica e più funzionale, un'informazione altrettanto esauriente. Da questo punto di vista la situazione è tutt'altro che positiva, e anche per questo risalta i l valore di un impresa come quella dell'IGI, che trovava dietro di sé -sul piano nazionale - ben poco. E' infatti una verità tanto lapalissiana quanto spesso trascurata che l'andamento e l'esito di un catalogo collettivo dipendono in larga misura dallo stato della catalogazione nelle singole biblioteche. Il nostro paese ha molte grandi raccolte di incunaboli che però quasi sempre mancano di cataloghi adeguati. Per comodità, ho scelto la soglia arbitraria del migliaio di esemplari per individuare le "grandi" raccolte incunabolistiche italiane; come ci si poteva attendere, le cifre riportate nelle fonti usuali a cui ho fatto ricorso non sono sempre omogenee e coerenti e non escludo che qualche raccolta, o qualche catalogo a stampa, possano essermi sfuggiti. Comunque, se lasciamo da parte cataloghi ormai antichi come quello della Magliabechiana, scheletrici indici come quello del Sorbelli per l'Archiginnasio e fonti parziali e occasionali come i cataloghi di mostre, mancano di un vero catalogo a stampa le raccolte di incunaboli della Nazionale di Torino, della Braidense, dell'Ambrosiana (salvo, come si sa, un'impresa sbagliata interrotta alla lettera A) e della Trivulziana di Milano, dell'Universitaria di Padova, della Marciana di Venezia, della Civica di Verona, dell'Universitaria di Genova, della Palatina di Parma, dell'Archiginnasio di Bologna, dell'Ariostea di Ferrara, della Nazionale di Firenze, dell'Augusta di Perugia, della Corsiniana, della Casanatense, della Nazionale e dell'Angelica di Roma (senza trascurare le raccolte pur numericamente inferiori di Alessandrina e Vallicelliana), e infine della Nazionale di Napoli. Si tratta di diciotto
- 5 7 2 -
La catalogazione degli incunaboli
delle ventitré biblioteche italiane che risultano possedere almeno un migliaio di incunaboli. E a queste dovremmo aggiungerne ancora due, la Comunale di Mantova e la Civica di Bergamo, che hanno cataloghi relativamente moderni (il primo del 1937, i l secondo del 1966) ma che comunque non rispondono in nessun modo all'esigenza di una verifica bibliografica approfondita o di un'informazione storica sugli esemplari, com-pletamente assente in entrambi.'^ Cosa rimane allora all'attivo, sempre oltre questa soglia convenzionale dei mille esemplari? Soltanto tre biblioteche possiedono cataloghi di qualche utilità, anche se non certo ottimali. I l catalogo della Comunale di Palermo, come quello della Regionale (ex Nazionale) appena inferiore ai mille esemplari e uscito pure negli anni Settanta, dà sulle caratteristiche degli esemplari informazioni limitate e molto sommarie, oltre che solo in parte recuperabili tramite gli indici.''* Più approfonditi sono soltanto i l noto catalogo della Queriniana di Brescia, del Baroncelli, e più indietro quello dell'Estense, di Domenico Fava.'̂ Quest'ultimo è anzi l'unico, sempre fermandosi alle raccolte maggiori, ad essere dotato di uno strumento elementare come un indice completo dei possessori e degli altri personaggi menzionati a proposito degli esemplari, indice che - un po' inspiegabilmente - manca nel Baroncelli ed è chissà perché limitato soltanto alle istituzioni (biblioteche, conventi, ecc.), escludendo le persone e comunque con lacune, nei due cataloghi palermitani. Fra le ventitré raccolte maggiori solo tre, quindi, sono dotate di un catalogo che vada oltre la semplice localizzazione di esemplari, già offerta dall'IGI. Qualche altro catalogo utilizzabile a fini di ricerca storico-bibliografica esiste, fortunatamente, per raccolte meno ricche ma comunque importanti (Universitaria di Pavia, Berlo di Genova, ecc.). Ma, senza nulla togliere ai cataloghi di raccolte anche minori, è evidente quale importante contributo alla ricostruzione della circolazione del libro potrebbe venire da una catalogazione attenta alle peculiarità degli esemplari nelle maggiori biblioteche di centri culturali di prima grandezza (per esempio Firenze, Venezia, Roma, Milano). Ho parlato, fin qui, di cataloghi a stampa, ma non credo che la situazione sia molto migliore per quelli non pubblicati. Non ho cercato di svolgere un'indagine esauriente o almeno rappresentativa ma ho avuto occasione di fare ricerche di incunaboli in parecchie biblioteche
13. Cesare Ferrarini, Incumbulorum quae in Civica Bibliotheca Mantuana adservantur catalogus, Mantuae: Academia Vergiliana, 1937; Luigi Chiodi, Indice degli incunabuli della Biblioteca civica di Bergamo, Bergamo: Tip. Secomandi, 1966.
14. Giuseppina Li Calsi, Catalogo degli incunabuli della Biblioteca comunale di Palermo, Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1978. Cfr. anche Anna Maria Dotto, Catalogo degli incunabuli della Biblioteca nazionale di Palermo, ivi, 1971.
15. Ugo Baroncelli, Gli incunabuli della Biblioteca Queriniana di Brescia, Brescia: Ateneo di Brescia, 1970; Domenico Fava, Catalogo degli incunabuli della R. Biblioteca Estense di Modena, Firenze: Olschki, 1928.
- 5 7 3 -
Alberto Petrucciani
italiane. Se qualcuna, come l'Universitaria di Genova, mette a disposizione del pubblico schede un po' datate ma piuttosto dettagliate (che per esempio riportano le note di possesso, segnalano o descrivono ornamentazione e legatura, ecc.), in molte altre (e per esempio, se non ricordo male, nelle quattro romane maggiori, alla Braidense, alla Marciana, alla Palatina, alla Nazionale di Firenze) sono a disposizione dei lettori soltanto i dati bibliografici essenziali, su schede o, più spesso, con l'annotazione delle collocazioni su una copia dell'IGI. Spesso manca anche la semplice segnalazione della completezza dell'esemplare, che permetterebbe di evitare inutili richieste di consultazione. C'è poi da chiedersi quanto a fondo e quanto accuratamente sia stata compiuta, nelle biblioteche partecipanti all'IGI, la ricognizione del materiale quattrocentesco, e quindi quanti nuovi ritrovamenti possano essere attesi, e più in generale quanti dati nuovi ricavati da una collazione non sommaria. Penso a edizioni magari di poche carte legate con manoscritti o con stampati dei secoli successivi, a manipolazioni e contaminazioni di edizioni, ad attribuzioni imprecise di esemplari a edizioni, fino alle maculature. Non poche edizioni quattrocentine, si sa, sono note esclusivamente tramite singoli fogli o frammenti recuperati da legature. Veniamo, ora, a quelle che mi sembrano le principali questioni di metodo. Si sa che le questioni catalografiche, anche più minute, suscitano spesso - o dovremmo ormai dire suscitavano? - accese polemiche, mentre nel nostro caso mi sembra di poter registrare un vasto consenso sui principi e sulle finalità, a cui però non sempre corrisponde una realizzazione adeguata. Catalogare un libro antico - non solo un incunabolo - significa essenzialmente due cose. In primo luogo, catalogare è assegnare l'individuo {esemplare) a una classe bibliografica {edizione) e ad eventuali sottoclassi (impressioni, emissioni, stati), notandone quindi le eventuali varianti, lacune, particolarità. Questa mi sembra la principale differenza di metodo fra catalogazione e bibliografia, a mio avviso resa poco felicemente dalla contrapposizione facilmente fraintesa fra "descrivere esemplari" e "descrivere copie ideali". Almeno idealmente - perché non sempre si può contare su bibliografie esaurienti ed autorevoli - i l catalogatore inscrive un'informazione in un quadro prefissato, come se classificasse impiegando uno schema. I l bibliografo, invece, costruisce una classificazione. Si potrebbe suggerire anche un'altra analogia, con i l lavoro del naturalista. Un naturalista individua una specie e la identifica con un nome e una descrizione differenziale. Chi viene dopo di lui non descrive di nuovo la stessa specie, bensì classifica gli esemplari. Va da sé, almeno nel nostro campo, che chi classifica gli esemplari al tempo stesso verifica, ed eventualmente integra o corregge, il quadro classificatorio. La seconda finalità, lo si è già anticipato, è quella di dar conto delle peculiarità individuali dell'esemplare, di ricostruire la sua storia di oggetto che, uscito dalla tipografia, è stato decorato o rubricato.
- 5 7 4 -
La catalogazione degli incunaboli
rilegato, letto e annotato, venduto donato o rubato, ed è infine arrivato fino a noi, in certe condizioni e in una data sede. Ma torniamo di nuovo, più a fondo, sulla prima finalità. E' evidente che la funzione catalografica è più chiaramente distinta da quella bibliografica quando esiste un quadro di riferimento sufficientemente completo e valido. Altrimenti è inevitabile che i l catalogatore si trovi costretto a descrivere oltre che a classificare. Ma per gli incunaboli, in linea di massima, questo modello _/Mnz/c»na, ed è principio acquisito che per un'edizione già analiticamente descritta ci si limiti a rinviare al repertorio appropriato. Dietro questa prassi non c'è solo un'esigenza di economia. Anzi, essa risponde in primo luogo a un principio generale del lavoro scientifico, che non riparte sempre da zero, bensì costruisce pezzo per pezzo, accumulando ed emendando. Ci sono anche soluzioni di continuità e "rivoluzioni" scientifiche, lo sappiamo, ma esse si comprendono proprio in opposizione a questa dinamica normale di crescita e affinamento del sapere. Questa prassi mi sembra avere implicazioni non tutte ovvie. Si sono sentite sbrigative liquidazioni deir"ozioso moltiplicarsi" dei riferimenti bibliografici in calce alle schede di repertori e di cataloghi, e mi sembra che critiche e repliche non abbiano colto appieno i l senso di questa pratica. La cosa è grave, perché una disciplina che perda la memoria della sua tradizione, non riconosca più le proprie forme di trasmissione ed avanzamento delle conoscenze, e abbia dimenticato i l senso delle proprie procedure, sarebbe davvero in cattivo stato. In effetti i riferimenti bibliografici in fondo ad una scheda appaiono tutti uguali (stili di citazione a parte) ma possono avere finalità molto diverse. In un repertorio descrittivo, come i l GW, i riferimenti bibliografici a opere superate o puramente segnaletiche possono avere la funzione di documentare, almeno in parte, da quando e per quah vie una certa edizione è bibliograficamente nota, registrata, oppure di indicare cataloghi collettivi che censiscano in maniera più esauriente gli esemplari superstiti. In altri contesti, i l riferimento a descrizioni e segnalazioni bibliografiche e catalografiche può dare indicazioni, anche se approssimative, sulla diffusione di un'edizione, e soprattutto è un fondamentale strumento di controllo qualitativo dei dati. Molto spesso, come avvertiva W.W. Greg, un libro antico non ci dice esplicitamente tutto quanto vorremmo sapere,'̂ e i l fatto di averlo visto con i propri occhi - come si fa catalogandolo -non garantisce che lo si sia correttamente analizzato, che non siano sfuggite manipolazioni, lacune, falsificazioni, ecc. I l controllo sistematico su fonti bibliografiche dei dati tratti dall'esemplare che abbiamo in mano eleva sostanzialmente la loro qualità e attendibilità, oltre ad affinare, nel confronto con i l lavoro altrui, la competenza del catalogatore. Inoltre, la segnalazione di uno o
16. Cit. da Fredson Bowers, Principles of bibliographical description, Princeton: Princeton University Press, 1949, p. 9.
- 5 7 5 -
Alberto Petrucciani
più repertori - ovviamente secondo una scala di priorità - facilita successivi lavori bibliografici, evidenziando subito quali edizioni sono già registrate, in quali fonti, e quali invece non lo sono. Ma questo modello di lavoro comporta ancora, a mio avviso, qualcosa di più: attraverso il riferimento a una descrizione dettagliata di confronto, i l catalogatore si impegna sulla corrispondenza fra esemplare e notizia bibliografica, ne dà garanzia. In questo modo i l contributo conoscitivo di un catalogo che non descrive ma fa riferimento ad una descrizione bibliografica può essere maggiore, e non minore, di quello di un catalogo descrittivo. Chi descrive ex novo, infatti, fornisce dei dati bruti che devono essere poi confrontati con le descrizioni repertoriali per accertarne la conformità o almeno la compatibilità. In pratica è molto facile che la corrispondenza non sia completa e i l lettore è lasciato nel dubbio: una variante? un errore? e di chi? Al contrario, il semplice riferimento alla descrizione repertoriale con l'esplicito avvertimento dell'esistenza di questa o quella discordanza fornisce al lettore un'informazione più sintetica e più affidabile. Se invece viene a mancare la condizione di una accurata collazione fra esemplare e descrizione repertoriale, e l'impegno a segnalare e quando possibile spiegare le discordanze, mi sembra che cada proprio i l fondamento della prassi per cui non si descrive ex novo quanto è già registrato. Se non c'è garanzia che l'esemplare corrisponda alla descrizione a cui facciamo riferimento, qual'è l'informazione che la scheda dà? Soltanto che l'esemplare catalogato ha una certa somiglianza - non definita - con un'edizione registrata nei repertori. La scheda, apparentemente, rimane la stessa, ma è come se ne avessimo tagliato via la maggior parte: non possiamo più inserire virtualmente nel catalogo, facendola nostra, la descrizione del repertorio. Dal punto di vista del metodo di lavoro, se la citazione viene infilzata invece che collazionata cala bruscamente l'attendibilità dei risultati. E' facile infatti che sfuggano incompletezze o manipolazioni, aggiunte estranee o commistioni, che si confondano edizioni diverse, non sottoscritte o riproducenti la stessa sottoscrizione, ecc. Una descrizione dettagliata serve appunto a risolvere problemi come questi. Vediamo rapidamente qualche esempio.'^ Traggo i l primo da un catalogo recente e senz'altro tra i migliori. Un'edizione del Tortelli (IGI 9683) è segnalata come in folio, e di 346 carte non numerate, con rinvio al BMC, oltre che a repertori privi di descrizione analitica o superati. Confrontando i l BMC, notiamo che l'edizione risulta di formato apparente misto, in folio e in quarto (con l'indicazione delle rispettive parti): questa informazione è utile per accertare se risme di fogli interi e di mezzi fogli di formato doppio siano state impiegate
17. Gli esempi sono tratti dai cataloghi già citati e da altri meno recenti. Essendo puramente funzionali all'argomentazione, non mi è sembrato necessario specificarne volta per volta la fonte.
- 5 7 6 -
La catalogazione degli incunaboli
indifferentemente. L'edizione è considerata di 345 (non 346) carte, non computandosi, correttamente, i l coniugato bianco di un inserto, destinato per la sua posizione ad essere reciso. Infine, l'esemplare del catalogo risulta appartenere non allo stesso stato di quello della British Library, ma ad una variante (a cui i l repertorio accenna) in cui nel colophon figura i l solo nome del tipografo invece di quello del libraio committente (editore). Era senz'altro preferibile, quindi, segnalare esplicitamente la variante, così come la presenza della carta bianca supplementare. Per quanto riguarda il formato, mancando un'esplicita segnalazione della discordanza con BMC è difficile che i l lettore possa fidarsi del compilatore ed esser certo che l'esemplare sia completamente in folio. Troviamo la stessa edizione in un altro catalogo recente. Presumibilmente l'esemplare appartiene alla stessa variante (ma questo si deduce solo dall'assenza, nella scheda, del nome dell'editore) e la questione del formato non si pone perché i l compilatore non l'ha ritenuto un elemento degno di inclusione nella scheda. Noto la stessa incredibile omissione in due recenti cataloghi di cinquecentine. Perché poi lo stesso catalogo dia invece la formula collazionale (o, con dizione tradizionale ma ambigua, i l registro delle segnature), inattendibile quando non presa di peso dai repertori, risulta incomprensibile. In un catalogo di qualche anno fa, che comprende anche cinquecentine, è presente un'edizione trevigiana di Plinio con una datazione diversa nel giorno e mese (non nell'anno) da quella del BMC e dell'IGI, pure correttamente citati. I l compilatore avverte in nota della discordanza commentando: «Fórse si tratta di edizione diversa da quella citata da IGI». Se i l compilatore non si fosse limitato a citare la scheda del BMC ma l'avesse anche letta avrebbe appreso che la data da lui non trovata era apposta a una dedicatoria e che l'esemplare della sua biblioteca era mutilo. Infatti i l BMC indica una consistenza di 360 carte (prima e ultima bianche), non di 349, come si dice, senza alcuna avvertenza, nel catalogo. Ancora un altro esempio, in un catalogo recente, che per un esemplare segnala la presenza di cartulazione a stampa in un solo foglio. I l fatto è ovviamente sospetto, ma non è questo che importa. Un adeguato controllo dei repertori avrebbe mostrato che questa stranezza non è stata segnalata per altri esemplari e avrebbe messo sulla pista della probabile soluzione dell'enigma: i l GW segnala infatti altre edizioni cartulate della stessa opera, in una delle quali i l sistema impiegato è lo stesso del foglio anomalo. Si tratterà quindi, con ogni probabilità, di una carta interpolata da quest'altra edizione. Anche prima di confrontare visivamente gli esemplari i dati del repertorio (impaginazione, numero di righe per colonna, misura del carattere, ecc.) offrono tutti gli elementi per la soluzione del problema. Cosa voglio sottolineare con questi esempi? La competenza, l'esperienza, l'intuizione che aiutano a risolvere problemi quotidiani
- 5 7 7 -
Alberto Petrucciani
come questi non sono doti che si possano richiedere per decreto, ma in tutti questi casi un metodo rigoroso, basato sul confronto accurato fra esemplari e repertori, avrebbe condotto a individuare le anomalie, a segnalarle esplicitamente e, quasi sempre, avrebbe anche permesso di spiegarle. Questo metodo di lavoro richiede, naturalmente, di scegliere quali repertori adoperare come base descrittiva, in considerazione della loro attendibilità; altri repertori potranno essere citati per finalità differenti. Ritengo, per esempio, che il riferimento al Repertorium bibliographicum dello Hain (con le relative concordanze) sia tuttora necessario, o comunque molto utile, anche se l'opera è superata come base descrittiva. Motivazioni funzionali e non descrittive sono alla base anche della pratica di citare sempre i numeri dell'IGI e del Goff, principali strumenti di riferimento nel nostro paese e nel mondo anglosassone. Definita la base di confronto, si incontreranno essenzialmente due ordini di problemi, la discordanza fra i repertori di riferimento scelti, non rara anche se solitamente di dettaglio, e la discordanza fra quanto emerge dall'esame dell'esemplare e quanto è registrato nelle descrizioni collazionate. Se non indichiamo queste discordanze, quale valore avrà il nostro rinvio alle descrizioni stesse? Se il numero di carte indicato dal BMC è diverso da quello indicato dal GW (capita abbastanza spesso) quale informazione stiamo dando sulla consistenza del nostro esemplare? Perché la nostra segnalazione abbia la stessa potenzialità informativa di una descrizione dettagliata dovremmo specificare, in caso di conflitto, a quale descrizione il nostro esemplare corrisponde, e naturalmente a quale variante già segnalata appartiene. Se non vi sono descrizioni che corrispondano senza alcuna discordanza al nostro esemplare, ci chiederemo se ci troviamo di fronte ad una variante non ancora segnalata o ad una inesattezza nel repertorio. Talvolta la questione può essere chiarita facilmente. L'esistenza di una variante è accertata quando mettiamo le mani su un esemplare che corrisponde pienamente alla descrizione repertoriale. Possiamo essere sicuri di una svista altrui, per esempio, quando verifichiamo che l'esemplare su cui si basa la descrizione del repertorio è conforme al nostro. Non ci sono limiti prefissati a questi confronti e a queste verifiche, che dipenderanno dalle possibilità di esaminare facilmente altri esemplari e dagli interessi del catalogatore. Comunque bisogna sapere che la redazione di un catalogo accurato ed attendibile spesso non potrà prescindere da confronti con altri esemplari, anche se non al livello richiesto da un lavoro bibliografico. Spesso, per esempio, solo il confronto di un esemplare internamente lacunoso con uno completo permette di determinare con certezza quali siano le carte mancanti, da indicare nel catalogo. Ogni minimo conflitto tra le descrizioni di riferimento e il nostro esemplare è un campanello d'allarme importante da non trascurare. Anche in una descrizione approfondita, ma di un'edizione non miscellanea, la trascrizione si limita a qualche linea de\V incipit e di
- 5 7 8 -
La catalogazione degli incunaboli
eventuali testi preliminari, a una linea all'inizio del secondo fascicolo di testo, e quindi salta aìVexplicit, al colophon e al registro. Di conseguenza, una modestissima discrepanza di trascrizione può mettere sulla traccia di una diversa composizione di parecchie carte e fascicoli. Anche quando, confrontando altri esemplari, accertiamo che si tratta di un intervento circoscritto, per esempio una correzione (o un incidente) che interessa soltanto una o poche righe, l'informazione è di non poco interesse per la ricostruzione delle pratiche d'officina e di lavoro, soprattutto quando le osservazioni si accumulano e consentono di tirare conclusioni più diversificate e quantificate.̂ ^ Quando invece si arriva a verificare, o anche solo a ipotizzare, una imprecisione nella descrizione repertoriale, la segnalazione della discordanza costituisce un piccolo contributo all'accrescimento e affinamento delle nostre conoscenze. Se fin qui mi sono soffermato su aspetti più strettamente descrittivi, può essere utile accennare anche alle questioni di datazione ed attribuzione. Direi che da un catalogo non ci si attende più un'originale attribuzione e datazione di tutto il materiale che lo richieda. E ' auspicabile, piuttosto, che si conoscano e quindi si rispecchino correttamente i dati acquisiti nei repertori e negli studi più recenti ed attendibili. Se, comunque, la competenza del compilatore, la possibilità di ampi confronti, soprattutto in una grande raccolta, e l'emergere di elementi nuovi consentono di dare un contributo su questo piano, è bene che esso sia evidenziato in una nota e non soltanto riportato tacitamente nella scheda. Chiarisco, una volta per tutte, che come in ogni attività catalografica il contesto in cui si opera (l'importanza della raccolta, la sua eventuale specializzazione, la disponibilità di supporti bibliografici o tecnici, ecc.) incide sostanzialmente sulla valenza bibliografica, forse mai del tutto assente, di un lavoro catalografico. Lavorare su una grande raccolta in una biblioteca con ottimi apparati di consultazione offre le condizioni per dare contributi originali anche sul piano bibliografico, senza che, però, questa opportunità si possa trasformare in un obbligo. Risalendo un po' a ritroso, dai dati più strettamente descrittivi a quelli tipografico-editoriali, arriviamo ad accennare all'informazione sulle opere e sugli autori. La prassi, nei cataloghi italiani, è di solito quella di adeguarsi alla formula e allo stile dell'IGL ed è una scelta che condivido. Sappiamo bene - lo notava anche Barberi nel lontano 1966, recensendo il quarto volume dell'IGI - che le intestazioni impiegate
18. Lavorando sugli incunaboli durazziani, per esempio, mi è capitato un caso in cui un intervento avvenuto durante la stampa era testimoniato semplicemente da una discordanza di punteggiatura rispetto alla descrizione del catalogo della British Library {Gli incunaboli della Biblioteca Durazzo cit., n. 290). Lo stesso BMC, del resto, nota scrupolosamente le discordanze di trascrizione con Hain. In altri esemplari durazziani (n. 75, 192, 348) minute discordanze di trascrizione hanno rivelato ricomposizioni anche cospicue, che possono per esempio testimoniare della decisione di ampliare la tiratura intervenuta, come nel caso ben noto della Bibbia delle 42 linee, a stampa già avanzata.
- 5 7 9 -
Alberto Petrucciani ^4 ìi
sono lontane dalle soluzioni più razionali, e comunque più uniformi, delle moderne regole di catalogazione per autori. Peraltro le questioni di forma dell'intestazione, come la preferenza per le forme latine, non toccano, tutto sommato, il contenuto delle informazioni. Piuttosto mi sembra poco efficace e poco trasparente il compromesso fra i termini di riferimento (titoli e nomi di autori) impiegati nelle edizioni e quelli della nostra sistemazione storico-letteraria. Non mi riferisco alle varianti formali, giustamente normalizzate, bensì a differenze di sostanza. Massicce sono, come si sa, le attribuzioni oggi respinte ai maggiori autori (Agostino, Girolamo, Bernardo, ecc.). L'opera a cui oggi facciamo riferimento come le Vitae imperatorum di Cornelio Nepote veniva pubblicata nel quindicesimo secolo come De virorum excellentium vita di Emilio Probo. Dalla scheda di una edizione del Quattrocento, quindi, credo che vorremmo sapere due cose spesso diverse: quali opere contiene nei nostri termini e con quali attribuzioni e con quali titoli esse erano presentate - anche lasciando da parte le varianti formali - ai lettori del tempo. La prima informazione è indispensabile per la compatibilità con gli strumenti bibliografici di oggi; la seconda è molto importante sia dal punto di vista storico sia da quello pratico (per facilitare l'identificazione delle edizioni, i confronti con cataloghi e inventari antichi, ecc.). Inoltre, tanto nell'IGI quanto in altri repertori, la segnalazione del contenuto è spesso incompleta, mentre almeno per un corpus così limitato e importante dovrebbe essere possibile recuperare con certezza non solo tutte le edizioni di un'opera, ma anche tutti i singoli contributi per quanto modesti di un singolo autore, ed informazioni di tipo diverso, ma di importanza non minore, come quelle riguardanti i dedicatari, i destinatari di testi preliminari, ecc.̂ ^ Anche in questo caso, se è preponderante l'interesse storico e letterario, non manca un risvolto strettamente bibliografico. Mi è capitato, per esempio, di dover ricostruire l'origine di un frammento, evidentemente quattrocentesco e contenente una dedicatoria, legato in un volume a cui non doveva appartenere. La ricerca tramite il nome dell'autore dell'epistola si è rivelata infruttuosa in tutti i repertori e cataloghi di incunaboli che ho consultato, nonostante molti di essi contenessero - come ho verificato in seguito - l'edizione di cui il frammento faceva parte. La dedicatoria e il suo autore non erano stati registrati nelle schede né negli indici. Alla fine la risposta saltò fuori soltanto in una sede imprevista: l'Audiffredi, l'incompiuto catalogo a stampa settecentesco della Biblioteca Casanatense, che conteneva una segnalazione per quel piccolo contributo.-̂ ^ Se questi sono i problemi, non mi sembra però che la soluzione più opportuna sia quella, suggerita da Serrai, di «dare
19. Questo punto è stato recentemente richiamato da Veneziani {Informatica e incunaboli cit., p. 154), sottolineando i notevoli progressi compiuti negli ultimi volumi dell'IGL
20. Cfr. Gli incunaboli della Biblioteca Durazzo cit., p. 328.
- 5 8 0 -
La catalogazione degli incunaboli
una spallata» alle convenzioni tradizionali, applicando gli stessi principi della catalogazione moderna.•̂ ^ Questa scelta sarebbe senz'altro opportuna in una nuova impresa bibliografica di vasta portata, pur scontando gli inevitabili disagi dell'abbandono di abitudini consolidate. Fatta salva in ogni caso la necessità di prevedere dei punti di accesso sotto i nomi e le forme di uso corrente nella catalogazione di oggi, credo che si debba tenere conto del contesto in cui si opera - perciò, in Italia, dell'IGI - e della valenza bibliografica del lavoro. Un singolo catalogo, anche di una grande raccolta, non comprende che una minima frazione di tutte le edizioni giunte fino a noi. Un catalogo che registri mille edizioni copre circa il 3% degli incunaboli conosciuti. Vi saranno archi di tempo, luoghi di stampa, autori, materie, generi rappresentati piìi largamente di altri, ma la copertura bibliografica sarà complessivamente molto limitata. Di conseguenza l'applicazione di una griglia analitica e descrittiva diversa da quella tradizionale potrebbe costituire, al massimo, una sperimentazione. Per la stessa ragione, confesso che sul piano catalografico (diverso è il discorso per quello bibliografico) non trovo il problema dell'ordinamento particolarmente cruciale. Sappiamo che in uno strumento di ricerca bibliografica il contesto in cui è posta ciascuna scheda costituisce di norma un elemento di primaria importanza. Ma in cataloghi relativi a qualche centinaio o anche a mille o duemila esemplari il contesto, quale che sia (edizioni di una stessa opera e opere di uno stesso autore, edizioni di uno stesso tipografo e di uno stesso centro, edizioni coeve, ecc.), non potrà non essere povero e scarsamente significativo, almeno nella grande maggioranza dei casi, e quindi insufficiente per trame serie conclusioni sul relativo universo bibliografico (fortuna di un autore, attività di una bottega, tendenze di un periodo, ecc.).-̂ ^ Il confronto fra le edizioni vicine sarebbe inoltre tarpato dal modulo descrittivo breve. L'ordinamento "scientifico" (quello del BMC e di qualche altro grande repertorio, a base geografico-topografica, quindi cronologica per officine) o quello semplicemente cronologico presentano in genere pochi vantaggi, e qualche svantaggio, rispetto al più banale ordinamento per intestazioni principali (autori o titoli). Prima di passare alla seconda funzione di un catalogo di incunaboli, quella di render conto delle pecuHarità degli esemplari, c'è un'altra avvertenza da sottolineare. Confrontando l'esemplare col quadro
21. Alfredo Serrai, Intorno agli incunabuli ed ai cataloghi di incunabuli cit., p. 209.
22. Si potrebbe osservare che l'obiezione non vale se il punto di riferimento non è l'universo bibliografico ma la singola raccolta. Se una raccolta è stata costituita sulla base di un criterio bibliografico ben definito è opportuno che la struttura del catalogo lo rispecchi. Ma in pratica le motivazioni e le vicende di formazione di una raccolta sono quasi sempre varie, ed è difficile che emerga un unico criterio di ordinamento significativo.
- 5 8 1 -
Alberto Petrucciani
bibliografico, è necessario avere sempre molto chiara la distinzione fra gli elementi propri dell'esemplare e quelli propri dell'edizione. La descrizione bibliografica è quella dell'edizione (almeno per gli stessi buoni motivi che valgono nella catalogazione moderna), anche quando l'esemplare è incompleto e mutilo, o costituisce solo una parte di un'unità bibliografica più ampia.'^^ Non per inutile purismo, ma per fare chiarezza in una differenza che non sempre è ovvia, almeno per i non specialisti, deve essere comunque evitata la contaminazione fra i dati propri dell'edizione e quelli propri dell'esemplare. Capita invece, nell'introduzione a un recente volume, di leggere che le «edizioni» sono in un certo numero, ma maggiore è quello delle «schede» perché si sono fatte «schede singole per ciascuna opera». Il lettore sobbalza di fronte ad una soluzione così stravagante ma poi si accorge, esaminando il volume, che il compilatore chiama «edizioni» i pezzi fisici (volumi) e «opera» l'esemplare di un'edizione, che ovviamente può trovarsi legato con esemplari di altre edizioni. Una questione su cui ha insistito ripetutamente Luigi Balsamo è quella del formato: da una parte il formato bibliografico - che dipende dall'impostazione tipografica ed è proprio dell'edizione - dall'altra le dimensioni in centimetri (dell'altezza, spesso anche della larghezza, e qualche volta dello spessore) dei singoli esemplari.-^'* La distinzione dovrebbe essere acquisita, eppure in un recente catalogo - questa volta di cinquecentine e pubblicato col patrocinio dell'Ufficio centrale per i beni librari - si legge: «Poiché la maggior parte dei testi è stata rifilata [e qui per testi si intendono evidentemente gli esemplari] ho pensato, evitando l'uso delle indicazioni f°, 4°, 8°, ecc., che non corrispondono all 'originale, di riportare in centimetri le dimensioni del testo [esemplare] ricavandole dal frontespizio». Evidentemente l'autore ignora cosa sia il formato bibliografico, e a quanto pare lo confonde con la vecchia pratica di impiegare le designazioni tradizionali, impropriamente, per indicare in modo approssimativo le dimensioni.
23. Per le stesse ragioni ritengo preferibile, in un catalogo a stampa, numerare le edizioni, non gli esemplari (e men che meno, come pure tocca vedere, i volumi). Anche in presenza di più esemplari, non c'è ragione di duplicare la parte della descrizione che si riferisce all'edizione: 10 noto perché questo è quanto avviene in un catalogo recente. Non si tratta solo di uno spreco. 11 lettore curioso che confronta le descrizioni ripetute incontra, in un caso, una cospicua differenza nella formula di collazione, non spiegata dal compilatore ma spiegabile così: nei due esemplari, di un'edizione con contenuto miscellaneo, le varie parti sono state legate in ordine differente (cosa tutt'altro che rara, come sanno gli addetti ai lavori). Ovviamente questo va detto nelle note sull'esemplare, senza inventare collazioni varianti che non hanno ragione di esistere.
24. Cfr. Luigi Balsamo, Funzione e utilizzazioni del censimento dei beni librari, «Biblioteche oggi», 7 (1989), p. 31-40 (p. 32). Ma una puntuale attenzione alle questioni di metodo lega da molti anni le recensioni a cataloghi di ibri antichi nella Rassegna bibliografica de «La bibliofilia».
25. Per esempio nelle Regole per la compilazione del catalogo alfabetico per autori nelle biblioteche italiane, pubblicate dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche del Ministero della pubblica istruzione (Roma: Palombi, 1956, par. 125) si prescriveva di descrivere come in folio i volumi alti più di 38 cm, in quarto quelli da 28 a 38 cm, ecc.
- 5 8 2 -
La catalogazione degli incunaboli
Confusioni fra edizione ed esemplare si incontrano spesso nel trattamento di carte bianche, che possono essere o non essere parte integrante della consistenza originale, e nella descrizione dell'ornamentazione, tra iniziali incise ed iniziali calligrafiche o miniate.̂ ^ Dell'esigenza di un'assoluta esattezza sulla completezza dell'esemplare - anche a costo di doverne verificare altri per determinare le lacune - ho già detto, e questo è particolarmente importante in cataloghi a stampa che si rivolgono, proprio per le caratteristiche del materiale, a studiosi di tutto il mondo, che è inutile mobilitare - per una visita o una richiesta di riproduzione - quando l'esemplare descritto non serve allo scopo. Per precisare varianti e lacune, per localizzare esattamente una carta o pagina menzionata in una nota,̂ ^ e più in generale per l'analisi e la collazione degli esemplari, è indispensabile una conoscenza dei metodi e delle convenzioni della bibliografia analitica. Oggi in Italia se ne vedono frequentemente tracce ma il livello di padronanza resta molto insoddisfacente. In questo campo non si può improvvisare e non basta certo una lettura della corretta ma sommaria sintesi offerta dal manuale del Gaskell (quindici pagine per l'intera descrizione, cinque per l'area più delicata della collazione).^^ Certo nessun bibliotecario "moderno" affronterebbe oggi una descrizione ISBD sulla base di una sintesi di poche pagine, per quanto corretta, senza ricorso allo standard e a manuali applicativi. Invece, non solo per il Quattrocento, l'approccio a questa metodologia di analisi e di descrizione è spesso superficiale e scorretto. Va ricordata, a questo proposito, l'indifferibile esigenza di una formazione seria e organica e la necessità, quando si affrontano lavori bibliografici, di discuterne con colleghi ed esperti l'impostazione e i risultati, pratica da sempre usuale nell'attività scientifica. Per
26. In qualche caso il dubbio può aver ragione di sussistere: sono note edizioni nelle quali iniziali xilografiche si incontrano solo in alcuni degli esemplari e sappiamo assai poco sulle pratiche di colorazione delle incisioni, con uniformità in più esemplari che fanno sospettare un'esecuzione "in serie" e forse all'origine. Se sussiste il dubbio deve prevalere, ovviamente, l'indicazione più prudente (attribuzione dell'elemento al singolo esemplare e non all'intera edizione).
27. Per il riferimento a singole carte o pagine nella tradizione incunabolistìca si è generalmente impiegata l'ideale numerazione progressiva delle carte (comprese quelle bianche) di un esemplare completo (o, se si preferisce, di una copia ideale). Al contrario, la tradizione bibliografica per i secoli successivi privilegia il riferimento tramite le segnature, mentre a partire dal Settecento può essere spesso preferibile l'uso della paginazione a stampa (eventualmente accompagnata, quando è il caso, dalla segnatura). La pratica incunabolistica ha l'inconveniente di presupporre che il lettore abbia a disposizione una descrizione analìtica: per individuare, per esempio, la carta 2, bisogna sapere se quella con l'inizio del testo era preceduta, in origine, da una bianca. Ma questo inconveniente non è superato dal riferimento tramite le segnature, dato che molte edizioni ne sono prive (e non sono uniformi i metodi di inferenza impiegati nei maggiori repertori) e che si incontrano spesso ripetizioni, errori o sequenze estremamente complesse. Qualunque sia il criterio seguito, è essenziale che il riferimento non sia ambiguo. In uh recente catalogo di incunaboli e cinquecentine, per esempio, una scheda indica la presenza di un frontespizio intemo a c. A l , ma dalla collazione risulta che di carte segnate A l ce ne sono addirittura quattro.
28. Philip Gaskell, A new introduction to bibliography, Oxford: Clarendon Press, 1972, p. 321-335.
- 5 8 3 -
Alberto Petrucciani
esempio, le formule di collazione - quando non sono copiate dai repertori - sono spesso di fantasia, non rispettando l'uso dei segni convenzionali, le norme di inferenza di fascicoli non segnati, ecc. Perfino una convenzione di base, l'uso del numero a esponente per indicare la conformazione normale di un fascicolo e del numero in posizione normale o in basso (deponente) per designare la singola carta, è spesso travisata. Bisogna essere consapevoli che la collazione bibliografica è il risultato di un lavoro analitico e interpretativo, che richiede una certa competenza ed esperienza e che spesso non può prescindere dal confronto di parecchi esemplari. Per questa ragione, nonostante l'importanza bibliografica della formula collazionale, ritengo sconsigliabile includerla in lavori catalografici o comunque non particolarmente approfonditi. Veniamo ora alla seconda funzione del catalogo di una raccolta, quella di render conto della storicità degli esemplari. Si tratta dell'aspetto fin qui più trascurato, come abbiamo visto, ma su cui esiste un ampio consenso e che forse nasconde meno insidie concettuali. Ci sono, a mio avviso, due variabili contingenti ma cruciali. La prima, come ha sottolineato più volte Innocenti, è l'esistenza di fonti per ricostruire la formazione della raccolta e sulla base delle quali interpretare gli indizi spesso minuti e frammentari tratti dall'esame materiale dei libri.-̂ ^ La seconda, su cui sarebbe sbagliato sorvolare per malintesi pudori, è il possesso, da parte del catalogatore, delle svariate competenze necessarie, quasi tutte piuttosto specialistiche, oltre che di appropriati strumenti e supporti (terminologici, metodologici, bibliografici, ecc.).^° Sarebbe non solo illusorio, ma metodologicamente sbagliato, partire dal presupposto di un catalogatore necessariamente specializzato in tutto, una specie di soggetto onnisciente. Quanto alla prima questione, non sono poche in verità le biblioteche italiane delle quali esistono cataloghi antichi e inventari, e per le quali possiamo rintracciare documenti relativi a lasciti e incameramenti, carteggi, anche di singoli bibliotecari, e perfino documenti amministrativi e contabili (registri d'ingresso, fatture, conti di legature). Questo materiale è spesso poco studiato o ignorato, mentre mi sembra che ogni biblioteca di tradizione abbia fra i suoi compiti quello di ricercarlo, di individuarlo anche in altre sedi, eventualmente di curarne la riproduzione, di raccogliere le informazioni pertinenti anche da fonti edite, da cataloghi e inventari di altre biblioteche, ecc. Queste informazioni possono poi trovare posto, ed essere organizzate, in varie sedi e maniere, nell'ambito dell'archivio della biblioteca stessa, nella bibliografia sugli esemplari (in genere molto carente anche per i
29. Cfr. Piero Innocenti, Presentazione, in: Anna Gonzo, Gli incunaboli e le cinquecentine della Parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento, cit., p. IX-XIII.
3 " Penso, per esempio, agli ambiti che ci riguardano di un'opera come il Vocabulaire codicologique di Denis Muzerelle (Paris: GEMI, 1985), oltre che a repertori specifici per singoli elementi ed aspetti.
- 5 8 4 -
La catalogazione degli incunaboli
manoscritti), fino all'ipotesi della costituzione di "dossier", per quanto informali ed agili, che inglobino un complesso di funzioni: di bibliografia sul posseduto, di documentazione sulla sua consultazione (estendendo quanto già previsto per i manoscritti dal regolamento delle biblioteche statali), di strumento per la conservazione e la tutela, ecc. Si tratta, insomma, di trovare degli strumenti tecnici che incamino la consapevolezza che il lavoro sul materiale antico e di pregio è comunque un work in progress. Senza una base di documentazione storica il lavoro analitico sugli esemplari è costretto a muoversi su ricostruzioni indiziarie sempre incerte. Molto, comunque, si può ricavare dal confronto minuzioso di piccole evidenze isolatamente di scarso significato ma ricorrenti o complementari. Non si possono fissare limiti a questo lavoro, e bisogna tenere conto, come si diceva, delle competenze, delle possibilità e degli interessi del compilatore. Fra gli elementi di storicità degli esemplari possiamo per comodità individuare tre ambiti principali, comunque spesso collegati fra loro: l'ornamentazione, le tracce di uso e di possesso, la legatura. Nel primo ambito si incrociano competenze storico-artistiche, a loro volta assai composite e specialistiche. Sono un profano in questo campo, e forse proprio per questo mi sembra particolarmente forte l'esigenza di disporre di adeguati punti di riferimento e di indicazioni di lavoro. Una descrizione sommaria e impressionistica dell'ornamentazione è probabilmente di poco o nessun aiuto per gli studiosi. Proprio da loro, invece, potrebbe venire l'indicazione di quali informazioni vadano considerate prioritarie, privilegiando, fin dove possibile, gli elementi che meglio si prestino ad essere accertati anche da non specialisti. Trovo un esempio nella relazione di Derolez al convegno di Mons su Ornementation typographique et bibliographie historique, con la proposta di una classificazione (con la relativa terminologia) e di una elementare griglia di dati per la registrazione delle iniziali bas-somedievali.^' Va da sé che, quando possibile, è opportuno il riferimento a un corpus pubblicato (penso per esempio al censimento degli incunaboli xilominiati e dei legni in essi impiegati),̂ ^ o il ricorso alla riproàuzione. A questo proposito, e per inciso, sottolinerei l'esigenza di considerare le illustrazioni di un catalogo a stampa come sua parte integrante, scegliendole per finalità di documentazione e non meramente estetiche: per esempio per varianti tipografiche, note di possesso o di datazione particolarmente rilevanti, miniature, ecc.
san
31. Albert Derolez, Les fondements typologiques d'une classification et d'une description des initiales dans les manuscrits du bas moyen àge, in: Ornementation typographique et bibliographie historique. Actes du colloque de Mons, 26-28 aoùt 1987, édités par Marie-Thérèse Isaac, Bruxelles: Van Balberghe, [1988], p. 17-26.
32. Cfr. Lamberto Donati, I fregi xilografici stampati a mano negl'incunabuli italiani, «La bibliofilia», 74 (1972), p. 157-164 e 303-327; 75 (1973), p. 125-174; 81 (1979). p. 41-74.
- 5 8 5 -
Alberto Petrucciani
Per il secondo ambito, e in particolare per le testimonianze di possesso, si cercherà di decifrarle e trascriverle - cosa non sempre facile sia per le condizioni di conservazione sia per il carattere non canonizzato o informale di molte scritture - e quindi di completare l'identificazione con ricerche biografiche e d'altro tipo. E ' importante fornire comunque l'evidenza dell'esemplare. Quando l'identificazione è riuscita la trascrizione completa di una nota potrà aiutare chi la incontri di nuovo mutila o danneggiata. Inversamente, la trascrizione di una nota decifrata solo in parte servirà a chi è riuscito a completarne la lettura in un altro esemplare. Allo stesso modo, l'indicazione delle dimensioni di un timbro in parte eraso e non leggibile può suggerirne l'identificazione con una occorrenza ben conservata. Elementi relativi al possesso si incontrano anche nell'ambito dell'ornamentazione (gli stemmi) o in quello della legatura (i superlibros). Anche qui ci inoltriamo in campi specialistici, ostici ai non iniziati e non sempre dotati di adeguati strumenti di lavoro. Quando questi strumenti esistono, però, il catalogatore deve tenerne conto, per esempio nella descrizione di uno stemma e nel riferimento preciso a repertori e riproduzioni di ferri araldici. Un obiettivo più ambizioso e complesso, anche se collegato agli accertamenti di base ora ricordati, può essere quello di contribuire a ricostruire le modalità di "finitura" dell'esemplare e le attività di "appropriazione" e approntamento per l'uso da parte del lettore. L'importanza di questa tematica è stata sottolineata, per esempio, da Paul Saenger, nel progetto di catalogo degli incunaboli della Newberry Library di Chicago.^^ Però è forse piuttosto con lavori di tipo bibliografico, su parecchi esemplari di una stessa edizione, che si può contribuire a rispondere alle domande sul chi, quando, dove, come, delle attività di rubricazione, ornamentazione, legatura. Può essere comunque importante cercare di determinare sistematicamente quali interventi (rubricazione, ornamentazione, cartulazione, annotazioni, note di possesso, ecc.) siano unitari e quindi abbozzare una tipologia degli esemplari: d'omaggio, da collezione ed esibizione, istituzionali, per lo studio individuale. Questo tipo di analisi, che si presta essenzialmente a un impiego seriale, può qualche volta avere una ricaduta anche su singole questioni specifiche. Il primo esempio che viene alla mente è la correlazione, da tempo suggerita, fra il fatto che molti esemplari delle edizioni di Sweynheym e Pannartz siano del tutto privi di interventi coevi, pure necessari all'uso (titoli e rubriche, iniziali, ecc.), e la crisi della loro impresa. Aggiungerei infine un avvertimento a essere particolarmente attenti a cogliere i segni dell'uso di un esemplare come testo base per un'edizione successiva. Questi
33. Paul Saenger, The Newberry catalogne of incunables, «Gazette du livre medieval», n. 8 (1986), p. 18-20.
- 5 8 6 -
La catalogazione degli incunaboli
esemplari sono infatti documenti importantissimi per ricostruire le pratiche redazionali, di composizione, ecc.̂ "̂ Il terzo degli ambiti che ho un po' schematicamente distinto, quello della legatura, è attualmente oggetto di molto interesse e di importanti lavori specialistici. I rischi stanno anche qui nella genericità, inutile per lo studioso, e in approcci impressionistici di scarsa attendibilità. Certo ogni sforzo va compiuto quando vi sia la possibilità di collegare, anche dubitativamente, l'evidenza dell'esemplare a una documentazione sulla sua esecuzione (conti, ecc.). All'altro estremo, può essere utile indicare comunque i casi in cui un totale rifacimento moderno esclude la presenza di elementi utili per lo studioso. Si tratta di un capitolo triste, che ci fa ricordare quelle "fosse comuni" in cui in diverse biblioteche è confluito - quando non è stato gettato via - materiale di risulta, di solito non più ricollegabile agli esemplari di provenienza. Anche sotto altri aspetti il restauro può rendere un esemplare inutilizzabile a fini bibliografici. Mi è accaduto, per esempio, di consultare alla Nazionale di Roma un incunabolo con una composizione dei fascicoli piuttosto irregolare "regolarizzata" in fase di restauro incollando accuratamente, ma arbitrariamente, carte che non dovevano essere coniugate. Mi sembra evidente, anche per la legatura, la necessità di disporre di indicazioni di lavoro date da specialisti, concretamente praticabili, non utopistiche, e accompagnate dalla relativa strumentazione (guide terminologiche, atlanti per il riconoscimento di materiali e tecniche, ecc.).̂ ^ Troviamo infine, in diversi cataloghi a stampa, informazioni sulle condizioni di conservazione.̂ ^ Concludendo questa rapida rassegna si può notare che moUi possono essere gli usi delle informazioni così riunite: ricostruire la formazione della raccolta, aggiungere un elemento alla biblioteca di un dato personaggio, ma anche trarre indicazioni sulla diffusione di un libro, sui suoi lettori, sulle pratiche di produzione e commercializzazione, e così via. Senza dimenticare la funzione di questi elementi anche come indizi per fini strettamente bibliografici: molte edizioni sono oggi assegnate a un termine ante quem soltanto attraverso note di acquisto, di rubricazione, di correzione, di possesso, che peraltro vanno interpretate con una buona dose di diffidenza perché spesso si sono rivelate inattendibili o falsificate. Ma, quando le informazioni su
34. Piero Scapecclii ha recentemente segnalato un caso di grande interesse, quello dell'esemplare del Leone Magno stampato a Roma dal Lignamine nel 1470 e poi impiegato, nello stesso anno, per l'edizione di Sweynheym e Pannartz. Cfr. Catalogo incunaboli, cit., n. 4, e An example of printer's copy used in Rome, 1470, «The Library», 6th ser., 12 (1990), p. 50-52.
35. Tra i contributi pili recenti: Carlo Federici, La legatura medievale, Roma: Istituto centrale per la patologia del libro; Milano: Bibliografica, 1993.
36. Devo dire che una sequela di indicazioni impressionistiche come quelle che traggo da un catalogo recente («esemplare molto bello», «esemplare ottimo», «esemplare ben conservato», «esemplare buono», ecc.) mi sembra di scarsa o nulla utilità. Tuttavia, la biblioteca può avere interesse a registrare, nell'occasione di una catalogazione sistematica, dati utili per la conservazione.
- 5 8 7 -
Alberto Petrucciani
un'edizione scarseggiano, anche un gruppo di antiche provenienze da una stessa area può costituire un indizio importante per la sua localizzazione. Infine, va sottolineata la necessità di mettere le informazioni raccolte a disposizione del lettore attraverso un complesso di strumenti di recupero, relativi a singoli tipi di elementi e a gruppi di essi. Le soluzioni pili opportune possono variare, anche a seconda delle forme assunte dal catalogo. In cataloghi a stampa non bastano, comunque, i tradizionali indici per autori e titoli, luoghi di stampa, tipografi ed editori, il meno usuale indice cronologico e le concordanze con i maggiori repertori. D'impostazione meno ovvia ma sempre necessario è un indice (o più indici) per le notizie relative agli esemplari. Un semplice indice dei possessori e delle provenienze - che pure, come abbiamo visto, è bene raro - può essere insufficiente a raccogliere e dare accesso a tutte queste notizie, anche se ne viene estesa la portata (a tutti gli enti e le persone connessi con gli esemplari, non solo in veste di possessori, e ai luoghi, di acquisto, miniatura, legatura, ecc.). Meritano una riflessione, quindi, i suggerimenti qua e là avanzati di indici "tematici", che non registrino soltanto nomi ma cerchino di rendere reperibili gli esemplari con questa o quella particolarità bibliografica, con tracce di provenienza di un certo tipo (per esempio stemmi, timbri, legature alle armi), con date tipologie e stili di legatura, ecc. Credo che su questo terreno, poco visitato e un po' infido, si possa cominciare a lavorare, superando la comprensibile ritrosia rispetto a un approccio che rischia di essere parziale e poco sistematico, e pensando a strumenti di normalizzazione.̂ ^
37. Esiste, per esempio, una serie di microtesauri elaborati negli ultimi anni dalla Rare Books and Manuscripts Section dell'Association of College and Research Libraries americana (cfr. la mia nota Microtesauri per il libro antico e raro, in: Annuario dei thesauri 1991, Firenze: Ifnia, 1991, p. 53-65). Strumenti di questo tipo potrebbero essere utilizzati sia direttamente per l'indicizzazione sia indirettamente come guida terminologica per la formulazione di note (facilitando, quindi, anche ricerche libere tramite l'elaboratore su archivi di dati che contengano informazioni di questo tipo).
- 5 8 8 -