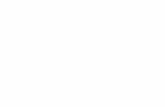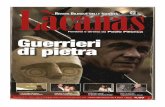Dante e la salvezza degli antichi
Transcript of Dante e la salvezza degli antichi
© 2
012
Vita
e P
ensi
ero
/ Pub
blic
azio
ni d
ell’U
nive
rsità
Cat
tolic
a de
l Sac
ro C
uore
Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 1 (2012), pp. 49-80
Maria Segato
DaNte e la SalVezza Degli aNtiChi
il caso eccezionale della salvazione di anime vissute nei secoli antecedenti la venuta del Redentore è argomento poetico e teologico dei canti in cui si assi-ste alla celebrazione della gloria degli spiriti giusti accolti nel cielo di giove. i canti XiX e XX del Paradiso rappresentano uno degli “snodi centrali”1 dell’in-tero poema. Essi, infatti, esemplificano, nel caso storico del troiano Rifeo, precristiano tramandato alla memoria collettiva soltanto attraverso due versi dell’Eneide2, l’imperscrutabile azione della grazia, che agisce secondo vie e
1 a.M. ChiavaCCi Leonardi, La salvezza degli infedeli: il canto XX del ‘Paradiso’, in “Regnum celorum vïolenza pate”, a c. di g. Cannavò, Montella 2002, p. 193.
2 Come è già stato ampiamento rilevato, non possediamo alcuna notizia circa la vita di Rifeo o circa tradizioni letterarie che possano averne tramandato la memoria; la giustizia del guerriero troiano viene ricordata con brevi accenni nel secondo libro dell’Eneide: “Primusque Coroebus / penelei dextra divae armipotentis ad aram / procumbit; cadit et Ripheus, iustissimus unus / qui fuit in teucris et servantissimus aequi / (dis aliter visum)” (Virgilio, Eneide, ii, 424-428, 6 voll., a c. di e. Paratore, ii, Milano 1978, pp. 61-62). È d’obbligo, in questa sede, ricordare quanto scritto da John Scott in merito alla corrispondenza fra i versi dell’Eneide e un passo del De Consolatione philosophiae riconosciuto come probabile fonte d’ispirazione per il XX canto del Paradiso. Boezio, discorrendo dell’“impossibilità in cui si trovano gli uomini di giudicare il prossimo secondo la verità divina”, scrive: “hoc quem tu iustissimum et aequi servantissimum putas omnia scienti providentiae diversum videtur; et victricem quidem causam dis, victam vero Catoni placuisse familiaris noster lucanus admonuit”. Scott conclude: “È davvero lam-pante il modo in cui il testo boeziano rispecchia quello virgiliano. […] Per di più, queste parole che trattano dell’imperscrutabilità del giudizio divino si trovano per l’appunto in quella sezione del De Consolatione che tratta del mistero della predestinazione” (J. SCott, Dante, Boezio e l’enigma di Rifeo (‘Par’. XX), “Studi Danteschi”, 61 [1989], p. 190).
03_Segato_1_12.indd 49 04/12/12 09.06
Maria Segato50
possibilità contemplate e confermate dalle voci più autorevoli del pensiero teologico medioevale. Dante eleva inaspettatamente al regno della beatitudine uomini nati e vissuti in contesti storici o geografici estranei al perimetro entro cui si è dispiegata la storia della salvezza cristiana. Si deve infatti ricordare, con Robert hollander, che “la prima anima salvata che il lettore incontra nel poema”3 è quella di Catone, precristiano e suicida. Nel contempo, alcuni fra i più illustri rappresentati delle antiche civiltà dei gentili sono relegati eter-namente nel “primo cinghio del carcere cieco” (Pg XXii 1034), tragicamente esclusi dalla beatifica visio Dei. argomento del presente studio è l’indagine del panorama teologico su cui fiorisce la formazione culturale dell’Alighieri, al fine di delineare l’orizzonte entro cui si collocano la nascita di un limbo così strutturato, ossia popolato dai massimi esponenti della cultura pagana raduna-ti attorno a un “foco” (If iV 68), e l’inaspettata salvazione di due precristiani non appartenenti al popolo eletto.
Si deve di necessità ricordare l’assoluta novità con la quale Dante ha inteso caratterizzare l’incipit della sua seconda cantica: Catone viene, infat-ti, non soltanto eletto fra gli spiriti salvati, ma deputato a presiedere all’ordi-ne con cui Dio stesso ha dispiegato la via della purificazione. Si noti poi che il suo sopraggiungere alle pendici del monte purgatoriale avviene in un’at-mosfera di penombra aurorale intessuta attraverso una trama di significazio-ni allegoriche volte ad evocare, nella luce proveniente da oriente, l’attesa del promesso “sole della salvezza”5 “oriens ex alto; / illuminare his qui in tenebris / et in umbra mortis sedens” (Lc 1, 78). In tale contesto, figurativa-mente segnato dall’attesa della rivelazione divina, desta, dunque, stupore incontrare un’anima vissuta in una civiltà che non conosce il Redentore6.
3 r. hoLLander, Ancora sul Catone Dantesco, “Studi Danteschi”, 75 (2010), p. 187.4 Cito da d. alighieri, Commedia, a c. di a.M. Chiavacci leonardi, Milano, 1991-1997.5 e. raiMondi, Rito e storia nel primo canto del ‘Purgatorio’, in Metafora e storia, tori-
no 2008, pp. 106-107 (già pubblicato col titolo Il canto I del ‘Purgatorio’, Firenze 1963). Come è noto, si fa riferimento alla stella di Venere, che negli inni cristiani spesso figura la vittoria della luce della salvezza sulle tenebre del peccato, e al colore del cielo assimilato al blu dello zaffiro (”Dolce color d’orïental zaffiro”, ‘Pg’. i 13), pietra che “simboleggia la speranza” e che spesso evoca il Cielo e le anime volte al raggiungimento della gloria celeste (g. MureSu, Il sacrificio per la libertà (’Purgatorio’ I), “Rassegna della letteratura italiana”, 10 [2001], 2, p. 366). Si vedano, a titolo d’esempio, le seguenti righe di gregorio Magno: “Sapphiris, qui scilicet lapides coloris aerei in se similitudinem tenent, quia robur ecclesiae in animabus caelestia appetentibus solidatur” (gregorius Magnus, Moralia in Iob, XViii, 33, CCSl 143/a, turnholti 1979, 920 -).
6 Cfr. hoLLander, Ancora sul Catone dantesco, pp. 187-188: “Si pensi ad altre situazio-ni parallele: nel primo canto dell’inferno è proprio Virgilio che è la guida in questo poema cristianissimo; nei canti terzi dell’inferno e del Purgatorio, rispettivamente, la dannazione di Celestino e la salvazione di Manfredi. Ci troviamo di fronte alla volontà di Dante di iniziare i prologhi e le ‘parti esecutive’ delle prime due cantiche in modo identico – con sorprese
03_Segato_1_12.indd 50 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 51
analogamente, assistere alla gloria divina di Rifeo, parte dell’aquila com-posta da anime quali il re Davide e il figlio Ezechia (precristiani appartenen-ti al popolo eletto) causa nel pellegrino un dubbio tanto trasparente quanto sbigottito anticipato nelle parole con cui l’aquila interrompe l’esposizione dei singoli exempla, eletti a comporre l’”esaedro”7 degli spiriti giusti, per introdurre il caso storico di Rifeo. il perfetto ordine del discorso intradiege-tico (scandito dalla regolarità ritmica dei versi precedenti che si ripetono in ugual modo lungo tutta la denominazione degli spiriti appena ricordati: due terzine per ognuno nelle quali prima si espone il merito terreno dell’anima, poi se ne indica la verità per come viene riletta e ri-conosciuta in Paradiso - “ora conosce” -) viene così spezzato dalle parole con cui l’aquila presen-ta il giovane troiano, immagine retorica della contemplazione che tracima nell’affermazione dell’imperscrutabile agire della grazia:
Chi crederebbe giù nel mondo erranteche Rifëo troiano in questo tondofosse la quinta de le luci sante?
Ora conosce assai di quel che ‘l mondoveder non può de la divina grazia,ben che sua vista non discerna il fondo. (Pd XX 67-72)
Viene così introdotta l’azione imprevedibile della predestinazione divina, che si manifesta patentemente nella “varietà individuale e irripetibile delle anime”8 che compongono l’immagine dell’aquila. alla vista del pellegrino si offrono, infatti, due cristiani (Costantino e guglielmo ii d’altavilla), due ebrei (Davide ed ezechia) e due pagani (traiano e Rifeo); questo a testimo-niare come, nell’universo teologico dantesco, le strade che possono condur-re gli uomini al “sommo ben” (Pd XiX 87) si diramino “lungo le più distanti latitudini”9. Si può, dunque, concludere con anna Maria Chiavacci leonar-di: “la scelta dei sei nomi non è, come niente nel poema, casuale. tre sono del tempo cristiano, e tre del precristiano; due sono pagani, due ebrei, due cristiani. Tutta la storia umana è così rappresentata, sia nei suoi tempi, sia nelle sue diverse fedi”10.
sconcertanti –: Virgilio come guida nel poema dell’aldilà cristiano, Catone salvato e custode del purgatorio cristiano”.
7 a. BattiStini, “Rifeo troiano” e la riscrittura dantesca della storia, “lettere italiane”, 42 (1990), 1, p. 30.
8 Ibi, p. 30. 9 L. CogLievina, Il canto XIX del ‘Paradiso’, “Medioevo e Rinascimento”, 13, n.s. X
(1999), p. 31.10 ChiavaCCi Leonardi, La salvezza degli infedeli: il canto XX del ‘Paradiso’, p. 197.
03_Segato_1_12.indd 51 04/12/12 09.06
Maria Segato52
la retorica che caratterizza il discorso dell’aquila trova, dunque, il suo culmine espositivo nell’introduzione del giovane troiano che diviene, quin-di, il focus tematico da cui traggono scaturigine gli interrogativi del viator. Nel ventesimo canto Rifeo esemplifica, infatti, quelle condizioni (estraneità alla fede cristiana e alla tradizione profetica ebraica) che determinano i dub-bi del viator espressi nei versi centrali del canto precedente (versi preceduti e seguiti da 23 terzine):
Ché tu dicevi: “Un uom nasce a la rivadell’indo, e quivi non è chi ragionidi Cristo né chi legga né chi scriva;
e tutti suoi voleri e atti bonisono, quanto ragione umana vede,sanza peccato in vita od in sermoni.
Muore non battezzato e sanza fede:ov’è questa giustizia che ‘l condanna?ov’è la colpa sua, s’ei non crede?” (Pd XiX 70-78).
la già ampiamente rilevata unità simmetrica dei due canti (suggellata dall’i-dentico numero di versi totali)11, permette di sancire la sovranità definitiva dell’illimitato orizzonte della grazia, la cui comprensione trascende ogni facoltà umana per compiersi nel mistero della visione divina; come compro-vato dal suggestivo e netto trapasso dalla speculazione intellettiva umana, “quanto ragione umana vede” (verso centrale del diciannovesimo canto)12, allo scioglimento di ogni desidero conoscitivo nell’immagine contemplati-va dell’allodola che “tace contenta / de l’ultima dolcezza che la sazia” (vv. 74-75, centro del ventesimo canto).
l’ineffabile agire della Provvidenza, assunto con cui Dante risolve gli interrogativi partecipati al suo lettore, è argomento sempre ricorrente fra le più autorevoli pagine teologiche dell’epoca, che spesso chiosano le loro
11 Si vedano almeno e. Paratore, Il canto XX del ‘Paradiso’, in Tradizione e struttura in Dante, Firenze 1968, p. 283 e BattiStini, “Rifeo troiano” e la riscrittura dantesca della storia, p. 1.
12 zygmunt Baranski ha letto in questo verso il segno di una conoscenza ancora “razio-nalista, prodotto di una cultura scolastica”. a tal riprova, il critico ricorda i vv. 82-84 del medesimo canto in cui “l’aquila prosegue per stabilire che, in più, queste dottrine non erano basate sull’autorità scritturale, perché, se lo fossero state, avrebbero fornito a Dante-perso-naggio una risposta al suo quesito. […] Ciò che l’aquila rende evidente è che il pellegrino avrebbe potuto trovare una soluzione al dubbio in terra (vv 33, 27). il motivo per cui non lo fece fu perché egli preferì ascoltare le sirene della ragione, piuttosto che tentare di interpre-tare i segni divini del Verbum” (z. BaranSki, I segni della salvezza: ‘Paradiso’ XIX, in Dan-te e i segni. Saggi per una storia intellettuale di Dante Alighieri, Napoli 2000, pp. 193-194).
03_Segato_1_12.indd 52 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 53
disquisizioni con le parole dell’apostolo: “Quid ergo dicemus? Nunquid iniquitas apud Deum? absit. Moysi enim dicit: “Miserebor cuius misereor, et misericordiam praestabo cuius miserebor”. igitur non volentis neque cur-rentis, sed miserentis est Dei. Dicit enim Scriptura Pharaoni: “Quia in hoc ipsum excitavi te, ut ostendam in te virtutem meam, et ut adnuntietur nomen meum in universa terra”. ergo cuius vult miseretur, et quem vult indurat. Dicis itaque mihi: “Quid adhuc quaeritur? Voluntati enim eius quis resistit? O homo, tu quis es, qui respondeas Deum?””13 (Rm 9, 14-20).
1. Il limbo: luogo della dannazione per i grandi sapienti antichi
l’elezione in Paradiso di un personaggio scaturito dalla penna poetica di Virgilio richiama inevitabilmente alla mente la sorte eterna del cantore mantovano, relegato nel primo cerchio dell’inferno fra gli spiriti magni14 e destinato all’eterna privazione della visione divina fra le “genti dolorose / c’hanno perduto il ben de l’intelletto” (If iii 17-18). Nonostante varie voci critiche abbiano messo in dubbio la natura infernale del limbo, cogliendo nella condizione delle anime che vi sono radunate l’emblema di una pace estranea alla sofferenza che proviene dalla mancata visione di Dio, sono le parole stesse del poeta pagano a confermare la sua personale “tragedia”15, ossia la sua definitiva reclusione nel regno infernale. Quanto narrato dall’auctor nel quarto canto (“così si mise e così mi fé intrare / nel primo cerchio che l’abisso cigne” If iV 23-24) trova conferma nel discorso pro-nunciato dallo stesso Virgilio nel momento in cui narra a Stazio come lui fu “tratto fuor de l’ampia gola / d’inferno” (Pg XXi 31-32) per accompagnare
13 Trad. ufficiale della Cei: “Che diremo dunque? C’è forse ingiustizia da parte di Dio? No certamente! egli infatti dice a Mosè: “Userò misericordia con chi vorrò, e avrò pietà di chi vorrò averla”. Quindi non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell’uomo, ma da Dio che usa misericordia. Dice infatti la Scrittura al faraone: “ti ho fatto sorgere per manifestare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato in tutta la terra”. Dio quindi usa misericordia con chi vuole e indurisce chi vuole. Mi potrai però dire: “Ma allora perché ancora rimprovera? Chi può infatti resistere al suo volere?”. O uomo, tu chi sei per disputare con Dio?”. Per il riuso del passo paolino si veda, a titolo d’esempio, auguStinuS hiPPonen-SiS, De diversis quaestionibus ad Simplcianum libri duo, i, 2, 16.
14 È necessario ricordare, con Fiorenzo Forti, che nei grandi pagani, designati dalla tradi-zione esegetica col termine “magnanimi”, si indicano i “megalopsicoi” dell’Etica Nicoma-chea, ossia tutti quegli uomini che sono vissuti realizzando la loro natura morale attraverso la sequela delle virtù perseguibili secondo la misura umana. Si veda in merito F. Forti, Il limbo e i megalopsicoi della ‘Nicomachea’, in Magnanimitade, Bologna 1977, p. 464.
15 in merito alla tragica dannazione degli spiriti magni, si veda il commento alla Comme-dia di anna Maria Chiavacci leonardi (aLighieri, Commedia, i, p. 101).
03_Segato_1_12.indd 53 04/12/12 09.06
Maria Segato54
Dante lungo il suo viaggio ultraterreno. la natura infernale del limbo viene ribadita nel canto seguente, quando il poeta pagano descrive la condizio-ne di molti fra i grandi autori della classicità, come lui relegati nel “primo cinghio del carcere cieco” (Pg XXii 103). Il limbo si identifica, quindi, col primo cerchio dell’inferno, seppure “il più esterno e meno profondo”16.
il limbo non è dunque sottratto a quelle caratteristiche che contraddi-stinguono il regno dei dannati: dopo esser giunti alla “riva malvagia / ch’at-tende ciascun uom che Dio non teme” (If iii 107-108), i due pellegrini si trovano immersi nella valle infernale che si presenta ai loro occhi “oscura”, “profonda” e “nebulosa” (If iV 10). Fin dall’ingresso nella “valle d’abisso dolorosa” (If iV 8) si rintracciano, quindi, tutte le condizioni che, secondo la dottrina del tempo17, definiscono la fisionomia della dannazione eterna: assenza totale di ogni forma di luce, dolore eterno (anche se in questo caso ‘solo’ spirituale), privazione della visione di Dio. l’incessante pianto intri-so di lamenti, che “non suonan come guai ma son sospiri” (Pg Vii 29-30), accomuna “le turbe, ch’eran molte e grandi, / d’infanti e di femmine e di viri” (If i V 29-30): “Quivi, secondo che per ascoltare, / non avea pianto mai che di sospiri / che l’aura etterna facevan tremare” (If iV 25-27). Si può quindi asserire, con gian Carlo alessio, che “la collocazione nel limbo è una mitigazione della pena, non la sua cancellazione”18.
Fra gli spiriti riuniti nella prima cornice infernale, si distinguono, con onorevole singolarità19, gli autori e i filosofi che più di tutti hanno segnato la grandezza culturale delle grandi civiltà dei gentili, la cui somma virtù li “diparte” (If iV 75) dal resto dei dannati. la simmetria, mai casuale, della
16 F. Montanari, Limbo, in Enciclopedia Dantesca, 6 voll., iii, Roma 1970-1978, p. 651.
17 Per una sintesi delle speculazioni medievali circa la natura infernale del limbo, si vedano almeno M. Frezza, Il problema della salvezza dei pagani (da Abelardo al Seicento), Napoli 1962 e a. CarPin, Il limbo nella teologia medievale, Bologna 2006.
18 g. C. aLeSSio, In canto IV dell’‘Inferno’, in “Regnum celorum vïolenza pate”, p. 46. Scriveva nel 1950 Carlo grabher: “Non si potrebbe cogliere in modo più vivo un dolore segreto, profondo, un dolore che, se non deriva da martìri, da pene materiali, non per questo è meno acuto in spiriti, come li concepisce Dante, tutti nobilissimi, per i quali il vivere sanza speme in un eterno desiderio di Dio non può essere una lieve pena” (C. graBher, Il limbo e il nobile castello, “Studi Danteschi”, 29 (1950), p. 43).
19 la reiterazione di termini aventi come comune radice la voce onore sottolinea, per sette volte in tutto il canto con una evidente accumulazione dal v. 72 al v. 81, l’atmosfera che caratterizza l’incontro fra Dante e la bella scola, atmosfera permeata dall’honor riconosciu-to agli spiriti virtuosi radunati fra le mura del nobile castello. Cfr. B. CaSCioLa, Il castello e la valle, “il giornale Dantesco”, 35 (1932), 5, p. 145; a. oxiLia, Il canto del limbo, in Let-ture dell’‘Inferno’, a c. di V. Vettori, Milano 1963, p. 145; a. a. iannuCCi, Dante e la “bella scola” della poesia, in Dante e la “bella scola” della poesia. Autorità e sfida poetica, a c. di a. a. iannucci, Ravenna 1993, p. 20.
03_Segato_1_12.indd 54 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 55
costruzione poetica del quarto canto rivela la rilevanza degli spiriti magni; i versi che segnano la quasi esatta centralità del canto espongono, infatti, il privilegio loro concesso in conseguenza della loro condotta virtuosa:
O tu ch’onori scïenzïa e arte,questi chi son c’hanno cotanta onranza,che dal modo de li altri li diparte?”
e quelli a me: “l’onrata nominanzache di lor suona su ne la tua vita,grazïa acquista nel ciel che sì li avanza. (If iV 73-78)
La grazia donata agli spiriti magni, nella forma di un fioco lume fra le mura del nobile castello, sancisce la novità della creazione dantesca. Secondo la dottrina dell’età di Dante, come si esporrà in seguito, il mondo cultu-rale pagano non merita l’elezione al regno della salvezza perché estraneo alla fede nell’unico e vero Dio. la relegazione degli spiriti magni nel lim-bo trova quindi autorevole e unanime legittimazione fra le pagine delle più note auctoritates ma, nel contempo, si distingue per l’originalità con cui Dante innova, attraverso la sua figurazione poetica, il patrimonio teologico che lo raggiunge: nessuno aveva infatti ipotizzato un sito infernale atto ad accogliere la dannazione dei precristiani; la loro collocazione coi bambini morti senza battesimo non ha alcun antecedente nel panorama speculativo medioevale. È, dunque, frutto del genio poetico dell’autore aver giudicato i magnanimi meritevoli di una dannazione spirituale fino a quel momento riservata a quanti si erano macchiati del solo peccato d’origine. Si deve, tuttavia, ricordare, con lino Pertile che, nonostante l’evidente predilezione divina che distingue il sito del nobile castello, “il limbo rimane cosa severa […] è una regione che non presenta certo i mali della terra, ma della terra non ha nemmeno nessuno dei beni, se si eccettua, rispetto al resto dell’in-ferno, quella luce misteriosa che emana dal di sotto ad illuminare le turbe degli spiriti magni”20. Si deve quindi concludere, con giorgio Padoan, che “l’esaltazione dei valori umani in questo episodio non è priva di un giudizio religioso: non per niente siamo nel primo cerchio dell’inferno ed una colpa vi viene espiata, anche se non con tormenti fisici”21.
Sarà Virgilio stesso a ribadire, nel corso dell’opera, la causa della danna-zione dei limbicoli: gli spiriti che vissero “dinanzi al cristianesmo / non ado-rar debitamente a Dio”: (If iV 37-38) essi prestarono, infatti, il loro culto alle
20 L. PertiLe, Il nobile castello, il Paradiso Terrestre e l’Umanesimo dantesco, “Filolo-gia e critica”, 5 (1980), 1, p. 7.
21 g. Padoan, Il pio Enea, l’empio Ulisse, Ravenna 1977, p. 122.
03_Segato_1_12.indd 55 04/12/12 09.06
Maria Segato56
divinità pagane mantenendosi estranei all’unico e vero Dio22. il poeta paga-no approfondirà poi le ragioni della loro colpa declinandole nella mancata sequela delle tre virtù teologali: “Quivi sto io con quei che le tre sante / virtù non si vestiro, e sanza vizio / conobber l’altre e seguir tutte quante” (Pg Vii 34-36). Fede, speranza e carità torneranno poi nel XX canto del Paradiso ad indicare l’habitus di Rifeo, morto cristiano23, battezzato grazie alle stesse tre virtù, donategli in conseguenza della sua conversione alla futura reden-zione. Si deve notare che i versi dedicati alla narrazione della salvazione di Rifeo compendiano tutti quei meriti non perseguiti dagli spiriti radunati nel limbo (mio il corsivo):
L’altra [l’anima di Rifeo], per grazia che da sì profondafontana stilla, che mai creaturanon pinse l’occhio infino a la prima onda,
tutto suo amor là giù pose a drittura:per che, di grazia in grazia, Dio li apersel’occhio a la nostra redenzion futura;
ond’ ei credette in quella, e non sofferseda indi il puzzo più del paganesmo;e riprendiene le genti perverse.
Quelle tre donne li fur per battesmoche tu vedesti da la destra rota,dinanzi al battezzar più d’un millesmo. (Pd XX 118-129)
la salvezza di alcuni precristiani, resi partecipi della fede nel futuro Mes-sia, è stata una predestinata eccezione o si configurava come una possibilità offerta a tutte le genti?
2. Quale salvezza per i Gentili secondo la Teologia Scolastica
Per rispondere a tale interrogativo, è necessario prendere le mosse dalle parole dell’aquila, che stabiliscono il valore dirimente della fede nel Dio cristiano, redentore nella persona del Figlio: “A questo regno / non salì mai chi non credette ‘n Cristo, / né pria né poi ch’el si chiavasse al legno” (Pd XiX 103-105). Nel canto seguente, ad asseverare la già citata simmetria, gli stessi versi declinano la possibilità della conversione alla fede cristiana
22 Si veda anche Pg Vii 7-8: “io son Virgilio; e per null’altro rio / lo ciel perdei che per non aver fé”.
23 Cfr. Pd XX 103-105: “De’ corpi suoi non uscir, come credi, / gentili, ma cristiani, in ferma fede / quel de’ passuri e quel de’ passi piedi”.
03_Segato_1_12.indd 56 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 57
nelle persone dell’imperatore traiano e del giovane troiano: “De’ corpi suoi non uscir, come credi, / gentili, ma cristiani, in ferma fede / quel de’ passuri e quel de’ passi piedi” (Pd XX 103-105).
le quattro terzine che suggellano la vicenda personale di Rifeo esem-plificano quanto la cultura teologica medievale aveva meditato e concluso circa le possibilità di salvezza per i precristiani. la radicalità con cui Dante giudica i limbicoli, colpevoli per non aver adorato Dio nel modo dovuto, trova ampio e autorevole consenso in quanto la dottrina medioevale aveva affermato, con notevole e limpida continuità, da agostino a tommaso.
la necessità assoluta della fede in Cristo venuto o venturo era una tesi radicata e confermata dai massimi dottori della cultura medievale, come agostino, Ugo di san Vittore, Bernardo, Pietro lombardo e tommaso, fede-li interpreti del versetto evangelico che sancisce il valore essenziale del bat-tesimo: “Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu non potest introire in regnum Dei” (Io. 3, 5).
le scelte dantesche trovano conforto in alcune fra le più autorevoli voci del panorama speculativo medioevale, voci che sovente partono dall’auc-toritas paolina: “Sine fide autem impossibile est placere deo. Credere enim oportet accedentem ad Deum quia est, et inquirentibus se remunerator sit” (Ad Hebr. 11, 6). tale versetto trova spazio fra le pagine di agostino24, Ber-nardo25 e tommaso26, tutti concordi nell’asserire che non vi è alcuna possi-bilità di salvezza senza la fede nel Redentore. Si veda, a titolo d’esempio, quanto scritto da Pietro lombardo (che a sua volta riprende agostino):
Praedictis adjiciendum est de sufficientia fidei ad salutem. Illis enim qui praeces-serunt adventum Christi, et qui sequuntur, videtur profecisse fides secundum tem-poris processum, sicut profecit cognitio. Fides quippe magna dicitur, cognitione, et articulorum quantitate, vel constantia, et devotione. Est autem quaedam fidei mensura, sine qua nunquam potuit esse salus. Unde apostolus, Hebr. 11: Oportet accedentem ad Deum credere quia est, et quod remunerator est sperantium in se.
24 Cfr. auguStinuS hiPPonenSiS, Contra Julianum, iV, 3, 25, a c. di N. Cipriani et alii, in Opere di Sant’Agostino, 45 voll., a c. della Cattedra agostiniana presso l’Augustinianum di Roma sotto la direzione di P. agostino trapé, XViii/i, Roma 1968-2005, p. 692.
25 Cfr. BernarduS CLarevaLLenSiS, De Baptismo, ii, 8 (Pl 182, 1035). il confronto è stato suggerito da g. ingLeSe, Il destino dei non credenti. Lettura di ‘Paradiso’ XIX, “la Cultura”, 42 (2004), 2, p. 322.
26 Cfr. thoMaS aquinaS, De Veritate, in id., Opera Omnia, 48 voll., iussu impensaque leonis Xii P. M., cura et studio Fratrum eiusdem ordinis, XXii, Roma 1887-1906, p. 470. Nella Summa Theologiae l’aquinate conferma la necessità, in tutti i tempi della storia, della fede nell’incarnazione: “Mysterium incarnationis Christi aliqualiter oportuit omni tempore esse creditum apud omnes: diversimode tamen secundum diversitatem temporum et perso-narum” (id., Summa Theologiae, ii-ii, q. 2, a. 7 in id., Opera Omnia, Viii, p. 34).
03_Segato_1_12.indd 57 04/12/12 09.06
Maria Segato58
Sed quaeritur utrum hoc credere ante adventum et ante legem, ad salutem suf-fecerit. Nam tempore gratiae constat certissime hoc non sufficere; oportet enim universa credi quae in symbolis continentur. Sed nec ante adventum, nec ante legem videtur hoc suffecisse, quia sine fide Mediatoris nullum hominem, vel ante, vel post, fuisse salvum sanctorum auctoritates contestantur. Unde august., tom. 2, epist. 157, ad Optatum: Illa fides sana est, qua credimus nullum hominem, sive majoris sive minoris aetatis, liberari a contagione mortis et obligatione peccati, quod prima nativitate contraxit, nisi per unum mediatorem Dei et hominem Jesum Christum, 1 ad Tim. 2: cujus hominis ejusdemque Dei saluberrima fide etiam illi justi salvi facti sunt, qui priusquam veniret in carne, crediderunt in carnem ventu-rum. Eadem enim fides est illorum et nostra. Proinde cum omnes iusti, sive ante incarnationem, sive post, nec vixerint nec vivant nisi ex fide incarnationis Christi; profecto quod scriptum est (Act. 4, 12), Non esse aliud nomen sub caelo in quo oporteat salvari nos: ex illo tempore valet ad salvandum genus humanum ex quo in adam vitiatum est27.
Se l’antecedenza storica alla venuta del Redentore non costituiva, per la dot-trina del tempo, un impedimento all’esperienza della fede verso l’unico e vero Dio, anche il battesimo, amministrato per grazia “dinanzi al battezzar più d’un millesmo” (Pd XX 129), non si presentava come una eventuali-tà impossibile. a tal riguardo, si deve ricordare che san Bernardo, nel suo
27 Petrus lombardus, Sententiarum libri quatuor, iii, d. XXV, 1, in thoMaS aquinaS, Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo e testo integrale di Pietro Lombardo, 10 voll., a c. di R. Coggi, Vi, Bologna 2001-2002, p. 162. trad. di l. Perotto: “a quanto si è detto sopra si deve aggiungere come la fede bastasse per la salvezza. infatti in coloro che prece-dettero la venuta di Cristo e in quelli che vengono dopo di lui, pare che la fede sia progredita con il passare del tempi, come progredì la conoscenza. Inoltre, si dice che la fede è grande per la conoscenza e la quantità degli articoli, oppure per la costanza e la devozione. C’è però una misura della fede senza la quale non ci potè mai essere la salvezza. Per cui l’apo-stolo: “Chi si accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano”. Ma ci si chiede se credere a questo sia stato sufficiente per la salvezza, prima della venuta o prima della legge. infatti al tempo della grazia è assolutamente certo che questo non basta; infatti bisogna credere tutte le cose contenute nel simbolo. Ma ciò non pare che sia stato sufficiente neppure prima della venuta, né prima della Legge, perché le autorità dei santi testimoniano che senza la fede nel Mediatore nessun uomo fu salvo prima o dopo. Per cui S. agostino: “È sana quella fede con la quale crediamo che nessun uomo, sia maggiorenne che bambino, viene liberato dal contagio della morte e dal vincolo del peccato che contrasse fin dalla nascita se non tramite il solo Mediatore fra Dio e gli uomini Gesù Cristo”. Con la fede estremamente salutare di quell’uomo e dello stesso Dio sono stati fatti salvi anche quei giusti i quali hanno creduto che egli sarebbe venuto nella carne anche prima che venisse nella carne. infatti la loro e la nostra è la stessa. Perciò, dato che tutti i giusti, sia prima dell’incarnazione, sia dopo, né vissero né vivono se non per la fede nell’incarnazione, indubbiamente ciò che sta scritto, cioè che non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati, vale per il genere umano dal tempo in cui adamo è stato corrotto” (Ibi, p. 163).
03_Segato_1_12.indd 58 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 59
De Baptismo, afferma che la sola conversione del cuore a Dio può meritare all’uomo l’elezione al regno dei beati: “Non tantum passionem pro nomi-ne Christi id quod ex Baptismate deerat posse supplere; sed etiam fidem conversionemque cordis, si forte ad celebrandum mysterium Baptismi in angustiis temporum succurri non potest”28. Secondo il teologo, il possesso delle tre virtù teologali, “fides recta, spes pia, charitas sincera”29, può costi-tuire una via extrasacramentale di salvezza, certezza avallata dal Magistero ecclesiastico nel Concilio di lione del 127430.
Quanto fino ad ora esposto trova una solida conferma fra le pagine degli antichi commentatori, i cui contributi, nonostante lievi differenti sfumature, presentano un giudizio quasi univoco: molti, infatti, attribuiscono ai limbi-coli, con maggiore o minore larghezza di argomenti, un responsabile difetto di fede, ragione sufficiente per condannarli ai supplizi infernali31. Si vedano, a titolo d’esempio, le seguenti righe di Francesco da Buti:
E per null’altro rio; cioè per nessuno altro peccato, Lo Ciel perdei; cioè la beatitu-dine del cielo perdetti, che per non aver fè; cioè per lo peccato de la infideltà: impe-rò che adorò li dii dei gentili. e qui occorre uno dubbio; cioè come potea Virgilio essere fedele: chè al tempo suo non era anco seminata la fede nel mondo: imperò che Cristo non predicava ancora? a che si dè rispondere che dovea credere in Cristo venturo, che era stato revelato per li Profeti; e chiunque si salvò innanzi l’avveni-mento di Cristo, si salvò perchè credette in Cristo venturo; ma niente di meno stette nel limbo, infine a tanto che Cristo resuscitò32.
28 Bernardus Claravallensis, De Baptismo, ii, 7 (Pl 182, 1035-1036). traduzione mia: “Ciò che manca per il battesimo può essere colmato non soltanto con lo struggimento per il nome di Cristo, ma anche con la fede e la conversione del cuore, se per la difficoltà dei tempi non si possa procedere con l’amministrazione del sacramento”.
29 Ibidem.30 Cfr. Concilium Oecumenicum lugdunense ii, Michaëlis imperatoris Epistula ad Gre-
gorium papam – Professio fidei (De sorte defunctorum). in merito si veda CarPin, Il limbo nella teologia medievale, p. 169.
31 l’Ottimo commentatore introduce per primo un argomento che tornerà frequentemen-te fra le pagine degli esegeti antichi e moderni. Secondo il commentatore, il limbo si pre-senta come la dovuta conseguenza di una fede volta agli “déi falsi e bugiardi” (Inf. i 72), e la colpa che relega i magnanimi nel limbo si identificherebbe nel non aver prestato fede alla futura venuta del Redentore. la maggior parte dei commentatori si concentra sul tanto dibattuto v. 38 - “non adorar debitamente a Dio” - riconoscendo nel colpevole difetto di fede confessato da Virgilio il non aver creduto in Cristo venturo. tale ‘accusa’ ricorre anche fra le pagine di Pietro alighieri, giovanni di Serravalle, Cristoforo landino, Vellutello, giovan Battista gelli. Cfr. L’Ottimo commento della ‘Divina Commedia’, a c. degli accademici della Crusca, Pisa 1827, p. 37.
32 Commento di Francesco da Buti sopra ‘La Divina Commedia’ di Dante Allighieri, 3 voll., a c. di C. giannini, Pisa 1858-1862, i, p. 252.
03_Segato_1_12.indd 59 04/12/12 09.06
Maria Segato60
I diversi commentatori specificano ulteriormente le ragioni della condanna, declinandole principalmente nella mancata ricezione del Battesimo e nel cul-to delle divinità pagane, elemento non estraneo al sapere teologico del tempo. Alcuni fra gli esegeti considerati (nello specifico Guido da Pisa, Guiniforto delli Bargigi e Francesco da Buti) identificano la colpa dei limbicoli nel man-cato culto della Trinità; colpa che potrebbe apparire inadeguata per giustifi-care la dannazione di precristiani ignari della tradizione profetica ebraica. a tal riguardo, è cosa utile tornare all’opera dell’aquinate. tommaso ha, infatti, specificato la natura della fede declinandola nel culto della Trinità; possibili-tà, secondo il teologo, profferta non soltanto al popolo eletto: molti avrebbero potuto credere “implicite” nel Dio Uno e trino, verità compresa nel mistero dell’incarnazione di Cristo: “Mysterium Christi explicite credi non potest sine fide Trinitatis: quia in mysterio Christi hoc continetur quod Filius Dei carnem assumpserit, quod per gratiam Spiritus Sancti mundum renovaverit, et iterum quod de Spiritu Sancto conceptus fuerit. et ideo modo quo mysterium Christi ante Christum fuit quidem explicite creditum a maioribus, implicite autem et quasi obumbrate a minoribus, ita etiam et mysterium trinitatis”.33
Non sorprende, dunque, rinvenire nel secolare commento tali ipotesi, forse segno di una diffusa ricezione di quanto divulgato dalle più autorevoli voci teologiche.
anna Maria Chiavacci leonardi, e con lei molti altri, hanno ricordato l’importanza della dottrina della “rivelazione implicita”, diffusa non soltan-to fra le opere dei maggiori (in primis tommaso34) ma “anche a livello del-la predicazione, dove la troviamo esposta con parole ben simili a quelle di Dante nell’opera del domenicano giordano da Pisa: “Or se tu mi di’: ecco uno, che sia nato tra’ saracini, non udì mai predicare né ricordare Cristo; astiensi da’ peccati e da’ vizi per amor di Dio […]: che sarà di costui? […]. Dicoti che si salverà, ma non senza Cristo””35.
Merita ora approfondire quanto sarà poi confermato da Dante nel venti-novesimo canto del Paradiso: “e non voglio che dubbi, ma sia certo, / che
33 thomas aquinas, Summa Theologiae, ii-ii, q. 2, a. 8, in id., Opera Omnia, Viii, p. 35: “Non è possibile credere esplicitamente il mistero di Cristo, senza la fede nella trinità: poiché il mistero di Cristo implica l’assunzione della carne da parte del Figlio di Dio, la rin-novazione del mondo mediante la grazia, e la concezione del Cristo per opera dello Spirito Santo. Perciò prima di Cristo il mistero della trinità fu creduto come il mistero dell’incarna-zione, e cioè esplicitamente dai maggiorenti, e in maniera implicita e quasi velata dalle per-sone semplici” (trad. di t. S. Centi in id., La Somma Teologica, 33 voll., a c. dei Domenicani italiani, XiV, Firenze 1963-1984, p. 100).
34 a tal riguardo, si veda almeno l’imprescindibile volume di k. FoSter, The two Dantes and other studies, london 1977.
35 ChiavaCCi Leonardi, La salvezza degli infedeli: il canto XX del ‘Paradiso’, p. 203.
03_Segato_1_12.indd 60 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 61
ricever la grazia è meritorio / secondo che l’affetto l’è aperto” (vv. 64-66). Secondo la dottrina tomista, l’agire della grazia, volto ad illuminare la creatura umana per condurla alla rivelata conoscenza del Mediatore, non dipende soltanto dall’impenetrabile predestinazione divina, ma richiede una libera disponibilità dell’uomo atta ad accogliere i doni elargiti per mezzo della grazia stessa.
lo studio della relazione tra la grazia e il libero arbitrio dell’uomo è argo-mento ricorrente fra le pagine della Somma Teologica, opera in cui tomma-so sviluppa in suo pensiero confermando quanto era già stato argomentato da agostino36. il dottore angelico stabilisce innanzitutto che l’uomo, con le sue sole facoltà naturali, non può compiere opere meritorie proporzionate alla vita eterna; motivo per cui si pone come necessario l’intervento della grazia volto ad orientare primieramente l’uomo verso il bene. l’azione delle grazia si configura, dunque, come il primo motore atto a dispiegare all’uo-mo la via verso Dio: “et ideo homo per sua naturalia non potest produce-re opera meritoria proportionata vitae aeternae, sed ad hoc exigitur altior virtus, quae est virtus gratiae. et ideo sine gratia homo non potest mereri vitam aeternam. Potest tamen facere opera perducentia ad aliquod bonum homini connaturale, sicut laborare in agro, bibere, manducare, et habere amicum, et alia huiusmodi; ut augustinus dicit, in tertia responsione contra Pelagianos”37.
Se, dunque, “nullum meritum potest esse nisi ex gratia”38, è, tutta-via, compito dell’uomo “praeparare animum, quia hoc facit per liberum arbitrium”39. Si deve quindi concludere, seguendo Francesco Mazzoni40, che l’azione della grazia illuminante può manifestarsi nell’uomo soltanto se questi è disponibile a lasciarsi illuminare dal divino. Spetta, quindi, all’uo-mo mantenere lo sguardo aperto verso la luce del sole in attesa dell’illumi-nazione; in questa disponibilità si riconoscono il valore e il merito propri del libero arbitrio:
36 Cfr. augustinus hipponensis, De gratia et libero arbitrio liber unus, 14, 15, 20, 21 e 29, a c. di a. trapè, in Opere di Sant’Agostino, XX, pp. 58-89.
37 thomas aquinas, Summa Theologiae, i-ii, q. 109, a. 5, Vii, p. 297. trad. di t. S. Centi: “ecco perché l’uomo con le sue facoltà naturali non può compiere opere meritorie proporzionate alla vita eterna, ma si esige per questo una virtù superiore, qual è quella della grazia. Perciò l’uomo non può meritare la vita eterna senza la grazia. tuttavia può compiere così del bene di ordine naturale, e cioè, come nota S. Agostino rispondendo ai Pelagiani, lavorare i campi, bere, mangiare, e contrarre amicizie” (id., La Somma Teolo-gica, iX, p. 116).
38 Ibi, i-ii, q. 112, a. 2, resp., Vii, pp. 435-436.39 Ibi, i-ii, q. 109, a. 6, Vii, p. 300.40 F. Mazzoni, Saggio di un nuovo commento alla ‘Divina Commedia’. ‘Inferno’. Canti
I-III, Firenze 1967, p. 86.
03_Segato_1_12.indd 61 04/12/12 09.06
Maria Segato62
et ideo quod homo convertatur a Deo, hoc non potest esse nisi Deo ipsum con-vertente. hoc autem est praeparare se ad gratiam, quasi ad Deum converti: sicut ille qui habet oculum aversum a lumine solis, per hoc se praeparat ad recipiendum lumen solis, quod oculos suos convertit versus solem. Unde patet quod homo non potest se praeparare ad lumen gratiae suscipiendum, nisi per auxilium gratuitum Dei interius moventis. […] hominis est praeparare animum, quia hoc facit per libe-rum arbitrium: sed tamen hoc non facit sine auxilio Dei moventis et ad se attrahen-tis, ut dictum est41.
la salvezza non può dunque realizzarsi se l’uomo, mosso e sostenuto dalla grazia, non vi assente; la grazia stessa non sostituisce, infatti, l’esercizio della volontà umana nello stesso istante in cui si dispiega l’intervento gratu-ito di Dio42. Si può, dunque, osservare che l’aggettivo “meritorio” (Pd XXiX 65) aveva un suo probabile anticipatore nello stesso Tommaso, che definisce “meritoria” la “praeparatio hominis ad gratiam habendam”43.
Non si può certo concludere che l’intervento della grazia abbia come suo fondamento soltanto il merito umano (tommaso dedica diverse pagine a combattere il rischio di una così grave riduzione44), ma non si può pensare che l’agire di Dio non si dispieghi in conseguenza della risposta con cui l’uomo si volge al divino. il dottore angelico può, quindi, affermare che “defectus gratiae prima causa est ex nobis, sed collationis gratiae prima cau-sa est a Deo”45.
Nessuna possibilità di salvezza senza l’esercizio del libero arbitro: que-sta è la lezione che la cultura teologica e filosofica dell’età di Dante poteva guadagnare dalla sintesi tomista, questo è il principio che governa l’ordine dell’oltremondo dantesco (secondo quanto decretato dallo stesso poeta nel sedicesimo canto del Purgatorio).
la speculazione tomistica abbraccia anche il caso di uomini nati e vis-suti “nelle selve o tra gli animali”46, che non hanno, quindi, potuto udire
41 thomas aquinas, Summa Theologiae, i-ii, q. 109, a. 6, Vii, p. 300. trad. di t. S. Cen-ti: “Quindi il volgersi dell’uomo a Dio non può avvenire, senza che Dio lo rivolga verso di sé. Ora, prepararsi alla grazia significa appunto volgersi a Dio: come per chi non guarda il sole, prepararsi a riceverne la luce significa rivolgere gli occhi verso di esso. Perciò è evidente che l’uomo non può prepararsi a ricevere la luce della grazia, che mediante l’aiuto gratuito di Dio il quale lo muove interiormente. […] Spetta all’uomo preparare l’animo, poiché questo dipende dal suo libero arbitrio: ma codesta preparazione egli non può com-pierla senza l’aiuto di Dio che muove e trae, secondo le spiegazioni date” (id., La Somma Teologica, iX, p. 120).
42 id. , De Veritate, q. 28, a. 3, in id., Opera Omnia, XXii, pp. 826-827.43 Ibi, i-ii, q. 112, a. 2, resp. Vii, p. 324.44 Ibidem.45 Ibi, a. 3, Vii, p. 325. 46 id., De Veritate, a. 14, q. 11, XXii, pp. 470-471.
03_Segato_1_12.indd 62 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 63
voci recanti l’annuncio del Messia. Secondo il teologo, se un uomo perse-gue il “ductum” della sua ratio naturalis teso alla sequela del bene, Dio gli rivelerà le verità necessarie alla salvezza: “Si enim aliquis taliter nutritus ductum rationis naturalis sequeretur in appetitu boni et fuga mali, certissime est tenendum quod Deus ei vel per internam inspirationem revelaret ea quae sunt necessaria ad credendum vel aliquem fidei predicatorem ad eum dirige-ret, sicut misit Petrum ad Cornelium”47. la dottrina tomista rivela, dunque, che nessun uomo può dirsi escluso dalla via della salvezza.
È merito della speculazione agostiniana aver reso manifesta la necessità di guardare al tema della salvezza dei precristiani secondo una complessità di argomenti distinti e confluenti. Agostino volge ripetutamente la sua attenzione al difetto di fede dei pagani secondo una prospettiva nel contempo storica e teologica: il santo si concentra, infatti, sulle speculazioni inerenti l’intervento divino nella storia precristiana; contemporaneamente, in diversi luoghi della sua opera, rivela il suo interesse per i contatti storici e culturali che avrebbero potuto favorire un reale sincretismo fra il popolo eletto e le maggiori civiltà dei gentili. È, dunque, evidente che una comprensione del problema non può esi-mersi dal tentativo di perseguire l’unità di possibilità storiche e argomenti teo-logici tracciata da agostino e variamente perseguita nel corso del Medioevo.
il legame fra l’opera dantesca e il pensiero agostiniano è stato propo-sto da edoardo Fumagalli, che ha offerto un suggerimento che ci conduce al diciottesimo libro del De Civitate Dei. lo studioso ricorda che agostino aveva già affrontato tutti quegli interrogativi che Dante risolve nel discorso dell’aquila; il vescovo d’ippona si era, infatti, domandato se “all’infuori del popolo ebraico, ci fosse stata, prima dell’incarnazione del Verbo, la possibi-lità della salvezza. Agostino aveva risposto di sì, valendosi dell’esempio di giobbe (De Civitate Dei XViii 4748)”49. Prosegue Fumagalli:
47 Ibidem. trad. di R. Coggi: “Se infatti uno nutrito in quel modo seguisse il comando della ragione naturale nella ricerca del bene e nella fuga dal male, bisogna certissimamente ritenere che Dio gli rivelerebbe con una ispirazione interna le verità che si devono necessa-riamente credere, o gli manderebbe un predicatore della fede, come mandò Pietro a Corne-lio” (id., Le questioni disputate, 11 voll., a c. di R. Coggi, ii, Firenze 1992-2003, p. 541).
48 augustinus hipponensis, De Civitate Dei, XViii, 47, V/ii, p. 744: “an ante tempora Christiana aliqui fuerint extra israeliticum genus, qui ad caelestis civitatis consortium perti-nerent. Quapropter quisquis alienigena, id est non ex israel progenitus nec ab illo populo in canonem sacrarum litterarum receptus, legitur aliquid prophetasse de Christo, si in nostram notitiam venit aut venerit, ad cumulum a nobis commemorari potest; non quo necessarius sit, etiamsi desit, sed quia non incongrue creditur fuisse”.
49 e. FuMagaLLi, Il giusto Enea e il pio Rifeo. Appunti su Dante e Virgilio, Busto arsi-zio-Friburgo-Roma 2006 [opuscolo non venale per occasione privata], pp. 36-37. in riferi-mento alla figura di Giobbe si veda anche il contributo pubblicato pochi anni prima da Bor-tolo Martinelli, La fede in Cristo, “Rivista di letteratura italiana”, 20 (2002), 2, pp. 11-39.
03_Segato_1_12.indd 63 04/12/12 09.06
Maria Segato64
giobbe non apparteneva al popolo eletto, perché non era ebreo ma idumeo; e tut-tavia l’insieme della sua avventura umana, e l’essere la sua vicenda narrata con lode in un libro canonico della Bibbia, avevano permesso ad agostino di afferma-re con sicurezza ch’egli è tra i beati. Dunque il vescovo di ippona aveva utilizzato come fonte e come garanzia di verità la Sacra Scrittura; di fronte a tanto prece-dente, Dante si comporta in modo a prima vista sconcertante: non sceglie giobbe o un altro personaggio biblico, ma affida il compito di testimoniare che anche per i pagani è esistita la possibilità della gloria eterna a una minuscola comparsa del poema di Virgilio50.
Si rintraccia un’ulteriore conferma di quanto appena esposto nella Lettera CII di agostino, dove il santo si pronuncia in merito alla predestinazione delle genti pagane non appartenenti al popolo eletto. il teologo replica a quanti individuavano nell’assenza della grazia la radice del paganesimo pra-ticato dai gentili ed assevera con fermezza che a nessun uomo, in nessun tempo e in nessun luogo, è stata preclusa la possibilità di credere nell’unico e vero Dio:
et tamen ab initio generis humani, alias occultius, alias evidentius, sicut congruere temporibus divinitus visum est, nec prophetari destitit, nec qui in eum crederent defuerunt, ab adam usque ad Moysen, et in ipso populo israel, quae speciali quo-dam mysterio gens prophetica fuit, et in aliis gentibus antequam venisset in carne. Cum enim nonnulli commemorantur in sanctis hebraicis libris iam ex tempore abrahae, nec de stirpe carnis eius, nec ex populo israel, nec ex adventitia societate in populo israel, qui tamen huius sacramenti participes fuerunt; cur non credamus etiam in caeteris hac atque illac gentibus, alias alios fuisse, quamvis eos comme-moratos in eisdem auctoritatibus non legamus? ita salus religionis huius, per quam solam veram salus vera veraciterque promittitur, nulli umquam defuit qui dignus fuit, et cui defuit, dignus non fuit. et ab exordio propagationis humanae, usque in finem, quibusdam ad praemium, quibusdam ad iudicium praedicatur. Ac per hoc et quibus omnino annuntiata non est, non credituri praesciebantur; et quibus non credituris tamen annuntiata est, in illorum exemplum demonstrantur: quibus autem credituris annuntiantur, hi regno coelorum et sanctorum angelorum socie-tati praeparantur51.
50 Ibi, p. 38. giorgio Padoan ha richiamato all’attenzione un passo di greogorio Magno che conferma quanto affermato: “Beati Job vita attestante cognoscimus ut expectasse Redemptoris adventum multos etiam ex gentibus credamus” (g. Padoan, Il pio Enea, l’em-pio Ulisse: tradizione classica e intendimento medievale, Ravenna 1977, p. 109).
51 augustinus hipponensis, Epistula CII, 15, a c. di l. Carozzi, in Opere di Sant’Ago-stino, XXi/i, p. 966. Trad. di L. Carozzi: “Ciononostante, fin dall’inizio del genere uma-no, ora in un modo più occulto, ora in un modo più evidente, a seconda che la divina Provvidenza ritenne opportuno alle varie epoche, da adamo a Mosè non mancarono né le profezie né quelli che credettero in Cristo: non solo tra lo stesso popolo d’israele (nel
03_Segato_1_12.indd 64 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 65
l’opinione agostiniana è stata ripresa da Ugo di san Vittore che, nel De Sacramentis Christianae Fidei, ribadisce che la notizia della futura salvezza del mondo è giunta in ogni terra (”in ignotis regionibus, et remotis terrarum sedibus”52), tesi corroborata dal riferimento scritturistico “in omnem ter-ram exivit sonus eorum; et in fines orbis terrae verba eorum” (Psal. XViii), come osservato da giorgio inglese53. anche Ugo, quindi, esamina il caso dei precristiani dannati confermando che tutti i giusti dell’antichità furono giustificati per la loro fede e divennero custodi della notizia della futura ren-denzione: “redemptionem quasi in umbra et figura portaverunt”54.
Un preciso esempio storico, volto a confermare la linea di pensiero dif-fusasi nel Medioevo, è rinvenibile fra le pagine dell’Introductio ad Theo-logiam di abelardo55. il teologo rivolge, infatti, la sua attenzione al popolo degli indiani reputandolo meritevole “di comprensione speciale da parte del cristianesimo” per la sua “eccezionale fedeltà”56.
quale, per una speciale disposizione del piano salvifico di Dio, ci fu una stirpe di Profe-ti), ma pure tra altri popoli ancor prima dell’incarnazione. Nei libri sacri degli ebrei si ricordano effettivamente, fin dal tempo di Abramo, alcuni personaggi che furono messi a parte di questo mistero sebbene non appartenessero né alla stirpe di abramo, né al popolo d’israele, né a qualche altro gruppo etnico venuto ad inserirsi in esso; perché dunque non dovremmo credere che qua e là fra gli altri popoli ce ne fossero, in epoche diverse, pure degli altri, anche se non li troviamo ricordati nei libri della Sacra Scrittura? la salvezza quindi procurata dalla nostra religione, l’unica vera che promette in modo veridico l’au-tentica salvezza, non mancò mai a chi ne fosse degno; se perciò mancò a qualcuno, questi non era degno di riceverla. Essa viene predicata dall’inizio alla fine del genere umano, ad alcuni per la loro salvezza, ad altri per la loro condanna. Ecco perché Dio, fin dall’eternità ha previsto che non avrebbero creduto coloro ai quali la predicazione del Vangelo non arrivò affatto. Coloro invece ai quali fu annunciato, sebbene Dio avesse previsto la loro incredulità, devono servirci da lezione e farci riflettere. Coloro infine a cui è annunciato e che sono disposti a credere, vengono predisposti ad entrare nel regno dei cieli e ad esser compagni degli angeli santi” (Ibi, p. 967). Cfr. S. harent, Infidèles, in Dictionnaire de théologie catholique, 15 voll., commencé sous la dir. de a. Vacant, continué sous celle de e. Mangenot, Vii, Paris 1967, p. 1848-1856.
52 hugo De S. Victore, De Sacramentis Christianae fidei, ii, 5 (Pl 176, 451).53 g. ingLeSe, Il destino dei non credenti. Lettura di ‘Paradiso XIX, p. 324.54 hugo de S. viCtore, De Sacramentis Christianae fidei, i, 10, 8 (Pl 176, 340). Ugo
ha citato esplicitamente l’auctoritas agostiniana: “Verum etiam quia aliquotens Scripturae testantur, nullum ab initio sine fide Christi esse salvatum; et beatus Augustinus de hoc ipso loquens sic ait: Eadem fides mediatoris salvos justos faciebat antiquos pusillos cum magnis: non Vetus testamentum quod in servitutem generat; non lex quae non sic est data ut possit vivificare, sed gratia Dei per Jesum Christum. Quia sicut nos credimus Christum in carne venisse, sic illi venturum; sicut nos mortuum, ita illi moriturum; sicut nos resurrexisse, ita illi resurrecturum; et nos et illi venturum ad judicium vivorum et mortuorum” (Ibi, i, 10, 6).
55 Petrus abaelardus, Introductio ad Theologiam, iii, 23 (Pl 178, 1032-1033).56 t. hahn, I “gentili” e “un uom nasce a la riva / de l’Indo” (’Par.’ XIX, vv. 70 sgg.),
“l’alighieri”, 18 (1977), 2, pp. 6-7.
03_Segato_1_12.indd 65 04/12/12 09.06
Maria Segato66
alla luce di quanto rilevato, si può, dunque, concludere che la scelta dan-tesca di ascrivere al novero dei beati le anime di Catone e Rifeo si inserisce all’interno di un orizzonte di pensiero che prevede la possibilità che un precri-stiano sia giudicato degno di essere elevato alla partecipazione della visione divina. Risulta, quindi, evidente come l’inventio dantesca si nutra delle verità contemplate attraverso le speculazioni dei più influenti teologi del tempo.
Sembra non siano ancora stati messi in rilievo quei passi del De Civi-tate Dei in cui agostino si concentra sui grandi sapienti appartenenti alle civiltà dei gentili. il teologo orienta il suo pensiero in aderenza al dettame paolino, e riconosce, dunque, nel sapere tramandato dai filosofi una espli-cita manifestazione della grazia divina. Nella prima lettera ai Romani, l’a-postolo scrive che agli antichi saggi fu reso manifesto ciò che Dio stesso aveva inteso comunicare al pensiero dell’uomo attraverso il creato (Rm 1, 19-20). Si deve poi ricordare quel luogo degli Atti degli Apostoli in cui Paolo riconosce come alcuni dei poeti antichi avessero presagito che l’esi-stenza dell’uomo e del mondo annunciava, nell’immanenza del suo esse-re realtà creata, l’esistenza di un unico Dio: “Prateteriens enim et videns simulacra vestra, inveni et aram, in qua scriptum erat: igNOtO DeO. […] in ipso enim vivimus et movemur et sumus; sicut et quidam vestrorum poe-tarum dixerunt: “ipsius enim et genus sumus”57” (Act 17, 23 e 28). agostino si è posto come fedele interprete dell’auctoritas affermando che i sapienti antichi non adorarono Dio rettamente (“recte coluisse”) poiché riservarono a falsi idoli gli onori a lui dovuti58.
Nella medesima opera, agostino aggiunge che la colpa dei grandi sapien-ti consisterebbe nell’essersi macchiati di una superbia intellettuale tale da arrestare l’intervento divino offerto a tutte quelle anime che perseguono la ricerca della verità rivestendosi di un habitus conformato da pietà e umiltà:
Qui [philosophi] utcumque conati sunt ingeniis acutissimis praediti ratiocinando vestigare, quid in rerum natura latitaret, quid in moribus appetendum esset atque fugiendum, quid in ipsis ratiocinandi regulis certa connexione traheretur, aut quid non esset consequens vel etiam repugnaret. et quidam eorum quaedam magna, quantum divinitus adiuti sunt, invenerunt; quantum autem humanitus impediti
57 “Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l’iscrizione: “a un dio ignoto”. […] in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti: “Perché di lui anche noi siamo stirpe””.
58 augustinus hipponensis, De Civitate Dei, Viii, 10, a c. di a. trapè et alii, in Opere di Sant’Agostino, V/i, pp. 562 e 564. Cfr. Rm 1, 21 sgg: “Cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt aut gratias egerunt, sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscura-tum est insipiens cor eorum; dicentes enim se esse sapientes stulti facti sunt et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis et volucrum et quadrupedum et serpentium”.
03_Segato_1_12.indd 66 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 67
sunt, erraverunt, maxime cum eorum superbiae iuste providentia divina resiste-ret, ut viam pietatis ab humilitate in superna surgentem etiam istorum compara-tione monstraret59.
Si rinviene il medesimo pensiero fra le pagine del De Trinitate, opera in cui agostino corrobora la sua tesi affermando che i massimi sapienti del-la gentilità non furono giudicati degni (“idonei”60) di ricevere la notizia del Redentore per mezzo di Angeli, di impressioni fisiche o interiormente, per mezzo di rivelazioni rese manifeste nello spirito (“interioribus revela-tionibus in spiritu expressis”61). la pietà (“vera pietate”62) dei santi Padri dell’antico testamento è stata, invece, motivo della loro elezione e dell’e-largizione delle grazie che li resero testimoni della futura salvezza. l’evi-dente infedeltà dei filosofi pagani non ha, tuttavia, impedito che Dio usasse delle loro speculazioni perché la verità risuonasse nel mondo “fidelibus in adiutorium, impiis in testimonium”63.
Il tema della superbia dei filosofi antichi riaffiora nell’opera di Bonaven-tura, che avvalora quanto affermato da agostino asserendo che i sapienti pagani preferirono esser paghi della loro virtuosa magnanimità; virtù che, non essendosi nutrita della fede nel Mediatore, li condusse ad una definitiva separazione da Cristo64.
Agostino rivolge la sua analisi ai filosofi platonici, meritevoli, secondo il santo, per essersi avvicinati alla concezione monoteista; essi, infatti, intu-irono l’esistenza di un unico creatore dal quale trarrebbero la loro origine l’essere, la moralità e la verità65.
59 Ibi, ii, 7, V/i, p. 104. Traduzione di D. Gentili: “Essi (i filosofi) comunque, dotati di molto acume, hanno tentato di scoprire col pensiero i segreti della natura, i precetti e divieti nella morale, la conclusione che si trae con determinato nesso logico nelle regole del ragionamento, la deduzione legittima e perfino il sofisma. E alcuni di essi, perché aiutati da Dio, hanno scoperto grandi verità ma in quanto umanamente limitati hanno insegnato errori, soprattutto perché giustamente la divina provvidenza resisteva alla loro altezzosità. Così anche dal raffronto con essi mostrava la via della pietà che dalla terrenità si leva verso l’alto” (Ibi, p. 105).
60 id., De Trinitate, iV, 17, 23, a c. di a. trapè et alii, in Opere di Sant’Agostino, iV, pp. 212 e 214.
61 Ibidem.62 Ibidem.63 Ibidem.64 Bonaventura, Commentaria in quatuor libros Sententiarum, iii, d. 25, a. 1, q. 2, resp.,
4 voll., in id., Opera Omnia, studio et cura pp. Collegii a s. Bonaventura, iii, Firenze 1887, p. 541: “Sic igitur concedendum est, quod nullus post lapsum salvari potuit absque fide Mediatoris; qua quia philosophi caruerunt, suis meritis et virtutibus inhaerentes, ideo tan-quam superbi et a Christi membris et meritis separati, exclusi sunt a gaudiis paradisii”.
65 id., De Civitate Dei, Viii, 9, V/i, p. 562.
03_Segato_1_12.indd 67 04/12/12 09.06
Maria Segato68
La figura di Platone è motivo di un’indagine che cerca di ricostruire i pos-sibili contatti storici e culturali fra la tradizione profetica ebraica e le civiltà antiche. agostino ricorda, infatti, che per molti è motivo di stupore rilevare le profonde consonanze fra la dottrina platonica e le verità della religione cristiana; ragione che ha indotto all’ipotesi dell’esistenza di un rapporto fra Platone stesso e il profeta geremia (supposizione avanzata da eusebio di Cesarea, giustino, lattanzio e teodoreto). Dopo meticolose considerazioni cronologiche, agostino si dimostra cautamente disposto a credere che Pla-tone, una volta giunto in terra d’egitto, sia venuto a conoscenza della tradi-zione orale dell’antico testamento mediante un qualche interprete. il santo motiva le sue riflessioni esaminando le probabili coincidenze testuali fra il Timeo e l’inizio del Genesi; nello specifico egli rileva la consonanza nelle rispettive descrizioni dell’unione fra terra e cielo al momento della creazio-ne del mondo. l’ipponense sottolinea, poi, la vicinanza fra la dottrina plato-nica, che definisce l’unico Dio come “Colui che è”, e la voce di Dio, che si rivelò a Mosè definendosi “Ego sum qui sum”:
Deinde quod Plato dicit amatorem Dei esse philosophum, nihil sic illis sacris lit-teris flagrat; et maxime illud (quod et me plurimum adducit, ut paene assentiar Platonem illorum librorum expertem non fuisse), quod, cum ad sanctum Moysen ita verba Dei per angelum perferantur, ut quaerenti quod sit nomen eius, qui eum pergere praecipiebat ad populum hebraeum ex aegypto liberandum, respondeatur: Ego sum qui sum, et dices filiis Israel: qui est, misit me ad vos, tamquam in eius comparatione, qui vere est quia incommutabilis est, ea quae mutabilia facta sunt non sint, vehementer hoc Plato tenuit et diligentissime commendavit. et nescio utrum hoc uspiam reperiatur in libris eorum, qui ante Platonem fuerunt, nisi ubi dictum est: Ego sum qui sum, et dices eis: qui est, misit me ad vos66.
le speculazioni agostiniane riservano una minuta analisi al caso storico dell’impero romano. allo stato attuale delle indagini, sembra non sia ancora stata presa in esame l’opera in cui agostino, prima di dimostrare l’unità dei
66 Ibi, Viii, 11, V/i, pp. 566 e 568. trad. di D. gentili: “inoltre Platone afferma che il filosofo è amatore di Dio ed è il motivo che emerge con più vigore dalle Scritture sacre. E soprattutto ve n’è un altro ed è quello che fra tutti quasi convince anche me ad ammettere che Platone non fu ignaro di quei libri. a Mosè vengono riferite mediante un angelo le paro-le di Dio; e poiché egli chiede qual sia il nome di colui che gli comanda di recarsi dal popolo ebraico che doveva essere liberato dall’egitto, gli viene risposto: Io sono Chi sono e dirai ai figli d’Israele: Chi è mi ha mandato da voi. appare che, nel confronto con l’essere che esiste nella sua ideale verità, perché non diviene, le cose poste nel divenire non esistano. e Platone ha sostenuto con vivace dialettica questa dottrina e l’ha insegnata con costanza. Non so però se essa si trova in qualche parte dei libri di coloro che furono prima di Platone se si esclude il passo: Io sono Chi sono; dirai loro: Chi è mi ha mandato da voi” (ibi, pp. 567 e 569).
03_Segato_1_12.indd 68 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 69
quattro testi evangelici, dedica quasi un intero libro allo studio del sincre-tismo religioso romano-ebraico conseguente l’espansione dell’impero e la diaspora ebraica, alla quale seguì una provvidenziale diffusione della tradi-zione profetica custodita dal popolo eletto67.
Nel De consensu evangelistarum, agostino sostiene che i Romani erano soliti propiziarsi gli déi delle genti loro sottomesse accogliendone i riti e i culti tradizionalmente diffusi; fenomeno non verificatosi in seguito alla loro vittoria sugli Ebrei. Il teologo identifica la causa di tale rifiuto nella consape-volezza che, se i conquistatori avessero accettato di prestare il dovuto culto al Dio del popolo eletto, il quale richiedeva di essere adorato in modo esclu-sivo, sarebbe stato necessario rinnegare le varie divinità appartenenti alla tradizione romana, divinità alle quali era attribuita la straordinaria egemonia del loro popolo68. Per fuggire il rinnegamento degli idoli cui era attribuita la responsabilità delle sorti dell’impero, i Romani non vollero accettare le cerimonie del culto ebraico: “Ne [idola gentium] delerentur, recipere sacra eius Romani noluerunt, sicut receperunt deorum aliarum gentium, quas vicerunt”69. i Romani preferirono, dunque, rigettare il culto dell’unico e vero Dio in nome dei loro dèi “falsos atque fallaces”70.
Agostino esemplifica il suo pensiero attraverso alcuni versi della Pharsalia in cui il poeta lucano dimostra di conoscere il Dio degli ebrei: “Proinde quidam lucanus magnus eorum in carmine declamator, credo et ipse diu quaerens sive per suas cogitationes sive per suorum libros, qui-snam esset iudaeorum Deus, et, quia non pie quaerebat, non inveniens, maluit tamen incertum Deum, quem non inveniebat, quam nullum Deum dicere, cuius tam magna documenta sentiebat. ait enim: Et dedita sacris incerti Iudaea Dei”71.
67 id., De Consensus Evangelistarum Libri Quatuor, i, 14, 22, a c. di P. De luis e V. tarulli, in Opere di Sant’Agostino, X/i, p. 24.
68 Ibi, i, 18, 26, X/i, p. 28: “Proinde istis summa necessitas facta est non colendi Deum hebraeorum, quia, si alio modo eum colere vellent quam secolendum ipse dixisset, non uti-que illum colerent, sed quod ipsi finxissent. Si autem illo modo vellent quo ille diceret, alios sibi colendos non esse cernebant quos ipse coli prohibebat. ac per hoc respuerunt unius veri Dei cultum, ne multos falsos offenderent, magis arbitrantes sibi obfuturam fuisse istorum iracundiam, quam illius benevolentiam profuturam”.
69 Ibi, i, 12, p. 20.70 Ibi, i, 25, 38, p. 44. la medesima dittologia in riferimento alle divinità pagane è rin-
venibile nel secondo libro del De Civitate Dei: “falsos et fallaces deos” (ii, 2), espressione nella quale è già stato ampiamente riconosciuto l’antecedente di: “Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, / e vissi a Roma sotto ‘l buono augusto / nel tempo de li dèi falsi e bugiardi” (If. i 71-73), mio il corsivo.
71 Ibi, i, 30, 46, pp. 52 e 54. trad. di V. tarulli: “al riguardo un certo lucano, grande verseggiatore del paganesimo, si mise a cercare anche lui e a lungo - credo, mosso dai suoi
03_Segato_1_12.indd 69 04/12/12 09.06
Maria Segato70
Nel panorama teologico medioevale, agostino si è, dunque, distinto per aver valutato le possibilità di relazione fra i pagani e il Dio cristiano seguen-do un orizzonte teso ad abbracciare non soltanto la sfera della comunicazio-ne personale fra l’uomo e il divino, mediata dall’intervento della grazia, ma sostenendo l’effettiva realtà storica di scambi e contatti storici e culturali che il teologo ha reputato vie adeguate alla comunicazione della fede nel Dio dell’antico testamento.
3. Profeti e Sibille: annunciatori di Cristo?
la critica al culto delle divinità pagane diviene, nel Consenso degli Evan-gelisti, occasione e motivo per affermare la certezza dell’esistenza di voci profetiche precristiane diffuse fra le civiltà dei gentili. Robert hollander sollevava, nel 1983, l’ipotesi che la produzione letteraria virgiliana dovesse essere esaminata anche alla luce delle tradizioni oracolari sibilline diffuse all’epoca dell’imperatore augusto72. La figura della Sibilla, ha sottoline-ato lo studioso americano, si presentava agli occhi del mondo medievale come un’autentica portavoce dell’unico Dio, che andava dispiegando semi e annunci messianici poi riconosciuti e storicamente ricostruiti da alcune fra le voci più autorevoli della letteratura cristiana e apologetica medioevale. Scrive agostino: “aut legant, si possunt, vel aliquam Sibyllarum vel quem-libet aliorum vatum suorum praedixisse hoc futurum, ut Deus hebraeorum Deus israel ab omnibus gentibus coleretur, et quod eum cultores aliorum deorum recte antea respuissent. […] Sed haec omitto, quae cum proferimus a nostris ficta esse contendunt: ipsi omnino, ipsi urgendi sunt, ut proferant a vatibus deorum suorum contra Deum hebraeorum aliquid prophetatum, sicut nos tot et tanta de libris Prophetarum nostrorum contra deos eorum et iussa observamus et praedicta recitamus et facta monstramus”73.
pensieri o dai libri dei suoi - chi fosse il Dio dei Giudei, ma non riuscì a trovarlo perché non cercava piamente. Tuttavia di questo Dio che non trovava preferì dire che era un dio inde-finibile e non un dio inesistente, dal momento che scorgeva le grandi prove che c’erano nei riguardi di lui. e disse: La Giudea si dedica al culto di un Dio indefinibile” (Ibi, pp. 53 e 55).
72 Cfr. r. hoLLander, Il Virgilio dantesco: tragedia nella ‘Commedia’, ed. it. a c. di a. M. Castellini e M. Frankel, Firenze 1983.
73 Ibi, i, 20, 28, p. 30. trad. di V. tarulli: “Vengano dunque a leggerci, se possono, testi di qualche Sibilla o di qualcuno dei loro vati in cui si predice che un giorno il Dio degli ebrei, il Dio d’israele, sarebbe stato adorato da tutte le genti, mentre in un primo momento gli adoratori degli altri dèi a buon diritto lo avevano rifiutato. […] Tralascio infatti di dire che quanto si legge nei loro libri rende testimonianza alla nostra religione, cioè alla religione cristiana, in quanto vi si trovano cose che gli oracolisti poterono udire dagli angeli santi o dagli stessi nostri Profeti” (Ibi, p. 31).
03_Segato_1_12.indd 70 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 71
È, dunque, il caso di approfondire, in questa sede, le tradizioni medievali della Sibilla, secondo quanto è stato tramandato nelle opere più autorevoli della tradizione non solo cristiana, greca e latina74.
“Nella tradizione greca, accettata dai Romani non più tardi del quarto secolo a. C. e dagli ebrei non più tardi del secondo secolo a. C., le Sibille erano donne vecchie capaci di predizioni estatiche”75. la Sibilla si presen-tava agli occhi del mondo medievale come una “fonte autonoma di divina rivelazione, creatura misteriosa e vagante, spirata dall’alto [...] la quale par-la senza essere interrogata”76. I tratti che denotano tale enigmatica figura si riassumono in alcuni caratteri ricorrenti in differenti epoche e latitudini. le Sibille vengono innanzitutto ricordate per la loro voce, che assume tratti assolutamente distintivi, con toni piangenti e drammatici; eraclito descrive tali profetesse come persone solitarie, apparentemente senza età e dimora, la cui voce risuona perpetuamente attraverso le generazioni77, Clemente ales-sandrino (un esempio fra i molti) stabilisce l’anteriorità della Sibilla rispetto a Orfeo a tutte le tradizioni oracolari apollinee78.
la tradizione letteraria medioevale non concorda sul numero e sull’anti-chità delle profetesse: il “fenomeno della loro moltiplicazione”79, avvenuto in età ellenistica, si delinea come una tendenza tesa a ricondurre nella figura di un unico ed originario personaggio vaticinante le diverse voci profeti-che, “ovvero a fare della Sibilla [...] una sorta di seme o sostrato cosmico di ogni manifestazione, nel tempo e nello spazio, della voce profetica, unica e molteplice insieme”80. Varrone testimonia una moltiplicazione circoscritta
74 Per un riferimento bibliografico sulle Sibille, oltre ai testi che seguono, si rimanda almeno a F. aLLevi, Con Dante e la sibilla e altri (dagli antichi al volgare), Milano 1965; J. Baroin, La prophétie de la Sibylle Tiburtine, Paris 1987; h. Parke, Sibyls and Sibylline prophecies in classical antiquity, london 1988; P. dronke, Hermes and the sibys. Conti-nuations and creations, Cambridge 1990; La profezia nel mondo antico, a c. di M. Sordi, Milano, 1993; J. ChaMPeaux, Permission, monition, prédiction: le signes de la divination romaine, in Signe et prédiction dans l’Antiquité. Actes du Colloque International Interdisci-plinaire de Créteil et de Paris (22-24 Mai 2003), a c. di J. K. turpin, Saint-etienne 2005, pp. 211-22;
75 a. MoMigLiano, Dalla sibilla pagana alla sibilla cristiana: profezia come storia della religione, “annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, 18 (1987), 2, p. 408.
76 g. SFaMeni gaSParro, La Sibilla voce del Dio per pagani, ebrei e cristiani, in Sibille e linguaggi oracolari. Mito storia e tradizione, Atti del Convegno Macerata-Norcia. Set-tembre 2004, a c. di i. Chirassi Colombo e t. Seppilli, Macerata 1998, p. 525.
77 J. L. LightFoot, The Sibylline oracles, Oxford University Press, Oxford 2007, p. 14.78 t. SardeLLa, La Sibilla nella tradizione greca cristiana, in Sibille e linguaggi oraco-
lari. Mito storia e tradizione, p. 588.79 Ibidem.80 Ibi: “Si costituisce in tal modo una sorta di successione profetica che fa del tipo oraco-
lare sibillino, mutatis mutandis, il parametro più prossimo – all’interno del panorama divi-
03_Segato_1_12.indd 71 04/12/12 09.06
Maria Segato72
a precise località dall’italia all’asia; egli traccia poi un catalogo che loca-lizza dieci profetesse ‘distribuite’ in tutti i principali regni dell’antichità. “Negli Stromati Clemente si rivela pienamente consapevole dell’esistenza di numerose Sibille, appartenenti a diverse tradizioni culturali e religiose”81: si ricordino almeno la Sibilla Delfica, l’Eritrea Erofile, l’Egiziana, l’Ebrea e l’italica, legata alle vicende dell’antica Roma. Molti convengono nel sotto-lineare che i primi segni di figure sibilline comparvero fra il popolo ebraico in epoche antecedenti la diaspora, in anticipo rispetto alle analoghe tradi-zioni pagane; attilio Momigliano cita, a tal riguardo, il caso di Pausania, tramandata ai posteri come “nuora di Noè”82.
il mondo tardoantico e medioevale riconosce nelle Sibille un’autentica manifestazione della voce divina: ad esse viene riconosciuta non soltanto la piena dignità di profetesse, ma anche l’autorità e il privilegio di essere una voce divinamente ispirata e volta a diffondere messaggi profetici colliman-ti con quanto annunciato dal popolo eletto e culminanti nella rivelazione cristiana. Teofilo di Antiochia può, quindi, iscriverle nel novero dei profe-ti, cioè di coloro che ricevettero il compito di indicare a tutti gli uomini la verità per ispirazione dello Spirito Santo: la Sibilla risultò, così, “ipso facto situata nella medesima categoria degli uomini di Dio”83.
le Sibille hanno prestato il loro nome “a un ingente corpus di testi, la cui stesura si è lungamente protratta attraverso i secoli: dal Vii a. C al Vii d. C.”84. il contenuto dei vaticini pervenuti è molteplice, ma sempre inerente profezie circa la futura venuta del Re del mondo; il tema ricorrente è la “schematizza-zione della storia dell’umanità, scandita da grandiosi eventi metastorici: die-ci generazioni, quattro regni, conflagrazione cosmica finale, resurrezione dei morti”85; altri testi presentano, invece, tematiche quasi esclusivamente stori-che e politiche. Con l’eccezione dei libri sibillini romani (i quali contenevano, come si vedrà in seguito, precise istruzioni circa l’amministrazione di rituali religiosi) i versi sibillini annunciavano guerre, eventi politici o disastri natu-rali quali eruzioni vulcaniche, distruzioni di città, terremoti o inondazioni.
natorio pagano – al modello profetico giudaico caratterizzato dalla riproposizione, in tempi, situazioni e luoghi diversi, di un unico messaggio religioso”.
81 Ibi, p. 545.82 MoMigLiano, Dalla Sibilla pagana alla Sibilla cristiana: profezia come storia della
religione, p. 420.83 Cfr. teofilo di Antiochia, Ad Aut. i, 14 (SFaMeni gaSParro, La Sibilla voce del Dio
per pagani, ebrei e cristiani, p. 542). Si vedano anche BuitenwerF, Book III of the Sibylline Oracles and its social setting, leiden 2003, pp. 122-123 e CoLLinS, The Jewish transforma-tion of Sibylline Oracle, in Sibille e linguaggi oracolari, p. 369.
84 g. CaSadio, I paradisi della Sibilla, in Sibille e linguaggi oracolari. Mito storia e tradizione, p. 412
85 Ibidem.
03_Segato_1_12.indd 72 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 73
il pensiero medievale attinse la tradizione oracolare nell’opera di giu-stino, Atenagora, Teofilo, Clemente Alessandrino, Taziano, Celso, Origene, lattanzio e agostino, autori che hanno contribuito a teorizzare una visione della storia del mondo comprendente la reale possibilità dell’esistenza di voci divinamente ispirate, atte a diffondere la conoscenza dell’unico Dio in tutte quelle culture che già andavano conquistando semi di verità attraverso le più note speculazioni filosofiche.
Si deve prestare particolare attenzione al ruolo detenuto dalle Sibille nel mondo culturale e politico romano; come ha osservato Momigliano, “Roma invero sembra di essere stata unica nell’aver trasformato la consultazione degli oracoli sibillini in un monopolio esclusivo dello stato”86. Come con-fermato da tito livio e Cicerone, le profetesse venivano spesso interpellate per motivi politici; erano poi tradizionalmente ricercate per ottenere previ-sioni riguardanti piaghe o prodigi che avrebbero coinvolto l’impero87. le fonti testimoniano che i libri sibillini venivano custoditi nel tempio di giove e che furono traferiti in quello di apollo in età augustea, ad indicare come, già dai tempi di tarquinio il Superbo, lo stato si fosse impossessato di tali raccolte nate, secondo alcuni, da un sincretismo etrusco-greco-romano88. Cicerone, fra le pagine del De divinatione, “con specifico riferimento ai Libri Sibillini, sacro deposito oracolare dello stato romano [...] riprende il tema [...] del furor della profetessa”, riconoscendo come veritieri i “Sibyllae versus [...] quos illa furens fudisse dicitur”89. Ulteriori testimonianze sono rinvenibili nell’opera di tito livio, il quale conferma che la funzione socia-le degli oracoli sibillini era quella di presagire eventi naturali, legittimare operazioni militari ed autorizzare l’istituzione di nuovi culti.
Come è stato ampiamente sottolineato, fu soprattutto l’opera di ago-stino, che attribuiva agli oracoli della Sibilla valore di insegnamento per i fondamenti della religione cristiana, a “segnare il destino della profetessa e a garantirle un futuro nell’occidente cristiano”90. Nell’Esposizione incom-pleta della Lettera ai Romani, il teologo, facendo continuo riferimento
86 MoMigLiano, Dalla Sibilla pagana alla Sibilla cristiana: profezia come storia della religione, p. 409.
87 CoLLinS, The Jewish transformation, pp. 371-372, cita traducendolo, a titolo d’esem-pio, il seguente frammento di tibullo: “[the Sibyls] told that a comet would be the evil sign of war, and how plenty of stones would rain down on earth. they say that trumpets have been heard and weapons clashing in the sky, and that groves have prophesied defeat”.
88 Cfr. BuitenwerF, Book III of the Sibylline Oracles and its social setting, pp. 99-100. lo studioso suggerise il confronto con a. geLLiuS, Noctes atticae, i 19.1-11; d. haLiCar-naSSuS, Antiquitates romanae iV 62.1; PLiniuS, Historia naturalis Xiii 88.
89 SFaMeni gaSParro, La Sibilla voce del Dio per pagani, ebrei e cristiani, pp. 529-530. 90 SardeLLa, La Sibilla nella tradizione greca cristiana, p. 582.
03_Segato_1_12.indd 73 04/12/12 09.06
Maria Segato74
all’auctoritas paolina, afferma che ci furono profeti non appartenenti al popolo eletto negli scritti dei quali si rintracciano annunci riguardanti il Redentore, annunci forse attinti dalla stessa tradizione ebraica91. agosti-no si direbbe incredulo di fronte a tali prospettive se la voce autorevo-le della Sibilla non fosse stata confermata anche dall’illustre Virgilio92: “Quod ex Cumaeo, id est, ex Sibyllino carmine se fassus est transtulisse Virgilius; quoniam fortassis etiam illa vates aliquid de unico Salvatore in spiritu audierat, quod necesse habuit confiteri”93. la medesima certezza è custodita nell’opera di lattanzio: “Oracula [Christum] sanctum immorta-lemque confessa sunt”94. Seguendo il sentiero tracciato da agostino, Pie-tro il Venerabile accosta la Sibilla a giobbe, voce divinamente ispirata e non appartenente al popolo eletto: “Solet hoc idem Dei spiritus aliquan-do facere et lingua gentili prophetica vel divina proferre. Fecit hoc per iob iustum, non iudaeum sed Ydumeum, fecit et per impium Balaam. […] Quid ergo de Christo dixit Sybilla? […] De Christi enim passione inter plurima quae prophetice dixerat loquens. […] haec Sybilla dixit de Chri-sto multo ante Christum tempore”95.
isidoro di Siviglia, oltre a operare un confronto cronologico fra l’attivi-tà della Sibilla eritrea e le contemporanee voci profetiche appartenenti al popolo eletto96, attesta che le Sibille “generaliter dicuntur omnes feminae uates lingua Graeca. Nam σιοσ (= θεοσ) Aeolico sermone deos, βολλα Gra-
91 augustinus hipponensis, Epistolae ad Romanos inchoata expositio, a c. di S. Caruana et alii, in Opere di Sant’Agostino, XXiii/iii, p. 888.
92 Ibidem.93 id., Epistula CCLVIII, 5, in id. Epistulae, (CSel 57, Vindobonae 1911, 610). in riferi-
mento alle Sibille si vedano i seguenti luoghi: De Civitate Dei, X, 27 e De Consensu Evan-gelistarum, i, 14 e i, 18.
94 lactantius, Diuinae Institutiones, 1, 6, 7, in id., Opera Omnia, (CSel 19, Vindobonae 1895, 20). Nelle Divinae Institutiones, l’apologeta africano sottolinea più volte il valore profetico delle Sibille, le quali annunciavano l’esistenza di un unico e vero Dio a nome della “divina providentia” (Ibi, p. 138): “De uno deo haec sunt testimonia [...] hunc esse solum summum deum, qui caelum fecerit luminibusque distinxerit [...] qui quoniam solus sit aedi-ficator mundi et artifex rerum uel quibus constat uel quae in eo sunt, solum coli oportere testatur” (Ibi, p. 20).
95 Petrus Venerabilis, Aduersus Iudeorum inueteratam duritiem, ii, 862, (CCCM 58, turnholti 1985, 40-41). traduzione mia: “Questo stesso spirito di Dio suole talvolta fare o manifestare contenuti profetici o divini attraverso la parola dei gentili. Fece questo per mez-zo del giusto giobbe, non giudeo ma idumeo, e fece questo per mezzo dell’empio Balaam. […] Cosa dunque disse in merito a Cristo la Sibilla? […] essa infatti parlò della passione di Cristo, fra le altre cose che aveva profeticamente annunciato. […] Questa Sibilla parlò di Cristo molto prima del tempo di Cristo”.
96 isidorus hispalensis, Chronicon, quarta aestas saeculi, (Pl 83, 1030-1031).
03_Segato_1_12.indd 74 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 75
eci mentem nuncupant, quasi dei mentem”97. il nome stesso delle profetesse nasce, secondo il santo, dalla loro funzione: “ita omnis femina prophetans Sibylla vocatur”98. Dello stesso parere è Pietro abelardo, il quale, riferen-dosi all’autorità del vescovo d’ippona, afferma: “Per gentilem feminam, id est Sibillam, multo fere apertius quam per omnes prophetas uaticinatum”99. anche Bonaventura, in suo sermone, si è detto pronto a credere che una Sibilla avesse preannunciato all’imperatore augusto l’imminente nascita del Redentore100.
San tommaso d’aquino conferma il ruolo profetico delle Sibille rico-noscendole vere portavoci dell’unico Dio, sebbene non appartenenti al popolo eletto. in quattro occasioni il dottore angelico avvalora quanto già affermato da agostino: “Multis gentilium facta fuit revelatio de Christo: ut patet per ea quae praedixerunt [... ] Sibylla etiam praenuntiavit quaedam de Christo, ut augustinus dicit”101. Si veda, su suggerimento di giorgio inglese102, il seguente passo del De Veritate: “gentiles non ponebantur ut instructores divinae fidei, unde quantumcumque essent sapientes sapientia saeculari inter minores computandi sunt, et ideo sufficiebat eis habere fidem de Redemptore implicite, vel in fide legis et prophetarum vel etiam in ipsa divina providentia; probabile tamen est multis etiam gentilibus ante Christi adventum mysterium redemptionis nostrae fuisse diviniuts revelatum, sicut patet ex sybillinis vaticiniis”103. tommaso conferma, quindi, la linea di pen-siero tracciata da agostino affermando che le Sibille, perché divinamente
97 id., Etymologiarum siue Originum libri XX , Viii, 8, 1 (Pl 82, 309).98 Ibidem.99 Petrus abelardus, Theologia Scholarium, i, 110, (CCCM 13, turnholti 1987, 361). Si
veda anche harent, Infidèles, p. 1748-1749 ss. ha scritto abelardo in merito alla poesia di Virgilio: “hoc profecto sibyllae vaticinium, ni fallor, maximus ille poetarum nostrorum Virgilius audierat atque intellexerat, cum in quarta ecloga futurum in proximo sub augu-sto Caesare, tempore consulatus Pollionis, mirabilem cujusdam pueri de coelo ad terras mittendi, qui etiam peccata mundi tolleret, et quasi secundum novum in mundo mirabiliter ordinaret, praecineret ortum, admonitus, ut ipsemet ait, Cumaei carminis vaticinio, hoc est sibyllae, quae Cumaea sive Cumana dicitur” (Ibi).
100 Bonaventura, Sermones de tempore, 111, 8, introd. e note di J. guy Bourgerol, trad. it. di D. Profumo, a c. di leonardo Sileo, Roma 2003, p. 234.
101 thomas aquinas, Summa Theologiae, i-ii, q. 2, a. 7, Vi, pp. 23-24.102 ingLeSe, Il destino dei non credenti. Lettura di ‘Paradiso’ XIX, p. 325.103 thomas aquinas, De Veritate, q. 14, a.11, resp., XXii, pp . 470-471. traduzione di R.
Coggi: “i gentili non venivano posti come maestri della fede divina per cui, per quanto fos-sero sapienti di sapienza secolare, vanno annoverati fra le persone semplici, e quindi bastava ad essi avere la fede nel Redentore implicitamente [contenuta] o nella fede della legge e dei profeti o nella stessa divina provvidenza; è probabile però che il mistero della nostra redenzione sia stato rivelato da Dio anche a molti gentili prima della venuta di Cristo, come appare dai vaticini sibillini” (id., Le Questioni Disputate, ii, p. 541).
03_Segato_1_12.indd 75 04/12/12 09.06
Maria Segato76
ispirate “per angelos”104, “multa vera praedixerunt de Christo […]ut patet per augustinum”105.
Sembra non sia ancora stato ricordato che l’interpretazione medievale dei testi sibillini si ritrova nel commento al poema di Pietro alighieri che, in calce all’unica occorrenza della Sibilla nel poema (Pd XXXiii 66: “Così la neve al sol si disigilla; / così al vento ne le foglie levi / si perdea la sentenza di Sibil-la”) propone alcuni versi attribuiti alle antiche profetesse (mio il corsivo):
Fuerunt enim Sibille decem: hoc premissa Cumana, item Samia de ynsula Samo, item Persea, item Libica, item Delfica, item Cimeria, Ytalica, item Elithyria, Babi-lonica que excidium troie predixit, item ellespontia, item Frigia, item albunea, tiburtina que Christum prenumptiavit, dicendo: Iudicii signum, tellus sudore madescit, et celo rex adveniet per secla futurus, sed licet ut carnem presens ut vin-dicet orbem. et nota hec nomen Sibilla appellativum esse; nam Sibilla grece latine profetissa dicitur106.
il commento di Pietro rimanda, quindi, a quei testi in cui si narra della Sibilla riportando quanto da lei preannunciato in merito alla futura venu-ta del Redentore. i versi citati hanno trovato eco e diffusione nell’opera di Quodvultdeus, Freculfo di lisieux, giovanni di Salisbury, Pietro abelardo e Stefano di Borbone107, autori inseriti nel solco di una tradizione che sembra far capo ad agostino. Si veda a titolo d’esempio il De Civitate Dei (mio il corsivo):
eodem tempore nonnulli Sibyllam erythraeam vaticinatam ferunt. Sibyllas autem Varro prodit plures fuisse, non unam. haec sane erythraea Sibylla quaedam de Christo manifesta conscripsit quod etiam nos prius in latina lingua versibus male
104 id., In quattuor libros Sententiarum, d. 25, q. 2, a. 2, resp., in id., Opera Omnia, 7 voll., a c. di R. Busa, Milano 1980, i, p. 353.
105 id., Summa Theologiae, ii-ii, q. 172, a. 6, resp., X, pp. 383-384.106 Petri Allegherii super Dantis ipsius genitoris ‘Comoediam’ Commentarium, a c. di V.
Nannucci, Firenze 1845, p. 716. traduzione mia: “Ci furono infatti dieci Sibille, la già citata Cumana, poi la Samia, dell’isola di Samo, poi la Persica, la Libica, la Delfica, la Cimeria, l’italica, l’eritrea, la Babilonica, che predisse la distruzione di troia, poi l’ellespontica, la Frigia, poi l’albulnea, la tiburtina, che preannunciò Cristo dicendo: Segno del giudizio: la terra sarà madida di sudore. Verrà dal cielo Colui che sarà re per sempre, cioè presente nella carne per giudicare il mondo. e si noti che ‘Sibilla’ è il nome comune; infatti ‘Sibilla’ in greco e latino significa ‘profetessa’”.
107 Quoduultdeus, Contra Iudaeos, paganos et arianos, XVi, 1, in Opera Quodvultdeus Carthaginiensi Episcopo Tributa (CCSl 60, turnholti 1976, 248); Frechulfus lexouiensis, Historiarum libri XII, 1, 3, 12, (CCCM 169, turnholti 2002, 177); iohannes Sarisberiensis, Policraticus, ii, 15, (CCCM 118, turnholti 1993, 95); Petrus abaelardus, Theologia christia-na, i, 127, (CCCM 12, turnholti 1969, 126); Stephanus de Borbone, Tractatus de diuersis materiis praedicabilibus, i, 6, 2, (CCCM 124, turnholti 2002, 200).
03_Segato_1_12.indd 76 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 77
latinis et non stantibus legimus per nescio cuius interpretis imperitiam, sicut post cognovimus. Nam vir clarissimus Flaccianus, qui etiam proconsul fuit, homo facillimae facundiae multaeque doctrinae, cum de Christo colloqueremur, grae-cum nobis codicem protulit, carmina esse dicens Sibyllae erythraeae […] Iudicii signum tellus sudore madescet. E caelo rex adveniet per saecla futurus, scilicet ut carnem praesens, ut iudicet orbem.108
Non si può certo costringere l’inventio dantesca entro l’interpretazione del figlio; è un dato comunque significativo rilevare come uno dei commentato-ri in assoluto più familiari al poeta stesso dimostri di essere a conoscenza di quei testi che confermavano il ruolo profetico delle Sibille.
alla luce del panorama culturale che si è tentato di ricostruire, si può facilmente comprendere la complessità di possibilità e argomenti con cui la dottrina del tempo di Dante aveva affrontato i secolari interrogativi circa la sorte eterna degli uomini vissuti in contesti non raggiunti dalle più note forme profetiche. le massime auctoritates teologiche presentano opinioni significativamente consonanti riconoscendo nella fede in Cristo venturo una reale possibilità offerta a tutte le genti, ed ammettono la plausibilità storica della salvazione di anime precristiane o pagane non appartenenti al popolo eletto. Secondo alcuni fra i più autorevoli esponenti della dottrina medioe-vale, Dio avrebbe inteso diffondere, anche in epoca precristiana, dei semi messianici che avrebbero potuto condurre i gentili alla salvezza, semi fra i quali si devono comprendere anche i frutti delle speculazioni filosofiche pagane. Nel contempo, si deve ribadire quanto guadagnato dalla sintesi tomista, ossia la certezza che la grazia divina è volta al raggiungimento di ogni creatura umana, alla quale spetta la disponibilità a lasciarsi illuminare dall’intervento divino. la teologia medioevale non contempla, quindi, l’i-potesi di dannazioni necessarie e inevitabili: nessuna condizione storica o
108 augustinus hipponensis, De Civitate Dei, XViii, 23. iV/ii, p. 730. trad. di D. gentili: “Alcuni narrano che in quel tempo proferì vaticini la Sibilla Eritrea. Varrone riferisce che le sibille furono parecchie non una. la Sibilla eritrea ha dato allo scritto alcune manifeste divinazioni sul Cristo. le ho lette nella lingua latina, prima in brutti versi latini e anche sconnessi per non saprei quale inettitudine del traduttore, come ho appreso in seguito. infatti l’illustre Flacciano, che fu anche proconsole, uomo di spontanea eloquenza e di grande cul-tura, mentre parlavamo del Cristo, mi presentò un codice greco dicendomi che conteneva poesie della Sibilla eritrea […] Segno del giudizio: la terra sarà madida di sudore. Verrà dal cielo Colui che sarà re per sempre, cioè per giudicare di presenza la carne e il mondo”. Si deve, tuttavia, rilevare la differenza che intercorre fra i due testi: Pietro attribuisce i versi riportati alla Sibilla tiburtina, agostino li riconduce, invece, alla Sibilla eritrea. Si noti poi che il commento di Pietro attesta l’ablativo carne, lezione differente dall’accusativo carnem riscontrato nel testo di agostino. la tradizione del passo agostiniano riporta entrambe le varianti, come mostrato dal testo della Patrologia Latina che riporta l’ablativo carne.
03_Segato_1_12.indd 77 04/12/12 09.06
Maria Segato78
geografica può impedire il dono della grazia e la conseguente fede nel futuro evento cristiano. Si può, dunque, concludere con gian Carlo alessio, che Dante, “nelle linee portanti, risolve in modo strettamente aderente all’inse-gnamento delle sue fonti patristiche e teologiche il problema che imposta il iV canto”109.
l’armonico sentire che si offriva alla formazione culturale dell’ali-ghieri non elude, tuttavia, l’ultima insondabilità di tali ricerche, volte a confluire nell’affermazione del misterioso agire della grazia, come esem-plificato dall’viator nel già citato stupore conseguente la contemplazione della gloria eterna del troiano Rifeo110. la salvezza del precristiano, reden-to per la sua “scelta responsabile di assecondare il dono della grazia”111 ed eternamente partecipe della luminosa carità del Paradiso, contribuisce ad accentuare il dramma eterno di quel Virgilio che ne ha tramandato la giu-stizia alla memoria dei posteri. Nel contempo, la tradizione medioevale della Sibilla evoca inevitabilmente l’estensore di quel testo in cui lo Sta-zio dantesco riconobbe i semi della futura rivelazione cristiana. Virgilio, “nunzio inconsapevolmente ispirato della verità divina”112, assomma in sé, nella “delicata elevatezza”113 con cui è reso guida in inferno e Pur-gatorio (misteriosamente, dunque, anche nel regno della salvazione), la tragedia della sapienza pagana, eternamente esclusa dalla contemplazio-ne del Verbo, termine, fine e compimento dell’ardore conoscitivo proprio dell’essere umano.
Rifeo è reso fiamma114, è innalzato alla beatitudine consustanziata di luce e amore, è definitivamente plasmato dalla sovrabbondanza di quel-la charis che, come ha asserito Charles Singleton, segna il distacco tra la contemplazione puramente intellettuale, propria di molti fra gli spiriti reclusi nel limbo, e la vera Sapienza, in cui volontà e affezione si compio-no nel rapporto col Figlio115. il bagliore incessante, che permea l’atmo-
109 aLeSSio, Il canto quarto dell’‘Inferno’, p. 39.110 ha scritto andrea Battistini: “i motivi di sbigottimento sono più d’uno, e Dante non
abdica, pur nella fedeltà alla dottrina cristiana, ad avocare a sé il diritto di invenzioni perso-nali, perfino provocatorie, concesse un tempo al pellegrino investito di una missione provvi-denziale e al poeta che esercita in forme sublimi la tecnica dello straniamento” (BattiStini, “Rifeo troiano” e la riscrittura dantesca della storia, p. 37).
111 Ibi, p. 45.112 e. auerBaCh, Dante e Virgilio, in San Francesco, Dante, Vico ed altri saggi di filolo-
gia romanza, ed. it. a c. di V. Ruberl, Bari 1970 [1968]. p. 24.113 r. guardini, Dante in Germania, in Maestro Dante, a c. di V. Vettori, Milano
1962, p. 58.114 Cfr. Pd. XX 148.115 Cfr. C. SingLeton, La poesia della ‘Divina Commedia’, il Mulino, Bologna 1999, p.
283: “a distinguere ulteriormente la Sapienza in senso cristiano da qualunque cosa avessero
03_Segato_1_12.indd 78 04/12/12 09.06
dante e La SaLvezza degLi antiChi 79
sfera del Paradiso, può intendersi quale luce conoscitiva originata dalla continua rivelazione di sé operata da Dio stesso: “il corpo stesso diventa luminoso, quando la luce pneumatica della grazia lo compenetra e rende l’uomo redento partecipe del mistero della resurrezione di Cristo e del suo corpo trasfigurato”116.
Quello che le anime gloriose esemplificano agli occhi del viator non è soltanto una conoscenza pienamente illuminata, ma un compimento affetti-vo e intellettuale definitivo perché consustanziato di luce e amore; da questa unità fiorisce il calore che incendia le anime dei beati: “Così un sol calor di molte brage / si fa sentir, come di molti amori / usciva solo un suon di quella image” (Pd. XiX 19-21). tale illuminazione affettiva sancisce la distanza tra il beato Rifeo e il giusto enea, destinato, con Virgilio, ad essere per l’eterni-tà illuminato dalla luce di un debole “foco” (If. iV 68), che vince le tenebre circostanti, ma che, secondo l’evidente significazione allegorica, non può infiammare l’animo con fede e carità, non può compiere quella tensione di desiderio destinata, per i limbicoli, a rimanere “sanza frutto” (Pg. iii 40). la luce che pervade il cielo degli spiriti giusti è affettiva, sapienziale e sal-vifica, perché forma della comunicazione di Dio: “Luce intellettüal piena d’amore; / amor di vero ben, pien di letizia; / letizia che trascende ogne dol-zore” (Pd. XXX 40-42).
la gloria luminosa di Rifeo contribuisce, dunque, a ritrarre la tragedia del mondo pagano condannato nel limbo. i beati vivranno per l’eternità un compimento affettivo che è nel contempo vertice dell’amore e della Sapien-za; i limbicoli, invece, possiederanno per l’eternità quanto hanno perseguito nel corso della loro vita terrena: una conoscenza esperita con le sole forze del lumen naturale, con le sole forze della loro umana ragione, che non tro-verà mai il suo compimento nell’amore vero, nella carità vissuta e parteci-pata che eleva l’anima alla vera Sapienza, fruibile soltanto in una personale relazione col Dio unico al quale i grandi pagani, secondo quanto affermato dalle auctoritates citate, non vollero convertirsi.
potuto conoscere i filosofi pagani, c’è un altro elemento, e anch’esso trova rappresentazione nel poema dantesco. aristotele non aveva pensato che nell’ascesa alla speculazione potesse intervenire l’amore. Per lui la contemplazione è un fatto di pura intellezione; che la parte affettiva dell’uomo vi sia impegnata come elemento fondamentale, aristotele non lo ritiene. anche a questo riguardo è dunque della massima importanza, come tante volte avverte san tommaso, precisare se si sta parlando secondo il Filosofo o secondo la teologia cristiana, perché in quest’ultima la Sapienza interessa profondamente la volontà e la vita affettiva. e deve essere veramente così, poiché la Sapienza cristiana – a differenza della contemplazione di aristotele – è sempre accompagnata dalla carità e dalle altre virtù (anche quelle della vita attiva che sono infuse)”.
116 r. guardini, Dante, ed. it. a c. di M. l. Maraschini e a. S. Balestrieri, Brescia 1967, p. 333.
03_Segato_1_12.indd 79 04/12/12 09.06
Maria Segato80
la mancata adesione alla vera fede (“io son Virgilio; e per null’altro rio / lo ciel perdei che per non aver fé” (Pg. Vi 7-8) ha comportato per Virgilio l’eterna estraneità al regno della speranza e della carità. Questa è la novità cui gli spiriti magni mai parteciperanno: la conoscenza come rapporto, intel-lettuale e affettivo, col Divino. lungo il cammino del Paradiso dantesco si annulla ogni distanza tra la speculazione intellettuale e la partecipazione mistica all’amore di Dio: i due atti coincidono e si realizzano vicendevol-mente; l’indagine della ragione confluisce in una esperienza affettiva in cui trova riposo la “sete natural” (Pg. XXi 1) che costituisce la natura stessa dell’uomo. la mancata fede, che ha reso i limbicoli estranei al venturo o venuto Redentore, è, dunque, causa di un’eterna assenza di rapporto con Dio, Padre e Redentore, assenza alla quale consegue la mancata partecipa-zione all’unico amore che è insieme ed eternamente luce per l’intelletto e fiamma per l’affetto.
03_Segato_1_12.indd 80 04/12/12 09.06