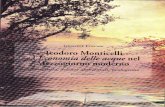Acque e siti termali nell’Italia romana. Le testimonianze degli autori antichi
Transcript of Acque e siti termali nell’Italia romana. Le testimonianze degli autori antichi
ANTENOR QUADERNI
Direzione
Irene Favaretto, Francesca Ghedini
Comitato sCientifiCo Maria Stella Busana, Jacopo Bonetto, Paolo Carafa, Marie Brigitte Carre, Heimo Dolenz, Christof Flügel, Andrea Raffaele Ghiotto, Giovanni Gorini, Stefania Mattioli Pesavento, Mauro Menichetti, Athanasios Rizakis, Monica Salvadori, Daniela Scagliarini, Alain Schnapp, Gemma Sena Chiesa, Desiderio Vaquerizo Gil, Paola Zanovello, Norbert Zimmermann
CoorDinamento sCientifiCo Isabella Colpo
segreteria reDazionale
Matteo Annibaletto, Maddalena Bassani
Il volume rientra nel Progetto di interesse nazionale (PRIN 2008) Il termalismo in età romana tra conoscenza e valorizzazione ed è interamente finanziato dal MIUR - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Layout grafico: Matteo Annibaletto
Università degli Studi di PadovaDipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musicaPiazza Capitaniato, 7 – 35139 [email protected]
ISBN 978-88-97385-32-5
© Padova 2012, Padova University PressUniversità degli Studi di Padovavia 8 febbraio 1848, 2 – 35122 Padovatel. 049 8273748, fax 049 8273095e-mail: [email protected] www.padovauniversitypress.it
Tutti i diritti sono riservati. È vietata in tutto o in parte la riproduzione dei testi e delle illustrazioni.
In copertina: Ipotesi ricostruttiva della villa romana di via Neroniana a Montegrotto Terme (disegno di Inklink).
UNIVERSITà DEGLI STUDI DI PADOVADIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALIarcheologia, storia dell’arte del cinema e della musica
ANTENOR QUADERNI 26
AquAe pAtAvInAemontegrotto terme e il termalismo in italia
aggiornamenti e nuove prospettive Di valorizzazione
ATTI DEL II CONVEGNO NAZIONALE(PADOVA, 14-15 GIUGNO 2011)
a cura di Maddalena Bassani, Marianna Bressan, Francesca Ghedini
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
aCque e siti termali nell’italia romana
le testimonianze Degli autori antiChi*
Cecilia Zanetti, Andrea Rizzi, Loredana Mantovanelli
1. i trattati meDiCi e l’iDroterapia: alCune ConsiDerazioni
L’utilizzo dell’acqua con funzione terapeutica aveva un ruolo di grande importanza nella me-dicina antica, già nel mondo greco1: infatti tutte e tre le scuole mediche greche – l’ippocratica, la me-todica e l’empirica – facevano ampio ricorso a trattamenti idroterapici nella cura di un gran numero di patologie2. Per quanto riguarda più propriamente le acque curative, grande rilevanza doveva ave-re anche l’aspetto sacrale, non disgiunto dall’ambito più strettamente medico3: basti pensare ai san-tuari del dio Asclepio o di Eracle, solitamente posti in prossimità di sorgenti d’acqua medicamen-tosa, nei quali i malati si sottoponevano a rituali di purificazione che prevedevano anche bagni4.
L’idroterapia raggiunse però il massimo sviluppo a Roma, dove si diffuse a seguito della pene-trazione della medicina greca sul finire del III sec. a.C.5; un impulso ulteriore lo diede sicuramen-te anche la realizzazione degli acquedotti, capaci di convogliare ingenti masse d’acqua per lunghe
* Il presente contributo si inserisce nell’ambito del PRIN 2008 Il termalismo in età romana tra conoscenza e valorizzazione (coordinatore nazionale F. Ghedini) ed in particolare nelle attività condotte dalla Unità Locale dell’Uni-versità degli Studi di Verona e coordinate da Patrizia Basso, mirate alla schedatura delle testimonianze letterarie antiche relative al termalismo. Le indagini sono tuttora in corso di svolgimento, tuttavia in questa sede si è voluto presentare una prima parte di risultati, concentrando l’analisi su una specifica tipologia di fonti letterarie, cioè la trat-tatistica, sia quella di specifico carattere medico (analizzata da Cecilia Zanetti), sia quella di carattere non medico (e in particolare le opere enciclopediche romane redatte nel I sec. d.C., considerate da Andrea Rizzi). La parte conclu-siva del contributo, incentrata sul confronto fra la classificazione odierna e quella antica delle acque termali, si deve a Loredana Mantovanelli, che è medico e dunque ha specifiche competenze in merito.
1 L’idroterapia antica è stata ed è tuttora oggetto di un gran numero di studi e pubblicazioni. In questa sede tuttavia si è scelto di far riferimento unicamente ai testi più recenti e significativi, ai quali si rimanda per ulteriori ap-profondimenti bibliografici. Rispetto a quei lavori, si è cercato soprattutto di evidenziare quale sia l’apporto delle fonti letterarie in merito ai siti termali dell’Italia romana.
2 A testimoniare l’antichità del ricorso a pratiche idroterapiche in Grecia, cfr. melillo 1995, pp. 462-468; pet-tenò 1997, p. 223. Inoltre, benché l’idroterapia non rivestisse un ruolo centrale nella teoria medica della scuola ip-pocratica, si riconosceva comunque la grande importanza dell’influenza delle acque sulla vita degli organismi: cfr. melillo 1995, pp. 468-469. L’acqua rimane un tema importante della trattatistica medica anche durante la tarda an-tichità: una rassegna di fonti si trova in garzya 1994 e pettenò 1997, p. 225.
3 angeletti 2008, pp. 822-823.4 Sulle figure mitiche di Asclepio ed Eracle e sui santuari curativi a loro dedicati e con annessi impianti termali
cfr. melillo 1995, pp. 465-468; angeletti 2008, pp. 833-835. Un approfondimento sull’uso dell’acqua a scopo cu-rativo nei santuari di Asclepio si trova in BouDon 1994.
5 Convenzionalmente si fa riferimento all’arrivo a Roma del medico greco Acargato, avvenuto intorno al 220 a.C.: stok 1992, p. 45. Quello della penetrazione della scienza medica greca nel mondo romano non fu tuttavia un cammino privo di ostacoli: anche la medicina subì l’atteggiamento diffidente tipico della cultura romana nei confronti dei frutti di quella greca che proprio in quei secoli venivano importati a Roma; anche su questo cfr. stok 1992, p. 51.
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
366 CeCilia zanetti, anDrea rizzi, loreDana mantovanelli
distanze e fino nelle città6. Il grandissimo numero di stabilimenti idroterapici – pubblici e privati – portati alla luce con gli scavi testimonia quindi l’enorme successo di tali pratiche7. È necessario co-munque fare una fondamentale distinzione fra quelli che erano gli stabilimenti termali cosiddetti “igienici”, diffusi in molte città del mondo romano, e quelli più propriamente curativi, i quali in-vece – come vedremo – si trovavano in località nelle quali sgorgavano naturalmente acque mine-rali, che proprio grazie alle loro proprietà chimico-fisiche svolgevano la funzione terapeutica.
1.1 la temperatura Dell’aCqua
Nel distinguere i tipi di acque per poterne fare un uso curativo, il primo parametro su cui gli antichi si basavano era il più evidente, ossia la temperatura.
Per tutta una prima fase, a Roma il bagno era per antonomasia quello caldo8: si facevano dunque bagni in acqua calda o bollente oppure bagni di sudore (come quelli che si potevano prendere a Baia e su cui torneremo più avanti). Questa prassi cambiò quando nel 23 a.C. il me-dico greco Antonio Musa riuscì a curare una malattia che metteva a rischio la vita di Augusto con una cura basata su bagni d’acqua fredda9: da quel momento in poi i medici cominciarono a suggerire ai loro pazienti trattamenti basati su acqua fredda, che all’epoca divennero presto una sorta di moda10. Tra l’altro i bagni d’acqua fredda e le docce gelate erano particolarmente ap-prezzati dai filosofi moralisti, i quali identificavano in quelli caldi una generale idea di mollities e dissolutezza; Seneca stesso, in alcune lettere rivolte a Lucilio, nel compiangere il fatto che al suo tempo il bagno caldo stava ritornando di moda, definisce se stesso vetus frigidae cultor11 o psychrolutes12, termine che indica le persone che facevano uso solamente di bagni freddi.
In questo stesso periodo, a cavallo fra il I sec. a.C ed il I sec. d.C. visse Aulo Cornelio Cel-so, autore di una vasta opera, il De Artibus, di cui però è giunto sino a noi soltanto il sesto libro, il De Medicina. Celso consiglia l’acqua in un gran numero di terapie13, dimostrando tuttavia di non seguire la moda del tempo, in quanto prescrive l’acqua a temperature diverse a seconda del-le condizioni del paziente. Difatti dato che, secondo il medico-trattatista, le patologie si divido-no in “secche” o “umide”, per provocare nel malato lo stato opposto e quindi riportare il corpo all’equilibrio della salute, bisogna che l’acqua abbia temperatura opposta a quella della patolo-gia stessa14. Una medesima malattia che avesse, però, origine diversa, poteva essere curata con acqua sia calda sia fredda: così, ad esempio, per trattare il mal di testa, Celso dice che se il dolore è causato dal caldo, la testa va bagnata con abbondante acqua fredda, […] «se invece è il freddo a causare dolore, bisogna bagnare il capo con acqua calda di mare o comunque salata, o in cui sia stato decotto dell’alloro; poi massaggiare con forza la testa, ungerla con olio caldo e velarla con un tessuto […], mentre se si comprende poco il motivo, si deve bagnare la testa prima con
6 melillo 1995, pp. 470-471: vi si sottolinea anche il carattere sociale oltre che terapeutico assunto dagli stabi-limenti idroterapici nelle città romane, nelle quali il recarsi alle terme divenne presto un rito quotidiano praticato da un gran numero di cittadini; su quest’aspetto anche Di Capua 1940, pp. 53-54.
7 Un’estesa trattazione delle patologie per le quali era consigliato un trattamento idroterapico nel mondo ro-mano, con rimandi alle fonti ed in particolare a Celso, si trova in Di Capua 1940, pp. 7-10, 19-38; cfr. anche jaCkson 1999, pp. 108-115. Sulle modalità in cui si potevano svolgere i trattamenti, cfr. yegül 1992, pp. 353-355.
8 Di Capua 1940, pp. 6-7.9 L’episodio è raccontato in Svetonio (Aug. 81) ed in Cassio Dione (53, 30, 3); ad Antonio Musa fu anche de-
dicata una statua: suet. Aug. 59.10 Di Capua 1940, pp. 15-17; stok 1992, pp. 42-43.11 sen. epist. 53, 3.12 sen. epist. 83, 5.13 Per una casistica, cfr. supra nota 7.14 melillo 1995, p. 473. In ciò Celso si rifarebbe a teorie della scuola medica metodica: stok 1992, p. 46.
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
aCque e siti termali nell’italia romana: le testimonianze Degli autori antiChi 367
acqua calda, […] poi con quella fredda»15; in un altro passo, poi, l’autore suggerisce l’uso di ac-qua calda o fredda per curare dolori alle articolazioni, aggiungendo che è necessario valutare la cura più appropriata a seconda del caso specifico16.
1.2 la Composizione ChimiCa e le loCalità termali
L’altro fondamentale parametro per classificare i tipi di acque da utilizzare a fini medici era la loro composizione chimica. Se Celso non sembra dimostrare particolari conoscenze al riguardo non affrontando questo tema nel De Medicina, il grande medico greco Galeno, vissuto nel II sec. d.C., in più passi della sua ampia opera si sofferma sul tema, individuando i seguenti tipi di acque17:
(ὕδατα) στυπτηριώδη − = (acque) alluminoseθειώδη− = (acque) solforoseἀσφαλτώδη− = (acque) bituminoseνιτρώδη− = (acque) nitroseχαλκανθώδη− = (acque) vetrioline
e inoltre menzionando acque che contengono carbonato di rame (μίσυ) e calcite (χαλκίτις) oppure ancora acque salate (ἁλμυρώδη), che sono diverse dall’acqua di mare (θάλασσα, che pure è impiegata in alcune pratiche terapeutiche). Inoltre Oribasio, medico del IV sec. d.C. na-tivo di Pergamo e autore di un’enciclopedia medica in 70 libri (le Collectiones medicae) in cui riassume e commenta le opere di Galeno, alle categorie di acque elencate da costui aggiunge an-che le acque ferruginose: ὕδατα σιδηρίζοντα18.
Accanto a quest’articolata classificazione, che dimostra già una discreta conoscenza delle ca-ratteristiche chimiche delle acque, nell’opera di Galeno – così come in quelle dei suoi successori che a lui facevano strettamente riferimento, come Oribasio – troviamo ovviamente alcune prescri-zioni sul loro utilizzo medico, anche se in generale Galeno è più attento a specificare con precisio-ne quando non si debba far ricorso alle acque minerali per non rendere nocivo il loro uso19.
Ciò che però nell’opera non troviamo – piuttosto sorprendentemente – è un’altrettanto arti-colata indicazione topografica di dove materialmente si trovassero tali sorgenti medicamentose. Galeno infatti nei suoi molti trattati menziona solamente le aquae Albulae per due volte20, dicen-do che i bagni in tali acque vanno evitati in caso di febbre, ma che sono utili per sanare le ferite.
La situazione non è molto diversa negli altri autori medici qui considerati (tabella 1). Anche Celso infatti dà scarsi riferimenti topografici e se anche nel De Medicina cita due
volte la località termale di Baia21, non lo fa per trattare le proprietà medicamentose delle sue acque, bensì per la possibilità di effettuare ba-gni di sudore (siccae sudationes) nei mirteti che si trovavano sopra la cittadina, dove il va-pore era esalato naturalmente dal terreno e ve-niva raccolto in un edificio apposito22. Solo in
15 Cels. 4, 2, 5-8.16 Cels. 4, 31, 3-7.17 gal. 6, 423 K; 10, 535-536, 667 K; 11, 388-389, 392-393 K.18 oriB. 10, 3, 7.19 melillo 1995, p. 474. Ad esempio in gal. 6, 423 K; 10, 535 K; 11, 392 K a causa di un utilizzo non appro-
priato le acque minerali vengono definite ἐναντιώτατα o πολέμια e persino βλαβερά.20 gal. 10, 536 K; 11, 393 K.21 Cels. 2, 17, 1; 3, 21, 6.22 Di queste sudationes baiane, definite di grande utilità, parla anche Vitruvio (vitr. 2, 6, 2).
galeno aquae Albulae
CelsoBaia
aquae CutiliaesCriBonio largo Terme dei Papi
Tabella 1 - Fonti mediche considerate.
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
368 CeCilia zanetti, anDrea rizzi, loreDana mantovanelli
un altro passo, nel testo si fa menzione a un centro termale, quello delle frigidae medicatae fontes Cutiliarum Sumbruinarumque nel Lazio23.
Un’ultima citazione compare nell’opera di un altro medico, Scribonio Largo, che fu attivo nella prima metà del I sec. d.C.: si tratta delle acque calde ferruginose di una località termale in Toscana, definite aquae vesicariae in riferimento alla parte del corpo che queste dovevano cura-re e per le quali l’autore ricorda che lo stesso effetto curativo si può comodamente ottenere im-mergendo un chiodo incandescente in un’acqua “normale”24. Grazie all’indicazione che Scribo-nio riporta della distanza di questa località da Roma (al 50° miliario), essa è identificabile con le odierne Terme dei Papi nel Comune di Viterbo, lungo la via Cassia25.
Più che i trattatisti medici, sono in realtà altri gli autori che nelle loro opere riportano riferi-menti e forniscono informazioni sulle località termali dell’Italia romana frequentate in antichità e sull’utilizzo terapeutico di tali acque, come dirà di seguito Andrea Rizzi.
Cecilia Zanetti
2. le aCque minerali in vitruvio, seneCa e plinio il veCChio
2.1 le fonti letterarie
Analizzando gli scritti di alcuni trattatisti romani che non possiedono una vera e propria formazione medica, si può osservare che le descrizioni più dettagliate di aquae medicatae, cioè medicinali26, in riferimento a sorgenti che possedevano proprietà crenoterapiche, si datano solo a partire dalla fine del I sec. a.C.-inizi I d.C.: sono infatti Vitruvio, Seneca e Plinio il Vecchio che all’interno delle loro opere, pur non avendo specifiche competenze mediche ed essendo mossi da motivazioni assai differenti fra loro, impostano una classificazione delle acque termali sulla base delle sostanze chimiche in esse contenute27.
Tutti e tre gli autori citano le acque solforose e le alluminose28; le ferruginose sono menzio-nate da Seneca e Plinio29, il quale, unitamente a Vitruvio, nomina pure le nitrose, le bituminose30 e le acide31; l’autore della naturalis Historia è poi l’unico a ricordare, oltre alle precedenti, an-che le acque saline32 (tabella 2).
Se le denominazioni delle prime tre tipologie di acque curative indicano chiaramente la loro composizione chimica, maggiori difficoltà presenta il riconoscimento delle acque nitrose, bitu-minose ed acide33. Probabilmente le prime sono da identificarsi con quelle classificate attualmen-te come bicarbonato-solfato-alcalino-terrose34, visto che Plinio definisce nitrosae le aquae Cu
23 Cels. 4, 12, 7.24 sCriB. larg. 146.25 Chellini 2002, pp. 115-117: l’identificazione è avvalorata dal combaciare delle prescrizioni terapeutiche di
Scribonio con quelle dei medici medievali, che infatti suggeriscono il ricorso a tali acque per la cura di calcoli renali e della vescica.
26 vitr. 8, 3, 5; sen. nat. 3, 2, 1; plin., nat. 31, 2, 5.27 Per la classificazione delle acque secondo questi autori, cfr. pettenò 1997 e guérin-Beauvois 2007, pp. 97-101
(dove vengono prese in considerazione anche le opere di Galeno, Oribasio e Isidoro di Siviglia) e relativa bibliografia.28 Per le acque solforose: vitr. 8, 3, 4; sen. nat., 3, 2, 1; plin. nat., 31, 2, 5; 21, 32; per le alluminose: vitr. 8, 3,
4; sen. nat., 3, 2, 1; plin. nat., 31, 5.29 sen. nat., 3, 2, 1; plin. nat., 31, 8, 12.30 Per le acque nitrose, vitr. 8, 3, 7; plin. nat., 31, 2, 5; 31, 32; per le bituminose: vitr. 8, 3, 8; plin. nat., 31,
5; 31, 32.31 vitr. 8, 3, 17-18; plin. nat,. 31, 5, 9.32 plin. nat., 31, 2, 5.33 Questo avviene perché la classificazione dei minerali effettuata in epoca antica è ovviamente differente ri-
spetto a quella moderna, che si basa sulla chimica degli elementi: angeletti 2008, pp. 831-832.34 pettenò 1997, p. 222.
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
aCque e siti termali nell’italia romana: le testimonianze Degli autori antiChi 369
tiliae35, che presentano tali caratteristiche. Per quanto riguarda invece le acque bitu-minose vi sono due possibilità: la prima fa riferimento ad un passo di Vitruvio che cita laghi d’asfalto in Siria, Arabia ed a Babilo-nia36, forse riconoscibili in laghi con un’ele-vata presenza di bitumi naturali; la seconda riguarda il Mar Morto, che Galeno chiama lago bituminoso (ἀσφαλτώδη)37 e Scribo-nio Largo bitumen Iudaicum38, caratteriz-zato invece da acque ipersaline e ricche di zolfo. Probabilmente questa è l’identifica-zione più corretta, in quanto sia Plinio sia Scribonio suggeriscono un uso dermatolo-gico delle stesse: infatti l’uno descrive gli ef-fetti positivi dello zolfo a livello cutaneo39, l’altro utilizza il bitumen per la preparazio-ne di un impiastro da applicarsi in caso di ferite e contusioni40, in accordo con quanto avviene al giorno d’oggi, visto che lo zolfo è tra i principali elementi impiegati per molte patologie cutanee. I termini acidae e acidulae, infine, non trovano corrispondenza col tipo di acqua attual-mente così classificato, poiché Plinio chiama acidula sia quella di Teano che molto probabilmente lo è, vista la zona vulcanica in cui tale località si trova, sia quella di Venafro, che invece è sulfurea.
L’esistenza di tipologie di acque così differenti veniva posta in relazione con i terreni attra-versati dalle stesse prima di sgorgare in superficie41. In particolare, alla domanda sul perché le acque di sorgente non possiedano tutte il medesimo gusto, Seneca risponde elencando quattro cause: il tipo di suolo attraversato, i mutamenti nel suolo stesso, la trasformazione dell’aria in acqua, la contaminazione, sottolineando inoltre che interest utrum loca sulphure an nitro an bitumine plena transierint42. Vitruvio esprime un concetto simile quando, a proposito delle sor-genti acide, ricorda che fieri autem hoc naturaliter ideo videtur quod acer at acidus sucus subest in ea terra, per quam egredientes venae intinguntur acritudine43.
È inoltre interessante osservare come questi autori denotino una conoscenza, sia pur empi-rica, non solo delle proprietà chimiche delle acque ma anche di quelle fisiche: infatti Plinio de-finisce le aquae Albulae e le Cutiliae rispettivamente egelidae e gelidissimae44, anticipando un altro degli attuali criteri classificativi, per cui si possono far corrispondere le acque gelidissimae con le acque fredde (<20°C) e le gelidae alle ipotermali (tra 20° e 30°C)45.
35 plin. nat. 31, 32. Cfr. tabella 3.36 vitr. 8, 3, 8.37 gal. 6, 423 K; 11, 387 K.38 sCriB. larg. 207-209.39 plin. nat. 35, 50.40 sCriB. larg. 207-209.41 plin. nat. 31, 52. Un pensiero simile è espresso anche da Galeno, per il quale le acque si mescolerebbero con
tali sostanze attraversando terreni che ne sono ricchi: gal. 11, 388 K. Questo concetto si dimostra scientificamente corretto alla luce delle conoscenze attuali, soprattutto per quanto riguarda le acque bicarbonate.
42 sen. nat., 3, 22, 1.43 vitr. 8, 3, 18.44 plin. nat. 31, 6, 10.45 In nat. 31, 4, Plinio, nel distinguere l’acqua in base alla temperatura, parla di aquae frigidae, calidae, tepi
dae, e gelidae.
VITRUVIO SENECA PLINIO
sulphurosae(solforose)
sulphuratae(solforose)
sulpuratae(solforose)
- ferratae(ferruginose)
ferruginei(ferruginose)
aluminosae(alluminose)
aluminosae (allumi-nose)
aluminatae(alluminose)
nitrum(nitrose) - nitrosae
(nitrose)
bituminosae(bituminose) - bituminatae
(bituminose)
acidae(acide) - acidulae
(acidule)
- - salsae(saline)
Tabella 2 - Tipi di acque menzionati dagli autori antichi.
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
370 CeCilia zanetti, anDrea rizzi, loreDana mantovanelli
2.2 le sorgenti termali e il loro utilizzo terapeutiCo
Come i trattatisti medici romani, appena ricordati da Cecilia Zanetti, così anche gli autori qui presi in esame fanno menzione nelle loro opere di un numero davvero limitato di siti (tabella 3), nonostante siano vissuti tra l’età augustea e la prima metà del I sec. d.C., dunque in un periodo in cui l’utilizzo delle acque termali ebbe un grande impulso46.
Alcuni di questi siti, come le aquae Albulae47 e le Cutiliae48, dovevano essere piuttosto ce-lebri e frequentati, stando alla loro ricorrenza nelle fonti letterarie; ma molte altre località, pure importanti secondo i dati archeologici, come ad esempio le aquae tauri e le Apollinares49, non vengono neppure citate.
Le sorgenti menzionate, se si esclude il caso delle aquae patavinae, si distribuiscono geograficamen-te nell’Italia centrale, attorno a Roma e in particolare nelle regioni del La-zio e della Campania (fig. 1). Per una decina di loro, come appare eviden-te dall’analisi della tabella,50 Vitru-vio, Seneca e in particolar modo Pli-nio (che offre il maggior numero di citazioni) specificano il tipo di acqua che vi sgorgava o indicano le patolo-gie che vi si potevano curare. Vitruvio e Seneca, peraltro, esplicitano sempre le caratteristiche dell’acqua delle fonti menzionate, elemento, questo, che in-vece solo in alcuni casi viene preso in considerazione da Plinio.
Secondo Plinio dunque le aquae Sinuessanae, presso l’odierna Mon-dragone (Campania), erano utili per contrastare la sterilitatem feminarum et virorum insaniam51, mentre le sor-genti di Ischia (Aenaria insula) e di Stabia (aqua Dimidia) erano indicate per i calcoli, così come le acque defi-nite acide che sgorgavano presso Te-ano (aqua Acidula) e Venafro (fons Acidula venafrana)52. Le fontes Leucogoei, tra Napoli e Pozzuoli, cura-
46 Lo dimostra la grande quantità di dati archeologici attualmente in corso di raccolta e studio nell’ambito del corrente progetto Il termalismo in età romana tra conoscenza e valorizzazione (PRIN 2008), di cui supra.
47 Cfr. anche stat. Silv. 1, 3, 75; svet. Aug. 82; mart. 1, 12, 2; paus. 4, 35, 10-11; tab. peut. V, 5.48 Cfr. anche straB. 5, 3, 1; D.C., 66, 17, 26; Anth. pal. 9, 349.49 Si osservi che entrambe le acque sono menzionate nella tabula peutingeriana (V, 3).50 Tralasciamo di parlare delle acque di Baia, poiché pur essendo tra le più note in età imperiale e a proposito
delle quali Plinio ricorda che nusquam tamen largius quam in Baiano sinu nec pluriuso auxiliandi generibus (plin. nat. 31, 2, 5), necessiterebbero di una trattazione più sistematica e approfondita, che si rimanda ad altra sede.
51 plin. nat. 31, 4, 8.52 Ibidem, 4, 9.
Fig. 1 - Carta di distribuzione delle località termali menzionate nel testo: n. 1: Aquae patavinae (Abano Terme, Montegrotto Terme – PD); n. 2: Aquae cutiliae (Cittaducale – RI); n. 3: pinna (Penne – PE); n. 4: fons Acidula venafrana (Venafro – IS); n. 5: Aquae albulae (Ti-voli Terme – RM); n. 6: fons Acidula di Teano (CE); n. 7: Aquae Sinuessanae (Mondragone – CE); n. 8: Aenaria insula (Ischia – NA); n. 9: fontes Leucogoei (Agnano Terme – NA); n. 10: Aqua Dimidia (Ca-stellammare di Stabia – NA) (elaborazione grafica di C. Zanetti).
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
aCque e siti termali nell’italia romana: le testimonianze Degli autori antiChi 371
vano gli occhi e le ferite53. Le aquae Albulae (Tivoli Ter-me), che Vitruvio e Sene-ca definiscono sulphuratae54, sono indicate da Plinio per la cura delle ferite55. È impor-tante rilevare che proprio da lì proviene uno dei pochi testi epigrafici a noi noti che met-tono in relazione cura e ma-lattia, menzionando appun-to quest’ultima: si tratta della base di un donario iscritto con un carmine metrico risa-lente al III sec. d.C. e colloca-to in ricordo della sanatio di un cavallo ferito durante una battuta di caccia56. Le aquae Cutiliae, presso Cittaduca-le, di tipo nitroso, erano utili per lo stomaco, i nervi e l’in-tero corpo57; della medesima sorgente Vitruvio ricorda gli effetti purgativi58, segnalati anche per la fonte situata nel-la città dei Vestini pinna, l’at-tuale Penne nel pescarese59.
Ancora diverso il caso delle aquae patavinae, sul-le pendici orientali dei Col-li Euganei, che pure vengo-no menzionate da Plinio ma senza indicarne nello speci-fico le proprietà chimiche e curative: l’autore ricorda in-fatti solo la presenza in area di acque calde che favorivano lo sviluppo di alghe60, men-tre in un altro passo della sua
53 Ibidem, 8, 12. I colli Leucogoei che si innalzano nell’area attorno alla sorgente devono il loro nome al colo-re bianco delle rocce che vi affioravano.
54 vitr. 8, 3, 2; sen. 3, 20, 4. Le Aquae Albulae erano così chiamate per il colore biancastro dell’emulsione gas-sosa costituita da anidride carbonica e idrogeno solforato liberatosi a contatto con l’aria.
55 plin. nat. 31, 6.56 CIL XIV, 3911. Sull’iscrizione, cfr. Basso, petraCCia, tramunto 2011 con bibliografia precedente.57 plin. nat. 31, 6, 10.58 vitr. 8, 3, 5.59 Ibidem.60 plin. nat. 2, 227.
autore tipo Di aCqua sorgente malattia Curata
vitruvio
sulphurosae(solforose)
aquae Albulae(fig. 1, n. 5) -
nitrum(nitrose)
pinna(fig. 1, n. 3)
depurgat etiam strumarum minuit
tumores(effetti purgativi,
tumori scrofolosi)
aquae Cutiliae(fig. 1 n. 2)
acidae(acide)
aqua Acidula ab teano Sidicino
(fig. 1, n. 6)
calculos in vesicis(calcoli alla
vescica)
seneCasulphuratae(solforose)
aquae Albulae(fig. 1, n. 5) -
plinio
- aquae Sinuessanae(fig. 1, n. 7)
sterilitatem feminarum et virorum
insaniam(pazzia maschile,
sterilità femminile)
- Aenaria insula(fig. 1, n. 8)
calculosis(calcoli)
- aqua Dimidia(fig. 1, n. 10)
calculosis(calcoli)
acidulae(acidule)
aqua Acidula ab teano Sidicino
(fig. 1, n. 6)
calculosis(calcoli)
fons Acidulus venafranus(fig. 1, n. 4)
calculosis(calcoli)
- fontes Leucogaei(fig. 1, n. 9)
oculis, vulneribus(patologie oculari,
ferite)
- aquae Albulae(fig. 1, n. 5)
vulneribus(ferite)
- aquae patavinae(fig. 1, n. 1)
nitrosae(nitrose)
aquae Cutiliae(fig. 1 n. 2)
stomacho, nervis, purgatio
(stomaco, tendi-ni, uso purgativo)
Tabella 2 - Tipi di acque menzionati dagli autori antichi.
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
372 CeCilia zanetti, anDrea rizzi, loreDana mantovanelli
opera afferma che tali acque, prive di particolari odori e benché non scolorino l’argento ed il bronzo, sono ugualmente medicamentose61. Si deve soltanto ad autori appartenenti alla tarda latinità, quali Claudiano62, Ennodio e Cassiodoro63 una descrizione più dettagliata dei luoghi e delle malattie ivi curate: è il vescovo di Pavia in particolare che ne segnala l’utilizzo per la cura all’obesità con i vapori che fanno sudare64.
Andrea Rizzi
3. le ConosCenze meDiChe Degli antiChi relativamente all’uso Delle aCque termali:alCune ConsiDerazioni
Il confronto fra le menzioni di acque e malattie nei testi di Vitruvio, Seneca e Plinio con le cono-scenze mediche odierne in merito all’utilizzo delle stesse sorgenti, permette di affrontare una que-stione relativa alle nozioni terapeutiche che gli antichi avevano riguardo all’uso delle acque curative. È evidente che in tal senso è importante tener presente l’attuale classificazione di tali acque65.
L’acqua presente in natura, oltre ad avere una certa temperatura, contiene composti di natu-ra biologica e sostanze disciolte, allo stato ionico e non, oppure allo stato gassoso; a seconda dei casi questi elementi le conferiscono delle caratteristiche particolari. In base a queste premesse si è distinta l’acqua minerale da quella potabile, intendendo per “minerale” un’acqua contenente elementi tali da conferirle particolari proprietà organolettiche, medicamentose e terapeutiche, e differenziandola così da quella “potabile” che, pur contenendo a sua volta una certa quantità di sostanze, non ha caratteristiche particolari.
Le acque minerali si possono identificare in molte maniere, ma in modo schematico si classifi-cano essenzialmente in base a caratteri di tipo fisico e chimico, comprensivi a loro volta di altri para-metri. I principali caratteri fisici presi in considerazione per la classificazione sono: la temperatura, il colore, l’odore, il sapore, la limpidezza, la densità e l’indice di rifrazione. I principali caratteri chi-mici sono: il pH, il residuo fisso, l’ammoniaca, i nitriti, i nitrati, l’ossigeno, la durezza e l’alcalinità.
Le classificazioni più seguite si basano sul carattere fisico della temperatura e su quello chi-mico della composizione e della concentrazione dei vari elementi, per cui in base a tali parame-tri le acque vengono denominate e caratterizzate come si riporta di seguito66.
Classificazione in base alla temperatura:
Acque fredde: con temperatura inferiore ai 20° C− Acque ipotermali: con temperatura compresa tra i 20° C e i 30° C− Acque (omeo)termali: con temperatura compresa tra i 30° C e i 40° C− Acque ipertermali: con temperatura superiore ai 40° C−
61 plin. nat. 31, 32, 61. A testimonianza della loro importanza, le Aquae patavinae sono citate anche da al-tri autori di età imperiale: cfr. mart. 1, 61, 3-4; 6, 42, 4; sil. it. pun. 12, 212-222; plut. Caes. 47, 3-6; suet. tib.14, 3; avit. in Anth. Lat., Carm. 36; auson. Ordo urb. nob. 17, 159-162. Per un’esaustiva raccolta di fonti pertinenti quest’area, cfr. lazzaro 1981, pp. 47-78; Delle antiche terme 1997, pp. 16-19.
62 ClauD. Carm. min. 26.63 CassioD. var. 2, 39.64 ennoD. epist. 5, 8. Ennodio sostiene anche (epist. 5, 12) di essere guarito da una malattia agli occhi che lo af-
fliggeva da tempo; tuttavia, stando anche alle attuali conoscenze mediche, appare improbabile attribuire la guarigio-ne all’utilizzo di queste acque termali.
65 Un recente testo di riferimento sulla medicina termale è agostini 2000, cui si rimanda per ulteriori appro-fondimenti. Sul tema della classificazione moderna delle acque termali in relazione all’antica, cfr. il bel lavoro in pet-tenò 1997. Va segnalato che le acque curative possono essere classificate secondo parametri differenti e quindi risul-tare talvolta diverse fra loro.
66 Per questa classificazione cfr. marotta, siCa 1929.
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
aCque e siti termali nell’italia romana: le testimonianze Degli autori antiChi 373
Classificazione in base alla concentrazione67:
Acque oligominerali: con residuo fisso inferiore ai 200mg/l (diuretiche)− Acque medio minerali: con residuo fisso tra 200mg/l e 1g/l (diuretiche)− Acque minerali: con residuo fisso superiore a 1g/l−
Classificazione in base alla composizione:
Acque salse o cloruro sodiche: sono acque in cui sono presenti in maniera prevalente so-− dio e cloro; in alcune si trovano solfato e bicarbonato di sodio, solfati, calcio e magnesio (proprietà: diuretiche, stomachiche, lassative).Acque salso-bromo-iodiche: sono acque fortemente mineralizzate, di origine marina; − contengono cloruro di sodio e altri minerali quali iodio e bromo (proprietà: antinfiam-matorie, antiedemigene, antisettiche).Acque solfate: sono acque in cui l’elemento dominante è lo zolfo e sono definite tali − quando i solfati superano i 200mg/l; contengono anche altri elementi come bicarbonati, calcio, magnesio, sodio, cloro, arsenico (proprietà: vista la natura complessa di queste acque, il loro meccanismo d’azione varia con il tipo, la quantità e le interazioni degli elementi contenuti; fondamentalmente stimolano le secrezioni biliari, pancreatiche e ga-striche, sono mucolitiche e antinfiammatorie al livello delle vie respiratorie).Acque sulfuree: sono acque con una quantità pari o superiore a 1mg/l di acido solfidri-− co; contengono zolfo in varie combinazioni, anidride carbonica, cloruri, ioduri, bromuri (proprietà: vasodilatatrici a livello capillare, stimolatrici del trofismo cellulare epatico, delle secrezioni gastrica e biliare, cheratoplastiche e cheratoliche, antiseborroiche, stimo-latrici del trofismo articolare).Acque arsenicali-ferruginose: sono acque contenenti ferro in grande quantità oltre ad − arsenico, magnesio, rame, zinco e litio in tracce (proprietà: antianemiche).Acque carboniche: sono acque contenenti anidride carbonica libera oltre ad altri elementi − in soluzione, per cui si definiscono carbonico-sulfuree, carbonico-solfate ecc. (proprietà: vasodilatatrici a livello del microcircolo, riduttrici della frequenza respiratoria, stimola-trici della secrezione gastrica, diuretiche).Acque bicarbonate: sono le acque più diffuse in natura (originatesi per attraversamento di − rocce calcaree), che contengono prevalentemente bicarbonati. Si definiscono bicarbonato-alcaline quelle in cui sono presenti sodio e potassio, bicarbonato-alcalino-terrose quelle più ricche di calcio e magnesio (proprietà: diuretiche, eutrofiche e protettive a livello della mucosa gastrica, stimolatrici delle secrezioni pancreatiche, coleretiche e colagoghe; per la presenza di altri elementi tuttavia, le loro proprietà sono difficilmente schematizzabili e spesso analoghe a quelle delle acque solfate).Acque radioattive: sono acque classificate, a differenza delle altre, in base a una proprietà − fisica, cioè la radioattività, che è data da diversi elementi presenti in esse, tra cui il più fre-quente è il radon. Ai fini terapeutici, tuttavia, la classificazione chimica mantiene inalterata la sua importanza, per cui si avranno acque radioattive oligominerali, salsobromoiodiche ecc.
Le patologie che possono trarre beneficio dalle cure termali sono attualmente indicate dal Ministero della Salute68 e riguardano alcune malattie reumatiche, dermatologiche, delle vie re-spiratorie, ginecologiche, vascolari, degli apparati O.R.L., urinario, gastroenterico, come si è ri-assunto schematicamente nella tabella n. 4.
67 L’azione diuretica è inversamente proporzionale al residuo fisso, intendendo per residuo fisso la quantità ponderale degli elementi presenti in soluzione nell’acqua.
68 La legislazione che indica tali patologie è costituita dai seguenti Decreti Ministeriali: D.M. Ministero della Sanità 12 agosto 1992; D.M. Ministero della Sanità 27 aprile 1993; D.M. Ministero della Sanità 15 dicembre 1994.
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
374 CeCilia zanetti, anDrea rizzi, loreDana mantovanelli
L’acqua termale, a scopo terapeutico, si utilizza sia per via interna che per via esterna: nel primo caso può essere bevuta, come ad esempio le acque ferruginose che si impiegano in pre-senza di anemie sideropeniche, oppure può essere assorbita per mezzo di irrigazioni o aerosol; nel secondo caso, si ricorre ad applicazioni locali come bagni o fanghi69, utilizzati specialmente per patologie cutanee, osteoarticolari e vascolari. Attualmente le principali terapie termali pra-ticate sono: l’aerosol, l’antroterapia, il bagno termale, la crenofisiochinesiterapia, le irrigazioni, la fangoterapia, l’idropinoterapia, le inalazioni, le nebulizzazioni.
Per quanto concerne le sorgenti dell’Italia romana, mettendo in correlazione patologie e cure indicate dagli autori romani qui considerati con le conoscenze scientifiche attuali (tabella 5)70, si evince che le applicazioni terapeutiche degli antichi risultano in una buona parte dei casi corrette, pur trattandosi con ogni probabilità del frutto di un sapere empirico più che scientifi-co o sistematico e talvolta contaminato (in particolar modo in Plinio) da un’eccessiva attenzio-ne verso tradizioni favolistiche e meravigliose, fatte di prodigi e miracula aquarum.
In molti casi si osserva una continuità delle cure praticate, per quanto gli utilizzi odierni sia-no in genere più vasti rispetto a quelli citati nei testi antichi: basti menzionare il caso delle Aquae Cutiliae, di cui Vitruvio sottolinea gli effetti purgativi e che Plinio esplicitamente dice curative per lo stomaco, ancor oggi (terme di Cotllia, presso Cittaducale) utilizzate per patologie del fegato e delle vie biliari, ma anche per patologie tipiche dell’apparato respiratorio, per favorire una miglio-re funzionalità del sistema cardio-circolatorio, per combattere le affezioni dell’apparato locomo-tore ecc. Altre volte, il confronto con la realtà odierna getta luce sull’uso antico. Si consideri ad esempio l’Aqua Dimidia (oggi Castellammare di Stabia) che secondo Plinio era usata per curare la
69 Un approfondimento sulla fango-balneoterapia si trova in serofilli 1994.70 Si osservi che il riconoscimento delle aquae acidulae di Teano Sidicino menzionate da Plinio resta dubbio.71 Per la legislazione che regolamenta la materia della medicina termale, cfr. Legge 16 luglio 1916, n. 947; D.M.
Ministero della Sanità 15 dicembre 1994; Legge 24 ottobre 2000, n. 323.
tipi Di aCque Componenti moDalità D’uso inDiCazioni terapeutiChe
Salse o cloruro sodiche
Sale, solfato di sodio, bi-carbonato di sodio, calcio,
magnesio.Da bere Diuretiche, stomachiche, insuffi-
cienza epatica, cistite cronica
Salso-bromo-iodiche Sale, bromo, iodio Balneoterapia, fanghi,
inalazioni, irrigazioni
Patologie cutanee, ginecologiche, circolatorie, degli apparati locomo-
tore e respiratorio
Solfate Zolfo Da bere, fanghi, inal-azioni rettali
Patologie ginecologiche, cutanee, dei capelli, del fegato
Sulfuree Zolfo combinato (ex. idrogeno solforato)
Da bere, balneoterapia, fanghi, inalazioni, ir-
rigazioni vaginali
Patologie cutanee, osteoarticolari e del ricambio (gotta), affezioni croniche, O.R.L., respiratorie,
ginecologiche, angiopatie
Ferruginose FerroDa bere, balneoterapia, fanghi, inalazioni, ir-
rigazioni
Anemie sideropeniche, diatesi linfatiche, convalescenze, malattie
della pelle, nevriti
CarbonicheBicarbonate
Bicarbonato in varie forme
Da bere, balneoterapia, irrigazioni
Affezioni dell’apparato circolato-rio, demineralizzazione
Acidule Anidride carbonica (libera sup. a 250 mg/l)
Tabella 4 - Classificazione attuale delle acque minerali in base ai sali contenuti. Componenti principali, modalità d’uso, indicazioni terapeutiche71.
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
aCque e siti termali nell’italia romana: le testimonianze Degli autori antiChi 375
calcolosi: poiché oggi di tali acque si riconoscono, tra le altre, anche le specifiche proprietà diure-tiche, probabilmente i calcoli cui si riferiva Plinio erano quelli delle vie urinarie.
La questione risulta quindi di grande interesse e andrà approfondita con il prosieguo del-la ricerca, cercando anche di confrontare i dati offerti dalle fonti letterarie con quelli archeolo-gici, così da affinare le notizie in merito allo specifico utilizzo delle diverse sorgenti: per capire il tipo di cura proposto e dunque la malattia da curare è in effetti importante definire caso per caso se vi si praticava la terapia idropinica o la balneoterapia.
Loredana Mantovanelli
nome Della sor-gente
patologie Curate seConDo gli antiChi
loCalizzazione sorgente
ClassifiCazione attuale
inDiCazioni terapeutiChe attuali
aquae patavinae Obesità, (occhi?)Abano Terme, Montegrotto
Terme (Veneto)
Salso-bromo-iodica
Patologie circolatorie e degli apparati locomotore, respiratorio e uro-genitale
aquae Sinuessanae Sterilità femminile, pazzia maschile
Mondragone (Campania) Solfata Varie patologie tra cui
quelle ginecologiche
aqua in Aenaria insula Calcoli (vescicali) Ischia (Campania)
Salso-bromo-iodica, alcalina,
lievemente radioattiva
Patologie ginecologiche, cutanee, circolatorie,
degli apparati locomotore e respiratorio
aqua Acidula ab teano Sidicino Calcoli (vescicali) Teano (Campa-
nia) Sulfurea?
aqua in Stabiano quae Dimidia
vocaturCalcoli (vescicali)
Castellammare di Stabia (Cam-
pania)
Cloruro-sodica, bicarbonato
calcicaDiuretiche
fons Acidulus venafranus Calcoli (vescicali) Venafro (Molise) Sulfurea
Patologie cutanee, os-teoarticolari, del ricambio (gotta), affezioni croniche O.R.L., respiratorie, uro-
litiasiche
aquae Albulae Ferite Tivoli Terme (Lazio)
Sulfureo-car-bonica
Patologie cutanee, gine-cologiche, degli apparati circolatorio, locomotore,
respiratorio
aquae Cutiliae Stomaco, nervi Cittaducale (Lazio)
Bicarbonato-solfato-alcalino-terrosa. Sulfurea
Patologie varie tra cui quelle del fegato e delle vie
biliari
fontes Leucogoei inter puteolos et
neapolimOcchi, ferite Agnano Terme
(Campania)Salso-iodico-
solfato-alcalina
Patologie varie tra cui quelle cutanee, gineco-
logiche, stomatologiche, degli apparati circolatorio, locomotore, respiratorio
Tabella 5 - Correlazioni tra le malattie curate nell’antichità e attualmente.
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
376 CeCilia zanetti, anDrea rizzi, loreDana mantovanelli
riassunto
L’idroterapia ebbe un importante ruolo nella teoria medica antica e raggiunse il massimo sviluppo a partire dalla fine del I secolo a.C. a Roma. I medici prescrivevano l’uso di acqua calda o fredda a seco nda del tipo di patologia e nelle opere di alcuni di loro troviamo anche una precisa classificazio-ne delle acque termominerali. Tuttavia furono in particolare alcuni trattatisti romani, quali Vitruvio, Seneca, Plinio il Vecchio, ad operare una chiara distinzione tra i vari tipi di acque e le loro proprietà. Vitruvio e Plinio, in particolare, menzionano anche alcune località termali italiane che all’epoca dove-vano essere famose e frequentate proprio grazie alle proprietà crenoterapiche delle loro sorgenti. Il confronto tra gli elementi che emergono dalla lettura di questi testi e le attuali conoscenze permet-tono di affermare che l’utilizzo delle acque termali fatto dai Romani era sostanzialmente corretto.
aBstraCt
Hydrotherapy had a prominent role in the ancient medical theory, both in the Greek and the Roman world; it was however in the latter that it reached its peak, with thermal bathing becoming widely popular among the Roman society.Physicians recommended the use of hot or cold water for an ample variety of treatments, as did Cel-sus, or the use of thermo-mineral water, in which Galen singled out some kinds of water (sulphu-rous, ferruginous, aluminous, ecc.) showing an articulate knowledge of its chemical composition. Yet, despite thermo-mineral bathing being an important part of medical treatments, only very few thermal springs were mentioned in medical texts.Other authors, who were not physicians, also wrote about thermo-mineral waters. Vitruvius, Sene-ca and Pliny the Elder – just as Galen – made the distinction between the types of water, trying to un-derstand their origin and their different therapeutic properties. However an adequate correspondence di scussing the remarkable development of crenotherapy that took place from the early Imperial age is not found in literary sources. Specifically, Vitruvius and Pliny mentioned only about ten thermal springs in Italy, but left out other, even though they were well-known and frequented at that time.Finally, the comparison between ancient data and modern knowledge allows us to assert that the use of thermo-mineral waters by the Romans was in most cases correct, so much so that many of the springs they used continue being utilized today.
Aquae patavinae. Montegrotto terme e il termalismo in Italia
aCque e siti termali nell’italia romana: le testimonianze Degli autori antiChi 377
BiBliografia
agostini g. 2000, Manuale di medicina termale, Torino.angeletti l.r. 2008, usi terapeutici delle acque nella trattatistica medica della tarda antichità
(secoli IvvII d.C.), in L’acqua nei secoli altomedievali, Atti delle settimane di studio del-la Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Altomedioevo (Spoleto, 12-17 aprile 2007), LV, II, Spoleto, pp. 821-864.
Basso p., petraCCia m.f., tramunto m. 2011, Il termalismo nelle testimonianze letterarie ed epigrafiche. primi passi di un pRIn, in Aquae patavinae. Il termalismo antico nel comprensorio euganeo e in Italia, Atti del I Convegno nazionale (Padova, 21-22 giugno 2010), a cura di M. Bassani, M. Bressan, F. Ghedini (Antenor Quaderni, 21), Padova, pp. 181-193.
BouDon V. 1994, Le rôle de l’eau dans les prescriptions medicale d’Asclépios chez Galien et Ælius Aristide, in eau 1994, pp. 157-168.
Chellini r. 2002, Acque sorgive salutari e sacre in etruria (Italiae Regio VII). Ricerche Archeologiche e di topografia Antica (BAR International Series, 1067), Oxford.
Delle antiche terme 1997 = Delle antiche terme di Montegrotto. Sintesi archeologica di un territorio, Montegrotto Terme, 1997.
Di Capua f. 1940, L’idroterapia ai tempi dell’impero romano, Roma.eau 1994 = L’eau, la santé et la maladie dans le monde grec, Actes du Colloque (Paris, 25-27
novembre 1992), a cura di R. Ginouvès, A.-M. Guimier-Sorbets, J. Jouanna, L. Villard (BCH suppl. XXVIII), Athenes-Paris, 1994.
garzya a. 1994, L’eau dans la littérature médicale de l’antiquité tardive, in eau 1994, pp. 109-119.guérin-Beauvois m. 2007, Les aquae: sujet médicoreligieux ou thème littéraire. essai
d’interprétation, in Bains curatifs et bains hygiéniques en Italie de l’antiquité au Moyen Âge, études réunies par M. Guérin-Beauvois, J.-M. Martin (Collection de l’École Fran-çaise de Rome, vol. 383), Rome, pp. 93-114.
jaCkson r. 1999, Spas, waters, and hydrotherapy in the Roman world, in Roman Baths and bathing, Proceedings of the First International Conference on Roman Baths (Bath, 30 March – 4 April 1992), I, a cura di J. DeLaine, D.E. Johnston, Portsmouth, pp. 107-116.
lazzaro l. 1981, Fons Aponi. Abano e Montegrotto nell’antichità, Abano Terme.marotta D., siCa C. 1929, Composizione e classificazione delle acque minerali italiane, in An
nali di Chimica Applicata, 19, fasc. 12, pp. 529-560.Melillo L. 1995, Il termalismo nel mondo antico, in MediSec, 7, pp. 461-483.pettenò e. 1997, Acque termali e uso terapeutico del bagno nel mondo romano, in termalismo
antiguo. I Congreso Peninsular. Actas, Arnedillo (La Rioja, 3-5 octubre 1996), a cura di M.J. Perex Agorreta, Madrid, pp. 217-227.
serofilli a. 1994, La fangobalneoterapia: meccanismo d’azione. Componenti attive, reazioni dell’organismo, effetti curativi, Padova.
stok f. 1992, La medicina termale dei Romani, in quaderni internazionali di storia della medicina e della sanità, 1, pp. 41-52.
yegül f. 1992, Baths and bathing in classical antiquity, Cambridge.